|
società
Rendere protagoniste le piazze
di Antonio Cardella
Al di là delle consuete “drammatiche” alternative strombazzate in campagna elettorale, le politiche dei governi (tecnici o politici) fanno riferimento ai vari poteri forti. Non certo alla “gente”.
Quando ebbi terminato l'intervento,
fui colto dall'angoscia di non essere stato chiaro, di non avere
sufficientemente motivato le ragioni che mi vedevano così
radicalmente contrario alle analisi e alle ipotesi di intervento
che governo e partiti – nessuno escluso – sostenevano
per uscire dalla crisi gravissima che attanaglia il nostro paese
e gran parte delle comunità occidentali.
I riflettori dell'auditorium della Rai di Palermo – dove,
con i compagni Vaccaro, Tirrito e La Via (relatore il sociologo
Enzo Macaluso) si presentava ad un pubblico eccezionalmente
numeroso e attento il nostro libro Il
buco nero del capitalismo – illuminavano di luce
intensa il proscenio sul quale eravamo seduti e dal quale la
sala appariva come uno spazio vuoto oscuro e impenetrabile.
Decisi subito – sulla scia della frustrazione che compagni
e amici non riuscivano a rimuovere – che avrei messo nero
su bianco, il più razionalmente e chiaramente possibile,
la mia tesi di fondo e cioè che quanto si sostiene sulle
ragioni che hanno reso la crisi così imponente e duratura,
e gli interventi messi in atto per fronteggiarla, sia totalmente
infondato.
Misure peggiori del male
Iniziamo – sia pure a volo d'uccello – dall'inizio
della crisi.
La presunzione, tutta americana, che il mercato fosse il regolatore
finale di ogni possibile scompenso delle economie reali, aggiunta
ad una politica del credito espansiva e disinvolta, determinò
una corsa all'indebitamento che investì in particolare
alcuni settori dell'economia americana, in prima fila l'industria
della casa. Per acquistare un tetto per abitarvi o per creare
reddito, le famiglie della Grande Mela ipotecarono presunte
risorse future, prosciugando i risparmi accumulati. Altrettanto
disinvoltamente gli istituti bancari cartolarizzarono i crediti
accumulati, creando un giro di denaro cartaceo che moltiplicava
fittiziamente il valore del credito originario nella presunzione
che il processo si potesse sostenere all'infinito e che, in
ogni caso, alla fine, la crescita del benessere collettivo,
ritenuta inarrestabile, avrebbe pareggiato i conti.
Come tutti ormai sanno, le cose non andarono esattamente così:
la bolla speculativa esplose, il valore degli immobili crollò
e istituti di credito e di intermediazione finanziaria si trovarono
con una valanga di titoli cartacei che non valevano nulla, mentre
le famiglie che si erano indebitate si trovarono a fare i conti
con una indigenza alla quale l'opulenza pregressa li aveva disabituati.
Ma la carta straccia prodotta dal sistema finanziario statunitense
aveva nel frattempo inquinato tutto il resto dell'area occidentale,
per cui le famiglie che, dolosamente consigliate dalle proprie
banche, avevano investito i propri risparmi in azioni o in obbligazioni
d'oltre oceano e lo stesso sistema bancario si trovarono a non
potere far fronte ai propri impegni.
A questo punto le misure delle istituzioni pubbliche per fronteggiare
la crisi furono, se possibile, peggiori del male che volevano
combattere. Anziché equilibrare le misure di sostegno
tra gli ambiti delle sofferenze maggiori, finanziando in misura
equilibrata sia il sistema del credito, selezionando quegli
istituti più sani e che meno avevano contribuito a diffondere
la pandemia, sia le economie reali dei paesi più pesantemente
investiti dalla crisi, si preferì privilegiare proprio
quel settore maggiormente responsabile della crisi stessa.
Così, tra la fine del 2008 e il primo trimestre del 2009,
le banche centrali di Stati Uniti ed Europa finanziarono le
banche con la stratosferica cifra di 14 mila miliardi di dollari,
una massa di denaro equivalente a circa il 50 per cento del
prodotto interno lordo dei paesi beneficiari (calcolo della
Bank of England).
In questo modo si è compiuta la più imponente
operazione di socializzazione del debito privato che la storia
ricordi. In pratica, i debiti accumulati dal sistema bancario
privato si riversano sul debito pubblico di tutti i paesi travolti
dalla crisi, determinando il decollo del debito pubblico complessivo
rispetto al Pil. In Italia tale rapporto, considerato in crescita,
è di circa il 121 per cento (2014 miliardi di euro).
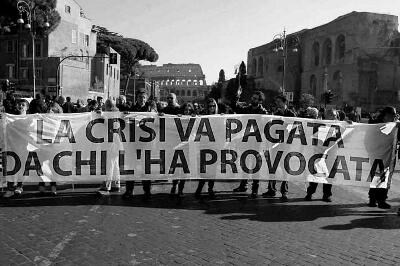
Processi recessivi a spirale
Il modo in cui tutti gli stati tentano di risolvere i loro
problemi per finanziarsi è quello di aumentare indiscriminatamente
la pressione fiscale e di effettuare tagli lineari alla spesa
pubblica, sottraendo risorse alle autonomie locali e, quindi,
servizi essenziali per i cittadini. Si verifica così
un circolo vizioso in virtù del quale le popolazioni
sono doppiamente vessate: dalla tassazione diretta e dalla necessità
di pagarsi i servizi essenziali sottratti dalla bulimia dei
governi.
Sono misure di brevissimo respiro e normalmente inutili. Infatti
innescano processi recessivi a spirale: la popolazione non ha
più soldi da destinare ai consumi e al risparmio, la
contrazione dei consumi deprime la produzione interna di beni
e servizi, aumenta la disoccupazione, si restringe – qualità
e quantità –base dei contribuenti con la doppia
conseguenza dell'aumento del debito pubblico e del rapporto
tra la produzione di ricchezza prodotta e il debito complessivo
dello stato.
Questa è la condizione attuale di molti paesi dell'eurozona,
con la fondata preoccupazione che per alcuni di essi i danni
che si stanno provocando all'economia reale diventino irreversibili.
In Italia, il dato sulla disoccupazione è gravissimo:
si stima che tra espulsi dalle attività produttive e
lavoratori potenziali che un lavoro, sfiduciati, non lo cercano
più, i senza occupazione saranno nel 2013 oltre 3 milioni
e 500.000, il 14 per cento della popolazione attiva, ai quali
occorre aggiungere circa 1 milione di cassaintegrati per un
numero di ore che supera il miliardo. La conseguenza diretta
è che i consumi sono diminuiti del 4 per cento su base
annua, la produzione industriale del 7 per cento in due anni
e il Pil del 2,4 per cento.
E noi stiamo ancora bene rispetto ad altri paesi.
Il voler porre rimedio a questa situazione con la politica del
rigore imposta dalle autorità della Comunità Europea
è pura follia. Tale strategia presuppone l'infondata
convinzione che l'indebitamento pubblico derivi dalla propensione
degli stati a spendere, mentre risulta chiaro da quello che
ho appena scritto – difficilmente contestabile perché
mi sembra sufficientemente suffragato da dati obiettivi –
che il debito pubblico cresce e si alimenta per effetto della
crisi: cioè per le dinamiche recessive che la speculazione
finanziaria ha innescato.
Bisogna aggiungere che in questi frangenti la moneta unica non
aiuta a risolvere i problemi, anzi contribuisce a cristallizzare
alcuni squilibri connessi ai diversi livelli di evoluzione delle
economie dell'eurozona. Le ragioni sono assai complesse, proverò
a sintetizzarle, scusandomi in anticipo se non riuscirò
ad essere esaustivo.
La moneta unica – che ha certamente contribuito ad evitare
derive inflattive incontrollabili all'interno dell'area –
si regge prevalentemente sulla definizione di un tasso d'interesse
omogeneo tra tutti gli stati dell'Unione (oggi è allo
0,75 per cento). Tale misura, che rende il costo del denaro
molto contenuto con effetti certamente positivi per gli scambi
commerciali, impedisce alle banche centrali delle singole nazioni
di immettere nuova liquidità (stampando cioè denaro
non vincolato) per quelle che erano definite inflazioni competitive,
volte a sanare squilibri (prevalentemente) degli apparati industriali,
in modo da renderli competitivi. In buona sostanza, le attività
produttive dell'area sono state private, anche giuridicamente
(leggi europee sulla concorrenza), della possibilità
di essere sostenute in qualche misura dai propri stati. Il che
rende poco flessibili i modelli di sviluppo, deprime il commercio
internazionale (oggi poche nazioni hanno bilanci commerciali
in attivo con l'estero) e innesca processi di deindustrializzazione,
dovuti anche agli alti costi dell'energia e delle materie prime.
In un panorama così deprimente, la funzione di un governo
europeo dovrebbe essere quella di immettere risorse adeguate
alle economie reali, potenziando tutte quelle attività
che nei singoli paesi faciliterebbero la ripresa dei consumi
e della produzione di beni e servizi essenziali, la riduzione
dei tassi di disoccupazione e, soprattutto, quelle attività
a tutela dell'ambiente e dei patrimoni culturali, di cui tutta
l'eurozona è ricca. Niente di tutto questo si vede all'orizzonte.
Ancora ultimamente, in aiuto ai titoli sovrani, Draghi ha erogato
ulteriori 1000 miliardi al sistema bancario, di cui 240 sono
arrivati in Italia. Complessivamente nei portafogli dei nostri
istituti di credito ne giacciono per 140 miliardi, chissà
a cosa destineranno l'eccedenza. Certamente non al credito a
favore di famiglie e imprese in sofferenza, a giudicare dal
fatto che alle famiglie non è neppure consentito rinegoziare
i mutui contratti e ogni giorno migliaia di imprese o chiudono
i battenti o sono sul punto di chiuderli.
Per queste ragioni e per tutte le altre che riguardano il sistematico
smantellamento di quel poco che rimane delle garanzie sociali
e giuridiche dello stato, bisogna in ogni modo che le logiche
del governo europeo, interpretate acriticamente da quel Berlusconi
travestito che è l'incartapecorito Monti, con la sua
agenda cinicamente antipopolare, non prevalgano alle imminenti
elezioni.
Noi, come sempre, ci siamo sottratti al gioco della scheda elettorale.
Ma guai se a questo sottrarsi non corrisponderà la promozione
più determinata, intanto, di una rivolta dal basso che
renda protagoniste le piazze e, contemporaneamente, di tutte
quelle libere e autonome iniziative che confermino la nostra
convinzione che un altro mondo sia possibile.
Antonio Cardella
“Il
buco nero del capitalismo”
(120 pagine) costa € 7,50.
Per richieste:
Zero in Condotta, casella postale 17127 - MI 67, 20128
Milano
zic@zeroincondotta.org
conto corrente postale 98985831 intestato a Zero in
Condotta
www.zeroincondotta.org |
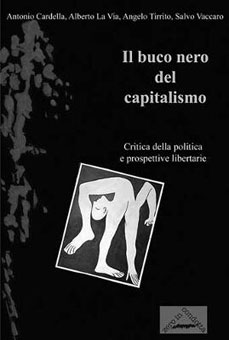 |
|