
Paesaggi
insorgenti
“Quanti siamo figli di contadini?
Figli pochi, nipoti tutti.”
Sarà stata casualità, sta di fatto comunque che
Genuino clandestino, viaggio tra le agri-culture resistenti
ai tempi delle grandi opere (Michela Potito, Robert Borghesi,
Sara Casna, Michele Lapini, Firenze, 2015, pp. 280 € 18,00),
è uscito per quelli di Terra Nuova Edizioni tre mesi
prima dell'inaugurazione di Expo Milano e che io mi sia trovata
a leggerlo proprio mentre era in corso tutto quel gran parlare
del “grande evento”, di quanto sia una presa in
giro per allocchi sprovveduti pensare che lì dentro si
tratterà seriamente di agricoltura/cibo/alimentazione,
delle reazioni mediatiche alla manifestazione No-expo dove la
rabbia di pochi ha cancellato gli argomenti di molti, compreso
“Genuino clandestino” che, in quell'occasione, manifestava
tranquillamente dietro il suo striscione.
Bisogna prendere atto (cito Guido Viale da un articolo su “Il
Manifesto” del 12 maggio 2015) – e far prendere
atto – che contro quella miseria infinita di cui l'Expo
è solo il simbolo più vistoso ed esaustivo, si
può aggregare una pluralità di forze ed iniziative
ancora assai eterogenee: uno schieramento potenzialmente maggioritario,
in barba a tutti i sondaggi e ai media di regime che ci raccontano
di una popolazione planetaria che non desidera altro che immedesimarsi
con quella simbologia fasulla.
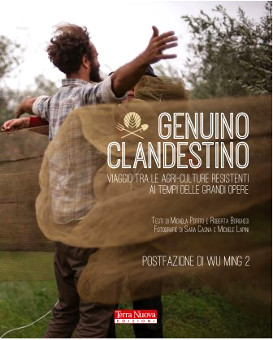 “Genuino
clandestino” fa parte di quella pluralità di forze.
Dietro quelle due parole ci sono persone che hanno fatto delle
scelte di lavoro e di vita in rapporto alla terra e al lavoro
della terra, cioè alla coltivazione di prodotti in maniera
rispettosa, che significa buona per la terra, per gli animali
e per noi umani. “Genuino
clandestino” fa parte di quella pluralità di forze.
Dietro quelle due parole ci sono persone che hanno fatto delle
scelte di lavoro e di vita in rapporto alla terra e al lavoro
della terra, cioè alla coltivazione di prodotti in maniera
rispettosa, che significa buona per la terra, per gli animali
e per noi umani.
Per collocare meglio questa realtà, per capire, bisognerebbe
guardare un po' alla storia del nostro paese perché,
parlando d'Italia, si parla di un territorio che è stato
sostanzialmente agricolo fino a poco prima dell'ultima guerra
mondiale (settant'anni fa) e che dalla fine del conflitto bellico
ha subito uno scriteriato processo di industrializzazione che,
in senso sia chimico che meccanico, ha coinvolto anche il lavoro
agricolo. Ciò ha significato l'introduzione progressiva
delle monocolture intensive in stile americano (che significano
anche grande quantità di mano d'opera per periodi brevi),
conseguenti consistenti modifiche nell'industria agroalimentare,
accentramento della proprietà terriera e addirittura
del patrimonio genetico delle piante. Poi c'è stata la
competizione col mercato mondiale e – per farla breve
– come si sa, sono sempre i piccoli a soccombere, quindi
molte piccole e medie imprese agricole a conduzione familiare
hanno chiuso e nel nostro paese c'è tantissima terra
abbandonata, soprattutto nelle zone collinari e montuose che
sono la parte più vasta della nostra penisola.
La situazione oggi è insostenibile e proseguire secondo
i criteri che impone il neoliberismo – ormai lo si sa
– è suicida. “Un fronte comune contro lo
strapotere della grande distribuzione e delle multinazionali
è necessario perché si rovescino i rapporti di
forza. Le pratiche di contrasto devono necessariamente diversificarsi:
il recupero delle terre (secondo un modello che superi la gerarchia
tra padroni e lavoratori), la riorganizzazione dal basso della
produzione e della distribuzione (l'accorciamento della filiera)
e il consumo critico devono andare di pari passo con pratiche
di mutualismo, che permettano ai lavoratori iper-precari della
terra di uscire dall'indigenza, dall'isolamento e dalla disinformazione
cui sono costretti.”
“Genuino clandestino” – che ufficialmente
nasce nel 2010 – sta dentro questa volontà di sovvertire
lo stato delle cose ma il fatto più bello e interessante
del libro è che oltre a raccontarlo ce lo fa toccare
con mano attraverso le storie dei loro protagonisti e le tante
fotografie che, a volte, dicono più delle parole. Molte
anche le analisi e le riflessioni teorico-politiche che si intercalano
in un volume di oltre duecentocinquanta pagine che, grazie al
bel lavoro delle curatrici, riesce in maniera sincera a renderci
compartecipi di quanto si sta muovendo nelle campagne italiane.
Sono dieci tappe per dieci realtà differenti: dalla riappropriazione
collettiva dei terreni del comune di Firenze di Mondeggi/fattoria
senza padroni in custodia popolare, a chi coltiva da solo
cinque ettari nei dintorni di Roma, nelle campagne della Sabina;
c'è la storica comune libertaria di Urupia nelle
Puglie e la coppia con podere di loro proprietà sulle
colline modenesi che ha scelto la campagna come stile di vita
per sé e i propri figli. Il panorama e le storie che
incontriamo sono quindi molto diversificati ma uno è
il fattore che accomuna tutti, quello di appartenere a un movimento
di comunità in lotta per l'autodeterminazione alimentare.
“Genuino clandestino” è nato da comunità
locali di cittadini e contadini che si autorganizzano insieme,
creano mercati di vendita diretta, sistemi di garanzia partecipata,
momenti di scambio di saperi e informazioni. Non è solo
le dieci realtà raccontate nel libro ma un intero movimento,
senza strutture gerarchiche, che negli anni ha creato forme
di resistenza quotidiana alla logica del profitto che, sfruttando
la terra e le persone, distrugge relazioni sociali ed equilibri
ecologici.
Il libro non cerca di mostrare la realtà più rosea
di quanto sia, le difficoltà di chi si ostina a vivere
di agricoltura senza grandi investimenti non sono nascoste,
però si vedono anche scorci nuovi su paesaggi insorgenti,
dove si sperimentano modi buoni di stare in relazione tra le
persone e con la terra. Resistere oggi è una necessità
per sopravvivere, per tutti, tanto più in agricoltura
e le comunità rurali che lo stanno facendo ci mostrano
qualcosa che è nuovo e antico allo stesso tempo, un modo
di stare sulla terra per nutrirla e nutrirsi che, secondo me,
va guardato con grande rispetto e attenzione per non farsi prendere
nelle trappole retoriche – Expo docet – e
nelle mode superficiali che si appropriano di tutto a loro uso
e consumo, anche del linguaggio di chi lotta per costruire la
sovranità alimentare.
Il “viaggio tra le agri-culture resistenti” ci aiuta
in questo, a vedere l'autenticità dei volti di chi con
le mani rivendica il diritto di produrre cibo buono per tutti
noi.
Silvia Papi
Giulio Questi,
poeta delle immagini
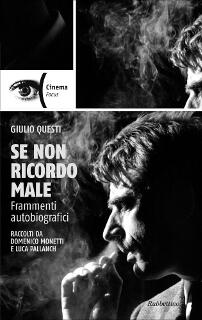 Protagonista
di “Se sei vivo spara”, Thomas Milian dichiarò
in un'intervista: “con lui [Giulio Questi] era come lavorare
con Antonioni, perché in fondo era un intellettuale rivoluzionario”.
Per lo scrittore e giornalista Oreste Del Buono era “il
Polanski orobico, il Bunel della Val Brembana”. Di certo
Giulio Questi è stato uno degli irregolari del cinema
italiano, un maledetto in attrito con tutte le conformità
e il glamour dell'universo della celluloide. Sceneggiatore,
attore e, innanzitutto, regista, ma le etichette professionali,
in fondo, lo disturbavano, specie quella del “metteur
en scène”: “Ho evitato di qualificarmi come
regista, mi avrebbe conferito uno status sociale dal quale mi
sono sempre tenuto alla larga per salvaguardare la mia libertà”.
Bergamasco di nascita, Giulio Questi è morto lo scorso
3 dicembre a novant'anni conservando una proverbiale ironia
e schiettezza, nonché una lucidità di pensiero
impressionante. Solo qualche mese prima della scomparsa, Rubbettino
aveva dato alle stampe Se non ricordo male (Rubbettino,
Soveria Mannelli - Cz, 2014, pp. 160, € 14,00), un'autobiografia
scaturita da una lunghissima discussione del regista con Domenico
Monetti e Luca Pallanch. Protagonista
di “Se sei vivo spara”, Thomas Milian dichiarò
in un'intervista: “con lui [Giulio Questi] era come lavorare
con Antonioni, perché in fondo era un intellettuale rivoluzionario”.
Per lo scrittore e giornalista Oreste Del Buono era “il
Polanski orobico, il Bunel della Val Brembana”. Di certo
Giulio Questi è stato uno degli irregolari del cinema
italiano, un maledetto in attrito con tutte le conformità
e il glamour dell'universo della celluloide. Sceneggiatore,
attore e, innanzitutto, regista, ma le etichette professionali,
in fondo, lo disturbavano, specie quella del “metteur
en scène”: “Ho evitato di qualificarmi come
regista, mi avrebbe conferito uno status sociale dal quale mi
sono sempre tenuto alla larga per salvaguardare la mia libertà”.
Bergamasco di nascita, Giulio Questi è morto lo scorso
3 dicembre a novant'anni conservando una proverbiale ironia
e schiettezza, nonché una lucidità di pensiero
impressionante. Solo qualche mese prima della scomparsa, Rubbettino
aveva dato alle stampe Se non ricordo male (Rubbettino,
Soveria Mannelli - Cz, 2014, pp. 160, € 14,00), un'autobiografia
scaturita da una lunghissima discussione del regista con Domenico
Monetti e Luca Pallanch.
Definire l'opera di piacevole lettura potrebbe essere riduttivo,
visto la notevole varietà di storie, avventure, situazioni
narrate da uno dei protagonisti (seppur molto appartato) del
cinema italiano degli ultimi settant'anni. “Se non ricordo
male” si potrebbe definire il romanzo-vita di Giulio Questi,
di un libertario che poco meno che ventenne decise di prendere
la strada della montagna ed arruolarsi in una brigata partigiana
(esperienza già fatta conoscere in “Uomini e comandanti”
pubblicato da Einaudi nel 2014). Finita la guerra a Questi si
prospettò la scelta di emigrare in Svezia o in Venezuela,
ma alla fine rimase nella sua amata Bergamo e iniziò
a scrivere sulle pagine culturali de “La cittadella”,
una rivista a cui collaboravano intellettuali affermati ed emergenti
e che - anche per volontà dello stesso Questi - scartò
di Pasolini le poesie in dialetto friulano. Alcuni racconti
di Questi uscirono sul Politecnico di Elio Vittorini il quale
si arrabbiò tanto con lui quando gli comunicò
che sarebbe andato a Roma per inseguire le muse della settima
arte. “Il cinema – lo liquidò Vittorini –
è una cosa effimera, che passa e scompare, lo scrivere
resta, è importante”.
Una volta a Roma, Questi conobbe Visconti, ma le prime serie
offerte di lavoro gli furono fatte da Valerio Zurlini che lo
volle come aiuto regia per alcuni documentari e il lungometraggio
“Le ragazze di San Frediano” (1954) tratto da un
romanzo di Vasco Pratolini. Con lo scrittore fiorentino incorrerà
in un incidente stradale mentre andavano in lambretta per le
strade di Roma. Questi ricorda che divenne conosciuto tra i
cinematografi della capitale proprio grazie a all'incidente
che procurò qualche frattura a Pratolini: “Quando
alla sera arrivavo al bar Rosati, in piazza del Popolo, dove
stazionava l'intellighenzia del momento, tutti dicevano: guarda
quello stronzo che ha rotto le costole a Pratolini. Ero diventato
famoso: ero uscito dall'anonimato!”. Le pagine del libro
sono rimorchianti anche per la lunga collana di aneddoti esposti
con disincanto e senza peli sulla lingua.
Ricorda Questi di quel provino in cui bocciò sia Silvia
Koscina che Sophia Loren (che poi una volta, a New York, se
la ritroverà nel suo letto), di quando fu scritturato
per caso come attore nella “Dolce vita” di Fellini;
delle vacanze al mare che faceva con Citto Maselli e la sua
compagna Goliarda Sapienza; del rigetto che continuò
ad avere per Pasolini e tutta la sua opera letteraria e cinematografica;
dell'incontro con il suo sosia Pietro Germi che lo volle tra
gli interpreti di “Signore i signori”; della militanza
nel Partito Comunista che poi abbandonerà; della cocaina
sniffata per puro godimento senza diventare mai un cocainomane
(”per me è sempre stato un momento di allegria,
l'esecuzione di un inno alla gloria nei momenti più felici
di comunanza”).
Il Giulio Questi regista, dopo aver lavorato in una serie di
film ad episodi, nel 1967 affiancato nella sceneggiatura e nel
montaggio dall'inseparabile Franco Kim Arcalli, firma la sua
prima vera regia con “Se sei vivo spara”, “il
western più violento, e pop che sia stato prodotto in
Italia”, una pellicola che segna una rivoluzione nel “cinema
nostrum” ma viene martoriata da sequestri e forbiciate
della censura. Con il successivo “La morte ha fatto l'uovo”
(1968), Questi “pigia il piede sul pedale del grottesco
e del nero” mentre con “Arcana” (1972) porta
a termine un “film rituale sul disordine urbano e i suoi
misteri, difficile da decifrare e catalogare”, tra gli
interpreti Lucia Bosè nei panni di una fattucchiera lucana
emigrata al nord”. Dopo “Arcana” tutte le
porte del cinema si chiuderanno per Questi, ma si apriranno
quelle della televisione dove realizza tantissimi spot e delle
fiction (“Quando arriva il giudice”, “Non
aprite all'uomo nero”, “Il segno del comando”).
Per quanto il suo cinema venga definito bizzarro, barocco, impudente,
Giulio Questi nella sua autobiografia confessa: “Io non
mi vergogno a dirlo, ho sempre cercato la poesia, cioè
qualcosa di inafferrabile, talmente inafferrabile da lasciarmi
a terra come poeta mancato. Ma non ci ho mai rinunciato e l'ho
sempre inseguita, sì, la poesia, distruttrice della logica
sintattica della normalità e del conformismo”.
Insomma, Giulio Questi un poeta delle immagini, il marchio del
“Polanski italiano” non sarebbe assolutamente disdicevole
o fuori posto... È azzeccatissimo.
Mimmo Mastrangelo
Pirati dove meno te l'aspetti:
quei ribelli del FC St. Pauli
“Danzano sulla storia di giorni conquistati
Figli della memoria, pirati a St. Pauli
Danzano sulla gloria di giorni conquistati
Figli della memoria, banditi a St. Pauli”
Talco, St. Pauli
(dall'albo Mazel Tov, 2008)
Il FC St. Pauli, di cui “A” rivista già
si occupò nel
n. 383 (ottobre 2013), è la squadra dell'omonimo
quartiere di Amburgo. I suoi risultati agonistici non sono esaltanti,
eppure conta sostenitori in ogni parte del mondo. Il Jolly Roger
(il teschio con le ossa incrociate, emblema tradizionale dei
pirati), simbolo della tifoseria sicuramente più diffuso
del logo originale della squadra, viene sfoggiato con orgoglio
su magliette, toppe e cappellini in tutta Europa, e non solo,
anche da chi di calcio ne sa ben poco.
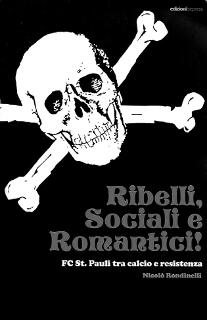 Dichiaratamente
antifascista e antirazzista, la curva de FC St. Pauli si è
messa spesso in luce per l'esposizione nel corso delle partite
di striscioni con messaggi solidali nei confronti di lotte in
corso nei confini tedeschi o all'estero, come accadde per i
No Tav nell'estate 2011 (lo striscione recitava in italiano:
“St Pauli sta con le montagne. No Tav!!!). Quest'anno,
con la propria squadra a rischio di retrocessione, i tifosi
hanno lanciato nuovamente la parola d'ordine: Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder 3. Liga [Mai più
guerra, mai più fascismo, mai più Terza Lega]-
e si noti l'ordine d'importanza delle cose. Il FC St. Pauli
nel corso degli anni è diventato un vero e proprio Kultclub,
dietro al quale tuttavia c'è una complessa realtà
che spesso viene lasciata in ombra. Ad ovviare a ciò
è uscito pochi mesi fa il corposo volume di Nicolò
Rondinelli intitolato Ribelli, sociali e romantici. FC St.
Pauli tra calcio e resistenza (Edizioni Bepress, Lecce,
2015, pp. 361, € 15,00). Dichiaratamente
antifascista e antirazzista, la curva de FC St. Pauli si è
messa spesso in luce per l'esposizione nel corso delle partite
di striscioni con messaggi solidali nei confronti di lotte in
corso nei confini tedeschi o all'estero, come accadde per i
No Tav nell'estate 2011 (lo striscione recitava in italiano:
“St Pauli sta con le montagne. No Tav!!!). Quest'anno,
con la propria squadra a rischio di retrocessione, i tifosi
hanno lanciato nuovamente la parola d'ordine: Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus, nie wieder 3. Liga [Mai più
guerra, mai più fascismo, mai più Terza Lega]-
e si noti l'ordine d'importanza delle cose. Il FC St. Pauli
nel corso degli anni è diventato un vero e proprio Kultclub,
dietro al quale tuttavia c'è una complessa realtà
che spesso viene lasciata in ombra. Ad ovviare a ciò
è uscito pochi mesi fa il corposo volume di Nicolò
Rondinelli intitolato Ribelli, sociali e romantici. FC St.
Pauli tra calcio e resistenza (Edizioni Bepress, Lecce,
2015, pp. 361, € 15,00).
Rielaborazione della sua tesi magistrale in pedagogia, il libro
di Rondinelli non si concentra soltanto sull'aspetto calcistico,
che pure è ampiamente presente com'è ovvio, ma
narra anche tutto quello che si mosse e si muove intorno al
club. In primo luogo spicca Amburgo e più in particolare
il quartiere di St. Pauli, con la sua storia di contraddizioni
e lotte che portarono, per certi versi in modo sorprendente,
la scena della sinistra radicale ad incrociare il cammino del
FC St. Pauli. Ma il volume si concentra anche sulla concreta
organizzazione che si sono dati i tifosi nel corso degli anni,
sulle loro interazioni con il quartiere (e con la città)
e sul rapporto (spesso conflittuale) con la dirigenza della
squadra. Sostanzialmente mi pare che il merito del libro sia
quello di far interagire piano calcistico e piano storico-culturale
per così dire, mischiando in modo complessivamente convincente
saggi di natura accademica, testi di fanzine provenienti
dall'ambiente della tifoseria del FC St Pauli e interviste orali,
il tutto tenuto insieme da una scrittura appassionata, entusiasta
e coinvolta ma puntuale. Tuttavia c'è un ulteriore aspetto
che emerge dal mio punto di vista dal libro di Rondinelli. Senza
cedere alla facile mitizzazione, dal suo volume risulta come
il FC St. Pauli, con il suo percorso che parla la lingua della
libertà, dell'autodeterminazione e della solidarietà,
non sia una realtà data una volta per tutte, ma il prodotto
di una decennale storia fatta di conflitti, contraddizioni,
che ancora oggi è minacciata da numerosi pericoli, tra
cui quello che l'autore definisce efficacemente “lo spettro
della gentrification”. Insomma, il libro ha il
merito di mostrare come il FC St. Pauli non sia caduto dal cielo,
non sia perfetto e come la sua indubbia alterità deve
continuamente affrontare nuove sfide- con intelligenza, dal
basso e a stretto contatto con la comunità del quartiere,
rimanendo fedele a quei valori che l'hanno reso famoso al di
là e forse nonostante i suoi risultati agonistici. Ribelli,
sociali e romantici è dunque uno strumento per conoscere
meglio questo frammento di realtà calcistica e culturale
nei suoi diversi aspetti. Una realtà di cui sapere l'esistenza
fa senza dubbio stare meglio.
David Bernardini
Goliarda Sapienza,
l'arte di Essere
“Lei aveva cercato la sua morte affrontando Mattia quella
notte, ormai lo sapeva, e forse solo chi è stato così
vicino alla morte può dimenticare e poi rinascere come
Modesta rinasce giorno per giorno...
Che importavano gli anni quando si cominciava a capire? Quella
cicatrice che divide la fronte sta ora a dimostrare la saldatura
del suo essere prima diviso. Rinasce Modesta partorita dal suo
corpo, sradicata da quella di prima che tutto voleva, e il dubbio
di sé e degli altri non sapeva sostenere. Rinasce nella
coscienza d'essere sola”.
 L'arte
della Gioia (Einaudi editore, collana Super ET, Torino,
2014, pp. 552, € 15,00) è un libro scomodo come
solo la vita riesce ad essere. Scuote, lacera, pungola, indica,
denuda. È uno specchio impietoso e proprio per questo
merita di essere letto e poi riletto, a distanza di anni. Come
un monito. Non a caso si tratta di un libro postumo: scritto
da Goliarda Sapienza tra il 1967 e il 1976, venne rifiutato
dai principali editori italiani e fu stampato in pochissime
copie solo nel 1998, due anni dopo la morte dell'autrice. Una
scrittura anarchica nel contenuto e nello stile: componenti
inscindibili, interdipendenti, mente e corpo di un'individualità
complessa e a tratti contraddittoria. La prosa ha la spontaneità
della scrittura libera e al tempo stesso la solenne gravità
di un testamento. Materica, carnale, ossuta nelle digressioni
del pensiero, lirica nella rappresentazione di paesaggi interiori. L'arte
della Gioia (Einaudi editore, collana Super ET, Torino,
2014, pp. 552, € 15,00) è un libro scomodo come
solo la vita riesce ad essere. Scuote, lacera, pungola, indica,
denuda. È uno specchio impietoso e proprio per questo
merita di essere letto e poi riletto, a distanza di anni. Come
un monito. Non a caso si tratta di un libro postumo: scritto
da Goliarda Sapienza tra il 1967 e il 1976, venne rifiutato
dai principali editori italiani e fu stampato in pochissime
copie solo nel 1998, due anni dopo la morte dell'autrice. Una
scrittura anarchica nel contenuto e nello stile: componenti
inscindibili, interdipendenti, mente e corpo di un'individualità
complessa e a tratti contraddittoria. La prosa ha la spontaneità
della scrittura libera e al tempo stesso la solenne gravità
di un testamento. Materica, carnale, ossuta nelle digressioni
del pensiero, lirica nella rappresentazione di paesaggi interiori.
Modesta, protagonista e motore propulsivo del romanzo, è
una siciliana di origini povere nata il primo gennaio del 1900.
Una ribelle, un'indisciplinata. Una donna che mai si piega a
percorrere strade già tracciate: non cede alle sue origini,
alle circostanze che continuamente la mettono alla prova, ai
ricatti dell'amore, al terrore della solitudine. Sceglie, invece,
sempre. Si edifica un destino su misura, a lei rispondente,
senza timore di abbattere – con amorale spietatezza –
gli ostacoli in cui inciampa lungo la strada: convenzioni, regole,
imposizioni, nemici. Modesta asseconda la propria indole con
coraggio – e quanto ce ne vuole per vedersi senza filtri
e sovrastrutture – orientando le proprie scelte ad un'onestà
radicale, passando di azione in azione, combattendo sistematicamente
quell'immobilismo che “anche se confortevole, alla lunga
si risolve sempre in un pantano”. Dalla povertà
della campagna agli studi in convento, dalla nobiltà
conquistata con machiavellica astuzia alla prigione, dall'attività
politica ai viaggi in giro per il mondo. E poi amicizie viscerali,
amanti, figli, compagni, amori. Terra e mare, carne e poesia,
visceralità e pensiero raffinato.
“Il male sta nelle parole che la tradizione ha voluto
assolute, nei significati snaturati che le parole continuano
a rivestire. Mentiva la parola amore, esattamente come la parola
morte. Mentivano molte parole, mentivano quasi tutte. Ecco cosa
dovevo fare: studiare le parole esattamente come si studiano
le piante, gli animali... E poi, ripulirle dalla muffa, liberarle
dalle incrostazioni di secoli di tradizione, inventarne delle
nuove, e soprattutto scartare per non servirsi più di
quelle che l'uso quotidiano adopera con maggiore frequenza,
le più marce, come: sublime, dovere, tradizione, abnegazione,
umiltà, anima, pudore, cuore, eroismo, sentimento, pietà,
sacrificio, rassegnazione”.
L'arte della gioia è un libro sulla libertà, del
corpo e della mente (del tutto inscindibili, nella visione di
Goliarda Sapienza), e sui suoi più acerrimi quanto celati
nemici: autocommiserazione, pietismo, senso di predestinazione,
paura della solitudine, scarsa consapevolezza di sé.
Tutto ciò che relega nella rigidità asfittica
di un ruolo o di un percorso predefinito, impedendo l'affermazione
gioiosa dei propri desideri, la ricerca del piacere, la relazione
paritaria e costruttiva con l'altro. Quella propensione a spostare
il nemico fuori di sé, lamentando una schiavitù
che spesso è auto imposta e conducendo una vita da tristi
e ciechi detenuti, anziché da gioiosi protagonisti. La
vita di Modesta sembra suggerire che solo attraverso un faticoso
percorso di conoscenza di sé, di accettazione della propria
natura, delle spinte vitali che ci animano e delle paure che
ci frenano, è possibile uscire dal ruolo di personaggi
e renderci autori della nostra storia. Scegliendo, rifiutando
e – se necessario – opponendoci in modo effettivamente
consapevole e libero. Per farlo, occorre una buona dose di lucida
spietatezza, specialmente nei propri confronti.
Modesta si oppone alle ingiustizie sociali, ai dogmi religiosi,
alla cultura patriarcale e fascista in cui vive, ma la sua resistenza
è innanzitutto espressione vitale e creativa del sé
profondo. Non è un'eroina. A muoverla non c'è
quella “malcelata aspirazione alla santità o vocazione
al martirio” che intravede invece nell'atteggiamento del
pensiero di molti compagni antifascisti. Non si arrende alla
ferocia del dogma, dell'ideale monolitico che nasconde la paura
dell'errore, della ricerca, della sperimentazione, della fluidità
della vita. Non cede al dogma religioso così come a quello
del materialismo dialettico, in cui intravede la stessa tendenza
assolutista. Non soccombe all'ideale dell'amore come miracolo
silenzioso, come “venerazione di statue”, ma preferisce
immergersi nella complessità dei sentimenti, nella loro
caducità e insicurezza, nelle contraddizioni che rendono
vitale ogni incontro.
Amante sensuale di uomini e donne, Modesta agisce la volontà
del corpo senza opporre resistenze ideologiche o intellettuali.
Non tollera il vittimismo di chi continuamente lamenta di essere
discriminato dalla società in quanto diverso,
sbandierando la propria sofferenza: “mostrano le loro
ferite solo per chiedere clemenza alla società che anche
loro, soprattutto loro, sentono santa e giusta invece di lottarla”.
Rifiuta le dissezioni speculative dell'amore, il tentativo di
categorizzare i motivi del desiderio, dell'affetto, della passione.
Per giungere, ormai al termine della sua storia, ad ammettere
l'incomunicabilità di “questa gioia piena dell'eccitazione
vitale di sfidare il tempo in due, d'esser compagni nel dilatarlo,
vivendolo il più intensamente possibile prima che scatti
l'ora dell'ultima avventura”. Ritrovandosi a pensare che
“la morte forse non sarà che un orgasmo pieno come
questo”. La gioia di morire per il fatto di aver vissuto.
Laddove vivere, sia chiaro, non è un eufemismo.
Marta Becco
Su “A” 399 (giugno 2015) abbiamo parlato di
Goliarda Sapienza in un'intervista
a Massimo La Torre di Domenico Bilotti dal titolo “Ma
oggi la strada è vuota”.
Brasile, fine '800/
Quella Comune Cecilia ancora così attuale
 Un
mio caro amico mi manda in regalo il romanzo di Afonso Schmidt
Colonia Cecilia (Edizioni dell'Asino, Bologna, 2015,
pp. 162, € 12,00) sulla colonia Cecilia, in traduzione
italiana. Il libro, appena uscito, sfoggia una bella copertina,
che ha per sfondo un disegno di Lorenzo Mattotti. Il simpatico
disegno di un asinello accompagna l'indicazione dell'editore:
le Edizioni dell'asino (e i libri de Lo straniero). La copertina
contiene anche il nome della collana – “Le muse
furiose” –, un cartouche verde sul davanti
con l'indicazione del titolo e del sottotitolo, il nome dell'autore
e di chi scrive la prefazione, Alice Rohrwacher. Sul retro della
copertina si ritrova lo stesso cartouche verde con qualche
riga di presentazione. Appena apro il libro, che piacere ritrovare
l'asinello, in piedi, su questa pagina di solito desolatamente
bianca! Poi qualche informazione sulla casa editrice, che mi
permette di ritrovarla online, e in fondo l'elenco dei dieci
titoli, su temi estremamente vari, già pubblicati in
questa collana. Alla fine del libro, due paragrafi riportano
l'uno la filmografia della giovane regista insieme a un simpatico
commento e l'altro la presentazione del romanziere brasiliano,
con elementi tratti, penso, dalla scheda in portoghese di una
nota enciclopedia online. Un
mio caro amico mi manda in regalo il romanzo di Afonso Schmidt
Colonia Cecilia (Edizioni dell'Asino, Bologna, 2015,
pp. 162, € 12,00) sulla colonia Cecilia, in traduzione
italiana. Il libro, appena uscito, sfoggia una bella copertina,
che ha per sfondo un disegno di Lorenzo Mattotti. Il simpatico
disegno di un asinello accompagna l'indicazione dell'editore:
le Edizioni dell'asino (e i libri de Lo straniero). La copertina
contiene anche il nome della collana – “Le muse
furiose” –, un cartouche verde sul davanti
con l'indicazione del titolo e del sottotitolo, il nome dell'autore
e di chi scrive la prefazione, Alice Rohrwacher. Sul retro della
copertina si ritrova lo stesso cartouche verde con qualche
riga di presentazione. Appena apro il libro, che piacere ritrovare
l'asinello, in piedi, su questa pagina di solito desolatamente
bianca! Poi qualche informazione sulla casa editrice, che mi
permette di ritrovarla online, e in fondo l'elenco dei dieci
titoli, su temi estremamente vari, già pubblicati in
questa collana. Alla fine del libro, due paragrafi riportano
l'uno la filmografia della giovane regista insieme a un simpatico
commento e l'altro la presentazione del romanziere brasiliano,
con elementi tratti, penso, dalla scheda in portoghese di una
nota enciclopedia online.
Ma niente sul romanzo stesso, sulle date di prima, seconda edizione,
niente sulla traduzione, né sul traduttore né
sulla prima edizione di questa traduzione. Grazie a degli estratti
proposti su questa stessa rivista, nel
numero di marzo 2008, Colonia Cecilia, Siena, Casa
editrice Maia, 1958, ed. or. Colonia Cecilia. Uma aventura
anarquista na America, São Paulo, 1942), posso verificare
che si tratta dello stesso testo italiano. Devo cercare ancora
per arrivare al catalogo della Nazionale di Firenze e scoprire
il nome del traduttore, Italico Ancona Lopez. Ma perché
si dimenticano sempre i traduttori? E infatti di questo traduttore,
dal nome che suona come uno pseudonimo, non trovo traccia. Né
riesco a sapere a chi fosse venuto in mente, nel 1958, di tradurre
e pubblicare il romanzo di Schmidt. Forse al fondatore e direttore
della casa editrice Maia, il poeta e scrittore Luigi Fiorentino
(http://www.istitutoeuroarabo.it/DM/dove-i-motori-battono-alla-pesca-ricordando-luigi-fiorentino/)?
Non si tratta qui di commentare questa traduzione né,
come abbiamo fatto in altra sede, di evocare ancora l'impatto
del romanzo di Schmidt sulla storia e la leggenda della colonia
Cecilia, bensì di (tentare di) metterci nei panni di
chi legge il romanzo così “nudo”, come ha
fatto Alice Rohrwacher per scrivere questo testo e aiutare gli
“asinelli” (con questo vezzeggiativo lei chiama
gli editori) a “guadagnare in termini di lettori”.
La prima osservazione è che nonostante il filtro romanzato
attraverso il quale passa la Cecilia di Schmidt, che, ai suoi
tempi, aveva fatto di tutto per raccogliere materiale storiografico
e anche qualche “testimonianza”, restando con buchi
enormi e ritrovandosi con realtà deformate dalla memoria
(e anche dalla fantasia), il potere d'identificazione della
colonia Cecilia resta fortissimo.
La giovane regista mette infatti a confronto tre immagini tratte
da sue esperienze personali – il ballatoio di un palazzo
di Torino, una scuola alternativa sugli Appennini – e
dalla mitologia, con la dea Temis che personifica la giustizia.
Illustra così “l'eroismo fallimentare che ci piace
tanto”, con un “noi” che include, ma chi?
Il lettore, gli asini? Certo non Giovanni Rossi, il fondatore
della colonia Cecilia, il cui profilo psicologico non corrisponde
a quello creato da Schmidt, anche se, per tanti motivi, ha dovuto
rientrare nella vita “normale”. Sarà questo
il motivo per cui è venuto in mente agli asinelli (ci
sia concesso usare anche noi il vezzeggiativo) di ripubblicare
oggi la traduzione italiana del romanzo di Schmidt: ricordare
che questo tipo di esperienza è destinato a fallire?
Eppure la modernità di questa “vecchia” idea
si percepisce nel termine comune, maschile all'epoca della Cecilia,
diventato femminile da qualche anno in qua, e femminile anche
nel nuovo titolo dato al romanzo dagli asinelli: Una comune
di giovani anarchici italiani nel Brasile di fine Ottocento.
Osserviamo, per finire, l'aggiunta, nel titolo, della parola
giovani, che non corrisponde all'età dei personaggi del
romanzo, né, tanto meno, all'età dei membri della
vera colonia Cecilia. Non corrisponde neanche all'età
di tante persone che oggi ancora scelgono, a volte per una breve
parentesi, a volte per tutta la loro esistenza, di fare della
vita in comunità la loro “normalità”.
Isabelle Felici
Con la speranza
che il mondo cambi
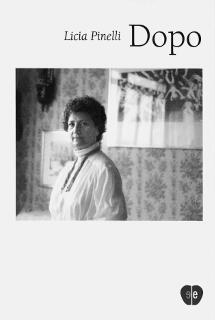 Alla
fine della vita ciò che conta è aver amato. Alla
fine della vita ciò che conta è aver amato.
Parole lette, rimaste impresse nella mente di Licia Rognini
Pinelli e poste in chiusura del suo bel libro, piccolo e toccante.
Dopo ( Enciclopedia delle donne, Milano, 2014, pp. 80,
€ 10,00) è la scrittura intima e privata, sofferta
e autentica di una donna, del suo coraggio di fronte allo sgomento,
rabbia, dolore per la morte innocente del marito Pino, “il
ferroviere anarchico”, “caduto” dal quarto
piano nel cortile interno della Questura di Milano. Molti i
dubbi sulla tesi del suicidio di Pinelli qualche giorno dopo,
alla notizia che la strage alla banca dell'Agricoltura di piazza
Fontana del 12 dicembre - diciassette morti, ottantotto feriti
- fosse stata compiuta da suoi compagni anarchici.
Quel dicembre 1969 segnerà una cesura tra un prima e
un dopo, una ferita pubblica e un dolore privato, quello che
non fa notizia.
Per Licia Pinelli il “dopo” è il tempo della
cura, della ricomposizione nella “normale quotidianità”,
del riprendere in mano la vita, sua e delle sue figlie bambine.
È anche il tempo in cui la fragilità inflitta
dalla sofferenza diventa forza resiliente. Forse per questo,
solo ora, il “dopo” può essere narrato lasciando
dipanare il lento e aggrovigliato filo della memoria, dove i
lembi del ricordo sono tribolati frammenti sparsi.
Intanto il “mondo fuori” - ben documentato nella
postfazione di Marino Livolsi - è uno spazio esterno
minaccioso, con i suoi anni bui, le manifestazioni studentesche
represse dalla polizia: a un anno di distanza da piazza Fontana,
le morti dello studente Saverio Saltarelli e poi di Roberto
Franceschi lasceranno tutti sgomenti. Licia condividerà
la sofferenza combattiva di quelle madri che hanno perso i loro
figli, e aumenterà il senso di protezione verso le proprie
figlie bambine ancora da crescere.
Ma è anche un “mondo fuori” accogliente che
consente a Licia di trovare un lavoro esterno casa, una casa
frequentata da studenti universitari, batteva a macchina le
loro tesi. Un incarico all'Istituto di Biometria e Statistica
Medica di Milano diretta dal professor Giulio Alfredo Maccacaro
la inserirà in un ambiente accogliente. Come primo lavoro,
la trascrizione a macchina di un “libro bianco”,
La strage di Stato, un'inchiesta militante collettiva
frutto di indagini e testimonianze di giovani studenti universitari
e coraggiosi amici, spinti dal desiderio di accertare i fatti
e risalire alla responsabilità politica. In seguito,
e fino alla pensione, sarà segretaria all'Istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina diretta dal professor
Marcello Cesa-Bianchi.
Non mancheranno bei gesti di generosità, come quello
ricevuto dalla collega Pia che le cederà il suo posto
di ruolo, perché scrive Licia: “lei e suo marito
lavoravano entrambi e io avevo più bisogno di loro”.
L'occasione di incontrare ancora gli studenti rinnoverà
la sua disponibilità all'ascolto. Per loro, una presenza
rassicurante, cui affidarsi per ricevere consigli. Licia convincerà
uno studente allontanatosi da casa a farvi ritorno. Contento,
per aver ricevuto dalla madre un'accoglienza inaspettata, le
sarà molto riconoscente.
In poco tempo, si tesse intorno a Licia e alla sua famiglia
una rete solidale. La dedizione affettuosa di genitori, di studenti,
di amici con i quali basta uno sguardo per capirsi. Il conforto
della vicinanza di padre Davide Turoldo, Corrado Stajano con
la moglie Giovanna Borgese, della Comunità di don Andrea
Gallo, Camillo Dal Praz. Insieme a nuove conoscenze, Giovanni
Testori, Cesare Musatti, la visita gradita di Enzo Jannacci
e Beppe Viola. Anche la solidarietà di sconosciuti, con
le loro lettere dal mondo dimostreranno sostegno e voglia di
giustizia. Cara la presenza di persone amiche, compagni di Pino
appassionati, coinvolgenti e dignitosi per quella loro semplicità
di vivere la vita.
Condividerà altresì con Marino Livolsi, Umberto
Mazzocchi e tutti gli altri compagni una forte commozione quando
trasporteranno le ceneri di Pino dal cimitero di Musocco al
cimitero di Carrara.
Licia condurrà una lunga lotta titanica per conoscere
la verità e avere giustizia, insieme agli avvocati Renato
Palmieri, Marcello Gentili, Domenico Contestabile e, in seguito,
agli affezionati Carlo Smuraglia e l'avvocata Enrica Domeneghetti.
Anche il linguaggio dell'arte sensibilizzerà l'opinione
pubblica. Come I funerali dell'anarchico Pinelli, dipinto
del pittore Enrico Bay esposto a Milano, a Palazzo Reale nel
2012. Oppure Morte accidentale di un anarchico, testo
di Dario Fo scritto per il teatro.
Sarà Piero Scaramucci, aggirando la riservatezza di Licia,
a raccogliere una lunga e travagliata intervista riportata nel
libro Una storia quasi soltanto mia pubblicato prima
nel 1982 e ripubblicato nel 2009 da Feltrinelli, con l'integrazione
di testimonianze di Carlo Smuraglia, Corrado Stajano, Giorgio
Bocca, Dario Fo, Franca Rame, Giuseppe Gozzini, Marino Livolsi,
Bruno Manghi, Luigi (Gigi) Ruggiu, Goffredo Fofi, Lella Costa.
Insieme al libro di Camilla Cederna Pinelli. Una finestra
sulla strage, contribuirà a dare fondamento ai dubbi
su quella morte ingiusta.
Interviste per testimoniare, per non dimenticare e tenere alta
l'attenzione. Incontri pubblici soprattutto dibattiti con gli
studenti fiduciosi di sapere. E ogni volta riaperta, la ferita
stillerà tenace fermezza di reagire, rialzarsi, resistere.
Ne uscirà fortificata, Licia, per la cura dedicata al
legame sincero e affettuoso fino ad oggi con le colleghe di
lavoro di un tempo, e quello amicale con donne sensibili e determinate
come Camilla Cederna e Franca Rame. L'amicizia con una donna
incontrata sul tram, Emilietta, vecchia socialista e staffetta
partigiana, sempre vicina e solidale a Licia e alla famiglia,
la condurrà ad intraprendere viaggi alla scoperta di
un nuovo “mondo fuori”, ancora più lontano.
Insieme ad altre persone guida, invece, si lascerà accompagnare
lungo un cammino personale di ricerca interiore, per un germe
di risposta alla domanda sul senso profondo della vita, alimento
di possibile serenità.
Poi il gesto gratuito e disinteressato del volontariato, a disposizione
di quanti hanno conosciuto il dolore. E il Coro “Città
di Milano” diretto dal maestro Mino Bordignon, con quei
canti “a cappella” così intensi e vibranti
e capaci di liberare la mente facendo fuggir via, almeno per
qualche ora timori e inquietudini.
Un personale rimedio ai momenti di malinconia, l'abitudine di
catalogare, ordinare libri, fotografie, ritagli di giornale,
rivedere istantanee e cartoline riportando indietro la memoria
senza lasciarsi troppo coinvolgere.
Forse proprio dopo l'udienza del 9 maggio 2009, giorno della
memoria per le vittime del terrorismo e delle stragi, Licia
ammetterà: “Mi sono in parte riconciliata con il
mondo”. In quell'occasione, il presidente Napolitano riconobbe
a Giuseppe Pinelli “rispetto e omaggio” per essere
stato “vittima due volte: prima, di pesantissimi e infondati
sospetti, e poi di un'improvvisa, assurda fine”.
Dopo quarantasei anni travagliati: “Ho ancora la speranza
che il mondo cambi”. E ora che spetta alle figlie Claudia
e Silvia partecipare agli eventi pubblici per testimoniare,
conclude, difendendosi da quanti le imputerebbero una chiusura
in se stessa, nella quale non si riconosce: “Preferisco
vedermi come il padre di Bambi che, alla fine di quello splendido
film di Walt Disney, guarda dall'alto di un colle con la serenità
datagli dalla saggezza dell'età, suo figlio e i suoi
compagni avviarsi verso il loro futuro”.
Claudia Piccinelli
Cos'è l'Enciclopedia delle donne
L'Enciclopedia
delle donne (che ha appena pubblicato il libro Dopo
di Licia Pinelli, recensito in queste pagine) è
un sito (www.enciclopediadelledonne.it) che raccoglie
le storie e le biografie di donne di tutti i tempi e di
tutti i paesi; è nata l'8 marzo 2010.
Le fondatrici sono Margherita Marcheselli e Rossana Di
Fazio. Insieme a Dafne Calgaro, che ha creato il primo
sito e il primo sistema per la pubblicazione e la gestione.
Il progetto nasce dalla volontà di dare voce e
visibilità a donne reali del passato o del presente
le cui storie possano costituire dei modelli vari, multiformi,
ricchi di complessità. Come diciamo nella presentazione
dell'Enciclopedia, alla voce “L'impresa” (http://www.enciclopediadelledonne.it/limpresa/):
“Ogni nome e cognome fa una storia, e ogni storia
singola va in un paesaggio pieno di storie, e tutto diventa
la Storia. Ma senza la storia delle donne - di tutte le
donne - non si fa una bella Storia: si fanno degli schemi,
delle approssimazioni, dei riassunti che non somigliano
più a niente. E che fan danno.”
Quindi questo è il compito che ci siamo date, nel
solco di una tradizione antica; tante donne nel passato
hanno fatto questo: hanno raccolto e organizzato le storie
di altre donne per dimostrare che la libertà di
pensiero e di azione è possibile oltre che auspicabile
e che altre donne prima di noi, tra le mille difficoltà
che la società, le convenzioni e le situazioni
imponevano loro, hanno trovato i modi per esprimere le
proprie energie, per realizzarsi e per essere felici.
Un compito che esprime anche gratitudine, che ricorda
e rende merito a coloro che con il loro coraggio e il
loro esempio hanno ottenuto risultati di cui tutte noi
ora godiamo: il diritto di votare, il diritto di vestirci
con abiti comodi, il diritto di non sposarsi, il diritto
di mantenersi economicamente, il diritto di muoverci e
fare lo sport che ci piace, il diritto di decidere se
e quando avere un figlio e tutte le mille altre piccole
e grandi libertà che abbiamo conquistato.
Questo lavoro si può fare solo sul web. È
un lavoro che non avrà mai fine ed è un
lavoro collaborativo. Nessun altra forma di comunicazione
avrebbe potuto supportare questa impresa. Il nostro è
un lavoro collettivo e collaborativo un po' particolare.
Funziona così: chiunque abbia studiato o approfondito
o conosca direttamente la storia di una donna che ritiene
interessante per l'Enciclopedia, scrive una mail alla
redazione (redazione@enciclopediadelledonne.it) proponendo
la voce, con una motivazione e una breve presentazione
di sé e del proprio percorso. Se la redazione accetta
la candidatura, “prenota” la voce all'autrice
o all'autore (anche gli uomini possono essere autori,
e ce ne sono: pochi ma veramente molto buoni). L'autrice
ha circa sei mesi per scrivere la voce.
Il testo viene inviato alla redazione che lo valuta, eventualmente
propone modifiche e aggiustamenti e, infine, dopo uno
scambio tra autrice e redazione, la voce viene approvata
e pubblicata online. Alla voce “Lavori in corso”
vengono pubblicate tutte le voci che sono state richieste
o affidate. Poi ci sono le “voci in corso di assegnazione”
che sono voci che ci piacerebbe che qualcuno scrivesse,
ma che sono tuttora “in cerca di autrice”.
Non ci sono delle categorie fisse, chiunque può
diventare una voce: ci sono scienziate, ballerine, scrittrici,
partigiane, balie, gelsominaie, attrici, cantanti, operaie,
contadine, maestre, pittrici, sportive, ricamatrici, cortigiane,
musiciste, compositrici... la storia di ciascuna donna
dà un suo contributo. Nessuna gerarchia. Nessuna
priorità.
Abbiamo cominciato con un nucleo di 100 voci, nel marzo
del 2010, ora siamo quasi a 1000 e, quel che più
conta, abbiamo cominciato con un gruppo ristretto di autrici
“madrine” che hanno creduto nel progetto fin
dall'inizio e ora abbiamo, oltre a loro, che continuano
a seguirci con impegno e affetto, più di 300 autrici
e autori (vedi la lista delle autrici e degli autori sul
sito).
Abbiamo una mailing list di oltre 1200 indirizzi, 30mila
visitatori unici e 120mila pagine viste mensili.
L'Enciclopedia delle donne è di chi la scrive.
I testi sono pubblicati sotto una licenza Creative Commons:
possono essere ridistribuiti liberamente soltanto se vengono
attribuiti alle rispettive autrici e ai rispettivi autori
e come appartenenti al progetto dell'Enciclopedia delle
donne e se non vengono utilizzati a scopo commerciale.
Dal 2012 l'Enciclopedia ha dato vita ad un catalogo di
ebook: romanzi, ricerche documenti (consultabile qui:
http://www.enciclopediadelledonne.it/e-book/). Dopo,
di Licia Pinelli, è il nostro primo libro di carta.
Per ogni informazione scrivere a: redazione@enciclopediadelledonne.it.
Margherita Marcheselli
Rossana Di Fazio
|
Anarchici italiani in Nord America/
Una resistenza quotidiana
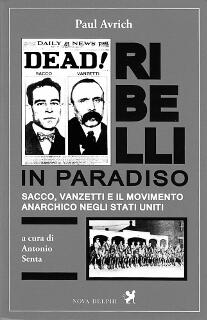 Il
merito principale di Ribelli in paradiso – Sacco, Vanzetti
e il movimento anarchico negli Stati Uniti, di Paul Avrich
(a cura di Antonio Senta, ed. Nova Delphi, Roma, 2015, pp. 382,
€ 15,00) è l'aver reso fruibile in lingua italiana
le peculiarità, contenute in documenti conservati in
archivi statunitensi, sulle quali Avrich ha potuto compiere
le proprie ricerche. Di conseguenza dobbiamo ringraziare Toni
Senta per la corretta traduzione e per la prefazione all'edizione
italiana nella quale possiamo leggere: “Con questa traduzione,
oltre a rendere un doveroso omaggio alla figura dello storico
newyorkese, colmiamo finalmente una lacuna nella storiografia
di lingua italiana, offrendo al pubblico un tassello, a nostro
avviso fondamentale, per la ricostruzione della storia dell'anarchismo
di lingua italiana.” Il
merito principale di Ribelli in paradiso – Sacco, Vanzetti
e il movimento anarchico negli Stati Uniti, di Paul Avrich
(a cura di Antonio Senta, ed. Nova Delphi, Roma, 2015, pp. 382,
€ 15,00) è l'aver reso fruibile in lingua italiana
le peculiarità, contenute in documenti conservati in
archivi statunitensi, sulle quali Avrich ha potuto compiere
le proprie ricerche. Di conseguenza dobbiamo ringraziare Toni
Senta per la corretta traduzione e per la prefazione all'edizione
italiana nella quale possiamo leggere: “Con questa traduzione,
oltre a rendere un doveroso omaggio alla figura dello storico
newyorkese, colmiamo finalmente una lacuna nella storiografia
di lingua italiana, offrendo al pubblico un tassello, a nostro
avviso fondamentale, per la ricostruzione della storia dell'anarchismo
di lingua italiana.”
Avrich ha qui focalizzato il proprio interesse su una parte
del movimento anarchico, quella “antiorganizzatrice”
che, nel periodo a cavallo della prima guerra mondiale, vide
protagonisti molti militanti di origine italiana migrati negli
Stati Uniti d'America. Quest'ultima precisazione va anteposta
a quella prettamente politica innanzitutto perché questa
analisi storiografica, prima di soffermarsi su scelte e azioni,
sia singole che collettive, è molto rigorosa nel dettagliarne
il contesto: nel tentativo di non dare giudizi, bisogna cercare
di comprendere motivazioni razionali e idealità.
Leggendo aneddoti e ricostruzioni storiche sulle origini italiane,
scopriamo che si partì per bisogno (l'estrema povertà
fu basilare per chi cercò nel Nuovo Mondo una possibilità
di riscatto) ma in alcuni casi, e proprio fra questi troviamo
sia Sacco che Vanzetti, fu decisiva la spinta giovanile verso
l'avventura e il desiderio di indipendenza. Gran parte dei migranti
anarchici conobbero l'ideale di libertà proprio in quella
terra d'oltreoceano che si rivelò deludente sotto molti
aspetti: le scarse opportunità lavorative e d'alloggio
li costringeva a spostamenti continui da una città all'altra
mentre i pregiudizi verso gli stranieri producevano pesanti
discriminazioni, controlli assillanti e totale mancanza di diritti.
La parola freedom, nella dura quotidianità, veniva
trasformata nel suo concetto opposto: diventò indispensabile
farla propria, traducendola in esistenze dignitose e nella volontà
di abbattere ogni privilegio.
Fra le righe dello scorrevole testo di Avrich si scopre quanto
il riferimento alla “libertà” concretizzò
una solidarietà decisiva non soltanto al fine di una
mera sopravvivenza in una terra ostile: instaurare relazioni
soddisfacenti e significative è un'esigenza primaria
ma, affinché possa essere condivisa come un valore imprescindibile,
bisogna che nasca da stimoli maturati culturalmente.
Scrive Avrich: “Erano tutti giovani orgogliosi della propria
ostinazione e audacia, devoti all'azione diretta senza compromessi,
tanto per temperamento quanto per convinzione. Inoltre avevano
tutti origini contadine, nati e cresciuti in piccoli paesi e
villaggi. Dei contadini conservavano la tenacia, una profonda
mancanza di fiducia nel governo (la legge lavora contro il popolo,
dice il proverbio), la cieca lealtà alla comunità
e al gruppo, il rifiuto del potere e del privilegio, il desiderio
di vendetta contro gli oppressori.”
Ecco che la comunità degli anarchici sperimentò
forme di condivisione quali “i picnic”, le colonie,
le rappresentazioni teatrali dalle quali sorse spontanea la
solidarietà umana e politica verso chi fosse vittima
di soprusi da parte del potere; ecco che il tema della suddivisione
fra “galleanisti” e “antigalleanisti”
fu sicuramente presente nel dibattito militante, ma nella realtà
produsse meno conflitti relazionali di quanto oggi tenderemmo
a valutare.
Certamente la “propaganda del fatto” segnò
l'anarchismo e il giudizio superficiale che la storia ha cementificato
su di esso; i pareri contrastanti su Luigi Galleani, su altri
(e altre!) militanti, sulla rivista Cronaca sovversiva
e numerose altre pubblicazioni, sull'opportunità di alcune
scelte e sulla speculazione che la polizia statunitense riuscì
a edificare, su infiltrazioni e ambigue frequentazioni, sulla
differente interpretazione di concetti come “coerenza”
o “verità”... argomenti sui quali sarebbe
scorretto calare il sipario.
Il libro di Avrich toglie a Sacco e a Vanzetti quell'alone mitico
che li aveva dipinti “innocenti sognatori”, ma comunque
la “verità” giudiziaria ha, paradossalmente,
evidenziato la gigantesca montatura che li portò ad essere
assassinati per mano dello stato. Se sono diventati simbolo
dell'ingiustizia istituzionale lo si deve alla solidarietà
di un movimento antagonista che seppe superare le dicotomie
ideologiche; si capì che lo stato dovette pianificare
il caso eclatante per giustificare una repressione di ben più
alta portata.
I primi provvedimenti legislativi approvati allo scopo di colpire
gli stranieri riluttanti all'omologazione, prevista per chi
venisse accolto nel Nuovo Mondo, suscitarono polemiche e applicazioni
non del tutto condivise dalla stratificazione istituzionale
americana. Già dal 1918 si tentò di espellere
gli ospiti indesiderati, ma evidentemente servirono leggi più
definitive affinché si eliminassero polemiche su “presunti
abusi” o “violazioni dei diritti costituzionali”.
Vinse la strategia di quanti si fecero scudo della “sicurezza
nazionale” per imporre sospetti, arresti, infiltrazioni,
deportazioni: un clima di ostilità che peggiorò
ulteriormente la considerazione per ogni persona straniera nella
“terra della libertà” per antonomasia. Evidentemente
una libertà che non avrebbe dovuto coincidere con le
istanze sociali abbracciate da operai in grado di scioperare
e attuare il mutuo appoggio... e questa fu la “terribile
minaccia” dalla quale i governi decisero di “liberarsi”!
La repressione nelle piazze fu giudicata insufficiente per eliminare
le istanze di giustizia sociale. Vanzetti e Sacco, accusati
di rapina e omicidio, conobbero il carcere per sette anni, prima
di morire sulla sedia elettrica nel 1927. Si tentò così
di uccidere anche le loro idee.
Il testo di Avrich ritrae le differenti origini e motivazioni
a lasciare la terra natia; l'indole e il diverso approccio nel
concepire la propria esistenza; l'avvicinamento agli ideali
libertari; la militanza che li fece conoscere e li portò
a condividere alcune scelte, non ultima quella di andare in
Messico per evitare l'arruolamento quando gli USA decisero di
entrare in guerra. A giudizio di alcuni storici la repressione,
scatenatasi contro chi si oppose alla guerra e alla coscrizione
obbligatoria, segnò un salto di qualità sul concetto
stesso di militanza.
Il merito di questo libro è di aver analizzato la corposa
produzione editoriale dell'epoca insieme a episodi e protagonisti,
ricordi e dettagli raccontati da singole soggettività,
memorie e testimonianze: l'insieme di una resistenza quotidiana
che si sviluppò nonostante la carenza di supporti logistici
e strumentali.
Chiara Gazzola
Catalogna/
L'altra memoria di un'Italia criminale
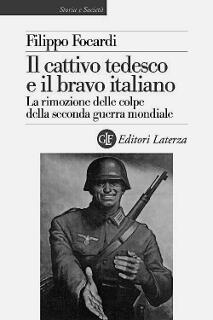 In
un'epoca in cui la storia tende ad essere presa in considerazione
solo quando si tratta di anniversari o commemorazioni, è
bene soffermarsi a pensare quale storia ci fanno ricordare. In
un'epoca in cui la storia tende ad essere presa in considerazione
solo quando si tratta di anniversari o commemorazioni, è
bene soffermarsi a pensare quale storia ci fanno ricordare.
Sul tema della costruzione di un immaginario collettivo è
recentemente uscito un libro di Filippo Focardi Il cattivo
tedesco e il bravo italiano. La rimozione delle colpe della
seconda guerra mondiale (Edizioni Laterza, Roma, 2014, pp.
308, € 24,00).
Il discorso di Focardi si centra sugli stereotipi che un popolo
crea di sè stesso ed in particolare su quelli creati
dopo la Seconda Guerra Mondiale. Fa riferimento alle tesi dello
storico Tony Judt, che parla di memoria comune della seconda
guerra mondiale nei paesi che hanno subito l'aggressione tedesca,
basata su: la creazione del mito della Resistenza; l'attribuzione
solo alla Germania dei crimini di guerra.
Questo non per sminuire la Resistenza, ma per evidenziare come
in ogni paese ci sono stati gruppi collaboratori che si ricordano
molto meno. In Italia in particolare parlare di collaborazione
con il regime nazista è quasi un eufemismo, dato che
il modello dello stato fascista nasce proprio qui, con la relativa
aggressività/bellicismo intrinseca/o. Quella che portó
avanti l'Italia fu una guerra con obiettivi propri che aspirava
a un nuovo ordine europeo e non semplicemente una collaborazione;
gli esempi chiari possono essere i 70.000 uomini inviati in
Spagna durante la guerra civile (chiamati volontari!), e l'occupazione
di Grecia, Slovenia e Croazia, tutti luoghi dove sono stati
perpetrati crimini di guerra.
Oltre al cattivo tedesco e al mito della Resistenza troviamo
un modello autoassolutorio dell'italiano che non voleva la guerra
contrapponendo lo straniero invasore e sadico all'italiano fondamentalmente
contro la guerra, difensore degli oppressi e intriso di umana
pietas (contro la furor teutonica).
Focardi sostiene che gli stereotipi vengono istituzionalizzati
tra il '43 e il '47 ovvero tra la firma dell'armistizio dell'8
settembre 1943 e la firma del trattato di pace del 10 febbraio
1947 con cui l'Italia perde l'Istria e paga danni a Grecia e
ad altri paesi.
Tanti soggetti convergenti hanno lavorato a quest'immagine,
ma soprattutto la propaganda alleata.
Ad esempio cita il peso della famosissima Radio Londra, utilizzata
per far crollare il fronte interno italiano (dove si era individuato
l'anello debole della catena) togliendo il consenso alla guerra.
La propaganda insisteva sul fatto che gli italiani non volevano
una guerra con un falso alleato che aveva altri obiettivi, dipingendo
i tedeschi come barbari che prima o poi avrebbero girato la
faccia.
Monarchia e forze antifasciste fino ad un certo punto remano
nella stessa direzione affinchè gli italiani prendano
le armi contro i tedeschi; il governo Badoglio, (generale che
aveva guidato l'aggressione in Etiopia con l'esercito di Mussolini)
dopo un veloce cambio di bandiera riutilizzerá gli slogans
di Radio Londra per non ricevere il castigo delle potenze vincitrici,
annunciato come minimo se si combattono i tedeschi. Da qui l'impulso
alla glorificazione della Resistenza.
In questo contesto di evidente costruzione di un immaginario
collettivo si situa la rivendicazione dell'associazione Altraitalia
a Barcellona, affinchè lo stato italiano ammetta i bombardamenti
portati a termine a Barcellona nel 1937 e perchè vengano
riconosciuti come crimini di guerra.
Della massima strage di popolazione civile, tramite l'aeronautica
militare, avvenuta in Europa nel periodo tra le due guerre mondiali
aveva già parlato su queste colonne Claudio Venza (“Barcellona
martellata” in “A” 381, giugno 2013); poi
la denuncia è stata presentata all'Audiencia Nacional
(tribunale politico eredità del franchismo) da Altraitalia
con la firma di due persone che hanno vissuto in prima persona
i bombardamenti. Nonostante la lentezza del processo burocratico
e i rimpalli da un organismo all'altro che negano l'argomento
sia di loro competenza, si tratta del primo caso in cui si portano
in tribunale dei crimini della guerra civile spagnola, cosa
che ha permesso una grande ripercussione mediatica. La proposta
di Altramemoria è che per le vittime non è
mai tardi almeno riconoscere i crimini commessi e soprattutto
per la creazione di una memoria condivisa.
Valeria Giacomoni
Contro
la servitù volontaria
 Né
dio né stato, né servi e padroni... così
dicevamo un tempo, ma oggi che l'unico dio è il consumo,
lo stato è ormai un fantoccio e i padroni, il
potere, sono diventati un'entità pervasiva, ma indistinta,
lontana e inafferrabile rimangono, paradossalmente, solo i servi? Né
dio né stato, né servi e padroni... così
dicevamo un tempo, ma oggi che l'unico dio è il consumo,
lo stato è ormai un fantoccio e i padroni, il
potere, sono diventati un'entità pervasiva, ma indistinta,
lontana e inafferrabile rimangono, paradossalmente, solo i servi?
Quel né servi del famoso detto è in effetti
un invito meno indagato e meno praticato, forse perché
spesso inteso come naturale conseguenza del né padroni.
Niente padroni niente servi. Sembra un equazione, quasi una
tautologia, ma non è affatto così: abbattere i
padroni non è lo stesso che divenire uomini e donne liberi.
Abbattere il padrone ha significato troppo spesso cambiarlo
con un altro padrone, sostituire un potere vecchio con un nuovo
potere. Tante volte così è stato nella storia,
da quella più antica ai giorni nostri, che viene un dubbio:
ma gli uomini vogliono o non vogliono essere liberi? Vogliono
o no un padrone?
Questo il dilemma: se gli uomini vogliono la libertà,
perché c'è il potere? E se gli uomini vogliono
il potere, perché anelano alla liberta? È una
domanda cruciale, perché solo la libertà individuale
sarebbe inattaccabile da quel potere oscuro e multiforme, svuotandolo
e annullandolo.
Gustavo Zagrebelsky, in un recente saggio, ha definito quel
dilemma l'enigma del potere.
Liberi servi. Il Grande Inquisitore e l'enigma del potere
(Einaudi, Torino, 2015, pp. 298, € 30,00) è un testo
intrigante, complesso ed antinomico, scritto da uno spirito
aperto e profondo, che non teme di addentrarsi nei sotterranei
della mente umana e delle sue contraddizioni.
Il titolo si riferisce a Il Grande Inquisitore, un capitolo
centrale de I Fratelli Karamazov, l'ultimo romanzo di
Fëdor Dostoievskij, pubblicato nel 1879, capitolo noto
anche come La leggenda del Grande Inquisitore. La leggenda
è un testo magnifico, poche pagine di profondità
abissale, per molti il vertice della produzione letteraria del
romanziere e pensatore russo.
La leggenda è ambientata nella Siviglia cinquecentesca,
nella Spagna dell'Inquisizione, all'indomani di un immenso rogo
ove più di cento eretici sono stati bruciati, di fronte
al re e alla sua corte, tra la folla esultante. Improvvisamente,
nella piazza antistante la Cattedrale, brulicante di uomini
e donne, appare il Cristo, dopo quindici secoli tornato sulla
terra, che è subito riconosciuto dal popolo che lo circonda
e si prostra in festosa adorazione. La stessa folla ammutolisce
però e tace quando, poco dopo, il Cristo viene fatto
arrestare per ordine del Cardinale Grande Inquisitore un vecchio
di quasi novant'anni, alto e diritto, dal viso scarno, che da
lontano ha assistito alla scena. La folla, come un solo uomo,
si inchina davanti al Cardinale, che la benedice con un gesto
e passa oltre. Il prigioniero viene condotto dalle guardie nei
sotterranei della Cattedrale e rinchiuso nella cella più
profonda e buia.
Quella stessa notte il Grande Inquisitore si reca, da solo,
con una lanterna in mano, nell'oscura prigione, per comunicare
al prigioniero la condanna al rogo, decisa per il mattino seguente,
ma non solo questo. Alla luce fioca della lanterna, dopo un
lungo silenzio, l'Inquisitore comincia a parlare, mentre il
Cristo lo fissa attento. L'inquisitore parla a lungo, nel silenzio
della cripta. Nessuno deve assistere a quell'incontro, è
un incontro tra due esseri che hanno accesso alle cose ultime,
segrete e forse oscene, per questo avviene di notte tra le mura
di una cella nei sotterranei della cattedrale di Siviglia. È
solo qui, in un luogo celato agli occhi del mondo, che l'Inquisitore
può non mentire e tratta il Cristo non come l'eretico
da mandare al rogo, ma come l'unico suo pari, il solo all'altezza
di un confronto, quasi il suo confessore.
L'Inquisitore accusa il Cristo di essere per gli uomini fonte
di dolore e sofferenza, causa i suoi insegnamenti sulle libertà
interiori e afferma che gli uomini, contrariamente a quanto
crede il Cristo, non anelano alla libertà, ma alla sottomissione,
che toglie loro l'angoscia di essere padroni del loro destino,
di essere consapevoli di ciò che li circonda, di dover
compiere delle scelte. La libertà, nelle parole del Cardinale,
è la massima causa di inquietudine per l'uomo, l'obbedienza
e la sottomissione, liberano da questa inquietudine, questa
la ragione del loro volontario e benefico trasferimento ad una
autorità superiore, sovrana.
L'Inquisitore vanta il merito di aver assunto su di sé
l'onere di quella libertà che gli uomini temono: Noi
li convinceremo che soltanto allora diverranno liberi: quando
rinunceranno alla loro libertà per noi e a noi si sottometteranno.
E ancora: Sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono
più che mai convinti di essere perfettamente liberi,
e tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà,
e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati
noi ad ottenerlo. Ove il “noi” si riferisce
alla Chiesa Cattolica e alle sue alte gerarchie.
L'Inquisitore è anche il vero difensore dei deboli, giacché:
...a noi sono cari anche i deboli. Essi sono viziosi e ribelli,
ma finiranno per diventar docili. Essi ci ammireranno e ci terranno
in conto di dei per avere acconsentito, mettendoci alla loro
testa, ad assumerci il carico di quella libertà che li
aveva sbigottiti e a dominare su loro, tanta paura avranno infine
di esser liberi!
E ancora l'accusa al Cristo: Invece di impadronirti della
libertà degli uomini. Tu l'hai ancora accresciuta!
L'Inquisitore continua così a lungo, e aggiunge infine:
domani stesso io Ti condannerò e Ti farò ardere
sul rogo, come il peggiore degli eretici, e quello stesso popolo
che oggi baciava i Tuoi piedi si slancerà domani, a un
mio cenno, ad attizzare il Tuo rogo, lo sai? Sì, forse
Tu lo sai, dice ancora, profondamente pensoso, senza staccare
lo sguardo dal suo Prigioniero.
Per tutta risposta, il Cristo non parla, lo sguardo è
penetrante, ma rimane muto, sembra non voler obiettare nulla.
Poi si avvicina lentamente, continuando a fissare quegli occhi
incavati e sfiora con un bacio le labbra secche e grinzose del
vecchio. L'inquisitore rimane immobile, stupito. Dopo un lungo
silenzio, apre una porta della cella che porta all'esterno e
dice al Cristo: Vattene e non venir più... non venire
mai più... mai più! Il Prigioniero si allontana.
Così termina la leggenda.
Nella metafora il Grande Inquisitore rappresenta il potere,
il male assoluto, nelle vesti del potere ecclesiastico che si
è impadronito nei secoli dell'insegnamento del Cristo:
la libertà, il bene massimo.
Alle esternazioni dell'inquisitore, il prigioniero oppone silenzio.
Il silenzio come risposta: cosa può significare? Il dilemma
che si pone tra il Cristo e l'Inquisitore non ha una soluzione,
non ha una risposta. Nella leggenda, come spesso accade, la
forza sta nelle domande, non nelle risposte. Tu mi guardi
con dolcezza e non mi degni neppure del tuo risentimento
dice il Cardinale, ma alla fine lascia andare il suo prigioniero,
rinuncia a mandarlo al rogo, gli chiede solo di non venire
mai più. Forse il Grande Inquisitore ha capito che
il suo potere ha bisogno della libertà, perché
è solo sulla libertà che il suo potere si esercita
e senza quella non può esservi questo.
Ma allora, verrebbe da dire, se la libertà è il
presupposto del potere, è vero anche il contrario? La
libertà ha bisogno del potere per inverarsi? E senza
potere non vi può allora essere libertà?
Il lieve bacio del Cristo, l'unica sua risposta, significa forse
che solo attraverso l'amore la libertà può fare
a meno del potere?
Nel libro, la leggenda è il filo conduttore per
profonde riflessioni sull'enigma del conflitto fra potere
e libertà, sulla natura ultima di questo e di quella
e su tutto ciò che vi si collega e ne discende. Un argomento
le cui implicazioni sono, a parere di chi scrive, il cuore stesso
dell'anarchismo.
Dopo il lungo percorso nei meandri dell'enigma, l'autore
tocca da ultimo il tempo nostro e quel sistema di dominio indistinto
e totalizzante, tale che: l'Inquisitore non avrebbe potuto
immaginare di meglio, nel suo proposito di assoggettamento delle
menti e delle coscienze. Le mille forme di quel dominio
sono sintetizzate in una parola: “frastuono”, un
rumore di fondo, un qualcosa che sempre ci avvolge e stordisce,
tanto da aver generato in molti una sorta di “horror vacui”
sonoro e visivo, una insofferenza per il vuoto e per il silenzio,
che deve essere riempito continuamente con cose, aggeggi, oggetti,
musica quale che sia, rumori, messaggi, parole far crescere
parole con e su altre parole, non importa se volte non a
chiarire ma a stravolgere i significati: le parole, devono
rispettare il concetto, non lo devono corrompere, [...]
così che la guerra diventi pace, la libertà
schiavitù, l' ignoranza forza.
Contro questo mondo di luci e rumori, evocando il Cristo muto
nell'oscura cella della Cattedrale, viene proposta un altra
parola: silenzio. Al contrario del rumore, il silenzio
è pericoloso, può mettere ciascuno di fronte a
se stesso, può generare introspezione ed essere creativo
e libero, può essere eversivo. Nel silenzio possiamo
ritrovare noi stessi e scegliere se essere servi o essere liberi.
Diversamente dal frastuono, il silenzio non è corrompibile
ne controllabile dal potere, non si vede e non si sente, non
ha parole.
In una breve nota finale, l'autore si dice ben conscio che in
altre parti del mondo il dominio ha ben altri metodi: violenza,
fame, ricatto, povertà... Ma si chiede anche se quella
condizione e il suo perdurare non siano un indotto della vittoria
dell'Inquisitore nel mondo che chiamiamo “sviluppato”.
Su questa rivista, Andrea Papi propone di non combattere frontalmente
il potere, cosa ormai vana, ma di “sottrarvisi”
in collettività autonome, libere e libertarie. Papi ha
ragione, ma prima ancora, ci vorrebbe forse un lungo, lunghissimo
se necessario, minuto di silenzio... per essere certi della
“nostra” libertà.
Una collettività è tale solo se composta di individui
liberi, e diviene un entità politica, un progetto, quando
è in grado di trasmettere il gusto e il valore per scelte
intimamente libere, libere dalle trappole del sistema ma anche
da dogmi politici e rigori ideologici.
Post scriptum. Vorrei dedicare queste parole ad un uomo
libero che ci ha lasciati da poco: Gianni Bertolo, che nel 1966
disegnò materialmente la A cerchiata, ripresa
allora dalla “Gioventù Libertaria” di Milano
e che ispirerà poi il titolo e il simbolo di questa rivista
di cui, dal marzo 1972 al febbraio 1973, fu anche direttore
responsabile.
Enrico Maltini
L'anarchico e il commissario/
Ma quel Pinelli è un contenitore vuoto
 Il
carnevale dei truffati (di Piero Colaprico, regia di Renato
Sarti) è lo spettacolo andato in scena al teatro della
Coperativa di Milano lo scorso giugno e che verrà replicato
a dicembre 2015, su un testo di Piero Colaprico, con la collaborazione
di Renato Sarti, direttore del teatro della Coperativa, in veste
anche di regista e attore. Quest'ultimo impersona Giuseppe Pinelli,
l'anarchico, a cui un dio grottesco, amante dei paradossi, interpretato
in video da Paolo Rossi, che con la sua interpretazione surreale
strappa facili risate, impone di camminare per l'eternità
a fianco del commissario Luigi Calabresi, Gigi, a cui dà
sembianze un Bebo Storti che lo rende un romano simpatico e
gigione. In un contesto in cui il “coro delle voci morte”
accomuna tutte le vittime di quegli anni in un unico lamento
(da Fausto e Iaio a Ramelli, dall'agente Annarumma alle vittime
delle stragi, Tobagi e il giudice Galli), il brillante commissario
e l'anarchico depresso che gli fa da spalla, vengono rimandati
sulla terra da dio e vi rimarranno 8 giorni ripercorrendo, sfogliando
e leggendo giornali, gli ultimi 45 anni della nostra storia
e trovando in Berlusconi, chiamato Plasticoni, e nelle sue olgettine,
motivo di sconforto tale da voler tornare nel limbo da cui provengono
rimpiangendo i “bei tempi” in cui c'erano degli
ideali. Rimane l'ulteriore perplessità che si scandalizzino
per il linguaggio scurrile e per delle donne nude e non per
le bombe o le stragi o le ecatombi di migranti. Diciamo che
l'argomento non sembra dei più attuali pur comprendendo
come sia stato importante per l'autore. Il
carnevale dei truffati (di Piero Colaprico, regia di Renato
Sarti) è lo spettacolo andato in scena al teatro della
Coperativa di Milano lo scorso giugno e che verrà replicato
a dicembre 2015, su un testo di Piero Colaprico, con la collaborazione
di Renato Sarti, direttore del teatro della Coperativa, in veste
anche di regista e attore. Quest'ultimo impersona Giuseppe Pinelli,
l'anarchico, a cui un dio grottesco, amante dei paradossi, interpretato
in video da Paolo Rossi, che con la sua interpretazione surreale
strappa facili risate, impone di camminare per l'eternità
a fianco del commissario Luigi Calabresi, Gigi, a cui dà
sembianze un Bebo Storti che lo rende un romano simpatico e
gigione. In un contesto in cui il “coro delle voci morte”
accomuna tutte le vittime di quegli anni in un unico lamento
(da Fausto e Iaio a Ramelli, dall'agente Annarumma alle vittime
delle stragi, Tobagi e il giudice Galli), il brillante commissario
e l'anarchico depresso che gli fa da spalla, vengono rimandati
sulla terra da dio e vi rimarranno 8 giorni ripercorrendo, sfogliando
e leggendo giornali, gli ultimi 45 anni della nostra storia
e trovando in Berlusconi, chiamato Plasticoni, e nelle sue olgettine,
motivo di sconforto tale da voler tornare nel limbo da cui provengono
rimpiangendo i “bei tempi” in cui c'erano degli
ideali. Rimane l'ulteriore perplessità che si scandalizzino
per il linguaggio scurrile e per delle donne nude e non per
le bombe o le stragi o le ecatombi di migranti. Diciamo che
l'argomento non sembra dei più attuali pur comprendendo
come sia stato importante per l'autore.
È uno spettacolo che vede modifiche in corso d'opera,
da una prima pesante, per contenuto e messa in scena, una replica
successiva da me vista aveva portato a una recitazione più
convinta e a tagli nel testo che lo rendevano meno greve.
Resta il dubbio su che cosa esattamente dovrebbe essere questa
rappresentazione che risulta sospesa tra il serio e il faceto
senza che una delle due tendenze riesca a prevalere in maniera
significativa dando spessore. Si è fatta una scelta,
quella di mettere insieme come voci narranti due persone nella
realtà contrapposte e che nello spettacolo mostrano una
irritante complicità quasi goliardica che forse è
quella che gli attori hanno nella vita, non quella dei protagonisti
presi a pretesto, uno sicuramente vittima innocente, l'altro
anche lui vittima, ma sulla cui innocenza c'è molto da
discutere.
Perplessità anche sul perché si è voluto
prendere Pinelli per renderlo un contenitore vuoto di propri
contenuti e riempito di pensieri e parole altrui, in un azzardato
accostamento che abbiamo già visto e che sempre stride
con una realtà che è ancora una ferita aperta
nella vita di molte persone.
L'idea di fondo, trattata in maniera più coraggiosa,
poteva essere valida, rimane la sensazione di superficialità
con cui vengono affrontati questi temi e che una simile operazione
alle persone più giovani non insegni nulla, ma che porti,
ancora una volta, a mettere insieme tutto e tutti in un calderone,
una “memoria condivisa” molto discutibile che suscita
ancora più dubbi venendo da persone che tanto hanno dato
e continuano a dare per il rispetto della storia e della verità.
Claudia Pinelli
Jasmina: apolide,
esule, clandestina
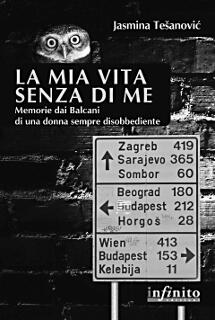 “Credo
che il mio successo dipenda dalle circostanze, mentre considero
normali i miei fallimenti. È perchè sono nata
donna”. “Credo
che il mio successo dipenda dalle circostanze, mentre considero
normali i miei fallimenti. È perchè sono nata
donna”.
Niente di più desolante di questa constatazione? Macchè.
La consapevolezza di Jasmina diventa energia, l'energia a sua
volta si trasforma in una vita ribelle e poco incline alle regole;
la vita acquista la bellezza del gioco, che non dipende dal
contesto, dall'età o dalle variabili sociali; la ribellione
diviene a suo modo equilibrio, pensiero libero, ma anche comprensione
e accoglienza, per se stessa e per gli altri. Saggezza, addirittura.
L'autobiografia di Jasmina (Jasmina Tesanovic, La mia vita
senza di me, Infinito edizioni, Formigine - Mo, 2014, pp.
201, € 14,00) non è dato sapere quanto romanzata
(l'autrice dice molte verità, ma quasi tutte sono inventate),
parte da un assunto fondamentale: poiché prima o dopo,
nella vita, chiunque di noi è costretto a fare qualcosa
che proprio non gli va, tanto vale risolvere il problema alla
radice. Perciò, quando opporsi alle situazioni sgradite
diventa inutile o peggio dannoso, l'importante è imparare
ad affrontarle “senza di sé”.
Questa filosofia di vita – geniale e semplice al tempo
stesso – nasce da un piatto di zuppa, che Jasmina ragazzina
non vuole a nessun costo mangiare e che invece i genitori si
ostinano a propinarle; così, per mettere fine a lacrime
e rimproveri, decide semplicemente che la mangerà, ma
lo farà “come se non fosse lei a mangiarla”.
Lo stratagemma le tornerà più volte utile nella
vita, in situazioni ben più complesse di una zuppa sgradita.
Jasmina attraversa il comunismo, la guerra, svariati paesi,
tre matrimoni, la malattia senza mai perdere ritmo e ironia,
e nemmeno la capacità di uscire da sé e fare come
se il problema, la disgrazia, la seccatura, la complicazione
del momento fossero vissute da qualcun altro.
La condizione della donna, il femminile raccontato attraverso
le figure forti della famiglia – la mamma, la nonna –
è certamente un motivo portante del libro; così
come lo sono il comunismo prima e la guerra dopo, con le loro
conseguenze difficili o tragiche che svelano però, tratteggiate
dalla penna di chi scrive, piccoli e insoliti aspetti ironici,
di un efficacissimo umorismo nero.
Nel comunismo di Jasmina i ricchi ostentano la loro povertà,
il maresciallo Tito diventa un quasi-parente, la tomba l'unica
possibile proprietà privata (e poi, volete mettere? un
appartamento è per una vita, ma una tomba è per
sempre).
La guerra – quella che non troppi anni fa ridisegnò
i confini di intere regioni vicino a casa nostra, soffocando
molte vite umane e l'idea che l'Europa fosse un continente maturo
e libero da certe contraddizioni – diventa l'occasione
per sperimentare condizioni estreme, senza perdere la fantasia.
Jasmina non ha nulla da insegnare, forse per questo da lei si
può imparare molto.
Se vi capita di incontrarla di persona, guardatela negli occhi:
sono chiari e profondi come la sua intelligenza, e l'irrequietezza
che vi regna ricorda i paesaggi Balcani.
Apolide esule e clandestina da una vita, al momento ha deciso
di mettere radici. Per farlo ha scelto Torino, perché
– dice lei – in questa città certe volte
c'è una luce straordinaria.
E meno male che c'è Jasmina a farcelo notare.
Claudia Ceretto
Ma Taranto è lontana
(dalla Svizzera)
Taranto è lontana. Lontana dalla Svizzera, lontana anche
dall’angolo più meridionale della Svizzera. E non
solo geograficamente: lontana dalla realtà, lontana dalla
coscienza, dalla solidarietà. Un malaffare altrui che
ci scandalizza, che eventualmente ci coinvolge come giudici,
non come coimputati. Perché mai?
Eppure, almeno per una sera di fine maggio, almeno emotivamente,
siamo stati molto vicini a Taranto. L’occasione è
stata offerta dalla rassegna cinematografica “Di terra
e di cielo. Cinema. Ambiente. Natura. Esplorazione” promossa
dall’associazione “Filmstudio 90” di Varese
ed estesa all’area transfrontaliera grazie alla collaborazione
con l’Associazione cultura popolare di Balerna (Canton
Ticino).
Buongiorno Taranto è il film documentario presentato
e poi discusso con il regista Paolo Pisanelli, presente alla
serata; è una delle trenta proposte della manifestazione
tenutasi tra l’8 maggio e il 18 giugno 2015. Un film delicato,
dedicato ai protagonisti veri di questa tragica vicenda territoriale,
economica, sociale, ambientale, sanitaria: uomini e donne, bambini,
ragazzi, anziani che a Taranto vivono, che lì devono
vivere, o che lì avrebbero voluto vivere.
|
| Taranto - Il pirata sulla strada dell'Ilva |
Delicato perché l’occhio della telecamera si
è appostato con discrezione ad osservare e a farsi raccontare
la quotidianità di una terra martoriata e in continuo
martirio. “Di che morte volete morire? Di fame o di cancro?”.
Suona così il cinico e inaccettabile dilemma che i politici
continuano a porre ai tarantini. Senza vergogna, anzi, quasi
atteggiandosi a salvatori che a colpi di “decreti salva
Ilva” annientano le norme ambientali e sanitarie a tutela
della popolazione con la giustificazione di dover salvare oltre
diecimila posti di lavoro. “Non vi lasceremo morire di
fame…”.
|
| Taranto - Il tuffo nel Mar Piccolo |
Delicato perché racconta la tragedia senza morbosità,
rispettando il dolore, l’intimità che richiede,
senza negargli la solidarietà, senza rinunciare a denunciare
chi fugge dalle sue responsabilità.
Delicato perché mette in luce anche le numerose iniziative
dei cittadini che autonomamente, senza più nemmeno dialogare
con un’amministrazione priva di potere reale, cercano
di riappropriarsi del loro territorio, delle loro coscienze,
delle loro capacità di dialogare, ribellarsi al ricatto,
alla rassegnazione, di lottare per un bene comune: la loro terra,
la loro Taranto. Davanti all’enormità dei problemi,
questo risveglio ha il sapore dell’eroismo: “Buongiorno
Taranto” non è solo un fi lm indipendente, è
un progetto per un nuovo giorno ma… il respiro dev’essere
davvero molto lungo.
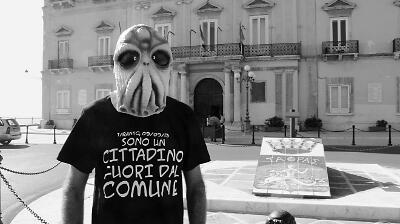
Noi ricchi, noi settentrionali, noi imprenditori, noi che
abbiamo avuto la fortuna (finora!) di poter esportare le nostre
pattumiere e le attività con maggiore impatto ambientale,
di fronte a queste tragedie non possiamo nasconderci.
Saremo sempre coimputati perché beneficiari e dunque
complici e corresponsabili di un modello malato. Taranto non
è poi così lontana.
Paola Pronini
|
“Buongiorno
Taranto” un film di Paolo Pisanelli realizzato
insieme agli abitanti della città più avvelenata
d'Europa con la partecipazione di Michele Riondino / Big
Sur Cinema, 2014 - Durata 85'40” / www.buongiornotaranto.it
Buongiorno Taranto è una produzione dal basso fondata
sul crowd founding. Per sostenere, promuovere, proporre,
condividere scrivi a: info@buongiornotaranto.it.
|
|