|
elezioni
Il voto, il vuoto
di Maria Matteo e di Antonio Cardella / foto AFA - Archivi
Fotografici Autogestiti
Scritti a caldo all'indomani delle elezioni politiche di fine febbraio, questi
due interventi invitano a riflettere sulle numerose novità emerse. Invero,
non particolarmente entusiasmanti. Anzi, a ben vedere....
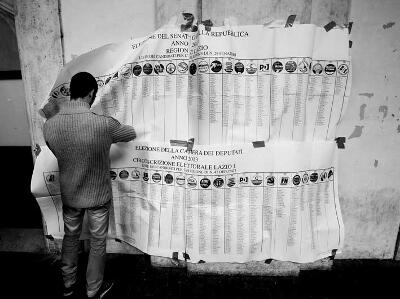
Il Grillo, il satiro e l'uomo in grigio
di Maria Matteo
Tentare una sorta di genealogia dello tsunami
è un esercizio necessario a comprendere cosa stia avvenendo
nel nostro paese, al di là della declinazione assunta
dal partito a cinque stelle nell'arena della politica istituzionale.
Il risultato emerso dalle urne
è stato un vero terremoto elettorale, il primo dal lontano
1994, quando la discesa in campo di Berlusconi, sotto l'insegna
politico-calcistica di Forza Italia, decretò la nascita
della seconda Repubblica. La legge elettorale che i maggiori
partiti non hanno voluto cambiare è stata per loro un
boomerang.
Il gioco del primo arrivato funziona solo con un maggioritario
secco su base nazionale, altrimenti il rischio che al Senato
non vi sia maggioranza, specie in presenza di un terzo polo,
è molto forte.
Quando leggerete queste note forse i giochi saranno fatti. Sapremo
se e come il Movimento 5 stelle ha accettato alleanze politiche,
o sarà nato l'ennesimo governo di “unità
nazionale” in vista di un'ulteriore tornata elettorale.
Tentare una sorta di genealogia dello tsunami è un esercizio
necessario a comprendere cosa stia avvenendo nel nostro paese,
al di là della declinazione assunta dal partito a cinque
stelle nell'arena della politica istituzionale. Proviamo a scomporre
il quadro. Cominciamo dalla sconfitta di Ingroia. Secca, senza
appello, rovinosa. La compagine affidata alla guida di un ex
giudice per meglio solleticare i pruriti giustizialisti della
sinistra, è rimasta invischiata nell'ennesima tentazione
al “realismo” che affligge la diaspora post comunista
e ne ha decretato la fine come formazione parlamentare sin dal
2008. Nata con l'ambizione sin troppo evidente di contendere
a Grillo le simpatie dei movimenti, costruendo un “soggetto
politico nuovo”, Rivoluzione civile non ha saputo sviluppare
un'ispirazione cittadinista in fondo estranea ai propri azionisti
di maggioranza, riducendosi al cartello degli sfigati che si
mettono insieme per fare il quorum.
Ingroia non ha recuperato i crediti persi da Rifonda, PdCI e
Verdi (più l'impresentabile Di Pietro) dopo l'avventura
di governo.
Leggere la sconfitta di Ingroia nella mera chiave del “tradimento”
sarebbe però riduttivo. Ingroia perde perché lo
spazio simbolico e reale che tenta di occupare è ormai
vuoto da tempo.
La materialità delle relazioni sociali è profondamente
mutata. La violenza della divaricazione di classe si è
fatta più netta, senza tuttavia innescare una stagione
di scontro sociale. I partiti conservatori hanno messo in campo
negli ultimi trent'anni un complesso meccanismo di scomposizione
sociale i cui effetti sono stati forti sia nella concretezza
della condizione lavorativa che nella sua rappresentazione simbolica.
Oggi il popolo delle partite Iva, dei precari, di chi lavora
senza tutele né garanzie è sempre più vasto.
La solitudine è il segno distintivo dello sfruttamento
nel secondo decennio del secolo.
L'operaio Fiat, lo scaricatore di porto, il bracciante agricolo
erano inscritti in un percorso collettivo, determinato dal comune
spazio di lavoro – e lotta – e da un identico quadro
normativo. Tutto questo oggi si declina in buona parte al passato.
Tra partite Iva e precari a vita si è modificata la costituzione
materiale delle classi subalterne, demolendone al contempo i
processi identitari.
Un padroncino che fa trasporti per conto della Fiat, non pensa
a se stesso allo stesso modo dell'addetto della logistica alle
dipendenze dall'azienda. La sua condizione di vita è
peggiore ma diversa.
Non ha nessuna delle tutele dei dipendenti, ma nemmeno i vantaggi
del piccolo imprenditore. Né carne né pesce, si
trova in un limbo dove la riproposizione della prospettiva welfarista
classica gli appare di assoluta inattualità. Inattingibile
e nel contempo estranea alla sua vita. Oberato dalle tasse,
spesso senza né lavoro né reddito, vuole meno
tasse e qualche copertura quando resta a terra. Questi soggetti
dispersi sono davvero al di là della destra e della sinistra,
in un altrove che il populismo grillino è riuscito a
catturare, mescolando istanze ultraliberiste con l'ultrastatalismo
del reddito di cittadinanza.
Estranei alle piazze fisiche si sono esercitati alla partecipazione
nella piazza virtuale di internet. Sebbene Grillo abbia celebrato
la propria apoteosi nel luogo simbolo dei grandi raduni della
sinistra romana, le piazze grilline sono nel grande magma del
web, dove ti colleghi dall'ufficio, dal bar dove fai pausa,
dai giardinetti dove bivacchi in attesa di domani, dal letto
prima di crollare addormentato. Se non hai tempo per un post
fai un tweet ed esisti. Ci sei anche tu. Ti riconosci nel faccione
debordante, nell'urlo del comico, nel suo ghigno moralista,
forcaiolo. Sei tu, quello è il tuo volto.
Forse la vittoria di Grillo è tutta qui, nella capacità
di intercettare il malessere di soggetti sociali che debordano
dal quadro novecentesco. L'affermazione/boutade sui sindacati
non gli allontana simpatie, perché questi costosi patronati
sono avvertiti, non a torto, come parte dell'odiatissima casta,
dei privilegiati, dei politici e sindacalisti di professione.
La memoria della lotta di classe non è il tuo presente
e nemmeno il futuro dei tuoi figli, già ipotecato da
una classe politica che modella se stessa ai ritmi della transazioni
finanziarie. Oggi, subito, domani non importa.
| 
|
Beppe
Grillo |
Lo spettacolo della politica e la politica
spettacolo
Il vincitore morale di questa partita elettorale non è
tuttavia Grillo, ma Berlusconi. Quando si dimise, poco più
di un anno fa, diversi editorialisti scrissero che era finita
un'epoca, che il berlusconismo era morto. Un anno dopo il Cavaliere
dei mille frizzi, lazzi, gag è risorto dalle sue ceneri,
si è tenuto la Lombardia dei mille scandali, ha ingoiato
la Puglia, rimasticato la Sicilia. L'Italia del cavaliere è
più viva che mai.
A tanti anni da tangentopoli, quando gli ingenui pensarono che
le inchieste del pool di “mani pulite” avrebbero
creato la via giudiziaria al rinnovamento morale, sappiamo che
quelle inchieste furono lo strumento per esodare in fretta e
furia un blocco politico che, caduto il muro di Berlino, aveva
perso ogni ragion d'essere. Il novecento era finito, i partiti
novecenteschi, fatti di grandi apparati, di amici/compagni/camerati,
di strutture pesanti e idee che plasmavano di sé il mondo
non servivano più. La nuova Italia era stata svezzata
ed era pronta a fare il salto nell'era del just in time,
delle televendite, della libertà fatta di tette/culi,
della vita quotidiana sparata in tv, dei sogni confezionati
da specialisti dell'immagine e consumati in un minuto. Volgare,
grezzo, ma vitale, Berlusconi inaugurò un nuovo stile
politico. Il corpo, negato, ingessato, smaterializzato, dimenticato
fa irruzione nella scena politica mutandola di segno.
Nella concretezza dello scontro di classe l'era berlusconiana
si lascia alle spalle la questione della mediazione politica
tra le “parti sociali”.
La socialdemocrazia ha un costo che i padroni, se possono, evitano
di pagare passando all'attacco. Berlusconi non ha regnato ininterrottamente,
perché una legislatura e mezza se l'è fatta anche
il centro-sinistra. Peccato che i più non si siano accorti
della differenza, al di là dei circoli ristretti dove
si spartiscono nomine e benefici.
Berlusconi viene obbligato ad abdicare perché il mantenimento
del blocco sociale che lo sostiene non consente la rapida attuazione
di politiche di contenimento del debito pubblico che, oltre
a colpire i salariati, stringano in una morsa anche la parte
bassa del ceto medio. Berlusconi non poteva permettersi di reintrodurre
la tassa sulla casa o di toccare ancora le pensioni. Monti,
l'uomo delle banche, invece sì. Il Partito democratico
si accoda nella speranza di poter andare al governo, facendo
fare ad altri il lavoro sporco.
Così si gioca una vittoria elettorale sicura.
Mario Monti ha provato a scavarsi un proprio ambito di potere
per fungere da ago della bilancia, ma non c'è riuscito.
In compenso ha ampiamente cannibalizzato Udc e Futuro e libertà:
Casini ne è uscito malconcio, Fini ne è uscito
e basta.
Monti, come Bersani, Ingroia e, in parte, anche Maroni, sono
comunque irretiti dalla tela di ragno di una strategia di marketing
politico che ha bisogno del corpo dei leader per poter incarnare
i sogni e le favole che vende. Serve una faccia, un corpo, che
riempia di sé la scena vuota di un agire politico che
si riproduce eguale da una legislatura all'altra.
Bersani perde perché la sua aria da apparatnik su fondo
grigio ha sapore ingessato, anonimo, freddo, duro e insapore
come la polenta della sera prima.
È il trionfo del berlusconismo, dello spettacolo che
si fa politica.
Chi poteva interpretare meglio questa parte di un attore? Grillo
è capace di riempire la scena saturandola di sé,
facendone un tutt'uno con se stesso. Il suo faccione deborda,
il suo grido esplode in faccia a chi guarda. Grillo è
come la minestra della nonna, sapore di autentico nel tempo
dove la distanza tra il vero e il falso è nel marchio
che ne decreta il prezzo.
Guida spirituale, guru, caudillo, Grillo “ha sempre ragione”,
come un padre amorevole che consiglia, incoraggia, sorregge,
protegge i suoi figli. Finché obbediscono. Poi sono sberle,
e, nei casi estremi, la cacciata dalla famiglia.
Grillo è l'apoteosi della politica post ideologica: mette
insieme illusione partecipativa e il dirigismo più esasperato,
corteggia i movimenti localisti e fa dichiarazioni razziste,
vuole moralizzare la politica, tagliando stipendi e privilegi,
ma gioca il proprio ruolo di garante per decidere, senza confronto
alcuno, la linea politica del “suo” movimento.
In campagna elettorale le piazze si sono riempite di spettatori,
che andavano via appena prendevano la parola i candidati, meri
fantocci all'ombra del conducator.
Oggi questi fantocci sono in parlamento, regalando a tanti l'illusione
di esserci anche loro.
Maria Matteo

La grande rincorsa al centro
di Antonio Cardella
Corteggiare la fantomatica area moderata si è
rivelato, ancora una volta, una strategia perdente, che ha consegnato
una buona fetta del Parlamento in mano a due forze politicamente
inerti quanto pericolosamente ingombranti.
Le poltrone, ben sagomate
e assai comode, erano disposte ai due lati del grande camino
appena acceso. Al centro del salone sonnecchiava un pastore
tedesco dallo sguardo inconsuetamente languido e, per completare
l'atmosfera tardo ottocentesca, non mancava la governante che
si apprestava a servire il tè. Cassola si godeva palesemente
l'agio della sua bella casa a Marina di Castagneto, sul litorale
toscano, poco distante da un mare placido, parzialmente occultato
da due filari di alberi che a me parvero dei pini.
Avevamo deciso di incontrarci per scambiare alcune considerazioni
sul fallimento della cultura nel contribuire ad elevare il tono
della politica in Italia e sulle conseguenze che tale fallimento
avrebbe comportato per il futuro del paese.
Gli esiti di quell'incontro confluirono poi in un libro, Conversazione
su una cultura compromessa, pubblicato da “Il Vespro”
nel 1977 e ripubblicato venti anni dopo dalle Edizioni e/o di
Milano.
Perché ricordo adesso i contenuti di quell'incontro?
Perché già da allora, quando le voci accorate
del '68 si erano quasi del tutto disperse e si cominciavano
a percepire i conati astiosi, corruttivi e arroganti del craxismo,
quell'equivoco profondo del centrismo come soluzione praticabile
delle molte inefficienze della società italiana, un centrismo
plasticamente rappresentato dalla confluenza della cultura comunista
e di quella cattolica per la gestione della cosa pubblica; quell'equivoco
– dicevo – aveva iniziato a inquinare i termini
di una contrapposizione che si sarebbe purtroppo composta nella
resa, incondizionata quanto inconfessata, alle ragioni del capitalismo
e della globalizzazione delle ricchezze smisurate e dei poteri
prevalenti.
I contenuti essenziali della campagna elettorale che ha preceduto
le elezioni del 24 e 25 febbraio sono palesi conseguenze di
quella corsa al centro che avrebbe dovuto comporre, in funzione
salvifica, la contrapposizione che divideva il progetto comunista
da quello moderato rappresentato dalla cultura catto-liberale.
Così, sino alla scadenza delle tribune politiche, dalle
agende dei concorrenti alla gestione politica del paese, tra
il delirio delle promesse consapevolmente insostenibili e le
suggestioni populistico-palingenetiche, sono apparse assai labili
le differenze tra i vari schieramenti in campo: ciascuno si
è preoccupato di sbiadire la natura della propria origine
quando non addirittura a ripudiarla. L'immagine d'insieme apparsa
ad un elettorato smarrito e confuso è stata quella di
un coacervo indistinto di politici – di vecchio o nuovo
conio – che sventolava vessilli scoloriti e lanciava alla
luna urla sconnesse.
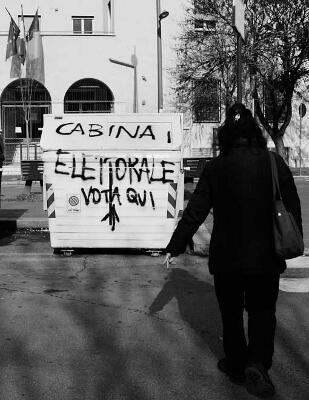 Era
di conseguenza difficile che da questo cianciare indistinto
uscisse dalle urne un quadro politico decifrabile. Di per sé,
l'elettorato italiano è incolto e facilmente suggestionabile,
soprattutto se a blandirlo sono tribuni che vellicano le parti
molli della gente, gli impulsi che partono dalla pancia e si
scaricano sul cervello sollecitando gesti inconsulti. Non si
spiegherebbe altrimenti che un guitto come Berlusconi abbia
potuto calcare il proscenio della vita politica italiana, da
protagonista, per oltre un ventennio e sia ancora lì
a caricare di grottesco le vicende di un popolo che è
immerso sino al collo in una crisi devastante. Era
di conseguenza difficile che da questo cianciare indistinto
uscisse dalle urne un quadro politico decifrabile. Di per sé,
l'elettorato italiano è incolto e facilmente suggestionabile,
soprattutto se a blandirlo sono tribuni che vellicano le parti
molli della gente, gli impulsi che partono dalla pancia e si
scaricano sul cervello sollecitando gesti inconsulti. Non si
spiegherebbe altrimenti che un guitto come Berlusconi abbia
potuto calcare il proscenio della vita politica italiana, da
protagonista, per oltre un ventennio e sia ancora lì
a caricare di grottesco le vicende di un popolo che è
immerso sino al collo in una crisi devastante.
Così, dal confluire del grottesco nel pressappochismo
astioso e cinico di un elettorato che mostra, in misura prevalente,
di non possedere gli strumenti per decifrare correttamente i
dati della realtà, nasce e cresce il fenomeno Grillo:
non a caso un movimento egemonizzato da un comico che si presta
alla politica.
Affaristi reazionari e ribelli velleitari
Grillo rappresenta compiutamente quella consistente massa
di persone che non è mai stata né di destra né
di sinistra, che ha sempre cavalcato una protesta qualunquista,
priva di una visione alternativa dell'esistente e, quindi, semplicisticamente
distruttiva. Nel nuovo Parlamento saranno ingombrantemente rappresentate
due correnti politiche, una affaristico-reazionaria (i relitti
del berlusconismo), l'altra velleitariamente ribellistica, con
venature di razzismo mascherato e di ammiccante fascismo.
Queste due forze costituiranno insieme più della metà
del nuovo Parlamento: la prima sfiorando il 30 per cento; la
seconda con oltre il 25 per cento. La somma di queste due presenze,
politicamente inerti, cristallizza la crisi, irrigidisce le
istituzioni europee, favorisce la ripresa della speculazione
finanziaria. Ovviamente, la nostra preoccupazione non riguarda
quanto l'instabilità della situazione politica italiana
metta in sofferenza i palazzi di Bruxelles o di Francoforte,
bensì – e non possiamo non esserne angosciati –
le ricadute sul sistema sociale che si possono prevedere per
l'immediato futuro. Con questi chiari di luna l'economia reale,
quella che riguarda la carne viva della popolazione, subirà
un'ulteriore decelerazione, in termini di crescita della disoccupazione,
di riduzione drastica dei già falcidiati redditi delle
famiglie che vivono di lavoro, di un azzeramento effettivo dei
servizi sociali.
In questo quadro, il suicidio di Bersani è solo un nuovo
episodio di quella norma che ha sempre determinato la sconfitta
di tutte le sinistre che si istituzionalizzano. Il rincorrere
l'aria moderata per cercare di ampliare il presunto consenso
del suo elettorato, ritenuto prevalente, ha, alla prova dei
fatti, demotivato quanti, nella sua area, si aspettavano una
sterzata decisa contro un'austerità che soffocava la
popolazione. La miopia politica del romagnolo, invece, lo ha
indotto a corteggiare un centro montiano inesistente, per di
più costituito da personaggi da cui una sinistra degna
di questo nome dovrebbe tenersi sempre lontana.
Complessivamente, comunque, il dato che costantemente si conferma
è quello di un popolo, quello italiano, che premia reiteratamente
la corruttela, il malaffare, l'oscenità ostentata e persino
i comportamenti mafiosi. È per questo che non abbiamo
scampo. Qualunque sia la scelta, il corpo del grande malato
non migliorerà. E noi stiamo a guardare.
Antonio Cardella
|