|
scuola
Galleggiare sugli abissi oscuri
di Philippe Godard
Utopia, pedagogia e rassegnazione: la “Miscredenza passiva”
al centro della crisi della scuola.
“Miscredenza passiva”
(Mécréance, ndr): l'espressione è
di Fernand Deligny, e con essa egli intendeva riferirsi a quei
medici, infermieri e altre persone che ricoprivano un ruolo
in un ospedale psichiatrico, molti dei quali non credevano a
ciò che stavano facendo e mantenevano un atteggiamento
passivo nei riguardi della situazione. Probabilmente, di notte,
disfacevano con il pensiero ciò che di giorno si erano
sentiti costretti a fare, dandosi ottime e multiformi giustificazioni,
dalla tradizionale ingiunzione, interiorizzata: “Devi
guadagnare soldi per nutrire i tuoi figli”, fino a visioni
più ciniche sugli emarginati, i pazzi, i figli perduti
per la società, che bisogna “raddrizzare”.
Eppure è indubbio che la maggior parte viveva molto male
quell'ospedale psichiatrico in cui prestava servizio, e si vergognava
di impersonare fino a quel punto la schiavitù volontaria,
che facciamo nostra, come ha perfettamente dimostrato La Boétie.
L'ospedale psichiatrico è una forma esacerbata del Malencontre
(“cattivo incontro”) – ancora La Boétie
–, che è il Potere, ottenuto e perpetuato grazie
alla partecipazione di ciascuno alla propria oppressione. Il
Potere contraccambia, permettendo a noi di opprimere gli altri,
quelli che stanno più in basso, poiché oppressione
significa prima di tutto partecipazione a questa specie che
persiste nel credersi umana: tutti uniti grazie a questa schiavitù
che costruiamo e condividiamo. Che diffondiamo e modelliamo
con le nostre mani, con il nostro linguaggio. Ma non soltanto
in questi modi. Perché noi operiamo anche mediante il
nostro gusto acquisito per la passività.
La differenza tra attivo e passivo è sfumata: la passività
ha la meglio sulla volontà attiva. Noi siamo diretti
dal Sistema, dal Potere, fino a diventarne dei rifiuti non appena
non corrispondiamo più alla norma sociale. La domanda
è: senza Potere, il nostro “noi” non avrebbe
maggiori probabilità di emergere, di farsi parte attiva
e di rifiutare la passività nei confronti di situazioni
ingiuste e distruttive?
È un interrogativo al quale sarebbe vano tentare semplicemente
di dare una risposta. Perché non è da un linguaggio,
in una teoria fumosa – fumisteria? –, che
proverrà la risposta. Bensì e solamente da un
agire.
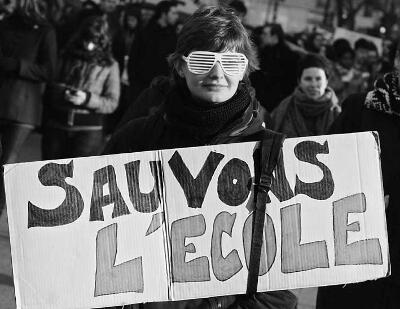
Zattere alla deriva
Agire a partire da quelle “zattere” di cui parlava
Deligny, remando qua e là sull'oceano del Malencontre
e permettendo a individui emarginati, asociali o desocializzati
di aggrapparsi per non sprofondare? Zattere sufficientemente
lasche e allentate per lasciar passare le ondate di un mare
vessatorio, ma dalle assi talmente saldate tra loro da riemergere
in continuazione, galleggiare e andare alla deriva. Ma, in tutto
ciò, che fa la pedagogia, e la scuola?
La scuola non è di quelle zattere alla deriva –
e quant'è difficile, ma così bello, andare alla
deriva sull'oceano del Malencontre! La scuola è
nave ammiraglia, vivaio di talenti, dove tutti i giovani allievi
devono recarsi per inspirare la propria schiavitù volontaria,
per il Sistema, senza soffrirne. Volere davvero la propria schiavitù
a un prezzo infimo, al prezzo di niente, quel niente che, nel
tempo del digitale, riempie la prodigiosa infinità degli
schermi. Aspirare a un vuoto che assomiglia incredibilmente
a quel tedio così diffuso ai nostri tempi, tedio per
la vita del mondo, che spinge a smettere di desiderare, di farla
finita con il ciclo delle rinascite. Smettere di desiderare
= abbandonare la lotta = sconfitta di ciò che restava
della zattera di fortuna, sconfitta del battello di quei patrimoni
che sono e rimangono gli esseri umani esenti dalla Miscredenza.
A questa miscredenza passiva, vorremmo contrapporre una pedagogia
della Via: diventiamo Zattera. Imbarchiamoci sugli abissi oscuri,
e per non inabissarci, la cosa migliore è galleggiare
senza agire eccessivamente. Ma galleggiare.
Di che agire si tratta? Un agire che assomigli al Tao dei taoisti,
quel “wuwei” che si traduce anche “non agire”.
Che assomiglia anche alla rivolta collettiva di Camus (“Io
mi ribello, quindi siamo”), alla società in lotta
contro lo Stato di Pierre Clastres, o a quella zattera di Deligny
che recupera ovunque i resti di cui l'ospedale psichiatrico
non sapeva che fare, se non abbrutirli di farmaci. Le parole
agire, non agire, zattera, resto, lo stesso ospedale psichiatrico
proliferano in questo oceano di Miscredenza soltanto per giocarci
insieme: lasciamoci andare alla deriva verso il margine per
liberarcene. Non lasciamoci rinchiudere in un vocabolario: “Le
parole ci dividono, le azioni ci uniscono”, dicevano i
Tupamaros uruguayani. Utilizziamole semplicemente per avviare
discussioni, dibattiti, problematiche. Non agiamo a vantaggio
di ciò che ci opprime. Non salviamo il Sistema che ci
stritola. Non siamo né scettici né passivi.
Dove sta il margine? Si può ancora essere nel Margine?
È all'intersezione tra la realtà e l'utopia, il
Sistema e il Margine che interviene la pedagogia, fondata su
un'etica del non-dominio.
Infatti, per il fatto stesso di collocarci al Margine, eccoci
nel cuore della Miscredenza. Il Sistema non ha bisogno di gatte
da pelare. Atene ha immolato la sua gatta-Socrate. La Cina ha
fagocitato la gatta-Tao. Al capitalismo piacerebbe veder sprofondare
la pedagogia utopica negli abissi del consenso.
Così, a scuola, in questa nave ammiraglia, perché
è lì che si trova, è costretto a essere,
il futuro del mondo, grazie al succedersi di generazioni, cui
si cerca di togliere ogni possibilità di essere in conflitto,
vale a dire, semplicemente, di essere, a scuola si trova un
terreno di lotta in cui l'utopia – il Margine, la Società
contro lo Stato – esiste, soprattutto non in quanto avanguardia.
L'avanguardia è potere, dunque partecipazione alla Miscredenza.
L'Utopia è allo stato latente, persino del tutto nota.
Essa è espressa, pensata, discussa a volte. Ma è
agita?
Non sta forse qui il nucleo fondamentale della crisi della scuola?
I bei progetti teorici sono legioni; vengono discussi, a volte
con asprezza e cattiveria; i testi ufficiali organizzano “progressioni”
o tengono conto dei dibattiti teorici per snaturarli nel momento
stesso in cui sono trasformati in riforme pratiche e concrete.
Così, le pedagogie realizzate da trenta o quarant'anni
a questa parte sono per lo più risposte mal tradotte
a problematiche che permangono relegate nella pura astrazione.
È sufficiente un gruppo di studenti fuori norma, malamente
condizionati dall'Istituzione, per far esplodere, in una classe,
in una scuola, tutte le migliori volontà del mondo.
L'importanza di credere 
Non abbiamo la pretesa di uscire da questa situazione mediante
un qualche colpo di bacchetta magica. Ma soprattutto non cadiamo
in quella “Miscredenza passiva” che, ovunque, estende
sulle scuole la sua ombra sinistra. Non credere più a
ciò che si fa e non fare niente per cambiare la situazione:
non c'è niente di peggio per i ragazzi, per coloro che
lavorano e soffrono a scuola, e purtroppo anche per il mondo
futuro, perché i ragazzi di oggi, in futuro, saranno
condizionati dalla scuola che avranno avuto o subito nella loro
giovinezza.
Come non credere in un'Istituzione come la scuola? Questa è
l'espressione della Miscredenza: resa incondizionata, schiavitù
volontaria quasi teorizzata e accettata, negazione di sé
– e degli altri al contempo, ma a più lungo termine
e secondo processi individuali che avvertiamo, ma che non riusciamo
mai a spiegare. Eppure: se non ci si crede, che cosa possiamo
sperare di indicare ai giovani, se non il fatto drammatico che
si può vivere senza credere in niente, neppure in ciò
che si fa e in ciò che si vive insieme ad altri esseri
umani, che sarebbe certamente una delle più belle vite
che si possano immaginare?
Ebbene, qualsiasi riforma della scuola implicherebbe alla base
il fatto che coloro che dovranno realizzarla debbano almeno
crederci un po'... In un contesto del tutto differente, Guevara
si chiedeva come fare a costruire il socialismo se gli unici
incentivi erano economici. A suo avviso, esisteva un'etica della
costruzione dell'uomo nuovo; quel processo utopico non poteva
accontentarsi unicamente degli incentivi economici, che dovevano
essere soltanto transitori. Ma l'etica ha senso soltanto se
gli individui coinvolti hanno la volontà di riuscire
a trasformare il mondo. Se, a scuola, l'immensa maggioranza
si arrende e ci va come altri si recano alla catena di montaggio
o al patibolo, consapevoli della loro oppressione, che speranza
ci resta di cambiare?
Questa dimensione viene sempre lasciata da parte, perché
è proprio lei a porre il vero problema di fondo della
scuola. Questo problema non è quello della scuola. È
il sintomo di una società che non crede più in
se stessa come un tutto dotato di senso, e si limita a un elenco
delle sue componenti dissociate le une dalle altre, tra le quali
scegliere. Allora, si appartiene a questa o a quella tribù,
in attesa di essere, un giorno, contro le altre tribù.
La società capitalista è più che mai una
lotta di tutti contro tutti in un quadro unico, che regge ancora
grazie ad alcuni pilastri. Il primo è il denaro: e se
non avessimo conti in banca, se dunque tutti dovessimo sopravvivere
grazie al baratto, è certo che questa (assenza di) società
scomparirebbe, dando vita forse a una autentica società
di scambi tra gli esseri umani. Il secondo è la paura:
di non avere più soldi, e anche la paura dell'altro,
il desiderio di far paura per imporsi, la paura della gerarchia
e l'uso della paura per garantirsi una posizione di dominio,
la paura di non essere al top, di avere l'alito cattivo o le
ascelle sudate, la paura di non pensare in modo omologato, la
paura di non aver paura e di essere diversi, di essere tentati
da quel Margine che, invece, non ha paura.
La paura e il denaro sono connessi tra loro. Anche a scuola
la paura e il denaro sono costantemente presenti. La paura del
professore, dell'amministrazione, dell'errore, del brutto voto,
della reazione dei genitori alla pagella. Il denaro come scopo
supremo, quella profusione di denaro che si conquisterà
se si avrà successo negli studi, ma, prima di ciò,
il denaro necessario per pagar(si) gli studi, la scuola come
investimento per il futuro.
È l'intera società a mostrarsi scettica e passiva
quando si aspetta di superare la propria paura soltanto mediante
l'accumulo di denaro, cosa che si verifica soltanto per i più
“fortunati” – i più alienati –
di noi. Ma il Margine vive ancora e parla ancora, e noi sappiamo
che certi eventi possono ribaltare una situazione. E, questa
volta, è il Sistema ad avere paura. Cerchiamo di essere
un creativo Margine all'attacco.
Philippe Godard
traduzione di Luisa Cortese
|