|
letture
Quaderni dal carcere
a cura di Laura Antonella Carli
fotoAFA - Archivi Fotografici Autogestiti
L'universo carcerario raccontato attraverso i libri: dalle testimonianze dirette degli ergastolani a riflessioni di ampia portata sulla legittimità stessa dell'esperienza penitenziaria. Con un racconto e un breve estratto drammaturgico.
I libri che presentiamo in queste
pagine hanno degli aspetti in comune che vanno oltre l'argomento
carcerario. Sono entrambi opere corali: il primo, dedicato al
tema dell'ergastolo ostativo, raccoglie le testimonianze di
alcuni detenuti, il secondo è invece una raccolta di
saggi curati da Silvia Buzzelli, docente di diritto penitenziario
e procedura penale europea e sovranazionale e si accompagna
a un dvd contenente un documentario di Germano Maccioni, girato
nel 2011 presso la Casa circondariale di Lodi. La scrittura,
l'origine dei contributi, il punto di vista dei due lavori è
chiaramente molto diverso, entrambi però aprono a una
serie di dubbi: la pena detentiva è davvero “un
male necessario”? È davvero la “migliore
delle pene possibili”?
Quando ci si avvicina a certe tematiche, come ci avverte don
Ciotti, «non è possibile attivare il pensiero semplice»
e questi due documenti, anche in virtù della propria
diversità di approccio, ci offrono utili strumenti per
rapportarci al mondo del carcere in modo complesso, non complicato,
ma meditato e consapevole, aprendo a punti di vista e insinuando
qualche dubbio. Se infatti Francesco Maisto, presidente del
Tribunale di sorveglianza di Bologna, nel documentario di Maccioni
chiarisce immediatamente che il carcere è soltanto una
delle pene possibili previste dalla costituzione, don Ciotti
cita Carlo Maria Martini, secondo il quale non ci si può
limitare a pensare a “pene alternative” ma è
necessario immaginare “alternative alle pene”. «Il
carcere, insomma, – spiega il sacerdote – è
un prodotto dell'uomo e in quanto tale ha avuto un inizio ma
può dunque anche avere una fine».

Brevi
interviste a
uomini ombra
Urla a bassa voce. Dal buio del 41 bis e del fine pena
mai (Nuovi Equilibri, 2012, pagg. 190, € 15.00) è
la testimonianza collettiva di 35 ergastolani, interrogati su
diverse tematiche legate alla loro vita in carcere: la famiglia,
la salute, il perdono, la giustizia, fino ai temi più
delicati: l'omicidio, il suicidio. Don Ciotti, nella sua premessa,
lo definisce «un libro importante e necessario»,
come è sempre necessario tutto ciò che ci obbliga
a fare i conti con il sommerso, con le realtà comunemente
esiliate lontano dagli occhi. Ed è proprio dall'angolo
più remoto della già marginale realtà carceraria,
dal “buio del fine pena mai” che provengono le testimonianze
raccolte. Gli “uomini ombra” sono infatti, secondo
una sorta di auto-designazione poetica, gli ergastolani ostativi,
cioè coloro ai quali è negata qualsiasi riduzione
della pena, qualsiasi beneficio: dalle visite familiari ai permessi.
«Vale a dire che l'ergastolo è totale, effettivo
e senza termine», spiega don Ciotti. Tale regime speciale
è una conseguenza dell'inasprimento delle leggi per combattere
la criminalità organizzata in seguito ai delitti di mafia
dei primi anni '90 e coloro che vi sono sottoposti sono i condannati
per reati associativi che hanno scelto di non collaborare con
la giustizia. È una decisione, quella di non collaborare,
che, come spiega la curatrice Francesca de Carolis, «viene
ribadita con forza. Fino a respingere la legittimità
del termine “pentiti” che comunemente ormai tutti
usiamo per indicare i collaboratori di giustizia, trasformando
l'atteggiamento morale che accompagna il riconoscimento di colpa
in figura giuridica.» Si tratta di uno dei temi più
cari ai protagonisti del libro, perché è il vero
discrimine tra gli “uomini ombra” e coloro che,
a parità di reato, sono tornati in libertà. Ed
è uno degli argomenti sui quali sembrano essere tutti
concordi.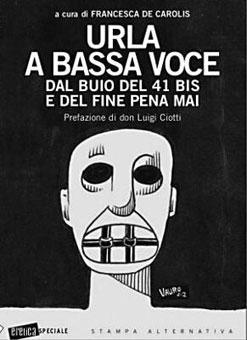
 Il tempo
scandito e il tempo vuoto Il tempo
scandito e il tempo vuoto
I contributi, tutti raccolti tra la primavera del 2010 e l'autunno
del 2011, sono raggruppati in macro-sezioni tematiche e introdotti
da titoletti che presentano l'argomento e da qualche breve incursione
della curatrice. Le domande che hanno stimolato gli interventi,
raccolte grazie a un appello telematico tra le proposte di medici,
giornalisti, religiosi e cittadini non sono riportate nel libro,
anche se in parte sono intuibili dalle risposte, sulle quali
la curatrice ha cercato di intervenire il meno possibile, limitando
al minimo modifiche e correzioni e lasciando spazio alla testimonianza
diretta, con tanto di incertezze sintattiche e contraddizioni.
Lo stesso discorso vale per le brevi autopresentazioni che aprono
il volume, alcune di poche righe, altre più dettagliate
– anche se i racconti biografici più intimi emergono
nel corso del libro, quando si toccano i temi della famiglia
e degli affetti: tanti rimpiangono di non aver visto crescere
i propri figli e vorrebbero avere la speranza di poter recuperare
almeno con i nipoti.
Nell'ottica di restituire uno spaccato autentico, senza demagogia
e senza giudizi, diversi brani del libro sono dedicati alla
descrizione della vita in carcere: i suoi ritmi, i suoi suoni,
le sue presenze. Sul concetto di tempo in carcere sono due i
ragionamenti che prevalgono: da una parte ciò che più
viene temuto e percepito come alienante è l'ozio forzato
dei regimi penitenziari più duri. Carmelo Musumeci, ricordando
la sua esperienza all'Asinara, spiega: «Non avevo nessuna
attività. A quel tempo il regime di tortura del 41 bis
non prevedeva nessuna attività culturale, sportiva, lavorativa.
Si viveva da cane in un canile». Il secondo aspetto che
emerge a proposito del tempo in carcere è la sua rigida
organizzazione modulare, la stessa descritta da Foucault, che
considerava parte integrante dei meccanismi disciplinari la
ferrea amministrazione del tempo – la stessa della fabbrica
e della scuola –, un modo per garantire insieme efficienza,
controllo, docilità e sorveglianza gerarchica. Giuseppe
Pullara ad esempio vuole sfatare il luogo comune secondo cui
«in carcere c'è più tempo libero; sappiate
che tutto il nostro tempo libero è cadenzato dal regime
penitenziario». Colazione, battitura delle sbarre, passeggiata,
rientro, doccia... tutto ad un'ora precisa, tutto è perfettamente
scandito, limitando «il tempo “libero” a un
lumicino, per cui ogni soggetto lo vive come meglio può:
chi studia per non oziare o pensare alla negatività in
cui è costretto a vivere, chi scrive molte ore, anche
la sera tardi; chi guarda la tv dalla mattina alla sera; chi
si dedica alla cucina preparando piatti succulenti e altri pessimi,
per sperimentare». Ciò che Giuseppe lamenta è
l'assenza di maggiori stimoli per impiegare in modo fruttuoso
anche il tempo non organizzato: lavoro, corsi specialistici,
progetti culturali... La stessa presenza della tv suscita alcune
perplessità, ad esempio Musumeci si mostra scettico:
«Molte persone “perbene” del mondo dei vivi
dicono: “Hanno anche la televisione!” ma spesso
è anche grazie alla televisione che i detenuti sono docili
come pecore». Il motivo per cui Giuseppe non guarda la
tv è invece meno politico, più personale: è
il senso di estraneità e impotenza nei confronti del
mondo raccontato dai teleschermi: i telegiornali gli danno la
netta percezione «di un mondo che cambia senza poterne
fare parte».

 “Arrugginirò
come il ferro” “Arrugginirò
come il ferro”
Il libro ospita interventi di vario tenore: militanti, intimi,
propositivi, amareggiati. Alle riflessioni più amare
si alternano momenti più leggeri in cui si racconta ad
esempio la difficoltà di ingegnarsi nella preparazione
di ricette che rendano il vitto carcerario più sopportabile:
sono storie rocambolesche, che vanno dalla sostituzione fantasiosa
di alcuni ingredienti difficili da reperire alla costruzione
di una sorta di forno rudimentale. Da una parte ostinati sprazzi
di vita, come la voglia di studiare, di continuare a comunicare
con il mondo esterno, addirittura di realizzare qualche manicaretto;
dall'altra momenti di sconforto, come il pensiero del suicidio
che, dicono gli “uomini ombra”, una volta o l'altra
sfiora un po' tutti.
Antonio Presta ha 40 anni (38, all'epoca delle interviste).
È entrato in carcere a 19 anni, condannato all'ergastolo
a 25. Racconta: «Un vecchio ergastolano mi disse: “Noi
ergastolani prima diventiamo carcerati, poi il carcere”.
Ecco, non è un luogo comune quando si afferma che diventiamo
arredamento del carcere, perché non potrò oppormi
a lungo; prima o poi, mi piaccia o no, sarò 'il carcere':
arrugginirò come il ferro, sarò umido e pieno
di muffa come i muri, mi aprirò e mi chiuderò
alla stessa ora e morirò ogni volta in un giorno diverso,
fin quando esisterà l'ergastolo, fin quando resisterà
il mio corpo».
 Laura Antonella Carli
Laura Antonella Carli
Questa
è la storia di Biagio: né morto, né
vivo, né sano
Qui
di seguito ospitiamo un racconto che ci ha inviato Carmelo
Musumeci, ergastolano ostativo, attualmente detenuto
presso il carcere di Padova. Carmelo è nato il
27 luglio 1955 ad Aci Sant'Antonio, in provincia di
Catania.
Quand'era all'Asinara, in regime 41 bis, riprese i suoi
studi e in cinque anni terminò le scuole superiori
per poi conseguire, dopo tre anni di studi la laurea
in giurisprudenza con una tesi in sociologia del diritto
dal titolo Vivere l'ergastolo.
In carcere ha scoperto la passione per la scrittura,
tra i suoi libri Undici ore d'amore di un uomo ombra
e Zanna blu. Carmelo ama il linguaggio fiabesco
e per descrivere la sua condizione di ergastolano utilizza
metafore evocative: gli ergastolani sono gli “uomini
ombra”, l'ergastolo è la “pena di
morte viva”, lo Stato è “il ladro
di sogni”.
Mi viene da sorridere quando sento parlare di convegni
sulla sanità in carcere, è un sorriso
ironico e benevolo al tempo; per vivere e per stare
bene c'è bisogno di amare e di libertà.
(Alessandro Bruni)
«Biagio Campailla è un giovane “Uomo
Ombra” arrestato in giovane età e condannato
all'ergastolo ostativo.
È arrivato da poco tempo dalla Sardegna, dal
lager di Badu Carros, e abbiamo fatto presto amicizia.
Tutte le mattine appena ci aprono i cancelli, viene
a trovarmi nella mia cella, gli faccio il caffè,
lo ascolto e provo a confortarlo.
Biagio sta male, soffre di una malattia genetica come
la sorella, che per questa malattia è scomparsa
da pochi anni.
Soffre di numerosi linfonodi latero-cervicali, di cervicobrachialgia,
di ipoastenia sinistra e dell'arteria mammaria interna
sinistra che incrocia e impronta il vaso venoso succlavio,
che da 15mm passa a 6mm con conseguente possibile situazione
clinica di sindrome dello stretto toracico superiore.
Sulle sue spalle pesano due gravi condanne, tutte e
due mortali, ma, bizzarria della sorte, una condanna
può far finire l'altra.
Dagli uomini è stato condannato alla “Pena
di Morte Viva” (così chiamiamo l'ergastolo
ostativo, quello senza possibilità di liberazione),
dal destino invece è stato condannato a questa
rara malattia.
Biagio s'è sposato giovane, appena quattordicenne,
come accade ancora nel meridione, ha quattro figli e
a quarantadue anni ha cinque nipoti.
Ha una famiglia che risiede in Belgio da tanti anni:
dolce, colorita, solare e affettuosa, con una madre
malata ma combattiva che lo segue con affetto da quattordici
anni, l'ho conosciuta nella sala colloqui.
Biagio mi parla spesso dei suoi figli e dei suoi nipotini
e mi confida che gli dispiace che a causa della malattia
non potrà vederli crescere.
L'altro giorno mi ha confidato che non ha neppure più
l'energia per stare male, che quello che lo terrorizza
di più è spegnersi lentamente fra sbarre
e cemento.
Penso che abbia ragione perché quello che fa
più paura ad un uomo ombra malato è morire
prigioniero, lontano dai propri familiari. Invece quello
che terrorizza un uomo ombra sano è continuare
a vivere senza neppure un calendario in cella per segnare
i giorni che mancano al suo fine pena.
Questa è la storia di Biagio: né morto,
né vivo, né sano, che si sta spegnendo
lentamente come una candela senza luce e al buio in
una prigione dei buoni.»
 Carmelo Musumeci
Carmelo Musumeci
Padova, dicembre 2012 |
Dove
tutto è scontato e
niente lo è
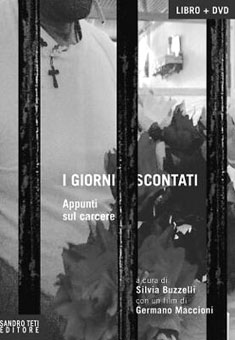 La
raccolta saggistica I giorni scontati (Sandro Teti Editore,
2012, pagg. 205, libro + dvd € 20.00) ci invita immediatamente
ad aprire il vocabolario: «cercate il verbo “scontare”
e l'aggettivo “scontato”: non sorprendetevi se i
significati vi condurranno dentro il carcere». I contributi
ospitati nel volume, opera di un gruppo di studiosi, direttori
penitenziari, educatori, esperti europei e giuristi, sono tutti
caratterizzati da una grande precisione terminologica, a cui
Silvia Buzzelli ci abitua fin dall'introduzione, nella quale
utilizza spunti lessicali come chiave d'accesso a una riflessione
che sappia mettere in discussione i falsi assiomi legati all'universo
carcerario. Prima ancora però c'è il titolo, giocato
su un'interessante polisemia. Tra i tanti significati del verbo
“scontare” e dell'aggettivo “scontato”,
i più facilmente riconducibili all'ambito detentivo parlano
di “fare ammenda” e “patire le conseguenze
di uno sbaglio”. In questo caso però, oltre all'ovvio
legame con l'argomento in questione, il titolo pone l'accento
su un'altra accezione: “scontato” significa anche
“previsto, prevedibile, dato per certo” e “dare
per scontato” vuol dire smettere di problematizzare una
questione, considerala ovvia, già data, non oggetto di
discussione. E qui arriviamo a quello che, io credo, è
l'obiettivo del libro: scardinare questa semplicità di
analisi e riaprire la riflessione sul carcere, sul suo funzionamento,
sulle sue criticità, sulla sua stessa esistenza: «Tutto
è scontato e niente lo è, compresa l'esistenza
del carcere. Questa è la ragione degli appunti, questo
il motivo del documentario». La
raccolta saggistica I giorni scontati (Sandro Teti Editore,
2012, pagg. 205, libro + dvd € 20.00) ci invita immediatamente
ad aprire il vocabolario: «cercate il verbo “scontare”
e l'aggettivo “scontato”: non sorprendetevi se i
significati vi condurranno dentro il carcere». I contributi
ospitati nel volume, opera di un gruppo di studiosi, direttori
penitenziari, educatori, esperti europei e giuristi, sono tutti
caratterizzati da una grande precisione terminologica, a cui
Silvia Buzzelli ci abitua fin dall'introduzione, nella quale
utilizza spunti lessicali come chiave d'accesso a una riflessione
che sappia mettere in discussione i falsi assiomi legati all'universo
carcerario. Prima ancora però c'è il titolo, giocato
su un'interessante polisemia. Tra i tanti significati del verbo
“scontare” e dell'aggettivo “scontato”,
i più facilmente riconducibili all'ambito detentivo parlano
di “fare ammenda” e “patire le conseguenze
di uno sbaglio”. In questo caso però, oltre all'ovvio
legame con l'argomento in questione, il titolo pone l'accento
su un'altra accezione: “scontato” significa anche
“previsto, prevedibile, dato per certo” e “dare
per scontato” vuol dire smettere di problematizzare una
questione, considerala ovvia, già data, non oggetto di
discussione. E qui arriviamo a quello che, io credo, è
l'obiettivo del libro: scardinare questa semplicità di
analisi e riaprire la riflessione sul carcere, sul suo funzionamento,
sulle sue criticità, sulla sua stessa esistenza: «Tutto
è scontato e niente lo è, compresa l'esistenza
del carcere. Questa è la ragione degli appunti, questo
il motivo del documentario».
La difficoltà di un discorso così elaborato è
tenuta presente dagli autori stessi, che sono chiamati a scrivere
non dei lavori conclusi quanto degli appunti (non a caso il
sottotitolo è Appunti sul carcere), che rimandino
ad altri approfondimenti e soprattutto testimonino indirettamente
della complessità e della difficoltà di affrontare
l'argomento con organicità e coerenza. Anche il termine
“appunto” non ha un solo significato: è inteso
anche come rimprovero, come osservazione. «E di rimproveri
al nostro sistema detentivo – osserva Bruzzelli –
se ne possono muovere davvero parecchi».
 Luogo
ideologico per individui generici Luogo
ideologico per individui generici
Gli appunti raccolti nel libro sono frutto di approcci
diversi e mettono a fuoco differenti aspetti della questione,
con una grande attenzione allo spazio-carcere: dal significato
– reale, metaforico e simbolico – delle sbarre e
come esse incidono sulla visibilità e sugli incontri
tra detenuti, fino allo studio più specifico di due luoghi-tipo:
l'isola di Gorgona, ultima isola-carcere italiana, sede di un
penitenziario a indirizzo agricolo-zootecnico, e il carcere
di Lodi, raccontato con approccio storico, ricostruendone le
tappe, senza prescindere da chi vi è vissuto.

Proprio nella casa circondariale di Lodi è girato il
documentario I giorni scontati, che costituisce la seconda
parte del progetto. «È un film nel carcere,
non sul carcere», spiega Silvia Bruzzelli, che
ci racconta come l'idea di un progetto diviso in due parti,
strettamente correlate ma che fanno riferimento a due supporti
diversi, video e cartaceo, sia nata dalla volontà di
«abbandonare un'analisi a senso unico», facendo
ricorso ad uno sguardo diverso: quello della telecamera, ma
soprattutto quello di un regista-attore, un artista, che sappia
interpretare la realtà con occhi sensibili e immergersi
in essa in prima persona. In questo modo al lettore-spettatore
è offerta la possibilità di «gettare uno
sguardo dentro locali, di solito opachi, spesso impenetrabili».
«Diamo per scontata l'esistenza delle prigioni, ma non
vogliamo affrontare le realtà che producono e le condizioni
di coloro che le vivono – racconta il regista Maccioni
–. Siccome sarebbe troppo penoso accettare l'eventualità
che capitasse a noi stessi, tendiamo a considerare il carcere
come qualcosa di avulso dalla nostra vita, una sorte riservata
ad altri, un luogo ideologico per generici individui indesiderabili.
Il che ci solleva dalla responsabilità di riflettere
sulle problematiche concrete che affliggono i funzionamenti
di tali strutture. Riflettere su questa presenza-assenza significa
iniziare a riconoscerne i paradossi».
Maccioni ci accompagna alla scoperta della vita nel carcere
di Lodi con l'ausilio della direttrice, Stefania Mussio e con
il commento prezioso di Francesco Maisto, presidente del Tribunale
di sorveglianza di Bologna. Quest'ultimo, fin dal primo intervento,
mira a sfatare il luogo comune secondo cui la pena è
una e una sola: il carcere. «Questo non sta scritto da
nessuna parte. La costituzione, all'articolo 27, parla di pene,
che non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
Maisto, anche in virtù della propria professione, non
è un abolizionista, ma ritiene che sia comunque essenziale
partire da questa consapevolezza: il carcere non è l'unica
pena possibile. Dalla sua prospettiva riflette su come la situazione
penitenziaria attuale soffra di un'assoluta mancanza di razionalità,
anche in termini di efficienza dei costi, e si mostra amareggiato
per l'assuefazione che in Italia abbiamo sviluppato nei confronti
del malessere delle persone. Anche questo, secondo Maisto, è
dato per scontato.
Nella seconda parte del progetto si mantiene dunque l'eterogeneità
di contenuti che caratterizza il libro: l'approccio giuridico
si accompagna dunque a quello artistico, per offrire spunti
di analisi su quello che Bruzzelli definisce “il problema
di fondo”: «la presenza, cioè, di un “corpo
carcerato”, prigioniero di un'istituzione naturalmente
contraddittoria e ipocrita nel momento in cui si prefigge lo
scopo di punire senza sofferenza».
 Laura Antonella Carli
Laura Antonella Carli

Questa
è la storia di un erbivoro...
«...Un
detenuto condannato alla reclusione fino al giorno 99
del mese 99 dell'anno 9999. “Fine pena mai“,
come una ghigliottina al rallentatore. [...]
Colpire il carcere significa colpire lo stato al cuore.
Cambiare il carcere è il passo più importante
verso un cambiamento radicale della società.
Come cittadino di questa città carceraria posso
lottare per i diritti più elementari. Lo sa,
signor giudice, che nella cella del penitenziario che
mi ospita posso avere solo dodici fotografie? Chi l'ha
deciso questo numero? E da cosa dipende? Sono dodici
come gli apostoli? E perché non trentatré
come i trentini o sette come i nani? Se mia madre mi
porta la foto del matrimonio di mio cugino, le devo
ridare indietro quella di mio nipote che ha fatto la
cresima. Giochiamo alle figurine.
Signor giudice, mi svegliano alle sette con la battitura,
alle otto passa la colazione, mentre la cena è
alle cinque del pomeriggio. Per mangiare di nuovo devo
aspettare venti ore. Oppure devo fare la domandina allo
spesinoto e accedere al sopravvitto, ma per quello si
deve pagare. E quale carcerato può permettersi
di fare la spesa tutti i giorni? C'è gente che
passa le due ore d'aria giornaliere a elemosinare monetine
e gli bastano solo per fare una telefonata a settimana,
perché chiamano in Africa o in Cina. E lo sa
perché, signor giudice? Perché quaranta
detenuti su cento sono immigrati. Detenuti che hanno
commesso reati piccoli e piccolissimi. Perché
ottanta immigrati regolari su cento sono stati irregolari
e dunque in questo paese per un immigrato essere irregolare
è la norma, perciò diventa normale che
finisca in galera. A questi bisogna aggiungere altri
trenta detenuti su cento che sono tossici. Capisce?
Settanta detenuti ogni cento hanno rubato la mela soltanto
per fame. E considerando la totalità degli ospiti
nelle nostre prigioni, soltanto uno su due è
stato condannato in via definitiva, perché quell'altra
metà sconta una pena senza aver ricevuto una
condanna.»
 Ascanio Celestini
Ascanio Celestini
da Pro patria, Einaudi, 2012, pagg.136, €
17.50
Il libro è tratto dall'omonimo spettacolo teatrale
(vedi “A”
373, estate 2012) |
I
numeri dietro le sbarre
Secondo dati aggiornati al 30 giugno 2012:
1.546 è il numero degli ergastolani in Italia, tra cui
35 donne.
Più di 100 hanno alle spalle oltre 26 anni di detenzione
(limite previsto per accedere alla libertà condizionale);
la metà di questi ha superato i 30 anni di detenzione.
Circa 1.200 è il numero degli ergastolani ostativi; 154
sono i morti in carcere durante l'anno 2012; 60 è il
numero dei suicidi avvenuti in carcere durante l'anno 2012.

Per
contatti e per saperne di più
http://urladalsilenzio.wordpress.com
www.carmelomusumeci.com
www.associazioneantigone.it
www.ristretti.org
www.informacarcere.it
www.innocentievasioni.net
|