| La conquista
dell’inutile
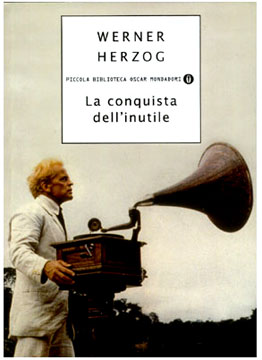 Questo
libro raccoglie il lungo diario tenuto da Werner Herzog durante
i due anni e mezzo di lavorazione del suo film-limite Fitzcarraldo
nella giungla amazzonica, tra il giugno 1979 e il novembre 1981:
un’impareggiabile avventura, tra enormi difficoltà
logistiche e mutamenti nel cast che, alla fine, comprenderà
Klaus Kinski e Claudia Cardinale (Mick Jagger sciolse il contratto,
essendo troppo occupato nell’ambiente musicale, ed Herzog
scelse di eliminare il suo personaggio piuttosto che affidarlo
ad un altro attore). Il regista tedesco ha definito queste pagine
“più appassionanti del film stesso”. Questo
libro raccoglie il lungo diario tenuto da Werner Herzog durante
i due anni e mezzo di lavorazione del suo film-limite Fitzcarraldo
nella giungla amazzonica, tra il giugno 1979 e il novembre 1981:
un’impareggiabile avventura, tra enormi difficoltà
logistiche e mutamenti nel cast che, alla fine, comprenderà
Klaus Kinski e Claudia Cardinale (Mick Jagger sciolse il contratto,
essendo troppo occupato nell’ambiente musicale, ed Herzog
scelse di eliminare il suo personaggio piuttosto che affidarlo
ad un altro attore). Il regista tedesco ha definito queste pagine
“più appassionanti del film stesso”.
Potrete leggere passaggi come questi:
- Sulla lapide (del poeta pazzo Rafael Avila) si legge:
le vanità del mondo/le grandezze del potere/sono chiuse
nel profondo/silenzio del cimitero.
- (…) proprio perché era stato ripudiato
da tutti io avevo avuto quell’attenzione per lui e gli
avevo dato lavoro.
- (…) la vita è micidiale, sia mentre la
vivi che quando finisce.
- La famiglia che ci aveva prestato la pentola di acqua
calda ci si è avvicinata, allora abbiamo preparato tonno
anche per loro e gli abbiamo offerto del tè, qui funziona
così, il cibo viene sempre condiviso. César dice
che è una cosa talmente naturale che nella loro lingua
non esiste la parola “grazie”.
- La burocrazia (…) è (…) una spiacevole
forma di organizzazione.
- Mick Jagger (…) è venuto da noi in taxi,
ma siccome l’autista si è rifiutato di procedere
per gli ultimi cento metri tra le buche piene di fango, nemmeno
al doppio della tariffa, l’ho trovato che camminava a
tentoni al buio, in smoking e scarpe da ginnastica.
- Ho dormito in una capanna (…) su una sorta di
letto, dal quale primo ho dovuto togliere gli escrementi di
topo secchi. I ratti si arrampicavano come lucertole sulle stuoie
che facevano da pareti. La mattina mi sono svegliato presto
e mi sono trovato davanti il muso di un porcellino d’India
che mi fissava sbigottito.
- Durante la scena una delle scimmie ha morso Mick (Jagger)
sulla spalla e lui è scoppiato in una risata così
sonora che sembrava di sentire ragliare un asino.
- (…) la domanda a cui tutti volevano una risposta
era se avrei avuto il coraggio e la forza di ricominciare di
nuovo tutto dall’inizio. Risposi di sì, perché
altrimenti sarei stato un uomo che non aveva più sogni,
e senza sogni non volevo vivere.
- La morte è ereditaria.
- Senza prove le cose sembrano sempre migliori, altrimenti,
come ripeto ogni volta, subentra una meccanica degli avvenimenti
che rimane priva di una vera vitalità.
- Di colpo si è scatenato di nuovo l’urlo
infiammato di Kinski, ma questa volta non aveva niente a che
fare con la situazione del campo. Gridava fuori di sé,
sbraitando che gentaglia, che canaglie fossero quelli come Sergio
Leone e Corbucci, quegli stronzi colossali. C’è
voluto parecchio prima che Kinski fosse esausto. Le sue urla
si sono poi accese di nuovo, ma brevemente, per dire che persona
spietatamente non dotata, che maiale spietatamente grasso fosse
Fellini.
- (…) così nero e reale come i peccati del
papa.
- (…) l’accettazione di un evento che non
ha avuto luogo modifica definitivamente tutta una vita.
- La nostra squadra di cucina ha ucciso le quattro anatre
che erano rimaste. (…) Il tacchino bianco, quell’animale
vanitoso, sopravvissuto a tanti polli arrosto e anatre bollite
per il brodo, è arrivato soffiando e pavoneggiandosi,
ha sollevato raspando con le sue brutte zampe una delle anatre
decapitate che sbatteva sanguinante le ali a terra, l’ha
sistemata in una posizione per lui comoda e arrivando di corsa,
violaceo, mentre emetteva dei gorgoglii di stomaco, è
montato sull’anatra morente e si è accoppiato con
lei.
- Le due scimmie nere, tra le quali c’era Tricky
Dick, che compare nel film come attrice, i Campas se le sono
mangiate prima di partire.
- Una cauta tristezza è calata su ogni cosa, come
su antichi luoghi dell’infanzia che ora sono mutati.
- Solo scrivendo riesco a raggiungere me stesso.
Volete sapere qualcosa di più di questo libro? Nel gennaio
del 2004, lo stesso Herzog scriveva: “Per ragioni che
non conosco, un tempo non riuscivo nemmeno a leggere questi
diari redatti durante la lavorazione del film Fitzcarraldo.
Oggi, ventiquattro anni più tardi, mi è sembrato
improvvisamente facile (…). Queste annotazioni non sono
il resoconto delle riprese, a malapena accennate, né
possono essere considerate diari, se non nel senso più
ampio del termine: sono qualcosa di diverso, un paesaggio interiore
partorito dal delirio della giungla. Ma nemmeno di questo sono
sicuro.”
Nicola Chiaromonte
lo sprovincializzatore
Il francese Maurice Nadeau (e così pure la scrittrice
statunitense Mary McCarthy) lo ritenne uno degli ultimi “maestri
segreti” di tutta una generazione, mentre per Enzo Siciliano
Nicola Chiaromonte fu “un italiano del Sud Italia e talvolta
persino scontroso come certi lucani possono esserlo, ma appassionato
e devoto al proprio pensiero fino a soffrirne, fino ad un rabbioso
silenzio di fronte alle altrui velleità…”
.
Di Nicola Chiaromonte ricorrono i quarant’anni dalla morte
e speriamo che tale ricorrenza sia davvero occasione tanto per
rileggere articoli e opere (su tutte “Credere e non credere”
e “Il tarlo della coscienza”) andati sommersi dalla
polvere del tempo quanto per riscoprire il pensiero di uno degli
intellettuali che “contribuì a sprovincializzare
la cultura politica del Paese” negli anni immediati al
secondo dopoguerra.
Nato a Rapolla (Potenza) nel 1905, si trasferì con la
famiglia a Roma che era ancora bambino, poco più che
ventenne aderì a Giustizia e Libertà fiancheggiando
il gruppo del suo maestro Andrea Caffi, sostenitore di un socialismo
proudhoniano e libertario in contrasto con quello liberale dei
fratelli Carlo e Nello Rosselli. Perseguitato dal regime fuggì
a Parigi dove si ritrovò tra la schiera degli antifascisti
italiani in esilio, nel 1936 volle andare in Spagna a combattere
contro le armate di Franco affiancando la pattuglia aerea dello
scrittore francese André Malraux. Uscito traumatizzato
dall’esperienza spagnola, Chiaromonte divenne un antimilitarista
convinto. “Dopo l’esperienza che ho fatto in Spagna
- scriverà - non mi è possibile di vedere la guerra
come mezzo utile per risolvere le cose”. Nel 1941 si trasferì
negli Stati Uniti, qui collaborò con le prestigiose riviste
avanguardiste “Partisan Review” e “Politics
e si ritrovò negli ambienti letterari frequentati, tra
gli altri, da Hannah Arendt, Meyer Shapiro e dalla stessa Mary
McCarthy. E grazie pure a questa sua breve parentesi oltreoceano
che Chiaromonte, una volta definitivamente rimpatriato, si andò
affermando anche da noi in quel maestro che “ha insegnato
a scrivere ad almeno due generazioni d’intellettuali”
.
Lavorò al “Mondo” di Pannunzio come critico
teatrale, i suoi articoli era molto letti e commentati, perché
l’evento scenico era in lui solo un pretesto per insolite
osservazioni filosofiche e valutazioni politiche. Ma tutto il
percorso intellettivo di Nicola Chiaromonte è più
marcatamente cementato all’esperienza di “Tempo
presente”. La rivista che fondò nel 1956 con Ignazio
Silone e andò ad affermarsi per la sfida sferrata alla
degenerazione illiberale del socialismo, l’appoggio agli
intellettuali francesi che si schierarono contro la guerra d’
Algeria, l’opposizione (tenace) alla sinistra stalinista
e leninista.
Probabilmente Chiaromonte dalle pagine di “Tempo presente”
commise l’errore di liquidare sommariamente sia Marx che
Gramsci, ma a lui bisogna riconoscere la fermezza con cui difese
il primato della morale in politica, le insistenti denunce contro
la corruzione, la partitocrazia, la salda volontà nel
voler progettare crescere una rivista culturalmente non sottomessa
tanto al marxismo-leninista che alla chiesa cattolica e all’idealismo
crociano. L’esperienza di “Tempo presente”
purtroppo finì malamente nel 1968 a causa di uno strano
scandalo internazionale e che vedeva sullo sfondo l’oscura
longa manus della Cia. Negli ultimi anni della sua vita Nicola
Chiaromonte lavorò all’Espresso dove si confermò
in un principe della critica teatrale.
Morì a Roma il 18 gennaio del 1972 colpito da un improvviso
infarto nella sede Rai di via Mazzini, poco prima che si apprestasse
a registrare un programma radiofonico La sua opera più
importante rimane “Credere non credere”, una raccolta
di saggi su Tolstoj, Stendhal, Malraux che uscì per Bompiani
nel 1971. E su queste pagine che ritroviamo pillole del suo
pensiero estremamente non datato. Chiaromonte sta pienamente
inficiato dentro le tensione del nostro tempo quando scrive(va):
“La nostra non è un’epoca di fede, neppure
di incredulità. È un’epoca di malafede,
di credenze mantenute a forza, in opposizione ad altre e, soprattutto,
in mancanza di altre genuine”.
 Mimmo Mastrangelo Mimmo Mastrangelo
Cinema rumeno
“La ricostruzione” di Lucian
Pintilie
Ancora per tutti gli anni ’60 il cinema rumeno era ampiamente
demodulato tanto nelle scelte stilistiche quanto nei processi
di una originale ideazione narrativa. La crescita cinematografica,
quantomeno nel senso di una coscienza liberata del proprio dire
e dei rapporti dialettici tra arte e socialità, avvenne
più oltre per effetto del condizionamento abbondantemente
determinato da quel fenomeno di lentissimo disgelo che ha in
qualche modo limitato il controllo totale della gerarchia burocratica
sui modi dell’espressione cinematografica del paese.
Pure in queste condizioni, i cineasti hanno saputo comporsi
in un margine di azione autentica che ha prodotto opere estremamente
interessanti e, in alcuni casi, compiute proprio entro le ragioni
di una specifica appartenenza geoculturale. Lucian Pintilie
è l’autore che più si sottrae agli adescamenti
della complicità ideologica con il regime; quantunque
isolato e posto ai margini da una cultura d’apparato grigiamente
ufficiale, fino poi all’esilio, Pintilie ha assunto un’autorevolezza
intellettuale sapientemente congiunta al ruolo simbolico che
la sua stessa opera ha prodotto. Pintilie esordisce coltivando
interessi prevalentemente teatrali sui palcoscenici di Bucarest,
dove metterà in scena opere del rumeno Ion Luca Caragiale
e di altri drammaturghi europei contemporanei con spirito acre
e modi di effettivo e non compiaciuto sperimentalismo.
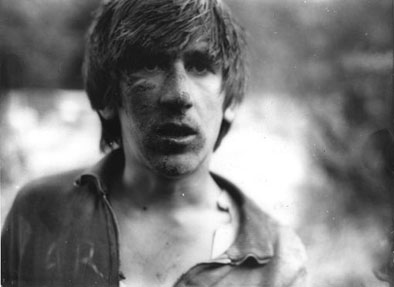 |
Un
fotogramma dal film “La Ricostruzione” |
Il suo primo lungometraggio giunge nel 1965 con Domenica
alle sei, opera che seppe rappresentare un atto isolato
di rottura per via della sua statura linguistica alternata tra
attitudine fenomenologica e rovesciamento onirico, con amplissime
influenze sulla concezione strutturale di cineasti inquietamente
raffinati come Resnais o Antonioni. Soprattutto Pintilie muta
i criteri di descrizione narrativa attraverso un’originale
soggettivizzazione dello sguardo della macchina da presa che
rinuncia al tracciato di mera registrazione naturalistica in
favore di una sua effettiva partecipazione al racconto; il linguaggio,
insomma, diviene stile, luogo di ricapitolazione estetica di
quei principi che Pintilie ha propri come demitizzanti l’anonimo
realismo del cinema di regime. Domenica alle sei prepara
il secondo film di Pintilie, e lo prepara nella misura in cui
gli artifici formali e gli istituti stilistici dell’avanguardia
europea saranno resi impliciti dalla struttura meditatamente
sottrattiva del nuovo racconto per immagini.
La ricostruzione (1968), dalla novella omonima
di Horia Petrescu, è la storia di due giovani studenti,
Ripu e Vujca, che una notte hanno festeggiato la loro promozione
bevendo qualche bicchiere di troppo. Ubriachi hanno aggredito
il gestore del bar, fracassato una vetrina e fatto a pugni tra
di loro. Qualche giorno dopo vengono riportati sul luogo del
reato da un poliziotto, un magistrato, un insegnante e una troupe
cinematografica. Il giudice ha deciso che al posto della prigione,
i ragazzi dovranno fare gli attori per un documentario pagato
dallo Stato contro l’alcolismo. Devono ricostruire fedelmente
gli eventi di quella giornata, dalla rissa con il gestore fino
allo scontro finale. Quello che non era accaduto nella realtà
avviene tragicamente nella finzione. Fin dalla sinossi delle
sue azioni narrative, il film di Pintilie appare come un’opera
allegorica che consente una complessa stratigrafia ermeneutica
sulla struttura manifestamente significante del metafilm strutturato
nel rispetto delle unità aristoteliche.
Come è stato scritto, “la irripetibilità
dell’esperienza, la vanità del pedagogismo repressivo,
la vacuità del mimetismo didascalico fondato sul “tipico”,
la inautenticità della riproduzione meccanica del reale,
la distruttività di ogni “ricostruzione”
che nasca da una visione schematica dei “fatti”
(anzi, appunto, dalla riduzione a meri fatti non più
immersi nella vischiosità dell’esistenza) sono
altrettanti – o meglio appena alcuni – dei motivi
che si rincorrono, si intersecano, si sovrappongono, si illuminano,
reciprocamente e dialetticamente, di chiaroscurate prospettive
(…) scambiando i colposi con i colpevoli, la finzione
con la realtà, il volontarismo pedagogico con l’intenzione
delittuosa, il dolore autentico con l’artificio”.
Con ogni probabilità Pintilie realizza in tempi di dittatura
il film più libero e significativo dell’intera
cinematografia rumena. Il principio iperrealistico della mera
ricostruzione costituisce, di fatto, nel rovesciamento dei suoi
paradigmi, una critica serrata al regime comunista; di più,
esso perviene all’esito paradossale di restituire la pellicola
non al mimetismo ma alla visionarietà.
Come documento, il film ha un valore simbolico proprio nella
misura in cui utilizza la metafora come strumento inalienabile
della contestazione politica; per via indiretta, intrecciando
il senso di realtà con la sur-realtà dell’esperimento,
Pintilie concepisce una parabola sul significato della libertà
come principio di responsabilità, eluso in questo senso
sia dalla grassa borghesia capitalista che dal rozzo comunismo
di regime. Inutile dire che la controversia giunge, di fatto,
alla negazione dell’estetica del socialismo reale (lo
zdanovismo, per intenderci) attraverso la dissacrazione del
soggetto del film didattico. A nostro parere, piuttosto, l’opera
di Pintilie si inserisce nella dialettica del comunismo reale
(dialettica negata, certo, ma in fondo modello di autentica
libertà) per quel socialismo dal volto umano cui ambiscono
in quegli anni i paesi dell’est.
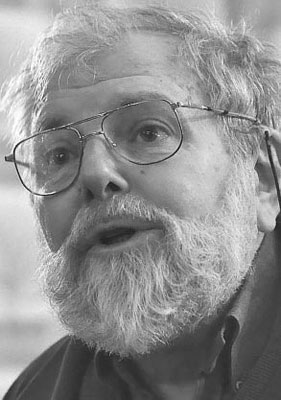 |
Il
regista rumeno Lucien Pintilie |
L’esigenza e insieme il precipitato della dialettica
politica del film è indubitabile persino in considerazione
delle scelte stilistiche di Pintilie (un pervicace ossimoro
filmico) e soprattutto del suo tracciato metafilmico che si
rovescia e sovrappone alla critica ideologica; così come
ha scritto Gianni Toti, per cui “(…) Alla fine,
che cosa c’è di veramente cinematografico e di
autenticamente socialista in un film come questo di Pintilie,
se non la denuncia cinematografica della illusione di una “ricostruzione”
della verità che sia soltanto cinematografica, culturale
cioè, e non vada al di là di questa stessa denuncia
di crisi conoscitiva che è anche crisi politica, etc.?”.
Così Pintilie nutre la sua parabola grottesca nell’intuizione
prodromica dell’entropia e, come per Cechov o Caragiale,
nella tragedia della mediocrità, nella noia dell’abitudine,
nella corrosione del tempo dell’esistenza è il
tramonto doloroso della storia.
 Beniamino Biondi
Beniamino Biondi
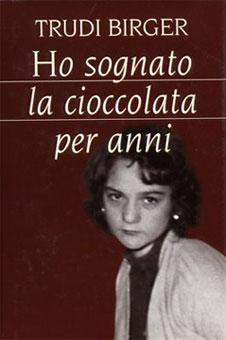 Una
bambina Una
bambina
nei lager
Trudi ha trascorso la propria infanzia inizialmente nel ghetto
di Kovno e poi nel campo di concentramento e di sterminio di
Stutthof in Polonia. La storia narrata in Ho sognato
la cioccolata per anni (Piemme editore, Milano 2008,
pagg. 181, e 9.00), di Trudi Birger, è incentrata sul
rapporto intenso fra Trudi e sua madre, grazie a cui riusciranno
entrambe a salvarsi.
Dal ghetto di Kovno, Trudi e sua madre furono trasferite sui
treni per il viaggio di deportazione, in condizioni igieniche
terribili, senza cibo e acqua. Non conoscevano la precisa destinazione
del viaggio, ma tutti sapevano che si trattava di un campo di
concentramento.
“Ho sognato la cioccolata per anni” di Trudi Birger
è un romanzo autobiografico, in cui l’Autrice racconta
la personale e tragica storia di vita. Trudi Birger, sopravvissuta
agli orrori dell’Olocausto, alla fine della guerra si
è trasferita a Gerusalemme, dove ha vissuto con la sua
numerosa famiglia.
L’Autrice, deprivata e derubata della giovinezza, ha scelto
di dedicarsi ai bambini più poveri di ogni etnia, cultura
e religione, fino alla sua morte nel 2002.
Trudi Birger con grandissima modestia, consegna a tutta l’umanità
un libro che tramanda gli orrori dell’Olocausto, della
guerra, raccontando delle personali radici etniche e culturali,
della vicenda di una madre e di una figlia che, all’interno
del dramma, giurano a se stesse di essere persone migliori nella
speranza di un domani di pace, di dialogo e di accoglienza tra
genti, culture e minoranze.
La storia di una bambina che viene strappata dalla quotidianità
di Francoforte, per trovarsi presto rinchiusa, come un animale
in gabbia, nel ghetto di Kovno, in attesa di essere reclusa
nel campo di concentramento e di sterminio di Stutthof. La storia
di una bambina, armata solo della propria innocenza, che si
lega alla madre e a tutto ciò che rappresenta, per la
memoria dell’intero popolo ebraico.
Questo libro è consigliato a chiunque tenta di fare memoria
dei drammi personali e mondiali che si sono consumati prima,
durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale, “Per Non Dimenticare”
gli orrori dei conflitti armati nella storia e per costruire
contesti collettivi di dialogo, accoglienza e soprattutto pace.
Da questa lettura, nella Testimonianza diretta di deportazione,
comprendiamo che l’odio, la guerra, il razzismo ingenerano
morte, annientamento e distruzione. La pace, la fratellanza,
l’accoglienza e il rispetto dell’altro sono il pensiero
e il valore che vuole trasmettere Trudi, in quanto vittima,
nel suo racconto.
 Laura Tussi
Laura Tussi
Dalle TAZ
all’agricoltura?
Wilson non è molto conosciuto da noi con il suo vero
nome, con cui firma questa microguida filosofica all’orticultura
d’avanguardia, mentre raggiunse una certa notorietà
con lo pseudonimo di Hakim Bey come teorico di quelle Zone
Temporaneamente Autonome che furono di moda nell’epoca
in cui si vide nei centri sociali occupati & autogestiti
i gangli vitali di un nuovo sommovimento liberatorio diffuso
nelle metropoli e (assai meno) nelle province d’Italia.
Tramontato l’entusiasmo per il centrosocialismo reale,
ricordare le Taz fa quasi tenerezza, seguita da una buona dose
di sarcasmo nel pensare quanto davvero fossero temporanee
quelle zone, magari durate l’attimo necessario a costruirsi
un’immagine vendibile sul mercato della musica o della
politica.
Nel 1999 Wilson Peter Lamborn Wilson, con Avant Gardening (Nautilus,
www.ecn.org/nautilus)
aggiorna il suo panorama di zone autonome con notevole lungimiranza,
visto come si va oggi diffondendo la voglia di ritagliarsi pezzetti
di città in cui far crescere, assieme agli zucchini,
la capacità di interagire con il nostro ambiente per
riprendersi, anche se solo in piccolissima parte, quella capacità
del fare, di aiutare organismi a svilupparsi, di avere la pazienza
di osservarli fiorire e maturare. Chi vive in campagna sorriderà
con ironia di gesti così ovvi, eppure proprio perché
il numero di persone che non hanno idea di quand è che
maturano mandorle o pomodori è in crescita costante,
muovere un timido passo per prendere le distanze dalla raggelante
sterilità di un mondo senza odore, costruito su un immaginario
artificioso, è già un gesto coraggioso e vivo.
«Curare un orto» – sostiene Wilson –
«è diventato un atto di resistenza, ma non è
solo un gesto di rifiuto. È un atto positivo, una pratica».
L’autore però non sta auspicando un ritorno di
massa all’agricoltura, vista come l’inizio d’ogni
sciagura autoritaria. «La cosiddetta Rivoluzione agricola
generò l’ascesa dei primi Stati, assieme alla schiavitù,
le tasse, la guerra, i sacrifici umani e altri benefici del
progresso e della civiltà». Non agricoltori
dunque, ma orticoltori o giardinieri, che
non inseguano il lavoro e l’economia, ma la perfezione
liberata nella creazione di pezzi di paradiso, termine
derivato dalla parola persiana che significava giardino.
Se a questo punto volete sapere se si riesce in questo modo
anche a vivere di ciò che si coltiva temo però
che Wilson non sia la persona adatta a rispondere, in fondo
lui vive nel Lower East Side di Manhattan, mica sull’appennino
pistoiese...
 Giuseppe Aiello
Giuseppe Aiello
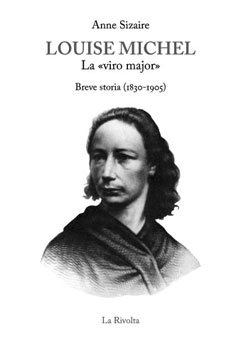
L’inclassificabile,
irrecuperabile Louise Michel
Ultima novità per la Fiaccola,
un piccolo libro solo per dimensioni su Louise Michel, di Anne
Sizaire, uscito per la classica collana La Rivolta. Il testo
ripercorre la storia, le azioni le idee a distanza di più
di un secolo dalla sua morte.
Louise Michel nasce il 29 maggio del 1830 a Vroncourt in Francia
da una relazione tra una domestica, Marianne Michel, e un castellano,
Etienne Demahis. Il padre, la educò alle idee illuministe
di Rousseau e di Voltaire e quando morì fu per lei un
duro colpo; 5 anni dopo morì anche la moglie del padre
e da quel giorno cambiò la sua vita: fu cacciata dal
castello e dovette portare il cognome della madre.
La sua infanzia fu ricca di stimoli: suonava il piano, dipingeva,
amava la natura, gli animali e, in particolare, i gatti. Il
suo rispetto e amore per gli animali è fondamentale nella
storia di questa donna che persino sulle barricate della comune
di Parigi pensava a salvare gli animali in difficoltà
mettendo a rischio la sua stessa vita.
Fin da giovane si cimentò con la scrittura e intrattenne
una fitta corrispondenza con Victor Hugo il quale le dedicò
la poesia Viro Major (da cui prende il titolo questo
saggio) ma soprattutto iniziò a scrivere una “Storia
universale” e dei racconti.
Nel gennaio 1853 incominciò la sua carriera di istitutrice
a Audeloncourt, dove ogni allievo pagava una retta mensile.
Presto lasciò questa scuola e diventò direttrice
di una scuola libera, perché per essere istitutrice comunale,
avrebbe dovuto giurare fedeltà all’impero e si
rifiutò di farlo. Louise adottò il metodo sperimentale
delle classi miste; non voleva accettare la divisione per età
degli alunni e attuava metodi educativi libertari
La prima volta che ebbe problemi con l’ordine costituito
fu quando paragonò Napoleone III, sulle colonne di un
giornale di Chaumont, a Domiziano l’imperatore romano.
Dopo qualche anno si trasferì a Parigi e da subito frequentò
una scuola popolare in via Thevenat dove diede delle lezioni
di letteratura e di geografia. Nella stessa scuola si riuniva
il gruppo “I diritti delle donne”, frequentato dalle
femministe Jules Simon, Andrè Leo e Maria Deraismes.
Il gruppo rivendicava la stessa educazione per uomini e donne
e lo stesso salario.
Fu la tesoriera di un comitato di soccorso ai profughi russi
il cui presidente era V. Hugo. Aderì anche all’Internazionale
dei Blanquisti e sostenne il giornale “Libero pensiero”,
dove discusse sulla religione e sulla rivoluzione ventura:
“Quando verrà l’ora e gli uomini esiteranno,
allora saranno le donne che marceranno in prima fila e io ci
sarò”.
 |
Louise
Michel |
In seguito all’assassinio del giovane Victor Noir, ad
opera del principe Pierre Bonaparte, in Louise si acuì
l’odio verso la monarchia e da allora portò abiti
maschili, una cappa, un cappello e un pugnale per difendersi
e, sulla tomba di Noir, Louise giurò di portare il lutto
per tutta la vita. Intanto il 19 giugno 1870 Napoleone III dichiarò
guerra alla Prussia, il 4 settembre crollò l’impero
e fu proclamata la Repubblica. Andrè Leo e Louise andarono
insieme a migliaia di manifestanti al municipio e reclamarono
armi per andare a liberare Strasburgo. Louise intanto si esercitava
al tiro a segno al luna park. Le donne parigine si organizzarono
costituendo comitati e L.M. fu una delle più attive organizzatrici
fino a diventare presidente del “Comitato di vigilanza
della guardia nazionale della XVIII circoscrizione”. Lei
fece parte sia di quello maschile che di quello femminile e
disse:
“tutti appartenevano alla rivoluzione... non si chiedeva
di che sesso fosse uno quando si trattava di compiere il proprio
dovere”.
Il 22 gennaio 1871 vi furono scontri abbastanza duri e per la
prima volta prese il fucile e non lo lasciò più
fino alla caduta delle ultime barricate nel maggio 1871.
“La prima volta che si difende la propria causa con
le armi, si vive la lotta così intensamente che si diventa
come un proiettile”.
Il 1 aprile il governo di Versailles dichiarò guerra
alla Comune di Parigi. L’esercito era composto da 35000
uomini, 3000 cavalli e 5000 gendarmi. Louise in quell’occasione
indossò la divisa della guardia nazionale e fece parte
del 61° battaglione. Quando i versagliesi andarono a casa
a cercarla e presero sua madre per fucilarla, lei si consegnò
per fare liberare la madre e rimase con i condannati alla fucilazione
attendendo il suo turno. Fu condotta al campo di Satory e da
questo trasferita a Versailles alla prigione “dei cantieri”.
Il 28 giugno iniziò il processo e durante gli interrogatori
Louise ammise di essere stata infermiera nel reparto ambulanze,
riconobbe gli scopi della Comune, confermò di volere
l’abolizione della istituzione clericale. Al secondo interrogatorio
non negò niente, disse
“sono accusata di essere complice della Comune! Certo
che lo sono perché la Comune voleva prima di tutto la
rivoluzione sociale che è ciò che desidero ansiosamente;
è un onore per me essere una delle autrici della Comune,
(..) Non voglio difendermi e non voglio essere difesa, appartengo
completamente alla rivoluzione sociale e mi dichiaro responsabile
delle mie azioni”, alla fine del processo aggiunse:
“Bisogna escludermi dalla società, siete stati
incaricati di farlo, bene! L’accusa ha ragione. Sembra
che ogni cuore che batte per la libertà ha solo il diritto
ad un pezzo di piombo, ebbene pretendo la mia parte!”
Alla fine non fu fucilata ma condannata alla deportazione. In
un primo momento fu trasferita alla prigione centrale di Auberive
(dipartimento della Marna) e ci restò 20 mesi. Nell’agosto
del 1873 iniziò il viaggio sulla “Virginia”,
una fregata a due vele che impiegò 4 mesi per arrivare
in Nuova Caledonia (il 10 dicembre 1873). Durante il viaggio
divenne anarchica e disse: “sono quindi anarchica
perché solo l’anarchia può rendere felici
gli uomini e perché è l’idea più
alta che l’intelligenza umana possa concepire, finché
un apogeo non sorgerà all’orizzonte”.
Nuova Caledonia, anni di prigionia
 Un
aspetto molto interessante su cui voglio soffermarmi della vita
di Louise Michel è che una volta arrivata in Nuova Caledonia
creò quasi subito un rapporto con i nativi Canachi. Un
aspetto molto interessante su cui voglio soffermarmi della vita
di Louise Michel è che una volta arrivata in Nuova Caledonia
creò quasi subito un rapporto con i nativi Canachi.
La popolazione indigena purtroppo veniva considerata dalla maggior
parte dei rivoluzionari come inferiore, i Canachi erano considerati
dei selvaggi, con i quali non si potevano creare legami.
Contrariamente agli altri deportati, Louise invece non si da
pace finché non instaura legami con loro, tanto che A.Sizaire
ci racconta che una sera, L.M. decide di andare a vederli da
sola, per presentarsi. Questi ultimi che, normalmente, preferiscono
evitare i bianchi, l’accettano velocemente e le danno
presto il nome di “chènère” che significa
sorella. Diventano amici e suoi allievi, lei impara rapidamente
la lingua Canaca (cosa che era assolutamente vietata) e improvvisa
per loro dei corsi, in particolare di storia e di politica sociale,
in piena foresta, all’interno di grotte o capanne abbandonate.
Sempre A. Sizaire ci racconta nel suo libro che L.M. alcune
notti scappa dalla sua dimora per raggiungere i suoi nuovi amici
e al chiarore dei fuochi, ascolta appassionatamente le leggende
dei loro narratori, o discute all’infinito con i loro
guaritori, i “Takata”, che la iniziano all’infusione
dei fiori di Niaouli, l’albero sacro.
L.M. si mostra sempre dolce e calma con i Canachi, notevolmente
aperta e attenta, completamente (o quasi) denudata dai pregiudizi
razziali del suo tempo, manifesta al contrario la speranza sincera
di scoprire una cultura altra, cercando di apprendere da loro
tanto quanto insegna.
Chiaramente questo suo rapporto con i nativi rimane incompreso
dai rivoluzionari deportati e in più attira le furie
del governatore francese, personaggio onnipotente dell’isola
che poteva decidere quasi su tutto senza doverne rendere conto
a nessuno. Il governatore giudica con decisione questa donna
pericolosa per le sue ridicole idee di emancipazione degli indigeni:
“Dove andremo a finire, santo cielo, grida lui , se
i Canachi adesso si mettono a parlare di oppressione”
Questi richiami non spaventeranno L.M. che continuerà
ad avere rapporti con i nativi, e proverà a far capire
loro cosa aveva significato la Comune e la ragione per la quale
lei si ritrovava al bagno penale, cosa che scatenerà
le loro personali confidenze:
“Quando i bianchi sono arrivati, all’inizio
hanno mangiato il piatto di igname che offrivamo loro. Poi hanno
tagliato i nostri alberi, portato via le nostre donne, devastato
le nostre colture, ucciso i nostri animali, preso i posti che
occupavano i nostri villaggi vicino ai corsi d’acqua,
cacciandoci nella foresta. Non ci hanno dato niente, nient’altro
che tristezza, promettendoci la terra e il cielo”.
Le raccontano la storia del progresso, la storia dell’invasione
e la distruzione di tutte le culture diverse dalla nostra che
nei secoli abbiamo come occidentali distrutto in tutto il pianeta.
Con somma vergogna di L.M. la maggior parte dei suoi compagni
di bagno penale, considerando i Canachi inferiori a loro, al
momento della loro rivolta portata avanti da Atai nel 1878,
non si interesseranno alle loro sorti, Louise scrive:
“Loro si battono e sono pronti a morire contro la
tirannia. Voi stessi qui, deportati, banditi, esattamente per
la stessa ragione…e la maggior parte di voi osa negare
i loro diritti!”
L’insurrezione delle zagaglie e delle fionde contro i
fucili europei volge, ovviamente al disastro: diverse tribù
vengono interamente decimate e duemila uomini, all’incirca,
muoiono.
Passati due anni da queste rivolte, l’11 luglio 1880 arrivò
l’amnistia. L.M. ritornò in Francia il 9 novembre,
alla stazione di Saint Lazàre dove fu accolta da migliaia
di persone. Senza stanchezza e senza soste iniziò presto
a fare conferenze. Fondò la “Lega delle donne”
perché voleva che le donne imparassero quali erano i
loro diritti per contrastare le leggi patriarcali forti anche
nei movimenti rivoluzionari.
Il 9 marzo 1883 partecipò ad una manifestazione di disoccupati
durante la quale furono assaltate le panetterie, ma solo contro
di lei fu emesso un ordine di comparizione e fu condannata a
6 anni di carcere. Dopo meno di tre anni di libertà fu
portata prima a Saint-Lazàre e poi nel carcere di Clermont.
Scontata la pena, iniziò un ciclo di conferenze. Il 23
gennaio 1888, durante una conferenza all’Eliseo, subì
un attentato da un uomo pagato da un prete. Una volta deviarono
addirittura il treno su cui viaggiava e imbastirono anche una
serie di false accuse da cui riuscì a salvarsi. Nel 1890
andò a Londra dove conobbe Malatesta, Emma Goldmann,
Kropotkin, Bakunin e Pietro Gori. Fondò nel 1895 il giornale
“Libertario” con Sebastian Faure.
Nel 1902 ritornò in Francia e un anno dopo riprese i
suoi giri di propaganda. Fece conferenze dal titolo: “Ciò
che vogliono gli anarchici” e “Che cos’è
l’anarchia”.
Negli ultimi anni della sua vita raccolse denaro per i moti
rivoluzionari in Italia, per l’indipendenza cubana, per
la rivoluzione spagnola; inoltre lavorò per l’internazionale
antimilitarista. Morì il 29 maggio del 1905 a Marsiglia
per una congestione polmonare, fu seppellita al cimitero di
Levallois salutata da centinaia di migliaia di donne e uomini.
 Andrea Staid
Andrea Staid
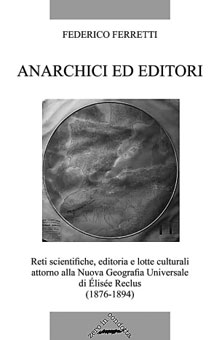 Topi
d’archivio Topi
d’archivio
che costruiscono
Federico Ferretti ha colpito ancora. Dopo il suo primo libro
per Zero in Condotta nel 2007, “Il mondo senza la mappa.
Elisée Reclus e i geografi anarchici”, ora esce
per la stessa casa editrice il suo Anarchici ed editori.
Reti scientifiche, editoria e lotte culturali attorno alla Nuova
Geografia Universale di Elisée Reclus (1876-1894).
240 pagine di testo fitto fitto, anche se di dimensioni un po’
ridotte, per soli 15,00 euro.
Meno scorrevole alla lettura rispetto a Il mondo senza la mappa,
ma necessariamente così vista la tipologia dell’opera.
Lettura comunque piacevole se si parte dal presupposto di leggerselo
“a pezzi”. Cioè anche andando a cercarsi
le parti che più interessano il lettore e non vincolarsi
alla sequenza narrativa del testo; che va bene comunque per
chi la vuole leggere dall’inizio alla fine, ma non è
la qualità fondamentale dell’opera quella del percorso
espositivo.
Il grande pregio del libro crescerà nel tempo, per i
lettori che lo leggeranno o lo studieranno tra qualche decennio.
Perché si tratta di un lavoro prezioso non solo per “noi”,
ma in generale come testimonianza di certe dinamiche culturali
e intellettuali in un periodo storico che gli anarchici in generale
conoscono e vogliono conoscere dal punto di vista della storia
dei personaggi e del movimento sociale, ma meno dal punto di
vista della “normalità” quotidiana dei soggetti
più conosciuti.
E tanto per cambiare (ironico) Reclus si presenta e spicca come
un caso emblematico di un (ri)conosciuto anarchico che riesce
a fare opera di divulgazione scientifica utile non solo ai militanti,
ma anche agli “altri”, i tiepidi e perfino gli oppositori.
Ferretti ha svolto una ricerca di archivi (plurale) fondamentale,
utile e idealmente motivata. Anche solo dal punto di vista del
tempo dedicato e dell’intenzione/motivazione nessuno fino
ad oggi ha fatto una ricerca del genere e c’è da
dubitare che altri l’avrebbero fatto; il tema anarchici
e simili tira poco sia nel campo accademico che in quello editoriale.
E giustamente Ferretti rileva e si-ci domanda quanti geografi
dichiaratamente anarchici potrebbero oggi vivere (e far vivere
i collaboratori) per 20 anni con i proventi della propria produzione
scientifica.
Il libro ci ricorda che oggi gli anarchici non ci sono nell’immaginario
collettivo (leggasi il sistema mediatico) se non per le bombe
(ancora: uffa!!) dei sedicenti informali, mentre un secolo fa
oltre alla banda Bonnot e a Bresci il dibattito/confronto/scontro
culturale vedeva la presenza degli anarchici anche come scienziati
autorevoli e ascoltati. E il libro ci mostra le modalità
di lavoro, l’impegno, la correttezza professionale e umana,
la tensione verso la precisione delle informazioni, la puntualità
della produzione, la chiarezza delle proprie posizioni nello
scambio di idee e la disponibilità a non irrigidirsi,
ma a trovare il punto di mediazione senza rinunciare ai principi.
In sostanza il mutuo appoggio applicato nella vita e nel lavoro.
Perché dalle lettere, dai documenti d’archivio,
dagli appunti e dalle riflessioni legate al lavoro di stesura
di un’opera durata 18 anni emerge questo, cioè
la capacità di essere militanti nelle cose quotidiane
come pure “nell’ideale”, come pure nello “sforzo
di costruire uno sguardo collettivo autonomo sul mondo”
(p.237) … “che rende la geografia una strategia
politica implicita” (p.238).
Oggi ci vuole proprio una geografia che serve a fare la pace
perché le notizie geopolitiche quotidiane sembrano continuare
a confermare la definizione di Yves Lacoste (1976) che “la
geografia serve soprattutto a fare la guerra”. Un libro
da leggere oggi (soprattutto i giovani che vogliono essere anarchici)
e da lasciare ai nostri figli come eredità nella biblioteca
di casa. Per non dimenticare e aver voglia di tendere al futuro.
 Fabrizio Eva
Fabrizio Eva
 |
Luciano
Bianciardi |
Luciano Bianciardi,
indisponibile al compromesso e al conformismo
Il Centro di Documentazione di Pistoia è una delle realtà
più stimolanti e interessanti sopravvissute, felicemente,
agli anni della cosiddetta contestazione. Nato inizialmente
nel 1969 come strumento di raccolta e conservazione del materiale
di propaganda prodotto dai gruppi e dalle realtà della
sinistra extraparlamentare che operavano negli anni Settanta
(un lavoro di raccolta prezioso in anni nei quali il fervore
militante era tale da far dimenticare la necessità di
conservare e coltivare la memoria delle attività e dei
progetti in atto) nel corso del tempo, grazie all’impegno
dei curatori dell’archivio e dei soci della cooperativa
formatasi attorno ad esso, si è dedicato anche e soprattutto
alla diffusione delle conoscenze che nell’archivio, e
tramite l’archivio, si venivano via via accumulando. Nacque
così il Notiziario del Centro di documentazione,
uno strumento prezioso di informazione, attento alle novità
e in grado di aggiornare le bibliografie degli argomenti e delle
istanze inerenti gli interessi e le conoscenze dei movimenti
e delle realtà della sinistra non istituzionale. Questo
Notiziario, che spesso ha assunto la forma di numeri monografici
di grande interesse, ha ormai raggiunto il n. 225, mostrando
così di essere una presenza vitale nel campo dell’informazione
non istituzionale, tanto più essendo fra le poche ancora
oggi operanti fra quelle nate in quegli anni lontani.
Fra le iniziative collaterali legate all’esistenza del
Centro di Documentazione, va segnalata l’ultima nata,
una collana di testi, I Quaderni dell’Italia antimoderata,
con la quale i responsabili del Centro si propongono di riproporre
all’attenzione delle nuove generazioni, ma anche a chi
tanto giovane non è più ma a cui forse sarebbe
bene rinfrescare la memoria, le figure di alcuni personaggi
che hanno segnato i processi culturali più innovativi
ed eterodossi del secondo dopoguerra. Figure che, nella loro
trasversale “marginalità” hanno contribuito
a gettare le basi formative di una nuova griglia interpretativa
della società, quella stessa che sarebbe diventata il
pane quotidiano delle generazioni della contestazione.
Italia antimoderata, dunque, in contrapposizione a
quella “mefitica” e opprimente Italia moderata che,
come spiega l’ideatore della collana Attilio Mangano nella
sua presentazione, già a partire dall’Unità
d’Italia esercitava “il peso rilevante del trasformismo
e del moderatismo sulla società italiana fino a influenzare
pezzi anche rilevanti della sinistra d’allora”.
Un’influenza che ha contribuito ad ingessare il Paese
nella falsa dialettica fra innovazione e conservazione, dove
l’innovazione non era che un processo indolore, ininfluente,
superficiale e sostanzialmente inutile, tale però da
creare l’illusione di una sua preponderanza sulla conservazione.
Questa sì, apparentemente sottotraccia, ma al contrario
effettivamente in grado di “conservarsi” –
si perdoni il gioco di parole – nonostante e contro le
apparenti spinte innovative. E non c’è bisogno
di dire che oggi, “morte” le ideologie, questa falsa
dialettica sia più attuale che mai. Il gigantesco “inciucio”
che ci sta agglutinando come un mostruoso blob è lì
a rammentarcelo.
Ecco dunque che i primi due titoli della collana sono dedicati
a due personaggi che, pur nella differenza dei percorsi esistenziali
e degli ambiti di intervento, sono stati fra i più refrattari
ad essere classificati all’interno di quelle categorie
(“intellettuale organico”, scrittore sociale”,
ecc.) con le quali si codificavano quanti contribuivano a rafforzare,
col proprio lavoro intellettuale, gli schemi e i confini di
una cultura istituzionale, eternamente moderata e pervicacemente
conservatrice. Sono “antimoderati, infatti, coloro che
hanno la coscienza e la capacità di opporsi a chi vorrebbe
depotenziare sempre e comunque tutte le espressioni di antagonismo
e di autonomia dei ceti subalterni, tutte le posizioni di riflessione
culturale e politica che non si ritrovano in questa linea di
pensiero”.
Parliamo di Luciano Bianciardi, l’indimenticato autore
de La vita agra, uno dei romanzi “simbolo”
della difficoltà di vivere negli anni del boom, e di
Giovanni Pirelli, inquieto e attento osservatore dei fenomeni
sociali, fratello di quel ben più famoso Leopoldo, al
quale, in compagnia di Agnelli, Restivo e Colombo si auguravano,
secondo uno dei più frequenti slogan dell’autunno
caldo, le inevitabili “piogge di piombo”. Il terzo
quaderno, già in cantiere, si occuperà di Dom
Franzoni, altra figura emblematica di questo dopoguerra, portatore
con altri di una coraggiosa eresia che contribuirà a
formare uno dei fenomeni più interessanti nati dalla
contestazione, il movimento dei “cattolici del dissenso”,
il vasto contenitore di “nuovi” cristiani impegnati
ad affrancarsi dalla secolare soggezione alle gerarchie e ad
aprirsi all’impegno sociale.
Nel primo fascicolo della collana Giuseppe Muraca traccia un’accurata
biografia di Bianciardi, arricchita da una bibliografia pressoché
completa dei suoi scritti. Il percorso esistenziale di Bianciardi,
parallelo a quello intellettuale, è stato assai complesso,
segnato irrimediabilmente dalla terribile tragedia della miniera
di Ribolla, in provincia di Grosseto, dove persero la vita 43
di quei minatori che erano stati il soggetto di una delle prime
inchieste operaie dell’epoca, effettuata alcuni anni prima
dallo stesso Bianciardi e da un giovane Carlo Cassola. Come
si sa, dopo quella tragedia di cui fu responsabile la Montecatini
(la futura Montedison), Cassola abbandona Grosseto e l’amata
Maremma per trasferirsi a Milano con il vendicativo proposito,
ben descritto nel suo più famoso romanzo, fortemente
autobiografico, di far saltare il grattacielo di quell’industria.
Ma la permanenza a Milano, dove si introduce presto negli ambienti
culturali della sinistra intellettuale, diventerà per
lui una sorta di terra di odio e amore, capace di raffreddarne
i propositi e al tempo stesso di angosciarne la rabbiosa esistenza.
Nonostante il grande successo editoriale della Vita agra,
e la benevola accettazione da parte della cultura meneghina,
nonostante il successo di altre sue opere e l’affermarsi
in campo giornalistico – diventerà anche un apprezzato
ed eterodosso cronista sportivo – nonostante trovasse
un amore capace di sostituire gli affetti famigliari dolorosamente
lasciati a Grosseto, la sua permanenza nella città del
benessere e del miracoloso boom economico dell’Italia
di quegli anni, non riuscirà mai a sopire la sua angoscia
intima e profonda, propria dell’osservatore attento e
disincantato di fenomeni sociali, per tanti aspetti positivi,
ma comunque destinati a stravolgere quei valori sociali ed etici
che lo accompagnavano fino dalle sue prime esperienze giornalistiche
maremmane.
Sarà quella angoscia, dunque, a determinarne le scelte
di vita, aspre nel rifiuto della omogeneità e al tempo
stesso riflesso di una incapacità alla mediazione. Saranno
dure, infatti, le scelte, da quella di rinunciare alla prestigiosa
collaborazione al «Corriere della Sera», fortemente
voluta da Montanelli (sintomatica la scelta di collaborare al
«Giorno», il quotidiano che in quegli anni sovvertì
le regole e gli stili del giornalismo italiano) a quella, altrettanto
“autolesionista”, di creare le condizioni per essere
licenziato dalla Feltrinelli, proprio quando quella giovane
casa editrice si stava dimostrando come una delle realtà
più innovative nella cultura del paese. E con quelle
scelte Bianciardi mostrava la sua innata incapacità di
diventare parte degli ingranaggi del potere, perché la
sua natura “anarchica” era un ostacolo insormontabile
per il compromesso e il conformismo che del potere, intellettuale
o economico che fosse, sono componenti ineliminabili. Saranno
altri i suoi punti di riferimento, quelli per cui continuerà
ad impegnare la propria lucida ed eterodossa intelligenza, gli
ambiti delle conquiste civili, della liberazione dai tabù
e dai pregiudizi, della liberazione dai puntelli sui quali poggia
e si forma il consenso di massa.
La sua parabola umana termina nel 1971 a soli 49 anni, causata,
a giudizio dei medici, dalla cirrosi epatica: “ma la verità,
la vera origine di quello che a molti sembrerà un lungo
suicidio, va cercata molto lontano e non ha radici fisiche.
La cirrosi è solo la punta dell’iceberg…”.
 Massimo Ortalli
Massimo Ortalli
I Machnovisti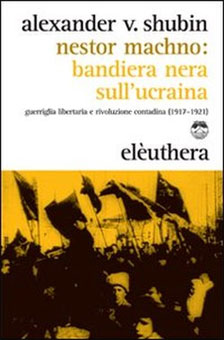
tra guerra e rivoluzione
La storia del movimento anarchico internazionale registra nel
Novecento due grandi momenti rivoluzionari: la rivoluzione russa
e la rivoluzione spagnola. In entrambi i casi gli anarchici
si sono trovati a lottare su due fronti. In Russia contro lo
zarismo, in Spagna contro franchismo; i rossi, invece, sono
stati sempre gli stessi, con la sola differenza che prima erano
agli ordini di Lenin, poi agli ordini di Stalin.
In Russia la lotta contro i bianchi e contro i rossi è
stata portata avanti soprattutto dal movimento machonovista,
sulla cui storia già esistevano varie testimonianze e
trattazioni, anche di pregio.
Ora però è uscita
un’opera storiografica (Alexander V. Shubin, Nestor
Machno: bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria
e rivoluzione contadina (1917-1921), Milano, Elèuthera,
2012, euro 15,00), che di Machno e del machnovismo intende dar
conto con un taglio interpretativo incline più alla ricostruzione
“tecnica” dello svolgimento spazio-temporale degli
avvenimenti che al loro significato ideologico. Ne è
risultato un libro molto utile perché offre una esauriente
documentazione di tutto ciò che è successo, sia
dal punto di vista militare, sia dal punto di vista politico.
Il libro di Shubin segue Machno dalla nascita alla morte; comprende,
quindi, anche il periodo dell’esilio in Francia, e offre
perciò un panorama completo della sua vicenda politica
ed umana.
Quello che emerge, innanzitutto, è un quadro di grande
violenza che non risparmia nessuno, in un susseguirsi di fatti
che cambiano rapidamente le situazioni esistenti perché
tutto è sempre fortunoso e precario; un ritmo che rovescia
continuamente ogni conquista in una sconfitta e ogni sconfitta
in una conquista. A ciò si aggiunga il fatto, enorme,
che per oltre un anno - dal 1917 alla fine del 1918 - l’intera
Ucraina è sottoposta alla duplice tensione della guerra
e della rivoluzione; il che spiega l’intreccio inestricabile
di un conflitto allo stesso tempo segnato da una rivoluzione
sociale e da una guerra civile.
Questo carattere fortemente dinamico impresso allo svolgimento
generale degli avvenimenti conforta la convinzione che la rivoluzione
russa abbia avuto, complessivamente, un carattere molto contraddittorio,
nel senso che il risultato finale - la conquista del potere
da parete dei bolscevichi - non risultava allora tanto scontato
ai contemporanei del tempo. Vogliamo dire, in altri termini,
che la rivoluzione russa è stata lungi dall’avere
quel carattere così marcatamente operaio che la successiva
storiografia marxista ha cercato di rappresentare, quello cioè
di una rivoluzione vittoriosa della classe operaia, sotto la
guida di un partito comunista avente un generale consenso nel
Paese.
Tutti sanno che nel 1917 la società russa era composta
da circa 140 milioni di individui, di cui oltre 100 erano contadini,
mentre gli operai non raggiungevano la quota di 3 milioni. Gli
operai, dunque, non superavano il 2, 5% dell’intera popolazione.
Sempre nel 1917 in tutta la Russia i seguaci di Lenin risultavano
23.600 - totale degli iscritti al partito - e a Pietrogrado,
vale a dire nella città dove i bolscevichi riuscirono
a attuare il loro colpo di mano, non erano più del 5%
di tutti i lavoratori industriali, numero, a sua volta, del
tutto insignificante rispetto ad una popolazione complessiva
di 2 milioni di persone. Ha ripetutamente scritto Trotsky che,
nell’intera Russia, a dar seguito alla presa del potere
nell’ottobre del ’17 furono circa 25.000 militanti
bolscevichi. Il putsch d’ottobre, avvenuto dopo tre tentativi
- aprile, giugno, luglio - di far crollare il governo Kerenskij
con agitazioni di piazza, non ebbe pressoché alcun carattere
cruento e fu il frutto di circostanze altamente fortuite. Occupate
le installazioni chiave della capitale, l’ufficio delle
poste e del telegrafo, l’ufficio centrale dei telefoni,
il quartier generale del comando militare del governo, i bolscevichi
assaltarono il Palazzo d’Inverno. Insomma se non vi fosse
stata la guerra, i bolscevichi non sarebbero riusciti a prendere
il potere. Conclusione: la rivoluzione d’ottobre non
fu una rivoluzione di popolo, ma l’esito fortunato del
colpo di mano di un piccolo partito.
Anche se gran parte della dialettica politica che ha dato vita
alla rivoluzione si espresse nei grandi centri urbani, la sua
autentica natura popolare fu quella datale dalla presenza e
dal protagonismo contadino, ideologicamente anarchico nella
sua immediata espressione sociale. Come scrisse il capo supremo
dell’esercito russo, il generale Alekseevc Brusilov: i
soldati, gli operai e i contadini «non avevano la minima
idea del comunismo, del proletariato e della costituzione. Volevano
la pace, la terra, la libertà di vivere senza leggi,
senza ufficiali, senza proprietari terrieri. Il loro “bolscevismo”
in realtà non era che una formidabile aspirazione alla
libertà senza remore, all’anarchia».
Pare difficile negare l’importanza del movimento machonovista,
che proprio di questo carattere è stato senz’altro
la sua espressione più radicalmente rivoluzionaria ed
egualitaria. Si consideri il fatto che Machno e i suoi seguaci
riuscirono a organizzare un movimento politico e sociale in
pochissimo tempo e in una situazione altamente caotica. Il seguito
popolare di questo movimento era sicuramente notevole, come
è dimostrato dai vari tentativi di instaurare un autentico
regime egualitario e libertario, perfino all’interno dell’apparato
militare.
 Nico Berti
Nico Berti
Alexander V. Shubin, Nestor Machno:
bandiera nera sull’Ucraina. Guerriglia libertaria e rivoluzione
contadina (1917-1921), Milano, Elèuthera, 2012,
euro 15,00.
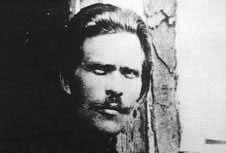 |
Nestor
Ivanovic Machno
(Guljaj Pole, 26 ottobre 1888-
Parigi, 25 luglio 1934) |
Nestor Machno,
il video
Dopo i lunghi decenni di silenzio imposti
dalla storia ufficiale, Hélène Châtelain,
regista cinematografica belga di famiglia russo-ucraina, è
tornata sui luoghi della machnovscina raccogliendo inedite testimonianze
che attestano una sorprendente sopravvivenza della figura di
Nestor Ivanovic Machno nell’immaginario popolare. Viene
così ricostruita, nel video Nestor Machno e la rivoluzione
anarchica in Ucraina, 1917-1921,regia di Hélène
Châtelain dvd 59’30’’ colore) anche
attraverso rare immagini d’archivio, non solo l’insurrezione
armata contadina ma anche la vita straordinaria del suo leader
carismatico.
Sconfitto dall’Armata Rossa nel 1921, è costretto
a lasciare l’Ucraina e nel 1925, dopo varie peregrinazioni,
si rifugia infine a Parigi. Lì lo insegue una domanda
di estradizione da parte del nuovo regime di Mosca per «tradimento
della patria, omicidio e saccheggio». Morirà in
esilio nel 1934, povero com’era nato. Eppure, la sua tomba
al cimitero di Père Lachaise è ancor oggi meta
di un curioso pellegrinaggio laico, testimoniato dai tanti bigliettini
lasciati dai visitatori, in particolare visitatori ucraini che
non hanno mai dimenticato la storia ormai leggendaria del loro
Batko Machno, il «piccolo padre» che novant’anni
fa aveva dato speranza alla loro aspirazione di libertà.
il filmato è visionabile sul sito
di elèuthera al link
http://www.eleuthera.it/scheda_libro.php?idlib=297
il dvd, in vendita
al prezzo complessivo di 20,00 euro insieme al libro di Alexander
V. Shubin Nestor Machno: bandiera nera sull’Ucraina.
Guerriglia libertaria e rivoluzione contadina può
essere richiesto a
Elèuthera,
via Rovetta 27, 20127 Milano - tel. 02 26 14 39 50
e-mail: eleuthera@eleuthera.it
o acquistato direttamente sul sito http://www.eleuthera.it
 |
Autunno
1918: un distaccamento machnovista durante
la guerriglia
partigiana contro le truppe
di occupazione austrotedesche |
|