
Marche/
Epopea operaia di una lotta vincente
È uscito a marzo un libro bello, intenso e coraggioso,
che fa rivivere un'epopea operaia lunga quasi vent'anni, dalla
fine degli anni '70 alla metà dei '90 del Novecento.
Il libro è La Simeide. Una lotta vincente di Tullio
Bugari (Seri Editore, Macerata 2019, pp. 353, € 15,00).
 Quello che scorre nelle pagine, in una cronaca incalzante narrata
con sapienza, è un protagonista corale: operai in assemblee
e cortei, delegati e sindacalisti nei Consigli di Fabbrica e
di Zona, padroni che fuggono e altri che ci credono, sindaci
e politici e partiti in consigli comunali e a facilitare trattative,
studenti che si mobilitano e cittadini che applaudono gli operai
in lotta.
Quello che scorre nelle pagine, in una cronaca incalzante narrata
con sapienza, è un protagonista corale: operai in assemblee
e cortei, delegati e sindacalisti nei Consigli di Fabbrica e
di Zona, padroni che fuggono e altri che ci credono, sindaci
e politici e partiti in consigli comunali e a facilitare trattative,
studenti che si mobilitano e cittadini che applaudono gli operai
in lotta.
La fabbrica è la SIMA di Jesi nelle Marche, coi suoi
700 operai che la salveranno insieme con gran parte dei posti
di lavoro. Operaio tra gli operai c'è Cesare Tittarelli,
anarchico, delegato nel CdF, in prima fila nella lunga lotta,
fuori dalla lista dei riassunti. È una storia lontana,
che parla però forte al presente.
Parla al presente per la memoria di persone che non devono essere
dimenticate, e di vicende che non devono andare perdute. Parla
al presente per la qualità della democrazia in cui viviamo,
così incerta oggi da dovere saper attingere a esperienze
di così grande partecipazione: di persone, comunità,
soggetti collettivi politici, sindacali, sociali. Parla al presente
anche per l'affidabilità delle fonti: cronache d'epoca,
ricerche, archivi personali, memorie orali; per “raccontare
dal punto di vista operaio”, scrive l'autore; ma anche
– guardando alla contemporaneità – per riaffermare
il valore delle fonti storiche contro la dittatura della post-verità,
di un'autoreferenzialità per cui ogni opinione è
vera e ogni fatto vale quanto un altro, in una sorta di inversione
di valore di quella democrazia diretta che Cesare Tittarelli
e gli operai della SIMA hanno saputo praticare.
Di fronte a un'impasse nella trattativa “la reazione
degli operai è immediata [...] escono dallo stabilimento
di Roncaglia e vanno a bloccare la ferrovia [...]: c'è
chi [Cesare] si incarica di intralciare i binari ed esce dallo
stabilimento con un muletto, si arrampica sulla scarpata, prosegue
per alcune centinaia di metri in direzione di Jesi seguito dagli
operai come in una specie di corteo, e poi lo lascia in mezzo
ai binari, estrae le chiavi e le scaglia lontano in mezzo all'erba
alta della campagna, gridando: Voglio vedere chi lo toglie!”
Dentro il vivo d'un racconto in presa diretta, ecco un primo
dilemma: trattativa e lotta, responsabilità e radicalità;
perché il “senso di responsabilità [...]
si costruisce ogni giorno, e occorre ogni volta riguadagnarselo
tra le tante discussioni interne, con opposti punti di vista,
ma pronti a ricomporsi”, anche ricorrendo ad azioni aspre:
“Il blocco si prolungava e la polizia aveva cominciato
a prepararsi per sgomberare i binari con la forza [...] Poi
arriva dalla direzione opposta un altro treno [...] e allora
gli operai indietreggiano [...] arrivano in fondo, dove ai lati
della ferrovia appare la città e c'è il passaggio
a livello, chiuso [...] È mezzogiorno, molti operai di
fabbriche e officine vicine stanno tornando dal lavoro e sono
fermi lì [...] e dai balconi e dalle finestre la gente
si sta affacciando [...] e inizia a battere le mani agli operai.
Dirigenti della polizia e delegati del CdF parlamentano di nuovo,
alla fine si accordano, prima smobilitano i poliziotti e dopo
cinque minuti si impegnano a farlo anche gli operai. Ma dopo.”
Quelli erano anni in cui partiti, istituzioni, eletti avevano
spesso un rapporto reale con la base, e forti erano anche le
spinte dal basso, esperienze di autonomia e autogestione. “Il
Consiglio Comunale all'unanimità esprime parere favorevole
alla trattativa”; la strategia operaia “non poteva
avere confini aziendali ma doveva anche ricercare all'esterno
l'unità necessaria [...] su proposta del CdF si costituisce
un Comitato interpartitico a cui aderiscono Pci, Dc, Pri, Psdi,
Pdup e Amministrazione comunale.”
Ma ecco, da contrappunto, l'operaio comunista Giordano Mancinelli
che puntualizza con orgoglio: “Le iniziative erano sempre
le nostre, le lotte, le assemblee, i blocchi sulla strada statale,
e anche quando andammo a Roncaglia ad aprire la manopola del
gas, perché ci avevano interrotto la fornitura, e ci
prendemmo la denuncia, mica chiedemmo prima ai sindacati o ad
altri, decidemmo da soli di andare.” E “se c'era
uno che spingeva continuamente, e diede un contributo fondamentale,
era proprio Cesare Tittarelli”.
Ecco un secondo dilemma che il libro ci squaderna continuamente
davanti, tra democrazia diretta e delegata, che la realtà
d'allora e di oggi pone con evidenza come questione permanente.
Quella vertenza ebbe un esito innegabilmente positivo. Eppure
l'autore sente di doverlo ribadire nelle ultime righe del libro,
quasi ad esorcizzare contraddizioni e limiti, su cui ancora
una volta è Cesare Tittarelli, il libertario, a riflettere;
lui che, non riassunto dalla sua fabbrica e costretto a trovarsi
un lavoro diverso, guida fino all'ultimo il comitato dei “cento
operai senza fabbrica” che – dice – “si
sono dovuti arrangiare: chi consegna pacchi, chi fa l'ambulante,
chi è rientrato in fabbrica ma con profili di basso livello.
Altri si sono persi di vista [...] Purtroppo, anche oggi che
il Comitato chiude per missione compiuta, non me la sento di
cantare vittoria.”
Ecco un terzo dilemma che il libro non può certo risolvere,
e che si presenta anch'esso come parte di un'idea regolativa
per una democrazia più vera, quello tra inclusione e
esclusione, integrità e compromesso.
Cesare Tittarelli era già stato l'anima operaia e sindacale
dell'Organizzazione Anarchica Marchigiana che con Tullio, giovani
studenti nei primi anni '70, abbiamo condiviso. Cesare ci ha
lasciato da un po' d'anni. Non c'è alcuno che, avendolo
frequentato, non gli abbia riconosciuto intelligenza, passione,
dedizione.
Tullio Bugari lo fa qui con discrezione, dentro il protagonismo
collettivo di una lunga vertenza operaia, magistralmente narrata
come epopea di un'intera comunità.
Massimo Lanzavecchia
Cultura proletaria o bolscevica?/
La rivoluzione parte da noi
“Più lo frequentava e più si rendeva conto
che il limite di Gor'kij non era la scarsa attitudine per la
filosofia. Il suo vero problema era non saper decidere tra due
innamoramenti: da un lato sé stesso, dall'altro la società.
Quando la voce interiore gli sussurrava “io, io, io”
subito si sentiva colpevole per non aver pensato “noi,
noi, noi”. Allora, per dimostrarsi all'altezza del suo
ruolo intellettuale, scriveva un peana per l'Umanità,
l'unico vero Dio che bisognava costruire e adorare insieme [...].
Il giorno seguente, però, l'idea di una simile fusione
lo preoccupava, perché lo avrebbe privato dell'ammirazione
altrui [...]. Alto sul piedistallo, gridava “noi”
con tutto il fiato, ma il suo era soltanto un plurale maiestatis”.
Questo breve paragrafo, che nulla rivela della curiosa trama
di questo romanzo, Proletkult (Wu Ming, Einaudi, Torino
2018, pp. 333, € 18,50), ne “spoilera” invece
a mio giudizio le intenzioni.
In quella discrepanza – fondamentale eppure spesso così
difficile da cogliere – tra il “noi” e il
“plurale maiestatis” si annidano sogni e bisogni,
ideologie e fallimenti, rivoluzioni e restaurazioni. E non solo
nella storia di cui qui si tratta, quella del post-Grande-Rivoluzione-d'Ottobre;
ma in quella di tante altre rivoluzioni, avvenute prima o dopo
o mai.
 Il
Proletkult, l'Organizzazione Culturale-Educativa Proletaria,
era stato fondato a Mosca poche settimane prima della Rivoluzione,
dal critico marxista e intellettuale bolscevico, nonché
scrittore di fantascienza, Aleksandr Bogdanov autore del famoso
romanzo “Stella rossa”. Il
Proletkult, l'Organizzazione Culturale-Educativa Proletaria,
era stato fondato a Mosca poche settimane prima della Rivoluzione,
dal critico marxista e intellettuale bolscevico, nonché
scrittore di fantascienza, Aleksandr Bogdanov autore del famoso
romanzo “Stella rossa”.
Nelle intenzioni del promotore, questa organizzazione avrebbe
dovuto gettare le fondamenta per un'arte e una cultura profondamente
proletarie, scevre da influenze e sfumature borghesi. Bogdanov
credeva nella rivoluzione, della quale era stato convinto fautore;
ma era al tempo stesso consapevole che la “rivoluzione
agita” non sarebbe durata a lungo senza una base culturale
costruita dal basso, a-gerarchica, solidale e cooperativa. L'emergere
di una vera arte proletaria, creata dai proletari per i proletari,
priva degli orpelli della cultura borghese, avrebbe gettato
fondamenta sicure, sulle quali edificare concretamente il sogno
del mondo giusto e uguale.
L'idea del Proletkult funzionò oltre le aspettative;
in tutto il paese fiorirono istituti, scuole, laboratori e corsi,
allo scopo non solo di insegnare ai lavoratori a leggere, ma
anche di incoraggiarli a “produrre” vere e proprie
opere teatrali, letterarie, poetiche.
A soli tre anni dalla sua fondazione il Proletkult vantava più
iscritti di quanti ne aveva il Partito, cioè mezzo milione
circa. E se il prodotto letterario/artistico di tanto fervore
non sempre poteva definirsi degno di gloria imperitura, certamente
colpisce l'energia creativa che così tante persone tirarono
di colpo fuori dal cassetto dei desideri.
Il Proletkult non era controllato direttamente dal Partito,
però era sovvenzionato dallo Stato; questa sorta di libertà
condizionata, per quanto forse inevitabile in quel contesto,
ne decretò ben presto la fine; osteggiato dai leninisti
che esigevano la centralizzazione del potere negli apparati
statali, fu presto inglobato nell'apparato burocratico dell'Unione
Sovietica, per essere poi abolito da Lenin nel '23.
Il Dottor Bogdanov fu spedito a dirigere il centro trasfusionale
di Mosca, dove il suo agognato collettivismo letterario dovette
cambiare forma e trasformarsi in “collettivismo fisiologico”
o “comunismo del sangue”, basato su pratiche trasfusionali.
Bè, meglio di niente.
Fin qui i fatti e la storia. Dentro i quali e la quale, nel
romanzo ambientato nel 1927, dunque dieci anni dopo la rivoluzione
e con Lenin già imbalsamato, si infilano nientepopodimeno
che... gli alieni. Nello specifico Denni, ragazza dall'aspetto
androgino proveniente dal lontano pianeta Nacun. Dove il socialismo
reale regna sovrano già da un bel po', comunque da abbastanza
tempo per vederne con chiarezza tutti i limiti e dover correre
altrove a cercar rimedi.
L'incontro tra Bogdanov e Denni – sul pianeta terra per
rintracciare suo padre, Voloch, vecchio rivoluzionario amico
di Bogdanov – dà il via a una serie di vicende
condite di discussioni, confronti e racconti dai quali emerge
un quadro credibile, a tratti ironico a tratti malinconico,
dei protagonisti di quel pezzo di storia così importante
per il destino dell'Europa e del mondo.
Il punto di vista della ragazza – ovviamente considerata
un caso clinico, e come tale trattata – apre a Bogdanov
prospettive insolite, lo costringe in qualche modo a rileggere
passato e presente; lo conduce a un finale dove i “padri”
si scambiano i ruoli perché “i figli sono di chi
li cresce” o di chi per loro crea un pianeta dove possano
crescere e vivere, se non nel modo perfetto, almeno nel modo
più giusto possibile.
Romanzo storico, fantascientifico, di riflessione sociale e
politica, nessuno di questi, di tutti un po'.
Il “socialismo agito” visto dal futuro, o da pianeti
lontani, rivela tutti i suoi limiti.
Perché ahimè, quando i sogni si trasformano in
vita reale, si traducono facilmente in privilegi, invidie, sospetti,
punizioni.
Il potere accentrato taglia via la volontà di emancipazione,
l'energia rivoluzionaria, il potenziale dei singoli moltiplicato
dal collettivo. E i sogni finiscono per diventare di un triste
colore molto simile al grigio.
Dalla Rivoluzione ai ministeri, il passo per alcuni non è
così lungo; le barricate si tramutano in ricordi, i whisky
di pregio in una comoda realtà. Gli ostinati, i sognatori,
quelli che davvero ci credevano, vengono spostati, trasferiti,
messi a fare altro; gli altri, gli improvvisamente ubbidienti,
gestiscono poterini e miserie burocratiche, sono i Varenucha
e i Nikanor Ivanovic di Bulgakov ne “il Maestro e Margherita”.
E lì non bastano nemmeno gli alieni, deve scendere in
terra il Diavolo in persona a risistemare qualche equilibrio.
Ammesso che esista la ricetta per una rivoluzione duratura,
dobbiamo cercarla dentro di noi, prima che contro qualcun altro.
O, meglio, le rivoluzioni esteriori devono corrispondere a quelle
“dentro”. Nessuna rivoluzione sopravvive a lungo
quando il “noi” è un plurale maiestatis;
e nessuno di noi è del tutto immune a questa contraddizione.
Facile a dirsi, difficilissimo a farsi.
Forse dovranno davvero venire gli alieni, ad aiutarci a casa
nostra.
O magari il diavolo, chissà.
Claudia Ceretto
Racconti/
La Calabria di ieri e di oggi
I racconti di Angelo Gaccione (L'incendio di Roccabruna,
Di Felice Edizioni, Martinsicuro - Te 2019, pp. 120 € 12,00)
sono ambientati in un paesino della Calabria al quale l'autore,
originario di Acri (CS), ha dato un nome di fantasia, “Roccabruna”.
Al pari del più noto paesello siculo di “Vigata”,
reso celebre dai racconti di Camilleri, i cittadini che lo abitano
hanno caratteristiche varie, ricoprono ruoli diversi, appartengono
a classi sociali molto distanti tra loro e quindi in contrasto
fortissimo per interessi economici e opzioni culturali, politiche
e sociali diverse.
Il libro contiene quindici racconti, storie estreme e truci
(storie di briganti, di vendette, di soprusi, di follie, di
ignoranza, di abusi e misfatti del potere, di fanatismi religiosi...),
come scrive nella sua bella prefazione Vincenzo Consolo, che
si consumano in un luogo abitato da gente dallo spirito vendicativo.
 Nel
racconto “Il Sacrilegio” si parla di Roccabruna
come di un paese caratterizzato politicamente dalla presenza
di circa 200 anarchici, “duecento teste calde che non
aspettano altro. Nel disordine ci sguazzano come vermi nell'acqua
marcia”, dove la vendetta viene vista come un dovere sociale,
come il giusto epilogo di uno scatto di dignità, di una
rivolta necessaria ritenuta, da un sottoproletariato perennemente
umiliato, come “l'unico perdono possibile”. Nel
racconto “Il Sacrilegio” si parla di Roccabruna
come di un paese caratterizzato politicamente dalla presenza
di circa 200 anarchici, “duecento teste calde che non
aspettano altro. Nel disordine ci sguazzano come vermi nell'acqua
marcia”, dove la vendetta viene vista come un dovere sociale,
come il giusto epilogo di uno scatto di dignità, di una
rivolta necessaria ritenuta, da un sottoproletariato perennemente
umiliato, come “l'unico perdono possibile”.
Di queste vendette sono piene le cronache di fine Ottocento-inizi
Novecento, consumate contro chi sparava e torturava la povera
gente, sicuro di godere della stessa impunità che non
fu accordata né al Re Vittorio Emanuele III, giustiziato
da Gaetano Bresci e neppure al colonnello della Polizia di Buenos
Aires, Ramòn Falcòn, fatto saltare in aria da
Simon Radowitsky, solo per citare alcuni “gesti eroici”
che, piacenti o nolenti, fanno comunque parte della storia del
movimento anarchico internazionale.
Anche nella filmografia più recente vengono rappresentate
storie in cui la rivolta singola e/o popolare si manifesta in
modo violento. Basti ricordare i film Novecento di Bertolucci
o V per Vendetta di James Mc Teigue, nei quali ritorna
il tema del “giustiziere politico e sociale” che,
con un sol gesto individuale, pensa di regalare il definitivo
riscatto ad interi popoli. In ogni singolo racconto, Gaccione
descrive con così grande accuratezza e precisione i protagonisti
che sembra quasi di vederli: il loro temperamento, le delusioni,
le umiliazioni che subiscono si riflettono tristemente sulle
vite dei familiari, spesso donne umili e bimbi così piccoli
da giustificare la rabbia che spinge il soggetto sfruttato alla
ribellione.
In modo molto efficace, l'autore non si disperde nel riannodare
i fili di una tirannia storica, che affligge la Calabria da
migliaia di anni, ma utilizza singoli episodi, detti popolari
e proverbi che più di ogni artificio letterario rendono
chiarissimo il contenuto e lo spirito degli episodi di ribellione.
Al tempo dei Borboni, anche in Calabria nacque il brigantaggio,
fenomeno resistenziale durato oltre quindici anni, di cui l'autore
fa cenno nel racconto dal titolo “La taglia”.
Il brigante Natale Cozza, protagonista di questo racconto, rivolgendosi
ai cittadini avverte: “La ricchezza si è fondata
sulla frode e sul delitto. Pensateci ogni qual volta vi chinate
a riverire”. Una volta finito il dominio in Calabria,
i Borboni furono sostituiti egregiamente, nel Novecento, da
una borghesia creatasi, come affermava Corrado Alvaro, nell'ultima
guerra con la “borsa nera”.
Una borghesia, ricordava Pier Paolo Pasolini, “arroccata
su posizioni dolorosamente antidemocratiche, convenzionali,
servili”.
Gaccione, nei suoi racconti intrisi di ingiustizie e dolori,
constata l'amarezza della vita soprattutto nell'azione di uomini
e donne che invece di prendere coscienza si dimenticano di essere
stati servi e diventano a loro volta aguzzini. Nel racconto
dal titolo “L'incendio di Roccabruna”, il padrone
Vincenzo Baffi impone una cena a casa di Turi Corda, il fattore
considerato da lui meno di uno schiavo. Durante il pranzo, il
barone Baffi chiede a Corda “A chi appartieni tu?”.
“A Voscienza” risponde l'uomo. E poi, non soddisfatto,
continua a chiedere al fattore, sghignazzando, a chi appartenessero
il casolare, la moglie, le scarpe, e i pensieri, e l'aria che
respira, e gli uccelli, e l'acqua che vi scorre, ottenendo sempre
la solita risposta ubbidiente: “A Voscienza”.
Alla fine, preso da un delirio di onnipotenza, il barone arriva
all'obiettivo prefissato: “E Nerina?” (la figlia
giovanissima e bella del fattore). “Nerina è sangue
mio” risponde Tulli Corda con una dignità che nessuno
si aspettava. Quella risposta gela l'aria, il viso di don Vincenzo
diviene satanico e, più cattivo che mai, urla ai suoi
sgherri con gli occhi venati di sangue... “Sgozzatelo!”
Quella descritta dall'autore è una parte importante della
storia della Calabria di allora; quella di oggi, grazie a meccanismi
e sistemi di potere sofisticati, a dinamiche meno evidenti,
sottili e alquanto complesse è, per certi versi, ancora
peggiore.
Angelo Pagliaro
Egitto/
Cosa resta della primavera
Sono passati ormai più di otto anni da quell'ondata
di proteste e di rivendicazioni che ha attraversato gran parte
del Nord Africa e del Medio Oriente e che oggi ricordiamo come
“primavera araba”. In Egitto il 25 gennaio 2011
una folla di manifestanti si riversava per le strade del Cairo
denunciando la corruzione dilagante e richiedendo le dimissioni
di Hosni Mubarak, al potere ininterrottamente da un trentennio.
Le immagini di Piazza Tahrir e di quelle migliaia di persone
che la occuparono per giorni rimbalzavano in tutto il mondo
e facevano da eco alle rivendicazioni dei manifestanti che invocavano
libertà, democrazia e giustizia sociale. Dopo diciannove
giorni Mubarak cadde, ma per l'Egitto non si è aperta
quella fase di pluralismo e democrazia in cui molti avevano
sperato.
 L'egiziano
'Ala al-Aswani, dentista di professione nonché uno dei
più apprezzati scrittori arabi contemporanei, ha preso
parte alla rivolta e scritto diversi testi a riguardo; Sono
corso verso il Nilo (Feltrinelli 2018, pp. 384 € 18,00)
è uno di essi. Mantenendosi in equilibrio sulla linea
di confine tra cronaca, testimonianza e narrativa, al-Aswani
dà vita a molteplici personaggi le cui vite si intrecciano
e si condizionano, e con la sua abilità nello strutturare
i capitoli in modo che il fuoco si sposti costantemente da una
vicenda all'altra, crea un gioco di suspense in grado di trattenere
il lettore fino all'ultima riga, lasciandogli poi il bisogno,
terminato il romanzo, di metabolizzare con calma e riflettere. L'egiziano
'Ala al-Aswani, dentista di professione nonché uno dei
più apprezzati scrittori arabi contemporanei, ha preso
parte alla rivolta e scritto diversi testi a riguardo; Sono
corso verso il Nilo (Feltrinelli 2018, pp. 384 € 18,00)
è uno di essi. Mantenendosi in equilibrio sulla linea
di confine tra cronaca, testimonianza e narrativa, al-Aswani
dà vita a molteplici personaggi le cui vite si intrecciano
e si condizionano, e con la sua abilità nello strutturare
i capitoli in modo che il fuoco si sposti costantemente da una
vicenda all'altra, crea un gioco di suspense in grado di trattenere
il lettore fino all'ultima riga, lasciandogli poi il bisogno,
terminato il romanzo, di metabolizzare con calma e riflettere.
Tanti sono i protagonisti di questa storia, tra essi spiccano
Asma, giovane insegnante che rifiuta di indossare il velo, e
Mazen, ingegnere impegnato nel difendere le rivendicazioni degli
operai del cementificio in cui lavora. Entrambi lottano contro
la corruzione nei rispettivi ambienti di lavoro e scendono in
strada insieme, scoprendo in se stessi una forza che forse non
credevano di avere e innamorandosi una dell'altro. C'è
poi Ashraf Wissa, ricco cristiano copto di mezza età,
che vive di rendita e sognava un tempo di diventare un grande
attore; Ashraf è profondamente scontento della propria
esistenza, solo l'hashish e il suo sarcasmo gli permettono di
andare avanti, fino a che la rivolta irrompe nella sua routine,
esattamente sotto il suo balcone. La vista dei primi giovani
morti sotto i colpi dell'esercito lo sconvolge, scopre che fuori
dal piccolo mondo in cui si era rintanato c'è una generazione
che ha deciso di lottare per cambiare le cose anche a costo
della vita, e insieme a Ikram, la domestica con cui aveva una
relazione clandestina, ma che diventa sempre più una
donna che ama e stima, una compagna, si unisce a quei ragazzi
cambiando nel profondo.
Sono corso verso il Nilo non ci porta solo tra le strade
e nelle piazze del Cairo: questo romanzo è anche la storia
di un regime che viene preso alla sprovvista da una ribellione
che non si aspettava, un regime disposto a sacrificare il suo
“uomo forte”, ma allo stesso tempo disposto a tutto
purché l'Egitto non cambi davvero. Ed 'Ala al-Aswani
ci accompagna dietro le quinte del potere, mostrandoci l'utilizzo
della religione per manipolare gli individui, lo sporco lavoro
dei servizi segreti del generale Ahmed 'Alwani e l'apparato
di menzogne propagandate dai media attraverso figure come quella
dell'abile presentatrice Nurhan, bugie diffuse con lo scopo
di spingere il popolo a invocare la sicurezza e a dissociarsi
dai ribelli. Ci racconta poi delle violenze di un esercito che
uccide e tortura, senza che le vittime abbiano possibilità
alcuna di ottenere giustizia in un'aula di tribunale, nemmeno
dopo la caduta del dittatore, quando avevano creduto che si
stesse finalmente delineando il mondo da loro immaginato. E
ci ricorda infine che spesso il corpo delle donne è campo
di battaglia, e quelle sono le pagine più dure da leggere.
Complessa è la figura di 'Issam Sha'lan che in qualche
modo rimane a cavallo tra queste due spinte contrapposte della
società: comunista e ribelle in gioventù, non
ha sopportato le torture e le umiliazioni inflittegli in carcere,
e si ritrova da direttore di una fabbrica che sopprime gli scioperi
degli operai, a osservare l'Egitto sollevarsi contro il suo
governo, facendolo dubitare di quella certezza che si era dovuto
costruire per scendere a compromessi con il potere, ovvero che
gli egiziani non avrebbero mai potuto reagire, e che chiunque
avesse voluto lottare, sarebbe stato lasciato solo.
Con Sono corso verso il Nilo 'Ala al-Aswani ha lavorato
partendo dalla propria esperienza in piazza Tahrir, dalle persone
che ha incontrato e con cui ha discusso, per scrivere un romanzo
e dare vita a personaggi che affrontano momenti realmente accaduti.
Intrecciando realtà e finzione ci restituisce il quadro
di un evento che è accaduto da poco, ma che è
già storia. E con la consapevolezza che questo romanzo
non restituisce del tutto la complessità degli eventi
accaduti e della molteplicità delle forze in campo, che
non è un saggio socio-politico ma narrativa, credo che
possa aiutarci a comprendere qualcosa in più.
Diana Galletta
Intorno al '68/
Storia di utopia e speranze
A distanza di 50 anni, il '68 è diventato materia di
studio nelle scuole medie superiori e nelle Università.
La puzza e la forza dirompente dei lacrimogeni, la violenza
scagliata contro gli studenti e contro i lavoratori, in breve
contro il binomio studenti-operai, la mobilitazione continua
di quell'anno in particolare e del lungo decennio successivo,
sono fatti che, per così dire, con il tempo si sono smaterializzati,
fino a diventare oggetto di pensiero e di riflessione.
 Si
è in presenza di fatti storicizzati, del tutto facenti
parte della comune nostra percezione sociale. Il '68 è
il termine di riferimento ormai diffuso concernente l'inizio
di una nuova epoca storica del Paese, come del resto dappertutto. Si
è in presenza di fatti storicizzati, del tutto facenti
parte della comune nostra percezione sociale. Il '68 è
il termine di riferimento ormai diffuso concernente l'inizio
di una nuova epoca storica del Paese, come del resto dappertutto.
Scrittori, storici, professori, ricercatori ne hanno fatto materia
di nostalgica rievocazione, argomento di corsi universitari,
materia di ricerca degli e sugli snodi ed i meccanismi sociali
e politici postsessantotteschi, che hanno consegnato il Paese,
pur scosso, rinnovato e ribaltato dal '68, al prevalente, consistente
e maggioritario blocco attuale di potere.
Tutto ciò è pur assai lodevole in quanto conserva
la memoria dell'inizio del rinnovamento strutturale e profondo
della nostra società, ancorché rapidamente contrastato
e recuperato dalle forze della conservazione e della reazione.
Ma non sono molti i libri che restituiscono il clima del '68,
i suoi temi, le sue profonde passioni di giustizia e uguaglianze
e le autentiche idealità, la difficile elaborazione ideologica
e politica che affrontarono gli anarchici dell'epoca, assediati
dalla repressione spietata e a rischio di confondersi e disfarsi
nelle varie traduzioni e versioni organizzative politiche del
marxismo e del leninismo.
Massimo Ortalli nella sua introduzione si dichiara convinto
che la storia sia maestra di vita, come ne sono convinto anche
io, e che quanto scritto da Massimo Varengo sia annoverabile
fra “gli strumenti più idonei per capire il presente
e prefigurare il futuro”. Già questo sarebbe sufficiente
per suggerire la lettura del libro.
Con il suo libro Intorno al '68. Utopie e autoritarismi nel
decennio 1968-1977 (Zero in Condotta, Milano 2018, €
7,00) in appena 96 pagine sobrie e sintetiche, Massimo Varengo
ci riporta in pieno a ciò che è stato il '68.
Gli anni raccontati sono stati anni pesantissimi, ma pieni di
speranze e sotto certi aspetti, a guardare la scena attuale,
pieni di generose illusioni.
Il libro tenta, e in gran parte vi riesce, di dare un senso
anarchico a quello che è successo. È articolato
per chiare e lineari descrizioni e talvolta interpretazioni
dei diversi eventi che si sono succeduti. Dal prologo costituito
dalla ribellione cosiddetta giovanile alla società patriarcale
e autoritaria, al vero e proprio '68, allo stragismo e alle
vittime della strategia della tensione, prevalentemente anarchici,
ma non solo, per giungere al movimento del '77 e alla violenza
rivoluzionaria.
La bella introduzione di Massimo Ortalli ci riporta l'eco di
quegli anni e introduce il concetto come la fughe in avanti
di alcuni settori del movimento “divennero il cavallo
di troia con il quale fu possibile scardinare e scompaginare
un intero movimento”. Un concetto che viene sviluppato
dall'autore nel capitolo “Appunti sul movimento anarchico
dal '68 al '77”. Appunti particolarmente importanti perché
nelle pagine dedicate alla progressiva rinascita e sdoganamento
sociale e politico del movimento anarchico, che pure è
stato uno dei principali movimenti politici del nostro Paese
fino all'avvento del fascismo, sono descritti in modo preciso
i passaggi complicati attraverso i quali il movimento ha di
nuovo incontrato e di nuovo fatto proprio, senza però
mai averlo dimenticato, il pensiero del maestro Malatesta.
Enrico Calandri
Rudolf Rocker/
Per un pensiero organico della trasformazione sociale
Contro la corrente (Milano 2018, pp. 208, € 15,00)
è il titolo della raccolta di saggi di Rudolf Rocker
recentemente pubblicata da Eleuthera e curata da David Bernardini
e Devis Colombo. “Contro la corrente” è forse
la definizione che più caratterizza l'identità
storica del movimento anarchico, come scrive lo stesso Rocker,
“malgrado tutto e tutti!”; ma “contro la corrente”
è soprattutto la cifra biografica di Rudolf Rocker, figura
di riferimento del movimento anarchico internazionale fino alla
metà del secolo scorso. Se dovessimo raccontare la storia
della pratica internazionalista degli anarchici ci basterebbe
ripercorrere le gesta del sindacalista tedesco per addentrarci
in una storia dal sapore mitico, ma dai tratti reali. Chi volesse
accingersi in tale avventura potrebbe farlo tuffandosi nelle
centinaia di pagine che l'anarchico tedesco ha donato ai posteri
e che Andrea Chersi ha reso disponibili in italiano.
Bernardini e Colombo regalano al pubblico italiano una raccolta
curata con intelligenza, che valorizza la profondità
della riflessione di Rudolf Rocker. Una riflessione di spessore,
mai accademica, superficiale o, peggio, consolatoria. I saggi
si snodano in un arco temporale che attraversa tutta la guerra
civile europea, dal 1919 al 1953. Ma nonostante la loro età,
leggendoli se ne può ammirare la freschezza. Ed è
qui l'assoluta necessità di scoprire e approfondire la
storia e il pensiero di Rocker, rimasto per troppo tempo nell'ombra,
soprattutto nel contesto italiano in cui lo studio della storia
anarchica non eccelle tra gli argomenti dell'accademia.
 L'inverno
politico che stiamo affrontando è ancora una farsa, seppur
concretamente vera, rispetto al nazifascismo e allo stalinismo
con cui si confrontò Rocker. Siamo ancora ad uno stadio
democraticamente autoritario, e non propriamente fascista. Eppure
l'analisi sviluppata nelle pagine di questi contributi ci parla
con molta franchezza. Sono tre i temi su cui Rocker più
si spende: l'analisi della scure totalitaria; l'autocritica
per il movimento anarchico; il metodo d'intervento di una politica
trasformatrice. L'inverno
politico che stiamo affrontando è ancora una farsa, seppur
concretamente vera, rispetto al nazifascismo e allo stalinismo
con cui si confrontò Rocker. Siamo ancora ad uno stadio
democraticamente autoritario, e non propriamente fascista. Eppure
l'analisi sviluppata nelle pagine di questi contributi ci parla
con molta franchezza. Sono tre i temi su cui Rocker più
si spende: l'analisi della scure totalitaria; l'autocritica
per il movimento anarchico; il metodo d'intervento di una politica
trasformatrice.
Andando in ordine, Rocker leggeva nella dittatura “un'idea
di per sé controrivoluzionaria”, pertanto volgeva
la sua critica tanto ai regimi fascisti quanto al blocco sovietico,
in cui individuava una matrice comune. Raccogliendo questi scritti,
Bernardini e Colombo riportano al centro dell'attenzione le
riflessioni anarchiche sul totalitarismo, la tara della loro
importanza nel processo storico della contemporaneità.
Rocker si inserisce in quella famiglia anarchica che nell'equidistanza
tra regimi fascisti, egemonia bolscevica e democrazie borghesi
ha costituito la propria specificità.
In questi scritti Rocker citava a ripetizione Lenin quando affermava
che “la libertà non è altro che un pregiudizio
borghese”. Per lui non era praticabile una società
migliore nelle torbide maglie di una visione escludente delle
libertà personali poiché “ogni scopo si
impersonifica nei suoi mezzi”. In queste parole sentiamo
echeggiare quelle affinità elettive che hanno spesso
unito, nella temperie fra le due guerre, liberal-socialisti
e anarchici; di chi ritenne discriminante per la propria prassi
politica legare immaginario futuro e coerente pratica quotidiana.
Ma se si fosse limitato a questo, Rocker sarebbe risultato interessante,
ma non illuminante, come a tratti invece appare. A tessere le
fila delle riflessioni dell'anarchico è una costante
verve auto-critica indirizzata alla propria area di appartenenza.
Non è un caso che il secondo articolo di questa raccolta
si apra con la denuncia della crisi del movimento anarchico.
Una crisi che nel 1927, anno di pubblicazione dello scritto
in questione, era palese su entrambe le sponde dell'atlantico.
Meno evidente erano le tracce di cosa rappresentasse quella
crisi, da cosa fosse data, come quindi era necessario intervenire
per invertirne la rotta. In questo Rocker è diretto,
non naviga a vista in analisi consolatorie sull'avanzata fascista:
“noi siamo diventati troppo dottrinari e pensiamo a molte
più cose più con la mentalità dei nostri
predecessori che con la nostra”. È la stessa impostazione
che lo caratterizzerà più di vent'anni dopo, quando
nel 1953 denuncerà la “stagnazione mentale”
che conduce a dimenticare “che anche il tempo scorre e
con lui tutti i mezzi che sono nati dal suo grembo”.
Le considerazioni del vecchio anarchico erano indirizzate su
molteplici direttrici, per quanto riguarda i suoi compagni,
la critica si assestava sul fatuo rivoluzionarismo intransigente,
incapace di leggere la rilevanza delle piccole riforme nel processo
rivoluzionario (senza necessariamente accomodarsi sul riformismo
politico); sia nei limiti di una visione economicista che vedeva
nella lotta economica “un fine in sé”.
Non è questo il luogo per approfondire i temi citati,
che pure Rocker affronta con mirabile chiarezza e capacità
di sintesi. Per chiudere è necessario spendere qualche
parola sul passaggio che dalla critica dell'economicismo ci
porta all'ultimo punto che credo possa sintetizzare la sua visione:
la necessità di uno “sviluppo organico nella trasformazione
sociale”. Rocker immaginava e costruiva delle linee per
una pratica rivoluzionaria che fosse al tempo stesso liberatrice
e libertaria.
Sfogliando le pagine di questa pubblicazione, andando avanti
e indietro tra gli articoli, i tre temi che qui ho brevemente
sintetizzato si intrecciano, si parlano a vicenda, se a tratti
uno sembra più rilevante, subito dopo torna a confrontarsi
con una visione complessiva della politica. Una visione organica,
appunto, che parte dalla riappropriazione del socialismo come
“in ultima istanza una questione culturale”. L'attenzione
di Rocker andava all'”universo mentale” su cui intervenire,
all'idea, come scrivono bene in introduzione Colombo e Bernardini
che “una premessa fondamentale per la messa in atto del
socialismo fosse la più larga diffusione e comprensione
possibile dei suoi presupposti culturali”.
A chiudere il volume sono due saggi. Il primo del traduttore
Nino Muzzi e il secondo del curatore David Bernardini. Mentre
il primo offre riferimenti sul linguaggio del nostro, il saggio
di Bernardini bene inquadra la vicenda storiografica dell'anarchico,
la sua biografia e la necessità di approfondirne lo studio.
Speriamo sia solo la prima tappa di un percorso proficuo.
Oreste Veronesi
Malamente/
Una rivista di lotta e critica del territorio
Alla redazione di Malamente abbiamo chiesto una presentazione della rivista. Eccola.

 “malamente
vanno le cose, in provincia e nelle metropoli “malamente
vanno le cose, in provincia e nelle metropoli
malamente si dice che andranno domani
malamente si sparla e malamente si ama
malamente ci brucia il cuore per le ingiustizie e la rassegnazione
malamente si lotta e si torna spesso conciati
malamente ma si continua ad andare avanti
malamente vorremmo vedere girare il vento
malamente colpire nel segno
malamente è un avverbio resistente
per chi lo sa apprezzare.”
Tutto va malamente, si direbbe in questi tempi, ma a ben guardare
non sempre le cose vanno male per noi, a volte una lotta riesce
a colpire malamente, ad aprire crepe nei muri e nelle catene
che tengono imprigionate le vite e i desideri di chi è
oppresso e sfruttato. L'incertezza e la crisi di questi tempi
sono anche possibilità che si aprono, vecchie certezze
che crollano.
Malamente è una rivista completamente autoprodotta
e autofinanziata, che esce ogni tre o quattro mesi. È
nata nella primavera del 2015 per ospitare spunti di approfondimento
e riflessione collettivi, per una condivisione dei saperi e
delle pratiche di critica sociale, per aprire prospettive concrete
di liberazione. È un cantiere aperto di sperimentazione
culturale e politica sul territorio delle Marche, tra l'Appennino
e la costa, ma non rispetta nessuna frontiera anche perché
pensiamo che le lotte sociali possano e debbano costruire le
proprie nuove geografie.
Siamo consapevoli che una lettura realmente efficace dell'esistente
non può essere calata dall'alto al basso come criterio
di descrizione ideologica, perciò percorriamo il percorso
opposto e a partire da ogni ambito del quotidiano in cui sperimentare
una trasformazione rivoluzionaria ci spingiamo a osservare,
ascoltare, dialogare con gli individui e le collettività
e con le loro – e nostre – contraddizioni. Quanto
più lontani dal replicare l'ennesimo spazio identitario
legato a una sub-cultura rivolta su se stessa, vogliamo calarci
nelle lotte sociali presenti sul territorio per individuarne
le connessioni, trarne gli opportuni stimoli e tentare il contrattacco
rifiutando l'arte di scegliere il male minore.
Il timone della rivista è rivolto a proporre uno sguardo
sul presente che abbia a cuore la libertà. Orientato,
quindi, alla necessaria critica sociale, dal momento che quello
che non manca, anche qui nella periferica provincia marchigiana,
sono le buone ragioni per opporci a un'organizzazione sociale
che mostra sempre più, se ancor ce ne fosse bisogno,
la propria insensatezza prima ancora che insostenibilità.
Sotto traccia, vi è il desiderio di rompere l'accerchiamento
del progresso a tutti i costi e della mercificazione dell'esistente,
per recuperare le capacità di saper agire nel mondo.
“Malamente” esce in formato cartaceo: scelta dettata
dalla volontà di riappropriarci di un mezzo di comunicazione
stabile e che induce alla lettura piana e riflessiva. Riteniamo
infatti che troppo spesso molti contenuti vengano oggi veicolati
esclusivamente online e finiscano per perdersi dentro il frettoloso
consumo quotidiano della rete. Nell'ottica della libera circolazione
dei saperi, tutti gli arretrati sono disponibili gratuitamente
in pdf sul sito della rivista. Benché consapevoli dei
limiti e dei danni dei social network, abbiamo comunque profili
facebook, mastodon e twitter con cui stiamo costruendo una rete
di relazioni e contatti. Soprattutto, auspichiamo di trovare
nuovi complici lungo la strada.
Nell'ultimo numero (#14, maggio 2019) trovate allegate sette
cartoline “d'autore/autrice”, disegnate da Aladin,
Marco Bailone, Emma Bignami, Blu, Samuele Canestrari, Prenzy
e Zerocalcare. Si tratta di un'iniziativa di solidarietà
– promossa in collaborazione con le riviste Nunatak e
NurKuntra – in sostegno di alcuni anarchici e anarchiche
recentemente arrestati tra Torino e Trento perché amano
(parecchio!) la libertà e per difendere quella di tutti/e
noi che siamo fuori ma comunque prigionieri di un presente autoritario
e becero che deve finire.
Siamo sempre in cerca di proposte e collaborazioni. Contattateci
e scrivete per Malamente!
Se volete leggere o scaricare gli arretrati, li trovate qui:
https://malamente.info/numeri-usciti
Malamente. Rivista di lotta e critica del territorio
1 numero: 3 euro.
Distributori (da 3 copie): 2 euro.
Abbonamento (sostenitore), 4 numeri: 15 euro.
www.malamente.info
malamente@autistici.org
fb: www.facebook.com/malamente.red
la redazione di Malamente
Orientalismo/
Ripubblicato un librone degli anni '30
Qualcuno fra i nostri lettori ricorderà l'intenso e
vivace dibattito sviluppatosi un paio d'anni fa su queste pagine
(“A” 416
e 417, rispettivamente
maggio e giugno 2017) intorno al tema, in verità poco
frequentato, dell'orientalismo.
Quella interessante discussione tra studiosi, operanti peraltro in contesti ambientali (Inghilterra, Spagna, Italia, Egitto) assai diversificati, sia dal punto di vista culturale che accademico e politico, si concludeva con l'auspicio di proseguire il confronto in ambito internazionale e di approfondire con particolare attenzione ed impegno proprio quelle ricerche di settore dedicate agli anarchici, “visti ogni volta sotto qualche prisma particolarmente contraddittorio”, come appunto l'orientalismo. Con il termine orientalismo – tanto per precisare – si intende quella rappresentazione stereotipata delle culture e degli ambienti orientali fatta in genere da scrittori e artisti occidentali.
In tal senso questo nuovo libro di memorie (Romolo Garbati, Mon aventure dans l'Afrique civilisée, édition notes et dossier Paul-André Claudel, Alexandrie (Égypte), Centre d'Études Alexandrines 2018, pp. 330, € 20,00), terza uscita della Collection Littérature Alexandrine, scritto in francese e pubblicato ad Alessandria d'Egitto nel 1933, oggi riedito e arricchito di note, dossier e vari apparati utili alla lettura, costituisce una possibile fonte primaria e di verifica diretta sul tema.
Romolo Garbati (1873-1942) anarchico sardo, tipografo, impegnato fin da giovane nella militanza, costretto nel 1902 a lasciare l'Italia per sfuggire alle prigioni e alle persecuzioni, approda in Tunisia e in Algeria prima di stabilirsi al Cairo e ad Alessandria. È uno dei tanti dimenticati che composero la numerosa e multiforme diaspora libertaria nel XX secolo. Svolge un'intensa attività pubblicistica sulla stampa di movimento e intraprende poi la carriera giornalistica, diventando direttore de «Il Messaggero Egiziano», il principale quotidiano italiano nell'area del Vicino oriente, attenuando col tempo – così diranno almeno le carte di polizia – la sua originaria fede anarchica.
Il titolo del volume non inganni. Il riferimento a “l'Afrique civilisée” è volutamente ironico; perché all'epoca – e, si deve dire, ciò è stato per lungo tempo – quasi tutta la letteratura sull'argomento si imperniava su argomentazioni stucchevoli e stereotipate, richiamando il fascino dell'avventura in un continente selvaggio, soddisfacendo insomma quel classico “bisogno” di esotismo coloniale così in voga nelle società dell'occidente progredito. Al contrario l'autore ci propone il racconto autobiografico di un significativo e singolare viaggio, effettuato in epoca primonovecentesca, nelle grandi città nordafricane (Algeri, Tunisi, Il Cairo, Alessandria), dove sussistono, insieme ad una borghesia cosmopolita e occidentalizzata, formata in larga parte da rifugiati ed emigrati, luoghi di immensa tribolazione e miseria. Diario di un esule e “viaggio di un passeggero di terza classe” (secondo la definizione dello stesso autore) e “odissea senza ritorno”, lo scritto ci fornisce un efficace spaccato sociale di quel mondo caratterizzato da grandi separatezze e contraddizioni; e ci dà anche spunti per meglio comprendere gli orizzonti mentali che pervadono quelle comunità di sradicati e le loro rarefatte connessioni con l'ambiente umano circostante.
Dal racconto emerge una perfetta istantanea su quel milieu fatto di emarginati, avventurieri, sovversivi e rivoluzionari sognatori, ma ci appare anche “la migliore foto di gruppo” sulla stampa eurofona allora presente sull'altra sponda del Mediterraneo.
All'editing raffinato di questa pubblicazione si affianca una ricca appendice, curata da Paul-André Claudel, con bibliografia e una biografia: Ritratto di un giornalista e libero pensatore, Romolo Garbati negli archivi del Casellario politico centrale. Davvero pregevoli le foto a corredo.
Nel momento in cui usciva la prima edizione di questo volume – scrive il prefatore Daniel Lançon – un altro sardo, Antonio Gramsci, terminava i suoi Quaderni del Carcere, richiamando così i concetti di “subalternità” su cui poi poggeranno la storia sociale e della quotidianità, le storie di vita in auge qualche decennio più tardi. Da tale punto di vista il libro, “nouvelle micro-histoire de l'anarchisme”, si inserisce a pieno in questa tipologia di studi.
Giorgio Sacchetti
Autoritarismo, metodi, libertà/
L'attualità della rivoluzione russa
Il libro curato da Antonio Senta (Gli anarchici e la rivoluzione
russa (1917-1922), Mimesis, Sesto San Giovanni 2019, pp.168
€ 14,00) raccoglie gli atti di un seminario promosso dall'Archivio
Famiglia Berneri – Aurelio Chessa e dalla Biblioteca Panizzi
di Reggio Emilia tenutosi l'1-2 dicembre 2017.
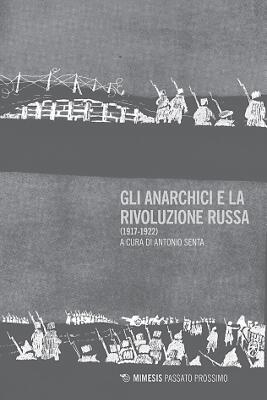 In
ogni intervento emerge un'accurata documentazione, a riprova
della competenza espositiva degli autori e di un dibattito più
che mai attuale su un tema che, dopo anni di stasi, rinnova
l'interesse storiografico grazie a documenti non più
segretati dagli archivi sovietici. Fra le riflessioni, che l'eco
del centenario del '17 ha suscitato, vi sono molti aspetti della
critica che il movimento anarchico, pur nella sua complessità,
elaborò già in prossimità di questi eventi,
anticipando analisi e alternative. Ne è esempio la proposta
autogestionaria (libera sperimentazione nel linguaggio di E.
Goldman) nel suo profilo di compatibilità con il processo
rivoluzionario: non la mera accettazione di un'aleatoria futura
emancipazione subordinata a un autoritarismo “temporaneo”,
ma la ricerca di una coerenza fra mezzi e fini su criteri di
libertà. In
ogni intervento emerge un'accurata documentazione, a riprova
della competenza espositiva degli autori e di un dibattito più
che mai attuale su un tema che, dopo anni di stasi, rinnova
l'interesse storiografico grazie a documenti non più
segretati dagli archivi sovietici. Fra le riflessioni, che l'eco
del centenario del '17 ha suscitato, vi sono molti aspetti della
critica che il movimento anarchico, pur nella sua complessità,
elaborò già in prossimità di questi eventi,
anticipando analisi e alternative. Ne è esempio la proposta
autogestionaria (libera sperimentazione nel linguaggio di E.
Goldman) nel suo profilo di compatibilità con il processo
rivoluzionario: non la mera accettazione di un'aleatoria futura
emancipazione subordinata a un autoritarismo “temporaneo”,
ma la ricerca di una coerenza fra mezzi e fini su criteri di
libertà.
È Alexander Shubin a delineare l'excursus delle diverse
fasi della rivoluzione, intesa come “l'ariete che elimina
gli ostacoli allo sviluppo sociale”, sottolineandone gli
aspetti meno scontati o tralasciati dalla divulgazione.
Marcello Flores s'addentra nel diversificato coinvolgimento
anarchico degli eventi fino all'insorgere dei contrasti alla
svolta autoritaria. “Le critiche circostanziate e articolate
(...) si accompagnarono a tentativi pratici di organizzazione
sociale” che a distanza di anni suggeriscono “interpretazioni
significative”: alle “speranze di emancipazione
sociale” si sostituì “una serie di delusioni,
di smentite, di disillusioni e di sconfitte”.
Giuseppe Aiello, con un'esposizione accattivante ma rigorosa,
si concentra sui “forti connotati da democrazia diretta”
che fecero di Kronstadt un teatro favorevole alla “realizzazione
di una nuova società basata su rappresentanze di lavoratori”.
Un'esperienza sulla quale incombe una “graduale repressione”
fino alla mancata terza rivoluzione e al “definitivo passaggio
al terrore rosso come strumento di attuazione del dominio”.
Mikhail Tsovma s'inoltra in “uno degli esperimenti sociali
più significativi della rivoluzione russa”: la
riforma agraria attuata dal movimento machnovista. La “brutale
repressione dei bolscevichi” continuerà nella denigratoria
propaganda di regime che soltanto negli ultimi tre decenni ha
potuto essere dipanata a vantaggio di una conoscenza più
completa.
All'unica voce femminile il compito di ricostruire gli ultimi
anni di P. Kropotkin, quando torna in Russia dedicandosi all'impegno
sociale e agli ultimi scritti. Selva Varengo racconta della
grande accoglienza ricevuta dopo l'esilio e delle difficoltà
affrontate in un contesto nel quale “i mezzi dittatoriali
adottati dai bolscevichi” si svelano via via più
cruenti. L'esposizione dell'autrice è ancor più
coinvolgente nel passaggio sui funerali: il “lungo corteo
di migliaia di persone, non autorizzato” passò
dalla “prigione di Butyrka dove i detenuti scuotono le
sbarre delle celle intonando canti anarchici”.
Pietro Adamo analizza l'evoluzione del pensiero di E. Goldman
e A. Berkman rispetto agli eventi rivoluzionari: i tentativi
di ricomporre un'idealità di supporto all'emancipazione
sociale in un clima di incertezza ricostruito attraverso i reciproci
scritti più noti e un fitto epistolario meno conosciuto.
Emerge una “prospettiva interpretativa (...) differente:
più decisa, aspra, convinta, Goldman, più dubbioso,
possibilista, persino più conciliativo, Berkman”.
Su quest'ultimo si sofferma Roberto Carocci descrivendo come
da un “atteggiamento non pregiudiziale” segnato
da “forti aspettative” giungerà dopo due
anni a “un giudizio radicalmente opposto”, quando
il pretesto della minaccia controrivoluzionaria non è
più in grado di mascherare il vero volto del nuovo potere.
Non a caso le analisi successive di Berkman si focalizzano sulla
dicotomia rivoluzione sociale/rivoluzione politica e sull'assunto
della coerenza fra mezzi e fini.
“L'irruzione delle donne nella rivoluzione russa andrà
di pari passo con un radicale cambiamento politico, sociale,
culturale (...) spinte da un identico ideale: sovvertire il
potere costituito, anche a costo di mettere in gioco la propria
vita”. Così Lorenzo Pezzica con i suoi ritratti
di donne capaci “di resistere, di opporsi, di protestare,
di ribellarsi, di pensare altrimenti, che è già
un essere contro”. La deriva autoritaria farà di
loro delle “emarginate, perseguitate, arrestate”,
destinate a carceri, manicomi, gulag o “relegate all'oblio
della storia, al silenzio assordante della memoria rimossa”.
L'approfondimento di Antonio Senta, supportato da una meticolosa
ricerca sui periodici dell'epoca, è dedicato alle valutazioni,
espresse dal movimento anarchico italiano, soffermandosi sul
pensiero di Malatesta, Fabbri, Berneri, Galleani e Fedeli. Prese
di posizione non uniformi, a volte contrastanti, che segnano
il dibattito militante nella dolorosa evoluzione che vede gli
anarchici tra “i più accesi fautori” per
divenire “critici severi quando si delinea nella sua crudezza
il monopolio del governo bolscevico”.
David Bernardini sposta lo sguardo su quella “rete di
mutuo appoggio transnazionale che permise al movimento anarchico
di sopravvivere”: a Berlino fra il '19 e il '26 la militanza
s'intreccia in un “network solidale e orizzontale (...)
in sostegno ai profughi russi”. R. Rocker diviene il fulcro
di quella opposizione al bolscevismo individuata nell'Internazionale
anarcosindacalista che si intreccia al supporto di esigenze
esistenziali primarie.
“Scopo di questo breve saggio è presentare (...)
libri e opuscoli pubblicati dal movimento anarchico di lingua
italiana sulla Russia in generale e, in particolare, sulla rivoluzione
d'ottobre e sul regime sovietico”, così Massimo
Ortalli spiega il suo contributo aggiornandolo alle ultime novità
editoriali che, nella continuità della ricerca, rendono
giustizia a pensieri “rimossi, se non denigrati dalla
storiografia ufficiale” ma anticipatori di un'analisi
critica ora oggetto di studi meno elitari.
Chiara Gazzola
Barbagia e cinema/
60 anni dopo “Banditi a Orgosolo”
Sessanta anni fa, nel 1959, il regista palermitano Vittorio
De Seta (1923-2011), ancora giovane e già autore di interessanti
documentari sulla difficile realtà dei contadini e dei
pescatori siciliani, si reca in Sardegna, ad Orgosolo, per girare
il suo primo lungometraggio, che avrà per soggetto i
banditi che con le loro gesta hanno reso “famosa”
l'interna e arcaica cittadina sarda. In due anni di vita vissuta
tra la gente del luogo, che è fatta essenzialmente da
pastori, De Seta dà seguito alla sua idea di film, che
appunto vuole raccontare l'universo dei pastori sardi, ai quali
spesso non resta altro modo, per sopravvivere, che diventare
banditi.
 Nel
'61, infatti, a Venezia, al Festival del Cinema, viene proiettato
il suo film Banditi a Orgosolo, che racconta la storia
del pastore Michele Jossu, che creduto erroneamente colpevole
di aver ucciso un carabiniere, scappa per sfuggire all'arresto,
perdendo, nella sua disperata fuga, il suo gregge di pecore:
quindi, in sostanza tutti i suoi averi, e il suo status
di pastore; vedendosi così costretto – per habitus
e animus fatalista e ligio ai ferrei e vetusti codici
comportamentali della sua tradizione - a rubare il gregge ad
un altro pastore e diventando così, per caso e per necessità,
bandito. Nel
'61, infatti, a Venezia, al Festival del Cinema, viene proiettato
il suo film Banditi a Orgosolo, che racconta la storia
del pastore Michele Jossu, che creduto erroneamente colpevole
di aver ucciso un carabiniere, scappa per sfuggire all'arresto,
perdendo, nella sua disperata fuga, il suo gregge di pecore:
quindi, in sostanza tutti i suoi averi, e il suo status
di pastore; vedendosi così costretto – per habitus
e animus fatalista e ligio ai ferrei e vetusti codici
comportamentali della sua tradizione - a rubare il gregge ad
un altro pastore e diventando così, per caso e per necessità,
bandito.
Sul film di De Seta, che fece epoca e che contribuì a
capire meglio la questione del banditismo in Sardegna e le sue
cause, storiche-ancestrali - che risalivano a secoli di isolamento
e sfruttamento della Barbagia e dell'area del Supramonte, dove
risiede Orgosolo, e di condanna ad una vita di stenti e miseria
dei suoi pastori - è stato appena pubblicato un bel volume
di Antioco Floris che prende il titolo dal film, Banditi
a Orgosolo (Rubbettino, Palermo 2019, pp. 264, € 18,00).
Il corposo studio di Floris indaga compiutamente le ragioni
che hanno indotto De Seta ad interessarsi dei pastori barbaricini,
in linea con la sua attività di cineasta di segno neorealista,
attento a documentare e a leggere criticamente la società
e la storia del suo tempo, in specie quella del meridione d'Italia;
offre un'ampia disamina della critica cinematografica sul film,
che ne seguì, con lodi che arrivarono anche da Martin
Scorsese, i successi internazionali e ne segnalò il rivoluzionario
modo di leggere il banditismo sardo come risposta ineluttabile
alle offese costanti e feroci dello Stato, assente e predatore,
nei riguardi del mondo antico e povero della Barbagia. Inoltre,
il volume, raccoglie alcuni scritti, notevoli e illuminanti,
di De Seta; i materiali di lavoro (appunti del regista, sceneggiatura),
una selezione delle foto di scena e di fotogrammi del film e
soprattutto presenta acute analisi sulla ricezione, nel tempo,
del film in Sardegna e a Orgosolo, dove è considerato
parte integrante e iconica della propria identità storico-culturale.
L'operazione di Floris, di recupero della storia del film di
De Seta, peraltro pensata dall'autore del libro assieme allo
stesso regista già nel 2011, quando quest'ultimo era
ancora in vita, ha, in più, un senso e un motivo importante,
di stimolo a una riflessione sull'attualità della Sardegna,
come sottolinea in un passaggio del suo saggio, lo stesso Floris:
“Il film è una metafora dei rapporti tra individui
ed istituzioni. La sostanza del conflitto che contrappone Michele
ai Carabinieri, non è molto diversa da quella che caratterizza
il conflitto tra le istituzioni alte (Stato, Regione, Unione
Europea) e la gente comune. L'inadeguatezza delle istituzioni
nel dare risposte ai bisogni del territorio è ciò
che costringe l'individuo a trovare da sé soluzioni in
cui il problema della legalità (dello Stato) è
del tutto secondario. La crisi economica riconduce a modelli
che hanno molti elementi in comune con l'universo narrato da
De Seta, certamente la società è cambiata ed è
cresciuta, ma basta fare un'escursione sul Supramonte per averne
conferma. Il territorio è sempre più abbandonato
a se stesso, le pecore sono state sostituite dai bovini che,
per il semplice fatto di esistere, danno diritto ad un contributo
comunitario. Non è pertanto necessario curarli e così
capita di vederli decrepiti o già cadaveri abbandonati
ai lati delle strade come le pecore di Michele Jossu. A questo
punto il film che è stato in grado di cogliere e rappresentare
un carattere proprio della realtà orgolese, può
valere ancora come lezione per interpretare il presente”.
Silvestro Livolsi
|