
Due tipologie di conversione
1.
Nel suo accurato tentativo di indagine sull'inquieta figura
di Shaul, o Paolo, di Tarso, vissuto nel primo secolo (d. C.)
e presumibilmente morto intorno all'anno 63, Riccardo Calimani
mette innanzitutto in evidenza come, sia in quello che con una
certa approssimatezza possiamo chiamare “medio oriente”
che nella penisola italica – e segnatamente in Roma –,
il cristianesimo ha trovato un brodo di cultura ideale per sorgere
e, poi – piuttosto rapidamente – per imporsi. In
particolare, Calimani pone l'accento sul culto del sovrano,
su alcune caratteristiche delle religioni misteriche e sulla
filosofia stoica. Il politeismo cominciò a perdere parte
del suo fascino con l'affermazione, in età imperiale,
di un “panteismo solare” che promuoveva l'idea di
una “supremazia di una sola divinità astrale”
– idea che, ovviamente, venne utilissima allorquando Augusto,
per consolidare il proprio potere, cominciò a farsi chiamare,
prima, divi filius (nel 40 a. C.) e, poi (nel 27 a. C.),
Augustus, che, in pratica voleva dire più divino
che umano. Nelle varie religioni misteriche orientali già
si prevedeva pasti sacri, ovvero assunzioni di cibi elevati
a simboli di Dio, nonché riti iniziatici che favorivano
la “purificazione” di un “ corpo” all'interno
del quale l'anima non poteva
che essere sofferente. L'idea della “salvezza” di
quest'anima una volta “liberatasi” del corpo prese
così piede in alternativa a quella, più rassicurante
ancora (almeno nei casi fortunati) che, con l'anima, sarebbe
anche risorto il corpo. Un esempio portato da Calimani è
quello del dio Attis, passibile di “essere sacrificato
come offerta di propiziazione per la gente e per i suoi peccati
e che sarebbe risorto per una vita eterna”. La stessa
filosofia stoica, infine, cui si ispirarono Posidonio, il suo
allievo Cicerone, Seneca, Plinio ed Epitteto contribuì
a creare un clima etico in cui il premio alla virtù e
il rifiuto del “piacere puramente edonistico” diventano
il paradigma più idoneo per la convivenza sociale. Seneca,
in particolare, nel De beneficiis, “si sforza di gettare
le basi della fratellanza umana” e invita espressamente
alle “buone azioni” come indispensabile complemento
delle virtù. Insomma, tra l'a. C e il d. C, gli elementi
di continuità non mancano e, volendo, ce n'è a
iosa.
Va da sé, allora, che, tra le tante affinità,
non si possa ignorare quella tra ebraismo e cristianesimo –
e non a caso il libro di Calimani si intitola Paolo l'ebreo
che fondò il cristianesimo. 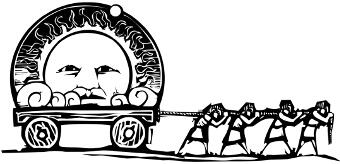 A
pensare a quante vite sono state malamente stroncate in nome
di una differenza tra queste due religioni si rimane sgomenti:
fino a che punto può giungere l'idiozia umana e via rigirando
il coltello della storia in una piaga collettiva. A
pensare a quante vite sono state malamente stroncate in nome
di una differenza tra queste due religioni si rimane sgomenti:
fino a che punto può giungere l'idiozia umana e via rigirando
il coltello della storia in una piaga collettiva.
2.
Così, tanto per ricordare come sono andate le cose –
fino all'“altro ieri”. Il “Corriere della
Sera” dell'11 gennaio 1939 relaziona del discorso di padre
Agostino Gemelli – l'omaggiatissimo fondatore dell'Università
Cattolica di Milano –, il giorno prima, all'Università
di Bologna, commemorando Guglielmo da Saliceto, e dice che “il
pubblico presente aveva sottolineato con particolari applausi
quando l'oratore aveva espresso il pensiero della Chiesa nei
riguardi degli ebrei, ed aveva fustigato severamente coloro
che, oltre frontiera, seguivano la politica della mano tesa”.
Riportando, altresì, quella che Ernesto Rossi definì
la “patetica conclusione del frate francescano”:
“Tragica, senza dubbio, e dolorosa la situazione di coloro
che non possono far parte, e per il loro sangue e per la loro
religione, di questa magnifica Patria; tragica situazione in
cui vediamo, una volta di più, come molte altre nei secoli,
attuarsi quella terribile sentenza che il popolo deicida ha
chiesto su di sé e per la quale va ramingo per il mondo,
incapace di trovare la pace di una Patria, mentre le conseguenze
dell'orribile delitto lo perseguitano ovunque e in ogni tempo”.
3.
Roberto Carusi, noto attore teatrale ormai in pensione ma ugualmente
attivo e partecipe del mondo, abita a Milano nei dintorni di
via Padova, una zona ad alta concentrazione di immigrati che
lo chiamano “zio” – che, come titolo di rispettoso
merito, lo conosco perché è riservato anche a
me, nel mio quartiere. In cerca di lapidi care, Carusi si attarda
a Musocco, nel Cimitero Maggiore, e immagina di scrivere una
lettera ai suoi genitori. Ne scaturisce un amabile libretto
di sobrietà esistenziale, Cattolico di ventre ebreo,
che, mentre sommessamente testimonia di un'epoca ormai trascorsa,
è l'occasione per far emergere i nodi cruciali di quella
riserva di dolorosa incertezza che l'autore definisce come “mitologia
familiare”. Tutti quanti ne abbiamo una, con la quale
dobbiamo fare i conti – non facili, come quelli che dobbiamo
fare con qualsiasi mitologia. La lacuna – l'omesso, il
mancante, il rimosso, il cancellato –, infatti, caratterizza
la narrazione mitologica. Deputata a sedare le nostre ansie,
a conferirci un passato affidabile alla meno peggio, ci richiede
implicitamente di sospendere la nostra incredulità e
ci trascina in avanti, sempre e comunque, accontentandosi di
una coerenza minore, di un racconto dove numerosi restano gli
spazi bianchi e dove non tutte le parole hanno davvero un significato.
La mitologia familiare di Carusi deve sopportare, allora, i
silenzi relativi alla “conversione” della nonna
e della mamma – “fatte cattoliche” per sentirsi
più a loro “agio” con “il resto della
famiglia” –, il tacitato orrore di tre zie “ammazzate
ad Auschwitz”, pianti improvvisi e non giustificati agli
astanti, vaghezze in ordine a parenti dispersi, discorsi interrotti
a danno tanto della logica quanto della relazione in atto.
Fra il detto e il non detto della crescita dei figli, ci sono
anche gli estremi della compatibilità tra una mamma “convertita”
ed un padre, figlio di un anarchico di Carrara, poco incline
ai rituali della religiosità esibita – un “babbo”
con il suo “consueto sguardo arguto” solidalmente
unito ad una “mamma” con il suo “inconfondibile
sorriso”. Ci si chiede, dunque, cosa li abbia tenuti assieme
e ci si risponde, ovviamente, che – a differenza di quanto
accaduto nel rapporto tra cristiani ed ebrei – l'amore
può far superare qualsiasi barriera culturale. Ma, intrufolandosi
nei ricordi più e meno disordinati di Carusi, ci si imbatte
in una figura demiurgica come quella di David Maria Turoldo
(1916-1992), “il tormentato ed entusiasta frate poeta”,
antifascista scomodo per la Chiesa ed orgogliosamente cosciente
delle necessità della lotta di classe. Come nel Gesù
ebreo zelota ipotizzato da Samuel Brandon, fede e ribellione
in Turoldo vengono forzate ad una loro complementarità
inducendo a pensare che, così come, a suo tempo, hanno
costituito il rapporto tra un uomo e una donna, più tardi
hanno informato di sé anche chi da questo loro rapporto
è nato.
4.
Mentre i motivi della “conversione” della mamma
di Carusi sono chiari o comunque del tutto comprensibili nonostante
quel minimo di opacità che sempre si deve concedere ad
ogni comportamento umano, i motivi della “conversione”
di Shaul Paolo – motivi che l'avrebbero fatto diventare
poi “San Paolo” – lo sono molto meno. Il destro
– a suo dire – glielo diede la famosa caduta da
cavallo sulla via per Damasco: “Udii dal cielo una voce
che mi diceva in ebraico” (si noti la lingua e, soprattutto,
il fatto che lui la faccia notare) “Saulo, Saulo, perché
mi perseguiti?”. Ma, come sottolinea Calimani insieme
ad altri, “se Paolo si 'convertì' da qualcosa a
qualcos'altro, certamente non fu dall'ebraismo al
cristianesimo”, perché Paolo “continuò
ad essere ebreo sino al giorno della sua morte” –
constatazione di un fatto che “molti cristiani di oggi
preferiscono trascurare e che molti studiosi ebrei trovano esasperante”.
Rispolveratosi e rendendosi conto di essere ancora tutto intero,
rispondendo alla “chiamata”, Shaul Paolo “non
ebbe affatto la sensazione di cambiare religione, di convertirsi,
ma piuttosto quella di servire Dio con lo stesso zelo su una
sponda ebraica differente, magari attraverso un cambiamento
di setta ma pur sempre nell'ambito di una fedeltà di
fondo alla tradizione ebraica”. La seconda Lettera
ai Corinzi (11,22) lo conferma.
La rabbia indotta dalle contraddizioni, allora, cresce. Tanto
sangue sparso, un conflitto che perdura nei secoli, originato
da qualcosa che risulta inaccessibile – tradizioni narrative
zeppe di lacune che, intangibili perché sacralizzate,
provano a parlarci di persone che, mitologie per accondiscendenti
complici e benevoli, della persona non hanno più addosso
alcunché o, comunque, se mai l'hanno avuto, non hanno
più quei requisiti minimi affinché noi le si possa
considerali tali.
Felice Accame
Nota
Paolo, l'ebreo che fondò il cristianesimo di Riccardo Calimani è stato pubblicato da Mondadori nel 1999 e riedito nel 2017. Le citazioni sono tratte dalle pagine 17, 30, 35-39, 141, 155-159. Cattolico di ventre ebreo di Roberto Carusi è stato pubblicato da Mursia, a Milano, nel 2017. Gesù e gli zeloti di Samuel Brandon, il cui sottotitolo è Il cristianesimo sovversivo prima di Paolo (e non è un caso se lo cito in questa circostanza), è stato pubblicato, da Rizzoli, a Milano nel 1983 e riedito da Pgreco, a Milano, nel 2014.
|