
Il borghesuccio in biblioteca
1.
Si narra che – alla domanda dell'incauto visitatore, “Ma li hai letti tutti?” di fronte alla sua nutritissima biblioteca – Umberto Eco abbia prodotto risposte diverse. La prima sarebbe stata, “Non ne ho letto nessuno, altrimenti perché li terrei qui?”. Tuttavia, considerato che come risposta avrebbe potuto incentivare un'ulteriore domanda, “Scusa, ma dove li metti quelli che hai letto?”, Eco ha finito con il ripiegare su una risposta del tipo, “No, questi sono quelli che debbo leggere entro il mese prossimo, gli altri li tengo all'università”, anche perché, lo fa notare lui, ponendo l'accento sul tempo, questa risposta anticipa il momento del congedo. Il tema non è nuovo. Già Anatole France, molti anni prima di Eco, era stato indotto a risolvere la questione, cavandosela, però, in tutt'altra maniera. Come ricorda Benjamin dando del “borghesuccio” all'interrogante, France rispose: “Nemmeno un decimo. Forse che Lei tutti i giorni pranza usando il suo servizio di Sèvres?”. Le due soluzioni, ovviamente, implicano atteggiamenti ben diversi. Mentre in Anatole France c'è perlomeno rispetto per il visitatore – e tramite l'analogia con le porcellane di Sèvres lo eleva alla classe sociale più abbiente e, al contempo, più colta -, in Eco sembra di vedere, sia nella prima che nella seconda risposta, una certa altezzosità disturbata, un fastidio cui metter fine prima possibile. Al di là di ciò, tuttavia, varrebbe la pena di indagare anche dall'altra parte – dalla parte dell'incauto visitatore.
Infatti, credo che una domanda così tipica da sciocchezzaio abbia tutta una serie di presupposti – prima sociali e poi individuali – alle spalle. Mi riferisco all'origine del giudizio di Benjamin, alla deferenza borghese nei confronti del libro in genere che può essere considerata come il sottoprodotto evolutivo di un processo di sacralizzazione.
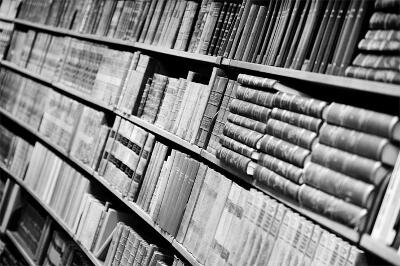 2. 2.
Allora. Ragioniamo in breve. La conquista della scrittura rappresenta
una spinta evolutiva notevole. Tramite la scrittura possiamo
lasciare a chi ci segue traccia delle nostre esperienze e possiamo
far sì che i nostri errori non siano ripetuti. Chi se
ne impadronisce, pertanto, acquisisce uno straordinario potere
sugli altri. Se, poi, questa scrittura viene separata da chi
la scrive o, meglio, se si conferisce uno statuto speciale a
chi l'ha scritta, ecco che il potere aumenta – diventa
immenso e incontestabile. È ciò che è accaduto
con le “Sacre Scritture”.
Come fa notare Melot in un suo libro dal titolo piuttosto originale
– Libro, si intitola, libro virgola -, le tre religioni
di maggior successo aventi a che fare con Scritture e con il
Libro si caratterizzano per tre concezioni ben diverse: “per
gli ebrei è sacra la scrittura; per i musulmani è
sacro il testo; e per i cristiani non sono sacri né la
scrittura né il testo”. Si tratta di risultati
di operazioni mentali del tutto particolari. I primi attribuiscono
un soggetto divino alla scrittura stessa della Torah; i secondi
identificano il Corano (che è stato scritto o, meglio,
messo assieme, intorno al VII secolo) con la parola stessa di
Dio – ed è per questa ragione che il Corano è
di principio intraducibile; i terzi, avvalendosi soltanto di
mediatori nel rapporto con un soggetto divino, hanno potuto
invece manipolare i testi quanto hanno voluto – inserendo
o togliendo dall'Antico Testamento, ritraducendo in continuazione,
“concordando” i Vangeli. Vorrei anche far notare
che, mentre per i musulmani vige l'imperativo di memorizzare
la parola di Dio, per i cattolici la libertà di possedere
e leggere il proprio libro sacro è una conquista fin
recente, perché per lunghi anni questo diritto è
stato appannaggio dei ministri del culto e negato al popolo
(cui toccava anche la funzione religiosa recitata in latino
e, pertanto, incomprensibile).
Anche se raggiungendo dimensioni più ridotte, analoga
ma con pretesa di maggior radicalità è l'operazione
mass-mediologica compiuta sulle immagini. La religione cattolica,
per esempio, ha basato il proprio successo anche sul concetto
di immagine acheropita (o achiropita), ovvero immagine non realizzata
da mano umana (e, implicito, è anche che non sia stata
realizzata nemmeno da uno scimpanzé). La sindone del
Duomo di Torino, la Madonna di Guadalupe (Messico) e la Madonna
della Cattedrale di Maria Achiropita di Rossano (Cosenza) ne
sono tre esempi ancora attuali. Il Mandylion, o “immagine
di Edessa” con il volto di Gesù Cristo, il velo
della Veronica (Gesù) o sono invece esempi di acheropite
perdute. Che questi mezzi oggi siano considerati obsoleti, beninteso,
non assolve nessuno – né chi li ha usati, né
chi li ha subiti. Come abbia potuto essere così facile
compiere queste operazioni e ottenere questi risultati –
come possa tuttora accadere – resta un po' un mistero
e un po' – un po' tanto – un tratto costitutivo
della miseria umana e dell'infelicità che produce.
3.
Di questi vari processi di sacralizzazione qualcosa è rimasto anche allorché, a partire perlomeno dall'XI secolo, è iniziata la lenta laicizzazione del libro. Allorquando avviene la borghesizzazione del mondo, insieme all'antica riverenza al libro toccano gli stigmi che toccano ad ogni veicolo di cultura. Cultura e quattrini non sempre vanno a braccetto – anzi, quasi mai - e il borghese lo sa bene. Per lui, infatti, il valore d'uso di un libro è praticamente zero, mentre qualcosina in più è pronto a riconoscere al suo valore di scambio, al suo valore di simbolo, come un attestato di sapere e, conseguentemente, di potere. Su questa strada la borghesia ha compiuto crimini ideologici ed estetici spaventosi come quelli di inventare intere pareti di libri finti – ridotti a “dorsi” – nelle proprie case. Ancora negli anni Sessanta del secolo scorso ebbe gran successo in Italia il “Club degli Editori” che, in abbonamento mensile, forniva la letteratura “giusta” con una copertina facilmente estraibile e con dorsi tutti uguali per far bella mostra di sé sugli scaffali. Prima l'apparenza – il libro come decoro –, poi, eventualmente, la lettura. Nella domanda – “Ma li hai letti tutti?” – si riassume l'atteggiamento della borghesia nei confronti del libro e di chi lo legge. Libro significa tempo e denaro, soprattutto tempo che non viene impiegato per produrre denaro. Il libro è un lusso – lo si valorizza nella misura in cui lo si disprezza e, al contempo, se ne ha rispetto. Siamo nello stesso sentimento contraddittorio di quella famiglia in cui nasce un artista: forse era meno costoso un tossicodipendente. Ma, come sempre, l'inquietudine del borghese è rappresentata dal tempo e dallo spreco – tempo sprecato ed eventualità che il suo consumo non sia protratto fino all'esaurimento della merce. Li hai letti tutti? Un libro comprato e non letto, un libro letto a metà, costituiscono spreco. Sotto sotto c'è anche la speranza di scovare una falla, ridurre l'intellettuale all'apparenza e veder quindi confermate due ferree convinzioni: che l'intellettuale è sempre e comunque una persona sospetta e incline a porre in dubbio l'ordine costituito e che “con la cultura non si mangia”. Sotto sotto c'è anche la speranza di ritrovare l'intellettuale – il presunto intellettuale – come compagno di strada, ovvero come “collezionista”, ovvero come l'afflitto da una tipica patologia borghese.
4.
Come risponderei io? Senza offendere il mio interlocutore e
senza offendere me stesso raccontando pietose bugie o cavandomela
con una boutade? Li hai letti tutti? No, non tutti e
non tutto di tutti, perché la mia biblioteca è
come la cassetta degli attrezzi – a volte servono, a volte
no, ma, prima o poi, può capitare.
Felice Accame
Nota
Per la risposta di Anatole France, cfr. W, Benjamin, Figure
dell'infanzia, Raffaello Cortina, Milano 2012, pag. 108.
Per gli atteggiamenti religiosi nei confronti del libro, cfr.
Michel Melot, Libro, Silvestre Bonnard, Milano 2006,
pag. 34, da dove ho tratto, tra l'altro, un paio di versi del
Gabinetto satirico (1618) che ignoravo: “La mia
bella, a concerto gentile/ aprì il suo libro allegramente”.
La più gustosa metaforizzazione del libro che mi sia
capitato di trovare.
|