|
militanti
Louis Mercier Vega
alias Charles Ridel alias...
Nel corso della sua vita ebbe vari nomi. Nato in Belgio, il suo ultimo passaporto era cileno. È stato una delle figure più stimolanti del movimento anarchico internazionale, dalla Spagna '36 alla rivista quadrilingue “Interrogations”. Nel centenario della sua nascita, lo ricordiamo con due testimonianze di militanti che hanno collaborato con lui.
Senza illusioni senza rimpianti
di Amedeo Bertolo
Ho visto per l'ultima volta Louis Mercier Vega (o meglio, colui
che all'epoca così si faceva chiamare) quasi esattamente
venti anni fa, nel novembre del 1977, a Parigi, nella sua casa
di rue de Valenciennes. Venti anni fa: una decina di giorni
prima della sua morte volontaria e programmata.
Proprio per il suo suicidio programmato eravamo venuti a Parigi,
io e un paio di compagni di Milano (Fausta Bizzozzero e Luciano
Lanza), che come me facevano parte del gruppo redazionale e
amministrativo italiano della rivista fondata da Mercier tre
anni prima: «Interrogations».
Nell'aprile precedente, a margine di un incontro organizzativo
di «Interrogations», a Torino, Mercier ci aveva
comunicato la sua intenzione di uccidersi verso la fine dell'anno.
Ce l'aveva comunicato perché sapessimo di non poter contare
su di lui al di là degli impegni compatibili con quella
sua scelta. Ce l'aveva detto un po' di sfuggita, senza dare
apparentemente peso alla faccenda. L'understatement non
era inconsueto in lui, ma questa volta ci lasciò perplessi,
così che non sapevamo se prendere davvero sul serio quel
suicidio annunciato. Lo avevamo preso più sul serio quando
aveva confermato la sua intenzione, sempre di sfuggita, in ottobre,
a Milano, a margine di un'altra riunione. Eravamo dunque andati
a trovarlo a Parigi, per cercare di capire e magari per dissuaderlo.
Per stare con lui, per lo meno, un'ultima volta se proprio era
vero che stavamo per restare «orfani» di chi era
stato, per noi, in quegli ultimi anni, un importante punto di
riferimento culturale (e anche umano).
Mercier si rifiutò categoricamente di parlare dell'argomento
suicidio, e io per rispetto, per delicatezza, non insistetti
più di tanto, conoscendo la sua serietà, la sua
volontà ostinata e constatando la sua calma determinazione.
Così andammo per librerie, per ristoranti, e poi a casa
parlammo per ore.
Aveva un vestito liso, i pantaloni sformati, con le borse alle
ginocchia. Dettaglio significativo per una persona che avevo
sempre visto vestire in modo formalmente corretto, quasi pignolescamente
corretto, pur senza pretese d'eleganza. Mentre eravamo a casa
e parlavamo – di tutto tranne che di «quello»
– è arrivato un acquirente del suo televisore.
Aveva fatto un'inserzione per vendere tutte le sue cose. Stava
pignolescamente monetizzando – per lasciare a iniziative
del movimento anarchico – le sue ultime modeste proprietà.
Stava chiudendo tutti i suoi conti con la vita, anche quelli
minori. E ho assistito a una sua telefonata a Maurice Joyeux,
esponente di spicco della Fédération Anarchiste
(FA). diceva di non preoccuparsi per i problemi sollevati
dalla sua eventuale partecipazione al Congresso dell'Internazionale
delle Federazioni Anarchiche, come delegato della Federación
Libertaria Argentina (FLA). Poiché il congresso era
stato rinviato alla primavera del 1978, egli non avrebbe potuto
partecipare comunque, al di là della polemica, attorno
alla sua persona e alla sua presenza, sollevata dagli spagnoli
in esilio della Federación Anarquista Ibérica
(FAI). Non avrebbe potuto partecipare, diceva con tranquilla
serietà, forse con nascosta ironia. Certo: di lì
a dieci giorni non avrebbe potuto partecipare ad alcunché,
se non nella memoria dei suoi amici e compagni.
Apro qui una breve digressione. La «questione spagnola»
era in breve questa: una parte della Confederación Nacional
del Trabajo (CNT) e della FAI in esilio (o meglio della frazione
maggioritaria di un movimento continuamente in preda a rissose
controversie, scissioni, riconciliazioni...) ce l'aveva con
Mercier già dagli anni Cinquanta. Riuscire a inimicarsi
una parte consistente dell'esilio libertario spagnolo è
cosa non da poco per uno come Mercier che era corso a combattere
con la colonna Durruti già nel luglio del 1936! La causa
era, credo, nella inflessibile schiettezza di pensiero critico
e nella sua disinibita eterodossia sperimentale... Nel 19581,
ad esempio, è tra i promotori di una Commission Internationale
de Liaison Ouvrière (CILO) assieme a esponenti di una
frazione della CNT e della Sveriges Arbetares Centralorganisation
(SAC) svedese (sospette l'una e l'altra di «revisionismo»
anarchico), oltre che con il gruppo di sindacalisti de «La
révolution proletarienne». Così Mercier
entra nella lista nera dei «nemici del popolo» cenetista
e faista. L'attacco a Mercier riprende quando Mercier riprende
«visibilità» nel movimento anarchico internazionale,
con il progetto «Interrogations». Così nel
19742, nel 19753,
nel 19764 e, infine, nel 1977
si susseguono le aggressioni verbali contro di lui, che aprono
un vero e proprio «caso» internazionale. Questa
volta Mercier non è più semplicemente «revisionista»
e amico degli «scissionisti», ma addirittura «noto
agente della CIA». La storia è complessa5,
ma fermiamoci qui.
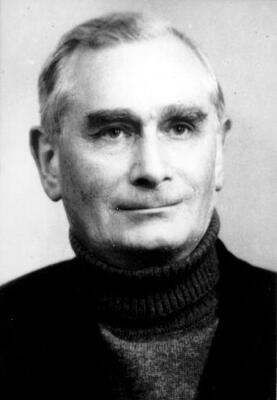 |
| Louis Mercier Vega |
Straordinaria cultura cosmopolita
Avevo conosciuto Mercier poco più di quattro anni prima, nell'agosto 1973, anche allora a Parigi, nella sua casa di rue de Valenciennes. Eravamo venuti a fargli visita io e Rossella Di Leo, perché avevamo trovato singolarmente originale e intellettualmente ricco il suo L'incrévable anarchisme [La pratica dell'utopia]. Volevamo parlargli e proporgli di collaborare alla nostra rivista anarchica italiana: «A». Il suo indirizzo ce l'aveva dato un vecchio compagno italiano, Pio Turroni, che lo conosceva da prima della guerra, quando Mercier si chiamava Ridel. S'erano frequentati a Marsiglia, dove erano entrambi reduci della Rivoluzione spagnola e non s'erano mai persi di vista.
Mercier non delude le nostre aspettative. Anzi. Apprezzo in
lui subito (e ancor più man mano che lo conoscerò
successivamente) il vero intellettuale anarchico, con una straordinaria
cultura cosmopolita e con una straordinaria esperienza militante,
«senza illusioni e senza rimpianti», con le sue
certezze e le sue problematicità di anarchico e di intellettuale.
Il suo lucido, antiretorico, affascinante anarchismo si palesava
nelle parole e negli scritti per quello che in un'intervista
pubblicata postuma6 avrebbe così
definito: «L'anarchismo deriva dalla volontà di
conoscersi e di conoscere la società nella quale si vive,
per arrivare a essere padroni del proprio destino, con gli
altri, affinché la società sia una comunità
libera e fraterna».
Comprendiamo subito che è stato un felice incontro, che
con questo Mercier potremo fare insieme buone cose e imparare
molto. Ci unisce tra l'altro l'interesse per il fenomeno della
nuova classe in ascesa, la tecnoburocrazia, una tematica cui
noi7 all'epoca dedicavamo un'attenzione
quasi maniacale e che percorrerà «Interrogations»
per tutti i suoi quattro anni e mezzo di vita. Una tematica
già trattata da Mercier sin dagli anni Quaranta8.
Durante quell'incontro parlammo a Mercier anche di un'idea che da qualche tempo carezzavamo: quella di una rivista internazionale anarchica. L'idea gli deve essere piaciuta molto (o forse rafforzava qualche sua idea analoga) perché ne fece subito un progetto. Il progetto di quella che sarebbe stata «Interrogations, rivista internazionale di ricerche anarchiche».
Con «Interrogations», che ancora non si chiamava
«Interrogations», comincia l'ultima avventura intellettuale
ed editoriale di Mercier, che già allora forse, stando
a sue successive allusioni, aveva deciso di porre un limite
temporale piuttosto breve alla sua vita residua. L'ultima avventura
intellettuale ed editoriale, ma non l'unica attività,
certo. Nei quattro anni che si concede e ci concede, scrive
due libri sull'America latina9 e
un libretto sull'anarco-sindacalismo10;
scrive sedici articoli per «A» tra l'ottobre 1973
e il novembre 1977 (dieci di argomento latino-americano e sei
di attualità politica francese) con lo pseudonimo di
Santiago Parane; collabora con il Centro studi libertari Giuseppe
Pinelli di Milano per l'organizzazione di un convegno sulla
tecnoburocrazia11... un convegno
che non vide, perché si tenne qualche mese dopo la sua
morte, ma per il quale ci lasciò una relazione scritta...
Cura la revisione e l'aggiornamento dell'edizione italiana dell'Increvable12...
Scrive anche qualcosa per un mio progetto di Piccola Enciclopedia
anarchica che non si realizzò mai... E questo è
solo (e non tutto) ciò che so per conoscenza diretta.
Fa certo molte altre cose tra il 1973 e il 1977, ma è indubbio che dedica la maggior parte delle sue energie intellettuali, del suo capitale di conoscenze e delle sue risorse materiali al progetto di rivista internazionale. Si butta nell'impresa, tanto ardua che solo lui allora, forse, avrebbe potuto realizzare, con la serietà, l'impegno, la tenacia, le capacità organizzative (un po' autocratiche) che gli erano proprie.
A fine 1973 spedisce a dieci persone una lettera circolare in cui la rivista non è più una semplice idea, è già un progetto in marcia. Un progetto che è un «suo» progetto, a questo punto. Seguono, a cadenza regolare, altre cinque circolari sull'avanzamento dei lavori, in preparazione e in prosecuzione di una riunione organizzativa che si terrà a Parigi, nell'aprile 1974. In quella riunione parte «ufficialmente» il progetto e comincia il lavoro redazionale. Ai primi di settembre Mercier mi informa che è stato scelto (da chi? da lui suppongo: non corrisponde a nessuno dei titoli suggeriti nelle riunioni internazionali e nelle lettere che ci eravamo scambiati sino ad allora) il titolo di «Interrogations». Un titolo non particolarmente brillante che non mi entusiasma, ma che ben esprime lo spirito con cui nasce la rivista. Per usare le parole di Mercier: il militante anarchico deve «imparare a vivere e ad agire in mezzo a una selva di punti interrogativi, perché sia la propaganda dottrinale sia le situazioni di fatto esigono una continua messa a punto».
Quell'ultima rivista quadrilingue
Nel dicembre del 1974 esce il primo numero di «Interrogations»,
e poi a puntualissima frequenza trimestrale, altri sette numeri,
fino al settembre 1976; dopo di che, passate le responsabilità
redazionali e amministrative a una equipe italiana, «Interrogations»
uscirà ancora, con minore puntualità, fino al
1979. L'ultimo numero sarà il numero doppio 17/18. In
quattro anni e mezzo erano state pubblicate complessivamente
quasi duemila pagine, di qualità per lo più buona
o eccellente. Molti gli studi originali su tematiche d'attualità
o teoriche di fondo, come era negli intenti di partenza. E,
come era negli intenti, numerosi e validi i contributi all'analisi
dei «nuovi padroni». In quegli anni «Interrogations»
è certamente la migliore rivista teorica anarchica esistente.
Mercier contribuisce non solo con un'intensa attività
redazionale di stimolo e di sollecitazione, di ricerca di temi,
di collaboratori, di documenti13,
ma anche con sei articoli importanti (di cui due firmati Parane)14.
La sua attività redazionale è particolarmente
intensa nella fase preparatoria di «Interrogations».
Per darne un'idea, si pensi che tra il 1974 e il 1975 Mercier
ha scritto, a me solo, novanta lettere circa, in media una alla
settimana!15 Ma il suo contributo
a «Interrogations» resta notevole anche quando,
dopo l'ottobre '76, egli passa le consegne all'equipe italiana
(Milano e Torino). Fino a poco prima della sua morte. Anche
in quel suo ultimo anno continuerà a occuparsi fortemente,
appassionatamente, di «Interrogations». Del resto,
aveva venduto la sua preziosa biblioteca, di oltre 1.500 libri
antichi e moderni sull'America latina, per procurare i fondi
necessari ad assicurare la vita della rivista nel biennio 1977-1978...
«Interrogations» muore nel 1979, per problemi finanziari
(è finita la «dotazione» Mercier che copriva
quasi metà dei costi) e per difficoltà redazionali
(non si trova, com'era nel progetto, un'altra equipe –
inglese o spagnola – per il terzo biennio 1979-1980 e
l'equipe amministrativo-redazionale milanese si trova quasi
involontariamente a doversi assumere, dal 1980, la pubblicazione
della rivista «Volontà»). Dopo l'apparente
successo di abbonamenti e vendite del primo anno16,
il secondo anno vede una caduta di abbonamenti e vendite, e
negli anni successivi continuerà un lento costante declino
di diffusione. Le difficili caratteristiche congenite di «Interrogations»
(quadrilinguismo e alto livello di trattazione e scrittura)
la mettevano, per così dire «fuori mercato».
«Interrogations» muore nel 1979. Un anno e mezzo
prima era morto Louis Mercier Vega, lucidamente come lucidamente
era vissuto. «Senza illusioni e senza rimpianti»,
per usare le sue parole.
Amedeo Bertolo
Questo articolo è apparso per la prima volta in
francese in Presénce de Louis Mercier, Atelier
de création libertaire, 1999.
Note
- Si veda la lettera a Mercier del 16.5.58 di Giovanna Berneri,
vedova di Camillo e responsabile della rivista anarchica «Volontà»,
cui Mercier collaborava assiduamente, con cronache e commenti
internazionali, sin dal 1946 con lo pseudonimo di Santiago Parane
(Fondi Mercier, cit.).
- Si vedano: lettera di Amedeo Bertolo a Mercier del 5.3.74
e di Mercier a Bertolo del 18.3.74 (Fondi Mercier, cit.).
- Si vedano: lettera di Pio Turroni ad «A» del
9.10.75, lettere di Mercier a Turroni del 13 e del 15 ottobre
1975, lettere di Bertolo a Mercier del 14.10.75, lettera di
Mercier a Bertolo del 14.10.75, lettera di Luciano Lanza e Paolo
Finzi (per «A») alla Comisión Intercontinental
de Relaciones de la FAI en el Exilio (e, per conoscenza, ad
altri organismi spagnoli e italiani) del 22.10.75, lettere di
Turroni a Bertolo et al. del 19.12.75 (Fondi Mercier, cit.).
- Si vedano: lettera di Isaac Barba al Comitato Spagna Libertaria
et al. del 12.3.76 (Archivio Pinelli, Fondo Mercier).
- Per una brevissima trattazione si veda Louis Mercier Vega,
ovvero l'amaro orgoglio di una lucidità senza rimpianti
di Marianne Enckell sul Bollettino dell'Archivio G. Pinelli,
n. 9 (luglio 1997), pp. 6-10.
- «Interrogations», n. 13 (gennaio 1975), pp. 23-37.
- Per «noi» intendo in questa sede la redazione
di «A» e più in generale l'organizzazione
di cui facevo parte: i Gruppi Anarchici Federati (GAF), nel
cui Documento programmatico è contenuta un'ampia
analisi della tecno-burocrazia (si veda in Che cosa sono
i GAF, CDA, Torino, 1976). A questo proposito, Mercier tra
anni dopo vorrà pubblicare una parte di quel programma
su «Interrogations» (n. 7, giugno 1976) e ne farà
aperto elogio; «[Le programme anarchiste des GAF] me semble
neuf, equilibré et par conséquence fort different
de la prose renâchée que nous trouvons en general
dans la presse anarchiste» (lettera di Mercier a Bertolo
del 28.4.76, Fondi Mercier, cit.). Per inciso, Mercier non condivideva
l'enfasi posta dai GAF, nella teoria e nella pratica, sul «gruppo
d'affinità», nucleo organizzativo che critica in
Sur les groupes d'affinité («Interrogations»,
n.13, 1978).
- Si veda ad esempio un lungo articolo, a firma Ridel, pubblicato
a puntate con il titolo Al di là del capitalismo
sui nn. 23, 24, 25 e 26 del 1941 de «L'Adunata dei Refrattari»
di New York. Quella dei «nuovi padroni», di una
classe dominante diversa dalla borghesia (manager, burocrati,
tecnocrati...) e da un sistema di dominio, diverso dal capitalismo,
fondato sulla funzione e non sulla proprietà (capitalismo
burocratico, collettivismo burocratico, tecnocrazia...), era
una tematica al centro di una vivace discussione, alla fine
degli anni Trenta e nei primi anni Quaranta, nella sinistra
rivoluzionaria non-stalinista, specialmente ai margini del trotzkismo.
E Mercier con grande tempestività la portò nel
movimento anarchico, che peraltro non ne approfittò molto;
tant'è che all'inizio degli anni Sessanta un gruppo di
giovani anarchici (di cui facevo parte) dovette «reinventarsi»
il problema, non trovandone traccia nella cultura anarchica
a loro contemporanea.
- Autopsie de Peron (1974) e La révolution
par l'Etat (1978; trad. it. La rivoluzione di Stato,
Antistato, Milano, 1979).
- L'anarchosyndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire
(1978; trad. it. Azione diretta e autogestione operaia,
Antistato, Milano, 1979).
- L'idea nasce nel 1975 come progetto di seminario di studi
ristretto (si vedano lettere di Mercier a Bertolo del 4.4.75
e del 8.4.75, Fondi Mercier, cit.), si trascina stancamente
nel 1976 e fino a metà del 1977 (accenno in varie lettere
tra Mercier e Bertolo, (Fondi Mercier, cit.) e poi diventa finalmente
operativa come progetto di grande convegno internazionale di
studi. Il convegno che si terrà a Venezia dal 25 al 27
marzo 1978, con 24 relazioni e davanti a un pubblico variabile
fra le trecento e le cinquecento persone. Mercier aveva inviato
la sua relazione già a fine maggio 1977 (Convergenze
e peculiarità latino-americane, in AA.VV., I nuovi
padroni, Antistato, Milano, 1978).
- Uscita postuma con il titolo La pratica dell'utopia,
cinque saggi sull'anarchismo, Antistato, Milano, 1978.
- A questo scopo, oltre a una forsennata corrispondenza, tra
il 1974 e il 1977 fa numerosi viaggi. Al di là di quelli
connessi con le annuali riunioni redazionali internazionali
e a brevi puntate a Milano, Torino, Ginevra, Amsterdam, nel
1976 fa una lunga trasferta in Spagna e Portogallo e nel febbraio
1977 gira l'America latina.
- Elements pour un dossier chilien (n. 3, 1975); La
variante militaire de la nouvelle classe (n. 5, 1975); Les
Eglises latino-americaines et le Siècle (n. 8, 1976);
Hors-jeu international et jeu internationaliste (n. 11,
1977); Sur les groupes d'affinité (n. 13, 1978);
Les nouveaux mâitres: confluences et particularités
latino-americaines (n. 14, 1978).
- La sua energia sembra inesauribile. Un aneddoto: il 28 giugno
1975 (lettera da Mercier a Bertolo) propone, per la riunione
internazionale che si terrà a Ginevra il 4 e 5 ottobre,
tre sessioni al giorno di lavoro – mattina, pomeriggio
e sera – proposta, beninteso, da noi prontamente rintuzzata
e ridimensionata... a misura umana!
- Duemila copie distribuite tra abbonamenti (quattrocento),
distribuzione commerciale e militante: Italia e Francia i due
«mercati» principali, con oltre la metà delle
copie, ma presenza più o meno consistente in una quarantina
di Paesi, in quattro continenti.
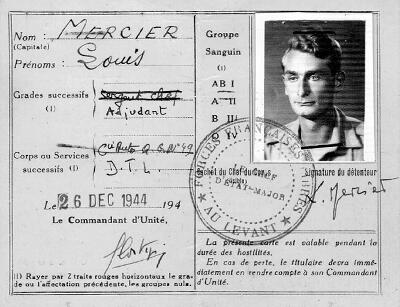
Bibliografia
di Louis Mercier
Vega
Opere:
Affinitietsgroepen, prefazione di Jaap van der
Laan, Spreeuw, Utrecht, 1983, 28 pp.
Les anarchistes face à la technocratie (firmato
Santiago Parane), Ed. du Libertaire, Parigi, 1950, 29
pp..
L'anarchosyndicalisme et le syndicalisme révolutionnaire
(con un testo di Victor Griffuelhes), Spartacus, Parigi,
1978, 100 pp. (trad. it.: Azione diretta e autogestione
operaia, Antistato, Milano, 1979, 143 pp.
Autopsie de Péron, Duculot, Liegi, 1974.
Bilancio della guerriglia in America latina, «Annali»,
Fondazione Einaudi, Torino, 1970, pp. 481-494.
La Chevauchée anonyme, prefazione di Marianne
Enckell, Noir, Ginevra, 1978. 125 pp. ill.
Confluences et particularités latino-américaines,
in Les nouveaux patrons: onze études sur la
technobureaucratie, Noir, Ginevra, 1979, pp. 151-171
(trad. it.: in I nuovi padroni, atti del Convegno internazionale
di studi su «I nuovi padroni», Antistato,
Milano, 1979).
Cuba : révolution et contre-révolution
: rémoignages, textes officiels et documents,
Parigi, 1962.
L'increvable anarchisme,UGE, Parigi, 1970 (trad.
it. rivista e corretta: La pratica dell'utopia: cinque
saggi sull'anarchismo, prefazione di Amedeo Bertolo,
Antistato, Milano, 1978, 187 pp.
Mécanismes du pouvoir en Amérique latine,
Belfond, Parigi, 1967, 208 pp.
Pourquoi et comment se bat la Hongrie ouvrière,
Union des syndicalistes, Parigi,1957.
Présence du syndicalisme libertaire, prefazione
di Roger Hagnauer, Union des syndicalistes, Commission
internationale de liaison ouvrière, Parigi, s.d.
(trad. it.: Presenza dell'anarcosindacalismo, Amici
dell'AIT, s.l., 1976, 53 pp.).
La révolution par l'État: une nouvelle
classe dirigeante en Amérique latine, prefazione
di Miguel Abensour, Payot, Parigi, 1978 (trad. it.: La
rivoluzione di stato, Antistato, Milano, 1981, 206
pp.).
Société et contre-société
chez les anarchistes et les anti-autoritaires (a cura
di L.M.V.), CIRA, Losanna, e Éditions Adversaires,
Ginevra, 1974.
Technique du contre-État: les guérillas
en Amérique du Sud, Belfond, Parigi,1968.
Riviste cui ha collaborato:
A rivista anarchica, Milano
L'Adunata dei refrattari, New York
Alliance ouvrière, Grenoble
Aportes, Parigi
Arbetaren, Stoccolma
Buiten de Perken, Olanda
CILO, Francia
Contacts littéraires et sociaux, Parigi
L'Espagne antifasciste, Parigi
L'Espagne nouvelle, Parigi
Études anarchistes, Parigi
Freedom, Londra
Interrogations, Parigi (poi Torino)
Le Libertaire, Parigi
Mundo nuevo, Parigi
New Politics, New York
Plus loin, Parigi
Preuves, Parigi
Reconstruir, Buenos Aires
Resistance, New York
Le Réveil syndicaliste, Liegi
Le Réveil syndicaliste, Parigi
Révision, Parigi
La révolution prolétarienne, Parigi
Témoins, Zurigo
Voce libertaria, New York
Volontà, Genova
War Commentary for Anarchism, Londra
Pseudonimi identificati:
Courami/Couramy, Damaschki, Hersay/R. C., L'Itinérant/L'itinerante,
Liégeois, Luis Mercier Vega, Pierre Paillard, Santiago
Parane, Charles Ridel. |
L'amaro orgoglio della lucidità senza illusioni
di Marianne Enckell
L'esistenza di Louis Mercier Vega comincia a Santiago del Cile
il primo ottobre del 1940, con l'acquisizione di una carta di
identità cilena. Ma è nato Charles Cortvrint a
Bruxelles, ventisei anni prima. I suoi articoli sulla stampa
anarchica sono firmati dapprima con lo pseudonimo di Courami,
poi come Charles Ridel, Damashki, Santiago Parane, L'Itinérant
e qualche altro nome di fantasia. Nel suo breve romanzo autobiografico
La Chevauchée anonyme si rappresenta insieme come
Parrain e come Danton: «Sono io stesso una federazione
di pseudonimi», amava dire di sé, con vezzo da
vecchio internazionalista.
È forse il cosmopolitismo che l'attira, ancora molto
giovane, a un meeting del Comitato internazionale di difesa
anarchica a Bruxelles? Hem Day, Ernestan, Nicolas Lazarévitch
vi tengono interventi in difesa di Francesco Ghezzi, antifascista
italiano scomparso nelle galere sovietiche. Parigi lo attira
presto, come un Varlin più che come un Rastignac. Con
il nome di Ridel vi si guadagna il pane come manovale ai mercati,
operaio pellettiere, venditore ambulante, sguattero (o meglio
«vaissellier à la petite argenterie»), correttore
di bozze, e qui fa sua la convinzione operaia per cui, in mancanza
di meglio, il sindacato è la più idonea espressione
di classe esistente. In seno alla Union Anarchiste, dove si
trovano all'epoca riunite tutte le tendenze libertarie francesi,
sotto il «cappello» ecumenico della «sintesi»
di Sébastien Faure, Ridel e i suoi amici delle Jeunesses
– il metallurgico Guyard, il carbonaio Carpentier, l'ambulante
Ringeas, l'aggiustatore metallico Faucier, lo scaricatore alle
Halles Patat – costituiscono una frazione comunista libertaria
che organizza gruppi di fabbrica e, non soddisfatto di dichiarazioni
antifasciste puramente verbali, propongono un programma economico
e politico alternativo al Fronte popolare.
Nel maggio del 1936 è presente al Congresso di Saragozza
della CNT spagnola. Quando il 19 luglio scoppia la rivoluzione,
aspetta appena che gli venga pagata la «quindicina»
di salario per partire. Assieme a Carpentier fonda il Gruppo
internazionale della colonna Durruti, «proscritti d'Italia
e sfruttati dall'imperialismo francese... la legione dei senza-patria
che sono venuti a battersi nella penisola per l'ordine operaio
e rivoluzionario». Ma quando le milizie vengono subordinate
al comando militare, quando gli anarchici entrano nel governo,
torna in Francia per sostenere, con un giro di conferenze, la
causa della Spagna rivoluzionaria. «Possiamo dire in tutta
coscienza, a nome di coloro che cadranno come miliziani della
rivoluzione sociale: 'Non è per quello che sono morti',
e possiamo impedire che i buffoni della rivoluzione sociale
depredino i loro cadaveri», dice nel maggio 1938 l'editoriale
di «Révision», piccola rivista dal titolo
provocatorio fondata da Ridel, Maria Luisa Berneri, Lucien Feuillade,
Jean Rabaut e qualche altro.
Nello stesso periodo il gruppo del «Réveil Syndicaliste»,
costituito da ex militanti delle Jeunesses anarchistes, si va
radicando nelle fabbriche. Ridel vive un po' del suo lavoro
di correttore di bozze e un po' di attività meno confessabili.
Quando scoppia la guerra non è neppure pensabile che
si lasci intruppare: «C'è ancora un amaro orgoglio
di disperata lucidità, in un mondo che corre verso l'abisso
cantando assurdi ritornelli». E poiché l'esercito
belga e la polizia francese lo aspettano al varco, parte per
un viaggio che sarà determinante per la sua vita futura.
In La Chevauchée anonyme (scritto sostanzialmente
autobiografico, pur se in forma di romanzo) racconterà,
molti anni dopo, l'esodo di un gruppo di anarchici impregnati
del ricordo delle lotte recenti in Belgio, Francia e Spagna.
Arrivati, loro malgrado, a Buenos Aires, si mettono in contatto
con il movimento anarchico locale e nel contempo cercano di
mantenere ogni legame possibile con i compagni rimasti in Europa.
Nel 1940, secondo la finzione narrativa, le strade dei due personaggi
– Danton e Parrain, i due doppi di Ridel – divergono:
il primo, che pure odia l'esercito, si arruola nelle Forces
libres francesi, nella speranza di tornare nel vecchio continente
e di ricostruirvi una rete di compagni. L'altro va in Cile:
il suo Paese, le sue radici. Ecco l'internazionalismo: tutta
la Terra per sé, a patto di avere delle solide radici.
Le Forces libres riportano Charles Ridel, divenuto nel frattempo
Luis Mercier Vega di fresca «anagrafe» e cileno
di fresca «nazionalità», a Durban, a Brazzaville
(nell'allora Congo francese) e poi in Libano, dove resta tre
anni, dapprima nei servizi d'ordinanza, e poi alla radio. Cumula
incarichi per mettere da parte soldi, impara il giornalismo,
cerca di mettere in piedi un gruppo, anche a costo di farsi
notare un po' come sovversivo. Ma ristabilire i contatti con
i compagni in Francia, Italia, Inghilterra è pressocché
impossibile: riesce a fare arrivare a Londra un solo articolo,
pubblicato su «War Commentary».
Mercier rientra, nel dicembre 1945, in Francia, dove i compagni,
sopravvissuti alla guerra, ai campi di concentramento o agli
espedienti per riuscire a cavarsela, vanno a poco a poco ritrovandosi.
Si stabilisce a Grenoble, dove si sposa e diventa giornalista
del «Dauphiné libéré». Ogni
mese manda una «lettera dalla Francia» ai giornali
anarchici di tutto il mondo: «Volontà» a
Genova, «Umanità nova» a Roma, «Freedom»
a Londra, «L'Adunata dei refrattari» a New York.
E collabora al «Libertaire» e alla «Révolution
prolétarienne» di Parigi. Lancia anche, in loco,
un giornale sindacalista, «L'alliance ouvrière»,
assieme ad alcuni militanti di Force ouvrière.
Ben presto la sua lucidità analitica e le sue capacità
organizzative lo fanno conoscere in ambiti più vasti
e viene assunto nella Segreteria del Congresso per la libertà
della cultura, un'organizzazione creata dall'American Federation
of Labor e da varie fondazioni nord-americane che così
definiva i suoi obiettivi: «difesa della libertà
della cultura, affermazione permanente dei valori della nostra
civiltà, lotta contro le dottrine totalitarie, istituzione
e sviluppo di un'organizzazione mondiale che riunisca gli intellettuali
in una cooperazione costruttiva su un programma antitotalitario».
Il Congresso è stato violentemente criticato come «macchina
da guerra» anticomunista e filo-americana. Ricordiamoci,
tuttavia, che tra i suoi fondatori ci sono personaggi come Arthur
Koestler, Ignazio Silone, Denis de Rougemont, François
Bondy, certo insospettabili di essere stati fantocci della CIA.
Può essere che nella Segreteria vi fossero uomini dei
servizi segreti, ma quelli che la facevano funzionare erano
il poeta polacco Costantin Jelenski, i militanti del POUM Julian
Gorkin e Ignacio Iglesias... e l'anarchico Mercier. Quest'ultimo
è segretario di redazione della rivista «Preuves»
e ben presto responsabile della sezione latinoamericana del
Congresso.
 |
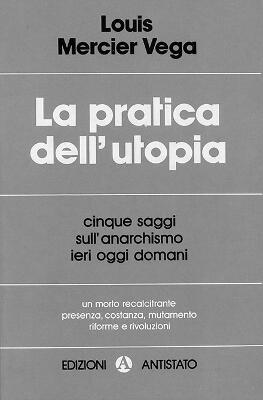 |
| Due volumi di Louis Mercier Vega pubblicati da Edizioni Antistato |
Il programma di una vita
Nel frattempo non lascia l'attività sindacalista. Partecipa
alla creazione, nella regione parigina, di una Unione dei sindacalisti,
che cerca di raggruppare militanti di diverse centrali sindacali
e di diversi ambienti. Nell'ottobre del 1956 scoppia la rivoluzione
ungherese: Mercier lavora giorno e notte a leggere, compulsare,
cercare di capire per pubblicare uno dei primissimi opuscoli
su quei fatti. Assieme a Helmut Rüdiger (un anarcosindacalista
tedesco rifugiatosi in Svezia e redattore di «Arbetaren»,
il quotidiano del sindacato libertario SAC) e ad Albert De Jong,
anarcosindacalista olandese, mette in piedi la Commission internationale
de liaison ouvrière (CILO), che pubblicherà un
bollettino in varie lingue dal 1958 al 1965.
Tra il 1962 e il 1965 è in missione in quasi tutti i
Paesi dell'America latina per installarvi delle «antenne»
dell'Istituto latinoamericano di relazioni internazionali: centri
di ricerca, gallerie d'arte, case editrici. Vi collaborano diversi
compagni esiliati come Benito Milla in Venezuela, André
Germain e Marcel Spielman in Cile, Fidel Miro in Messico, scelti
non per favoritismo o nepotismo, ma per la loro capacità
di lavoro e d'analisi. Mercier respinge senza pietà quelli
che tentano di servirsi opportunisticamente dell'Istituto o
del Congresso per fare carriera.
Le sue tesi, del resto, non sono fatte per piacere ai carrieristi:
ascesa di una nuova classe dirigente in tutti i Paesi della
regione, una classe di «fuoriusciti» dalla borghesia,
dall'esercito o dall'università – indifferentemente
di destra o di sinistra quanto a ideologia – il cui potere
è fondato sulla funzione e non più sulla proprietà.
Il concetto di tecnoburocrazia, che aveva già abbozzato
nell'immediato dopo-guerra, è uno degli elementi di base
dell'ultima rivista da lui avviata nel 1974: «Interrogations».
Alla fine degli anni '60 vengono denunciati cospicui finanziamenti
dei servizi americani, tramite fondazioni di copertura, al Congresso
per la libertà della cultura e delle sue istituzioni.
«Come tutti gli antistalinisti di sinistra, le rivelazioni
sulla partecipazione della CIA al Congresso l'avevano lasciato
impietrito», scrive Grémion, ma «Mercier
[...] era capace di incassare tutti i colpi che gli venivano
inferti in una situazione particolarmente difficile».
Nel 1972, per non svendere nulla, perde tutto: l'Istituto, la
rivista «Aportes» e il suo posto di lavoro.
Per tutto questo periodo è stato fedele ai suoi impegni
ma in modo defilato. Dopo la sua partenza per l'America latina
nel 1962, partecipa solo al bollettino della CILO e a «Révolution
prolétarienne»; al suo ritorno in Francia cessa
quasi del tutto le collaborazioni. Nel 1970 esce il suo L'increvable
anarchisme ed è una vera e propria scoperta per la
generazione del '68: quale comprensione, dall'interno,
del movimento anarchico, quale franchezza di parole, quale massa
di conoscenze e di esperienze! Questo smilzo libro dirompente
suscita nuove collaborazioni e profonde amicizie; ma risveglia
anche, ahimè, vecchi rancori e indegne calunnie in seno
al movimento anarchico.
Quando Mercier fonda la rivista quadrilingue (francese, inglese,
spagnolo, italiano) «Interrogations», è logorato
da queste campagne infami, dalla perdita del suo lavoro –
suo principale strumento di conoscenza – e dalla morte
prematura della sua compagna. Sa che è il suo ultimo
round. Ma non ha perso il fuoco che gli faceva criticare a venticinque
anni, tra la sconfitta della rivoluzione spagnola e la débâcle
delle democrazie di fronte alla guerra, «l'esecrabile
abitudine che hanno preso la maggior parte dei rivoluzionari
– sotto l'influenza dei lacrimosi democratici e dei reazionari
– di non riflettere sui fatti se non con passivo sentimentalismo
[...]. Vivere le lotte sociali rispondendo ogni giorno ai problemi
quotidiani, combattere con la certezza che ogni colpo inferto
si ripercuote anche su chi colpisce, costruire la propria teoria
tenendo ben saldi i piedi per terra e non negando la realtà
per idolatria dei princìpi, questo è il programma
che ogni militante può applicare».
E questo è il programma che Mercier s'è dato per
tutta la sua vita. Non gli resta che assicurarsi il ricambio,
mettere in marcia la rivista e i suoi interrogativi. Il 20 novembre
1977 Louis Mercier, alias Charles Ridel, alias Santiago Parane,
metteva fine ai suoi giorni. La Chevauchée anonyme, l'ultima
riproposizione dei suoi scritti sull'anarcosindacalismo e sull'America
latina e diverse traduzioni sono apparse postume.
Marianne Enckell
traduzione di Amedeo Bertolo
L'articolo pubblicato è apparso per la prima volta
in italiano nel Bollettino dell'Archivio Pinelli, n.9,
1999.
|