|
alternative
A che punto è l'autoeditoria?
di Claudia Vio
La differenza tra autopubblicazione e autoeditoria non è solo linguistica.
Il settore del self-publishing è in aumento, ma eterodirezione e mancanza di autodeterminazione sono i suoi limiti. L'autoeditoria può incrementare libertà di espressione e creatività, ma le esperienze dei singoli autoproduttori vanno aggregate. Per evitare che si disperdano.
Dopo quasi un decennio di attività, occorre fare un bilancio.
A partire da un autoesame. Nel primo libro pubblicato con Unica
Edizioni, nata nel gennaio 2006, davo fiato alle trombe della
mia personale autoeditoria. “Unica Edizioni – scrivevo
in una nota – risponde alla volontà di costruire
l'opera letteraria oltre la scrittura, inglobando la produzione
del testo e le forme della sua circolazione”.
Poche righe per esprimere un concetto che ho ripetuto in varie
circostanze, ma che vale la pena ribadire perché costituisce
la chiave dell'autoeditoria. Andare oltre la scrittura
significa intromettersi in tutto ciò che, in genere,
autori e autrici pensano che non li riguardino. Mi riferisco
a ciò che precede e che segue la pubblicazione di un
libro: lo scopo per il quale pubblicarlo, la scelta dei destinatari,
il modo di relazionarsi con i lettori, la vendita del prodotto-libro
(come la decisione di non venderlo). Sono tutti aspetti sostanziali
dell'editoria e tutti hanno a che fare con il pubblico: pubblicare
significa infatti, nella sua essenza, rendere pubblico.
La stampa è solo un mezzo, grazie al quale un autore/un'autrice
entra in contatto con il suo pubblico potenziale.
Dunque “pubblicare” non è sinonimo di “stampare”.
Mentre stampare è facile per chiunque - basta rivolgersi
a una tipografia - pochi autori invece riescono a “pubblicare”,
ovvero a collegarsi a un pubblico. Questo dipende dal fatto
che il complesso delle operazioni che sono connesse al pubblicare
sono monopolio dell'editoria. Contrariamente a quanto comunemente
si crede, infatti, il compito principale di un editore non risiede
tanto nel produrre libri, quanto nel gestire la loro circolazione.
Gli editori detengono il controllo della relazione autore-pubblico.
Nella grande maggioranza dei casi selezionano gli autori tenendo
d'occhio il pubblico, nella sua accezione di acquirente. Con
indagini di mercato intercettano le preferenze degli acquirenti
e su di esse orientano le loro scelte. Investono capitali nella
pubblicità, cioè nelle varie forme con le quali
il pubblico viene persuaso ad acquistare un libro. Attraverso
gli editori passano – o non passano – i contenuti
culturali. Il loro obiettivo è ottenere il massimo delle
vendite, i profitti più elevati.
Molta produzione, dunque, non accede all'editoria, perché
non viene considerata interessante per il mercato.
Le varie forme dell'autopubblicazione
Migliaia di “manoscritti” giacciono nei cassetti
perché vengono rifiutati dagli editori. A volte si tratta
di brutti libri, altre volte invece i libri sono scritti bene,
ma l'editore li ritiene di scarso interesse per il pubblico.
Spesso gli autori, respinti dagli editori, tentano di pubblicare
comunque. Da qui il fiorire delle cosiddette autopubblicazioni,
un fenomeno cresciuto enormemente nell'ultimo decennio.
Il termine “autopubblicazione” è ambiguo,
perché comprende realtà diverse. Facciamone una
rapida carrellata.
Stampare da sé in tipografia è la più tradizionale
delle forme di “autopubblicazione”. Da sempre, il
libro “pubblicato” in questo modo viene presentato
dall'autore con la dicitura “stampato in proprio”,
appunto perché non ha un editore. In genere, l'autore
stampato in proprio non definisce se stesso come autopubblicato;
egli pensa, giustamente, che “pubblicare” sia sinonimo
di “editare”, se ne guarda bene perciò dal
confondere le acque. Poiché non vuole ingannare il pubblico
millantando un editore che non esiste, l'autore stampato in
proprio si dichiara per quello che è: un autore senza
editore.
Nel Novecento l'autore stampato in proprio era una figura piuttosto
comune, una sorta di controcanto malinconico degli esclusi dall'editoria.
Esclusi dal rapporto con il pubblico, ovviamente, perché
“gestire” la relazione con il pubblico è
altra cosa da stampare ed è una competenza degli editori,
come abbiamo detto. Autori solitari, ignoti, attorniati tutt'al
più dalla cerchia ristretta degli amici e dei parenti.
Una sorte un po' diversa hanno avuto le autoproduzioni generate
dalle avanguardie artistiche e letterarie nei primi decenni
del secolo, così come quelle nate dalla controcultura
nella seconda metà del Novecento. Trattandosi di fenomeni
collettivi, che hanno provocato un sensibile rinnovamento del
linguaggio e del costume, queste autoproduzioni sono ancora
oggi apprezzate e spesso conservano la loro natura refrattaria
all'industria culturale e all'omologazione, con una forte carica
di vitalità creativa.
Anche i protagonisti delle autoproduzioni, come gli autori stampati
in proprio, hanno sempre evitato di definirsi “autopubblicati”.
In entrambi in casi c'è comunque una componente di radicalismo
(la volontà di non essere confusi con la cultura commerciale),
di elitarismo (la manifesta indifferenza verso il pubblico:
autoprodurre è considerato un valore in sé), in
qualche caso di deferenza verso l' “editoria vera”,
dalla quale sotto-sotto si spera di essere scoperti e a cui
ci si sente subalterni.
Per l'autore esiste anche un'altra possibilità per “autopubblicare”,
quella di pagare un editore che lo pubblichi. Questa forma di
autopubblicazione contiene una mistificazione, perciò
non viene mai rivelata come tale. Al pubblico si fa credere
che l'autore goda dell'accredito di un editore. In realtà
l'editore non ha investito un solo centesimo sull'autore, perché
è stato pagato dall'autore stesso (nelle varie forme
in cui ciò può avvenire: dal pagamento vero e
proprio all'impegno per l'autore di acquistare un tot di copie
o di comprare quelle invendute).
Questa forma di autopubblicazione è invisa agli editori
onesti, che la considerano a ragione una concorrenza sleale.
L'editore a pagamento, a differenza degli altri, non rischia;
attraverso l'autore si garantisce in partenza un profitto. Per
gli autori che la praticano è un controsenso. L'editore
pagato dall'autore non ha alcun interesse a cercare un pubblico,
perché ha già il suo acquirente, l'autore. Si
tratta di una pubblicazione senza pubblico.
Infine, prima di parlare della forma di autopubblicazione oggi
più in voga, il self-publishing, è opportuno menzionare
anche il crowdfunding o “produzioni dal basso”.
È un sistema di finanziamento collettivo – ovvero
di una raccolta fondi - a sostegno di uno specifico progetto.
I progetti possono essere i più vari, dalla costruzione
di un asilo alla realizzazione di una ricerca scientifica, da
un'emergenza umanitaria a un evento sportivo. Si tratta senz'altro
di una forma eccellente di “finanziamento dal basso”.
Il crowdfunding viene usato anche da alcuni autori per pubblicare
un proprio libro. Con il crowdfunding essi raccolgono il denaro
necessario per pagare un editore che li pubblichi. I loro libri
sono dunque autoprodotti? Appartengono alla dimensione dell'autoeditoria?
Gli autori ritengono di sì, perché questa pratica
è chiamata “produzioni dal basso” (si veda
il sito al riguardo).
Io credo invece di no. Dal basso proviene solo il denaro, che
però viene immesso in un sistema di editoria a pagamento.
È un peccato, perché l'aspetto positivo del crowfunding,
cioè la condivisione dell'iniziativa, viene inghiottito
nel solito tritacarne.
Self-publishing? No grazie
Nell'ultimo decennio il “self-publishing” è
diventato di moda. È una modalità di autopubblicazione
legata da un lato alla possibilità, offerta dall'informatica,
di “creare” un libro con pochi semplici passaggi,
dall'altro, di rendere “disponibile” il libro a
un pubblico planetario grazie al web.
Il self-publishing si sta affermando con l'aggressività
tipica delle battaglie commerciali per la conquista del mercato.
Ha rapidamente assorbito il concetto di “autoproduzione”,
di cui spesso si presenta come sinonimo, e ha spazzato via gli
“stampati in proprio”, dinosauri dell'epoca del
cartaceo. I siti di self-publishing dichiarano di essere “un
modo per pubblicare senza ricorrere a un editore”. Come
vedremo, usano il termine “pubblicare” in modo ingannevole.
Uno dei siti di self-publishing più noti è ilmiolibro.it,
tra i più fortunati c'è lulu.com, ma ve
ne sono molti altri. Tutti funzionano più o meno nello
stesso modo: l'autore accede alla piattaforma on-line del sito
dove trova disponibile, già nella homepage, un software.
Di solito il software non si presenta come tale: esso compare
con la dicitura “Crea il tuo libro” (in evidenza)
con un link sottostante da cliccare: “Inizia subito”.
Cliccando sul link l'autore inizia a “creare” il
proprio libro, nel senso che lo compone, guidato passo passo
dal software. Sceglie il formato, la rilegatura, l'immagine
di copertina, inserisce il testo. L'intera procedura è
gratuita. Alla conclusione di tutti questi passaggi, con un
“clic” di conferma il libro risulta “fatto”.
Il software ha creato automaticamente il libro.
I siti di self-publishing enfatizzano due aspetti allettanti
della loro offerta: la possibilità di “pubblicare
senza un editore” e, per l'autore, di “esprimere
se stesso liberamente”. L'editore è dipinto come
il grande nemico della creatività individuale, l'ostacolo
che impedisce all'autore-creatore di raggiungere il pubblico.
In parte ciò è vero. Come abbiamo detto prima,
l'editore ha il monopolio del rapporto con il pubblico. Ma non
è vero che il self-publishing non abbia un editore, ce
l'ha eccome. E non è vero che l'autore guadagni qualche
fetta di libertà con il self-publishing. Tanto per fare
un esempio, il sito ilmiolibro.it appartiene al Gruppo
Editoriale l'Espresso, lo stesso di Repubblica per intenderci.
Lorenzo Fabbri, ideatore del sito ilmiolibro.it, enuncia
i dettami della nuova editoria in una intervista rilasciata
a Rosalba Rattalino (www.inuk.it). La sua filosofia è
la stessa di lulu.com, creato da un imprenditore canadese,
Bob Young, il quale ha intravisto nell'autopubblicazione le
possibilità di un affare planetario grazie a questo principio
ispiratore: “il successo non è fatto da 100 libri
che vendono 100 mila copie, ma da 100 mila libri che vendono
100 copie ognuno”. I centomila libri che vendono cento
copie ognuno corrispondono ai centomila autori autopubblicati
(ciascuno con qualche decina di copie), in contrapposizione
ai pochi autori selezionati (i 100 libri) per ciascuno dei quali
l'editoria tradizionale si sforza di ottenere il massimo delle
vendite (100 mila copie).
Dunque l'editore esiste. Però non compare nei siti di
self-publishing. Questi siti forniscono pochissime informazioni
su di sé, in genere contengono solo le istruzioni per
“autopubblicare”. Non si sa a chi appartengano,
né da chi sia formata la redazione. Si presentano con
il volto dell'immediatezza (pubblicare subito). Questa
immediatezza viene attribuita al mezzo tecnologico. L'utente
si convince di poter scavalcare in un balzo gli ostacoli posti
dall'editoria in virtù di un mezzo tecnologico, il software,
e di internet, che metterà il suo libro “pubblicato”
a disposizione di un pubblico oceanico.
In realtà il libro generato usando il software del sito
non è affatto “pubblicato”. Esso è
solo potenzialmente pubblico, nel senso che può essere
conosciuto dal pubblico a condizione che l'autore acquisti una
serie di servizi, dall'inserimento in una libreria on-line,
al messaggio promozionale, dalla stampa di un tot di copie su
richiesta all'iscrizione a una community. L'insieme di questi
servizi editoriali, gestiti dal sito, rende evidente il fatto
che, ancora una volta, l'editore è il vero intermediatore
fra l'autore e il pubblico. L'autore che “pubblica”
se stesso con il self-publishing non rinuncia all'editore, al
contrario ne esalta il potere. Ciò a cui rinuncia l'autore
è sottoporsi al giudizio di un editore, positivo o negativo
che sia. Egli aggira l'ostacolo dell'editore (apparentemente),
per infilare la testa nel cappio di un'editoria che è
esclusivamente commerciale e sostanzialmente identica all'editoria
a pagamento.
Per inciso, osserviamo un altro aspetto del self-publishing.
La smaterializzazione dell'oggetto-libro, insieme alle potenzialità
comunicative del web, spinge l'editoria a spostarsi dalla produzione
del manufatto (tipica del cartaceo) alla fornitura di servizi.
In effetti, alcuni siti di self-publishing sono gestiti da tipografie
e il confine fra l'editoria degli editori e l'editoria dei grafici
si fa sempre più incerto. Tutti questi siti puntano sulla
“libertà creativa” dell'utente, che però
è solo un'espansione della soggettività; essa
non ha niente a che vedere con la libertà intesa come
autodeterminazione, che invece è minima, perché
il potere economico e il controllo della comunicazione restano
ben saldi nelle mani dell'editore o delle agenzie editoriali.
Strategie comunicative dell'autopubblicazione
Come ho detto, i siti di self-publishing puntano sull'immediatezza
del risultato (pubblica subito!), che coincide con l'automatismo
(per pubblicare basta un clic). L'immediatezza viene presentata
come un elemento innovativo, in contrapposizione con la lentezza
della carta stampata del passato. I giovani, soprattutto, sono
i più propensi a cercare un'espressione di libertà
attraverso il self-publishing, perché facilmente credono
di vivere una svolta tecnologica epocale. In altre parole, la
tecnologia viene presentata come portatrice di libertà;
il software sostituisce la politica.
Oltre all'immediatezza, i siti di self-publishing puntano molto
sulla personalizzazione. L'utente del sito viene sollecitato
a “creare” il libro seguendo le proprie preferenze.
La gamma delle possibilità offerte dal software è
limitata, ma è comunque sufficiente a generare la sensazione
di produrre secondo i propri desideri, anche perché l'utente
collabora attivamente al lavoro “interagendo” con
il mezzo tecnologico.
La personalizzazione del prodotto e l'interazione sono una tendenza
che si va affermando rapidamente anche al di fuori del mondo
del self-publishing. Il prosumer (il produttore-consumatore)
è il nuovo obiettivo del marketing, in sostituzione del
“consumatore passivo”. Il prosumer o l'“autore-consumatore”
è il nuovo vessillo della libertà contro la massificazione.
Il web – si sostiene – è “orizzontale
e democratico”. In realtà il massimo di soggettività
va di pari passo con il massimo controllo autoritario della
comunicazione.
Da questo punto di vista il self-publishing è tristemente
interessante non solo perché è una forma aggiornata
di editoria a pagamento, ma perché è la spia di
uno spostamento del sistema di potere dalla produzione di beni
alla produzione di servizi, dove è cruciale il controllo
della comunicazione. Paradossalmente, ma mica tanto, i veri
grandi editori sono i motori di ricerca. Tra tutti, Google.
Sta digitalizzando intere biblioteche in tutto il mondo. Oggi
i libri digitalizzati vengono offerti in lettura gratuitamente,
domani si dovrà pagare l'accesso ai libri. E forse pagare
potrebbe non essere sufficiente.
Ciò significa che si sta spostando il baricentro del
potere e che, da gerarchico e piramidale, sta prendendo una
forma diffusa, capillare, atomizzata. Non solo. Mentre nel mondo
del “cartaceo” il rapporto fra il lettore e il libro
è oggettivato perché l'oggetto-libro viene percepito
dal lettore come qualcosa di diverso da sé, ciò
non avviene nel mondo digitale gestito dall'industria culturale.
Qui il rapporto fra l'oggetto e il soggetto appare “fisiologico”.
I nativi digitali sono le vittime ideali di questa nuova dimensione.
Essi percepiscono lo strumento digitale come un'estensione di
sé, del proprio corpo. Manca quella separatezza dal prodotto,
che suggerisce un minimo di spirito critico. I nativi digitali
non si interrogano su ciò che stanno facendo mentre interagiscono
con il software.
Osserviamo: da una parte c'è un individuo, con la sua
aspirazione a comunicare, desideroso di “esprimere se
stesso”, animato dal desiderio di creare qualcosa di personale
e originale. Dall'altra c'è un'entità incognita,
anonima, cioè il sito di self publishing, che lo pilota.
Che governa quelle pulsioni. L'individuo è completamente
eterodiretto, proprio mentre crede di esprimere il massimo di
autodeterminazione.
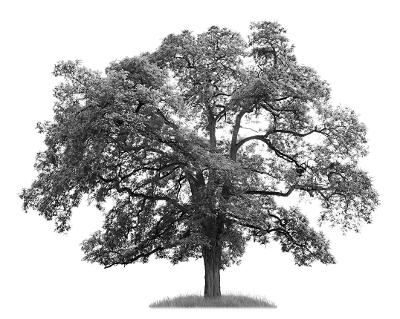 Infine
notiamo un altro aspetto preoccupante, la perdita del principio
dell'alterità, del dissenso. Quando dico che l'autopubblicazione
ha divorato l'autoproduzione non mi riferisco a un mero fenomeno
linguistico (che comunque non è mai a se stante). Intendo
dire che la propaganda del self-publishing ha fatto proprie
anche le parole d'ordine della controcultura, a cui addirittura
si richiama, a volte, e di cui si autoproclama erede. Svuotata
del suo orizzonte contestatario, la controcultura viene usata
per manipolare le aspirazioni alla libertà. Tant'è
che oggi chi pubblica in self-publishing lo dice apertamente
e ne è orgoglioso. Infine
notiamo un altro aspetto preoccupante, la perdita del principio
dell'alterità, del dissenso. Quando dico che l'autopubblicazione
ha divorato l'autoproduzione non mi riferisco a un mero fenomeno
linguistico (che comunque non è mai a se stante). Intendo
dire che la propaganda del self-publishing ha fatto proprie
anche le parole d'ordine della controcultura, a cui addirittura
si richiama, a volte, e di cui si autoproclama erede. Svuotata
del suo orizzonte contestatario, la controcultura viene usata
per manipolare le aspirazioni alla libertà. Tant'è
che oggi chi pubblica in self-publishing lo dice apertamente
e ne è orgoglioso.
Cos'è l'autoeditoria, cosa vorrei che fosse
Dire cos'è l'autoeditoria significa descrivere un paesaggio
che sta in bilico fra quello che già esiste e ciò
che si vorrebbe che esistesse.
L'autoeditoria è l'editoria degli autori e delle autrici
che autogestiscono l'intero processo collegato alla creazione
e diffusione del libro: dalla sua realizzazione come manufatto
(cartaceo o digitale, manuale o stampato in tipografia) alla
sua circolazione. Il termine non va inteso in chiave autoriflessiva
(mi pubblico da me), ma di autogestione. Nell'autoeditoria
tutte le decisioni che contano fanno capo all'autore, che perciò
si propone anche come editore. La figura dell'editore non viene
affatto cancellata. Essa contiene le funzioni decisionali più
importanti che riguardano la circolazione dei contenuti. L'autoeditore
non le delega ad altri, se ne fa carico.
Da questo punto di vista l'autoeditoria è parente stretta
dell'autoproduzione e certamente ingloba lo stampato in proprio.
Non ha niente a che spartire invece con il self-publishing,
dove l'autore ha compiti editoriali insignificanti e comunque
scorporati dal processo editoriale complessivo. Ovviamente è
anche lontanissima dall'editoria a pagamento.
Questa autoeditoria esiste. Da molti anni la praticano i Troglodita
Tribe, con la loro Editoria Casalinga Interstellare, e la Casa
Editrice Libera e Senza Impegni. Entrambi sono attivi soprattutto
sul versante dell'autoproduzione di libelli fatti a mano, sempre
con materiali di riciclo. Sul versante della scrittura esistono
da tempo la rivista Edizione dell'Autrice e la sottoscritta.
Altri si sono aggiunti negli ultimi anni, come Lieve Malore
ad esempio, testimoniando una grande vitalità dell'autoproduzione.
Tuttavia le esperienze dei singoli soggetti che autoproducono,
benché sempre più numerose, andrebbero disperse
se non si fosse fatto lo sforzo di aggregarle, creando occasioni
d'incontro e di scambio. Ricordiamo a Venezia, nel 2007, il
primo tentativo di riunire le forze locali con “Aut Aut”,
una rassegna di autrici e autori autoprodotti organizzata da
Unica Edizioni e Scoletta dei Misteri di Antonella Barina. Gli
eventi collettivi sono proseguiti con gli incontri annuali di
“M'Editare”, di Edizione dell'Autrice, e con altri
eventi organizzati da Unica Edizioni, come la rassegna “Dopo
l'ultima parola” presso il teatro Fuori Posto di Mestre
nel 2010 o presso l'Ateneo degli Imperfetti di Marghera nel
2010-2011.
Tra le iniziative nate per collegare gli autoproduttori, Liber
– I Libri Liberi è quella che meglio esprime l'idea
di un'autoeditoria libertaria. L'annuale salone milanese, nato
nel 2011 per volontà della Casa Editrice Libera e Senza
Impegni e di Edizioni Pratiche dello Yajè, è appunto
autoprodotto, autogestito e autofinanziato, oltre che organizzato
secondo una logica di rapporti non gerarchici. Liber si è
rivelato uno straordinario propulsore per l'autoproduzione,
contribuendo a diffonderne il linguaggio e la filosofia, come
dimostra il moltiplicarsi di nuovi autoproduttori, ispirati
da ciò che hanno visto a Milano e già capaci di
portare un contributo originale.
Ma, dobbiamo sottolinearlo, nemmeno questo è sufficiente.
Non basta creare eventi collettivi, benché rigorosamente
autogestiti, autoprodotti e autofinanziati. È necessario
anche creare un circuito che sia anch'esso autogestito, autoprodotto
e autofinanziato (giova ripeterlo), perché il terreno
dove si gioca il rapporto fra autorità e libertà
è proprio quello della circolazione del libro, più
che la sua confezione. Si faccia caso a quanto è accaduto
dopo il primo Liber. Esso ha attirato l'interesse di associazioni
che ora riprongono fiere o saloni di libri autoprodotti nelle
loro città. Il libro autoprodotto piace. È gioioso,
accessibile e, a differenza dei tradizionali “libri d'artista”,
non rinuncia mai al suo valore d'uso, pur restando un prodotto
unico e bellissimo. Non nasce per finire dentro una bacheca.
E può essere “imitato”, infatti gli autori
di libri autoprodotti insegnano come farli.
Ma, è questo il punto che mi preme sottolineare, le associazioni
culturali che organizzano fiere analoghe a Liber, non si muovono
nella filosofia dell'autoproduzione. Si collocano come intermediatori
culturali nel processo editoriale della circolazione del libro.
Godono di finanziamenti considerevoli, perché spesso
hanno il sostegno finanziario del Comune e dei privati. Certo,
servono a far conoscere i libri autoprodotti, ma in parte ne
mutilano l'essenza. L'intenzionalità politica dell'autoeditoria
viene decapitata e con essa, a ben guardare, anche la sua vitalità.
Proprio per non delegare a terzi l'autoproduzione del circuito,
negli ultimi due-tre anni si è cercato di creare almeno
due poli di circolazione: Milano e Venezia. Così la rassegna
Fare Libri Liberi, organizzata con l'Ateneo degli Imperfetti
di Marghera, e con lo sforzo notevole degli ospiti partecipanti,
ha consentito di scavare un primo solco. Il sostegno di A Rivista
Anarchica è prezioso, perché consente di dare
diffusione agli eventi e di mantenere nel tempo la continuità
dell'ispirazione libertaria.
Quest'anno si prosegue a Mestre con l'“Atelier dell'altra
editoria” presso Casa Bainsizza, con la collaborazione
del Gruppo di Lavoro Via Piave, un'associazione di promozione
sociale che da alcuni anni lavora in un quartiere difficile.
Il Liber-salone sarà presente all'Atelier, in trasferta
per così dire. È questa un'occasione per potenziare
la valenza sociale dell'autoeditoria, senza la quale essa rischia
di diventare una variante eccentrica del mercato editoriale.
Ma è necessario anche affrontare il web. Comprendere
la natura e la dinamica di potere che si sta realizzando attraverso
di esso. Il gruppo Ippolita ha scritto testi eccellenti al riguardo,
che l'editrice Eleuthera è stata la prima a pubblicare.
Occorre considerare il mezzo tecnologico e utilizzarlo a un
fine libertario. E qui il lavoro è tutto da fare.
Claudia Vio
|