|
antropologia
Un'antropologa dallo sguardo 'altro'
intervista a Franco Cuomo di Domenico Sabino
Annabella Rossi (Roma, 1933 - 1984) fu tra le prime ad utilizzare la fotografia e la ripresa video nella ricerca antropologica in Italia.
Ne parliamo con un filosofo e saggista.
Franco Cuomo, docente all'università di Napoli,
funzionario del settore Musei e Biblioteche della regione Campania,
dove e quando conosci l'antropologa Annabella Rossi? Qual è
il suo modus operandi per entrare in contatto con le persone
e gli informatori?
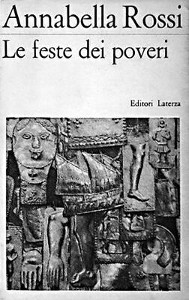 Non
sono un antropologo e la mia conoscenza di Annabella Rossi è
stata meramente fortuita. La conobbi nel 1976 a una festa popolare
al Santuario della Madonna di Materdomini a Nocera Superiore
(SA); la festa si svolge il 14 agosto vigilia di Ferragosto
e dura fino all'alba del giorno successivo. Durante la festa
numerosi gruppi si esibivano nello spazio antistante al Santuario
con canti e danze rituali “dedicati alla Madonna”.
Una festa molto intensa e suggestiva. Io andai con i miei amici
di allora: Annibale Ruccello, Franco Autiero, Vanni Baiano.
Noi eravamo col M° Roberto De Simone che registrava tali
canti di tradizione orale per una sua pubblicazione; fu lui
a presentarcela: bassina, rotondetta, con gonnellone e collane
etniche. Insegnava Antropologia Culturale all'università
di Salerno. L'impressione che ebbi fu quella di una donna molto
abile a entrare in contatto con altre donne, anche se molto
più avanti negli anni di lei e di diversa collocazione
culturale. Era capace di far venir fuori aspetti inconsueti
e oltremodo autentici, lavorando sul loro universo simbolico
su cui indagava già da anni attraverso ricerche storiche,
antropologiche e sociali del profondo Sud d'Italia. Credo che
per lei sia stato decisivo l'incontro avvenuto nel 1959 con
l'antropologo Ernesto de Martino, con l'uscita di un numero
monografico della rivista Nuovi Argomenti, dedicato a “Mito
e Civiltà Moderna”. Non
sono un antropologo e la mia conoscenza di Annabella Rossi è
stata meramente fortuita. La conobbi nel 1976 a una festa popolare
al Santuario della Madonna di Materdomini a Nocera Superiore
(SA); la festa si svolge il 14 agosto vigilia di Ferragosto
e dura fino all'alba del giorno successivo. Durante la festa
numerosi gruppi si esibivano nello spazio antistante al Santuario
con canti e danze rituali “dedicati alla Madonna”.
Una festa molto intensa e suggestiva. Io andai con i miei amici
di allora: Annibale Ruccello, Franco Autiero, Vanni Baiano.
Noi eravamo col M° Roberto De Simone che registrava tali
canti di tradizione orale per una sua pubblicazione; fu lui
a presentarcela: bassina, rotondetta, con gonnellone e collane
etniche. Insegnava Antropologia Culturale all'università
di Salerno. L'impressione che ebbi fu quella di una donna molto
abile a entrare in contatto con altre donne, anche se molto
più avanti negli anni di lei e di diversa collocazione
culturale. Era capace di far venir fuori aspetti inconsueti
e oltremodo autentici, lavorando sul loro universo simbolico
su cui indagava già da anni attraverso ricerche storiche,
antropologiche e sociali del profondo Sud d'Italia. Credo che
per lei sia stato decisivo l'incontro avvenuto nel 1959 con
l'antropologo Ernesto de Martino, con l'uscita di un numero
monografico della rivista Nuovi Argomenti, dedicato a “Mito
e Civiltà Moderna”.
Nel 1959 Annabella incontra Ernesto de Martino; trae indicazioni
per il proprio lavoro di ricerca sul campo; acquisisce una presa
di coscienza della problematica dei rapporti tra classi al potere
e classi subalterne e ne parla nell'articolo del '71 “Realtà
subalterna e documentazione”: «Questa realtà
deve essere documentata, per essere conosciuta, per circolare,
per smascherare chi la copre per precisi fini politici».
È attuale tale asserzione?
Oggi è molto difficile definire i rapporti tra classi
e potere perché le classi, nell'accezione marxiana del
termine e anche demartiniana, non esistono più, omologate
come sono in una low class di massa, mentre lo stesso
concetto di potere è diventato altro dall'idea monolitica
del grande Moloch. È un potere molto diffuso e 'liquido',
per dirla col sociologo Bauman. Anche il capitale politico è
'liquido' e pronto a qualsiasi investimento e coglie con prontezza
le possibilità di profitti che la paura del futuro offre
in misura crescente. Grandi investimenti si profilano di fronte
allo scricchiolare della sovranità di quel Leviatano
che aveva costruito la sua forza e legittimazione proprio sulla
paura (ma restituendo protezione e sicurezza). In questa fluidità
si accompagna un aumento della disuguaglianza che, se una volta,
soprattutto per le classi subalterne, aveva dei riferimenti
simbolici e identitari, oggi no. In più, vedo una forte
resistenza al cambiamento e una chiusura verso ogni possibile
emancipazione.
Negli anni Sessanta, conduce nel Meridione ricerche sulla
religiosità popolare, corredate di documentazione fotografica
e confluite nei volumi “Le feste dei poveri” e “Lettere
da una tarantata”. Si può affermare che abbia dato
inizio all'antropologia visiva in Italia, ovvero immagine-documento
definito 'campo visivo'?
Sicuramente. Annabella Rossi è stata tra le prime a utilizzare
la fotografia e la ripresa video nella ricerca antropologica
in Italia; molti suoi reportage sono fotografici. Un'antropologia
visiva è un documento antropologico definito 'campo visivo'.
A Vico Equense (Na) - nella frazione di Ticciano - con Roberto
De Simone ha fotografato e registrato una serie di canti rituali
inseriti poi nel saggio Carnevale si chiamava Vincenzo,
risultato di una ricerca durata quattro anni, ancora oggi unica
e insuperata per vastità e completezza, condotta negli
anni Settanta in Campania.
 |
| Annabella Rossi |
Di tammorra, taranta, pizzica salentina, ecc.
Nei due saggi sopra citati si evidenzia l'approccio gramsciano
alla struttura festa e al folclore considerato fino ad allora
elemento 'pittoresco' e 'spettacolare'; per la Rossi, invece,
esso è l'espressione di determinati strati sociali con
cui entrare in simbiosi. Basti pensare che con “Lettere
da una tarantata” - esempio ante litteram di antropologia
dialogica - l'analisi del fenomeno è scandita da una
tarantata e dal suo vissuto reso accessibile per la prima volta.
Cosa puoi aggiungere in merito a tale considerazione comparandola
alla situazione odierna?
Nulla. Gramsci è stato per molti di noi una guida per
comprendere ciò che Pasolini chiamò “mutazione
antropologica”, ma gli approcci antropologici di quegli
anni si nutrirono anche degli studi del linguista/semiologo
Saussure ovvero dello strutturalismo. Nel 1958 un gruppo di
antropologi, tra cui Tullio Seppilli, Amalia Signorelli e Tullio
Tentori, elaborò una vera e propria carta di fondazione
dell'antropologia culturale italiana che cominciò a fare
il suo ingresso negli atenei. Per ritornare al libro che citi,
Lettere da una tarantata, è un testo mitico e
introvabile. Lo conosco perché me ne parlava Annibale
Ruccello che lo aveva incluso tra le cose da leggere; ne abbiamo
letto anche qualche passo insieme, nella pizzeria 'Zemberiniello'
a Castellammare di Stabia (Na) dove ci incontravamo, oltre che
per mangiare la pizza anche per caotici seminari preparatori
di Ipata, una rilettura dell'Asino d'oro di Apuleio.
Le Lettere da una tarantata furono frutto di una corrispondenza
intercorsa dal '59 al '65 fra Annabella Rossi e Anna, un'anziana
contadina della provincia di Lecce, afflitta fin dalla giovinezza
da crisi epilettiche quotidiane. Il testo inquadra nella giusta
luce questo fenomeno, tenendo conto delle condizioni di vita
in cui viveva il contadino del Sud. Oggi tutto questo non esiste
più e laddove sembra esistere è solo una scialba
riproposizione folkloristica. Mi riferisco alle scuole di tammorra,
taranta, pizzica salentina, etc.
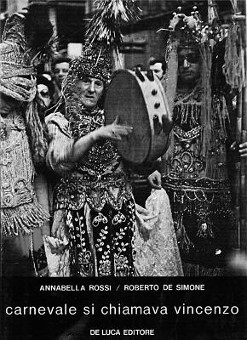
Negli anni Settanta, durante la docenza di Antropologia
Culturale presso l'università di Salerno, Annabella conosce
Roberto De Simone e avvia cospicue ricerche in Campania con
documentazione fotografica, sonora e filmica. Ritroviamo i risultati
antropologici ed etno-musicologici di tali lavori nei saggi
“Immagini della Madonna dell'Arco” e “Carnevale
si chiamava Vincenzo”. Ciò avrebbe dovuto suscitare
maggior attenzione per l'antropologia e la cultura popolare.
Cosa ricordi di quel periodo?
Quegli anni per molti di noi furono un laboratorio permanente
di crescita culturale, eravamo giovanissimi senza internet e
senza cellulari. La società italiana mi pareva più
aperta e curiosa rispetto a quella omologata di oggi. Certo
quegli anni furono attraversati dal terrorismo, ma credo che
la società fosse attraversata da un anelito democratico
e da una spinta al cambiamento che oggi non c'è. L'interesse
per le culture subalterne nasceva proprio dalla voglia di partecipazione
e di democrazia. A veicolare tutto ciò c'erano folk singer,
artisti, registi, scrittori. Noi eravamo giovani in quegli anni,
ma gli intellettuali che spingevano e alimentavano questa spinta
erano quarantenni: Annabella Rossi, De Simone, Calvino, Pasolini,
Signorelli. L'Antropologia Culturale e la cultura popolare fanno
il loro ingresso nelle università. Negli anni 70 io,
Ruccello e Autiero eravamo studenti; abbiamo conosciuto gli
antropologi Luigi Maria Lombardi Satriani, Amalia Signorelli,
Alfonso Maria di Nola e seguito con vivo interesse le lezioni
all'università di Napoli.
Negli anni in cui opera la Rossi, la cultura egemone opera
una sorta di rimozione della cultura popolare definendola volgare
e inopportuna. Contro tale rimozione si leva forte la voce di
Annabella, tant'è che durante i viaggi nel Salento e
nel Mezzogiorno studia e denuncia siffatta situazione. Oggi
ci sono antropologi che operano entrando in contatto diretto
con la comunità, carpendone le trasformazioni in atto?
Penso che l'Antropologia Culturale è diventata antropologia
urbana. Oggi la ricerca antropologica sulle comunità
è svolta in maniera dignitosa e con molta serietà
nei centri sociali, poli attrattori di istanze che arrivano
da culture 'altre' alla nostra: mi riferisco agli immigrati,
ma anche ai ceti emarginati dal nostro sistema sociale. La società
è diventata neofeudale: signori molto ricchi con una
sterminata, benché informatizzata, servitù della
gleba.
Attualmente la ricerca antropologica ha avuto un'evoluzione
o un'involuzione? Dove dovrebbe volgere lo sguardo? Cosa dovrebbe
significare per un antropologo 'osservare' una festa popolare?
La ricerca antropologica si è completamente trasformata
e oggi un antropologo potrebbe osservare le feste popolari degli
immigrati, i flash mob che si attivano per le cause più
disparate, i movimenti che si organizzano contro un grigio conformismo.
Perché una personalità vigorosa come Annabella
Rossi è spesso dimenticata dagli antropologi? Cosa rimane
proficuo della sua produzione scientifica e del suo insegnamento?
Cosa dovrebbe trasmettere la sua lezione a chi si avvicina all'antropologia?
La lezione che Annabella Rossi trasmette e lascia, come tutti
i grandi intellettuali, è l'impegno profuso nel lavoro
e nella ricerca. Un'analisi come la sua, oggi, non si potrebbe
più fare in Italia perché quel mondo magico del
Mezzogiorno, indagato in profondità, nei contenuti e
nei documenti della tradizione orale, è scomparso da
tempo e per sempre. Prevedo tempi ancora bui e lontana una possibile
ripresa.
Domenico Sabino
Bibliografia essenziale
Annabella
Rossi, Simonetta Piccone Stella, La fatica di leggere,
Roma, Editori Riuniti, 1964
Annabella Rossi, Roberto Leydi, Osservazioni sui canti
religiosi non liturgici, Milano, Ed. del Gallo, 1965
Annabella Rossi, Le feste dei poveri, I ed., Bari,
Laterza, 1969
Annabella Rossi, Lettere da una tarantata, I ed.,
Bari, De Donato, 1970
Annabella Rossi, Lello Mazzacane, Miseria e follia,
Milano, Editphoto, 1971
Annabella Rossi, Ferdinando Scianna, Il glorioso Alberto,
Milano, Editphoto, 1971
Annabella Rossi, Roberto De Simone, Immagini della
Madonna dell'Arco, Roma, De Luca, 1974
Annabella Rossi, Roberto De Simone, Carnevale si chiamava
Vincenzo, Roma, De Luca, 1977
Annabella Rossi, Claudio Barbati, Gianfranco Mingozzi,
Profondo Sud. Viaggio nei luoghi di Ernesto de Martino
a vent'anni da “Sud e magia”, Milano,
Feltrinelli, 1978
Annabella Rossi, E il mondo si fece giallo, Vibo
Valentia, Qualecultura - Jaca Book, 1991
Vincenzo Esposito (a cura di), Annabella Rossi e la
fotografia. Vent'anni di ricerca visiva nel Salento e
in Campania, Napoli, Liguori, 2003.
|
|