
Crêuza de mä
“(...) Appena uscito, Crêuza non sollevò
nessun tipo di entusiasmo che non fosse quello di qualcuno di
voi critici. La casa discografica non ci credeva, qualche rappresentante
mi chiese se ero diventato matto ed in particolare il venditore
della Liguria mi fece sapere, stizzosamente, che neppure a Genova
c'era qualcuno che ci avesse capito un cazzo. Nel giro di un
paio di mesi Crêuza aveva venduto qualcosa come 45mila
copie, perfettamente corrispondenti alle previsioni mie e di
Pagani. Poi vi ci siete messi voi, a dire che Crêuza era
un capolavoro, a riempirci la giacca di medaglie fino a quando
la gente prima si è incuriosita e poi ha cominciato ad
apprezzare. Così le prime 45mila copie sono diventate
le oltre trecentomila di oggi...”
(Fabrizio de André a Giancarlo Susanna, 1990)
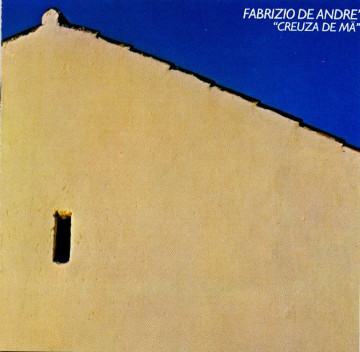
Com'è strano il destino di “Crêuza de mä”.
Fabrizio de André e Mauro Pagani trent'anni fa costruirono
in laboratorio il prototipo di quella che negli anni a venire
sarebbe stata la musica esposta negli scaffali dei negozi sotto
l'etichetta world music. Musica che appartiene alla gente, fatta
dalla gente per diffonderla tra la gente. Una musica difficilmente
misurabile su di un calendario e su di una carta geografica:
è musica che riporta alla mente certi paesi specifici
ma che è inadatta a restare chiusa dentro a dei confini
e che anzi si presta a contaminazioni, scambi e manipolazioni.
È musica insieme antica ed innovativa, pare affondare
le radici nel passato eppure è senza tempo. Fabrizio
e Mauro ci misero dentro tutto il loro amore e le suggestioni
raccolte in anni di letture e di viaggi. In testa un'idea vecchia,
la stessa delle genti che costruiscono le case sulla costa:
l'idea del mare messo lì a riunire le sue sponde e non
per tenerle lontane, la distesa d'acqua immaginata e vissuta
come porta aperta all'incontro, come occasione d'attraversamento
e non muro o ostacolo a separare. Stavo riflettendo su come
questa idea s'era fatta strada nella testa dei veneziani, che
avevano trovato nelle terre emerse della laguna un rifugio dall'invasione
e dal massacro, ma che avevano poi imparato a padroneggiare
quella distanza di sicurezza e a sfruttarla a proprio vantaggio
trasformandosi in esploratori, poi in viaggiatori, in commercianti.
E in predoni, anche. Ma Fabrizio e Mauro no: neanche una briciola
di pensiero distribuita agli avvoltoi dell'industria dello spettacolo,
neanche uno sguardo volto all'arrampicata in alto alla vetta
delle classifiche di vendita. Loro avevano in testa e negli
occhi una via tracciata sotto il mare, una via segreta che nei
secoli si è lasciata mappare solo da pochi.
“(...) Volevo mettere l'accento sul fatto che questo
è il contrario del disco folcloristico, cioè proprio
il contrario. E' casomai un disco etnico, che va a cercare le
etnie coi loro strumenti, i loro suoni e che cerca di omogeneizzare
per cercare di dare l'idea di quello che poteva essere un certo
tipo di mondo mediterraneo un po' di anni fa, e forse lo è
ancora adesso. Il mondo visitato dalle barche, voglio dire,
gli sciabecchi, le galee, e che fosse strettamente mediterraneo
e quindi la scelta della lingua genovese, io continuo a chiamarla
lingua...”
(Fabrizio de André a Ferdinando Molteni ed Alfonso Amodio,
1984)
Sembra siano state scritte a proposito le parole di Ivano Fossati,
un altro grande autore ligure: se c'è una strada sotto
il mare prima o poi ci troverà. Ed effettivamente una
qualche crêuza subacquea queste canzoni l'hanno trovata
e percorsa, ed appartengono sì a Pagani e a de André
ma anche a tutti, un poco anche a te che leggi e a me che sto
scrivendo, un tesoro comune e condiviso. Canzoni impossibili
a ricondurre al guinzaglio dell'appartenenza etnica, che si
sono svelate al vecchio contadino americano che le legge commosso
come ballate blues italiane (lo ha raccontato Beppe Gambetta)
come ai buskers polesani e romagnoli (vi invito ad ascoltare
come abitano nelle bocche di Bevano Est e Marmaja nelle raccolte
a sostegno di questo giornale nel segno di Faber: sembra abbiano
messo radici in riva ai nostri fiumi, sembra siano sempre state
lì, come certi grandi alberi, come le colline). Considerate
da alcuni solo come dei bei falsi, quelle di “Crêuza
de mä” non sono nate come canzoni popolari, ma lo
sono divenute. Tutti noi le abbiamo portate via carezza dopo
carezza, bacio dopo bacio: sono le parole che avremmo voluto
dire e sentirci dire, sono le parole che non siamo stati capaci
di dire. Ciascuno, con l'armonia, ne porta il profumo con sé.
Per me “D'ä mæ riva”, odora (un po' banalmente,
diciamocelo, ma per me è importante) come l'aria luminosa
d'argento e verde e azzurro che mi entrava nel naso quand'ero
piccolo nelle traversate in vaporetto dal paese fino a Venezia.
Odora di peocere e di stravedamento, di barene e murazzi. Al
mio naso di shakul “Sidún” ha l'odore metallico
bruciato dei vecchi televisori che portano cattive notizie.
“(...) Non sarebbe stato possibile fare questo disco
in nessun'altra lingua. E' molto tempo che io volevo cantare
in un idioma diverso dalla “lingua dell'impero”.
E solo in questo modo, con queste parole che ho usato fin da
bambino, mi era possibile: hanno la particolarità di
scivolare sopra le note, e sopra note dolci, orientali. Il genovese
è pieno di dittonghi, di iati, di aggettivi tronchi che
si allungano e si accorciano quasi come il grido di un gabbiano.
Tra gli idiomi neolatini è il meno latino di tutti, ha
1500 vocaboli arabi, e araba ne è la melodia...”
(Fabrizio de Andrè a Silvia Garambois, 1984)
A trent'anni dalla prima uscita, di “Crêuza de mä”
viene pubblicata una versione rimixata curata da Mauro Pagani,
che già ne aveva offerto dieci anni fa una bellissima
rilettura. Il disco di una volta adesso ha la forma di due cd
nascosti sotto la prima e la quarta di copertina di un libro.
Sarò sincero: mi sono avvicinato a questo lavoro col
mio gran bel carico di dubbi, che però si sono diradati
sin dal primo ascolto lasciando spazio a un grande stupore.
È indiscutibilmente “quel” lavoro, ma “questo”
suona diverso, suona bene, anzi suona benissimo. Mauro Pagani
è riuscito nella magia. Mi sembra di essere davanti ad
una di quelle immense opere pittoriche restituite agli occhi
del pubblico dopo anni di restauro: la mia bocca si apre di
meraviglia, le orecchie fanno fatica ad abbeverarsi di tutte
queste sorprese, dei particolari rimasti nascosti e finalmente
svelati, ondate di suono e di emozione una dopo l'altra che
non lasciano il tempo di riprendere fiato. Sembra quasi un disco
nuovo, fantastico, mai sentito prima.
Marco Pandin
|