
Milano/Libreria ex Cuem,
per non restare sul Vago
Nell'ottobre 2011 la storica libreria universitaria Cuem chiude
i battenti per debiti e falso in bilancio, lasciando la libreria
Cusl, di cui sono noti i collegamenti con Comunione e liberazione,
in sostanziale regime di monopolio. Viene occupata nell'aprile
2012: “Abbiamo occupato perché sentiamo l'esigenza
di creare un luogo che agisca da catalizzatore per la circolazione
di saperi critici all'interno della struttura universitaria;
abbiamo occupato perché partendo da noi stessi, dai nostri
sogni e interessi, vogliamo mettere in discussione il sistema
didattico tramite ciò che chiamiamo per-corsi”.
Gli occupanti danno immediatamente vita ad una serie di attività
culturali di alto livello, che affiancano il tentativo di tenere
in vita il tradizionale ruolo di fornitura di testi e dispense,
che l'ex Cuem distribuisce ora senza profitto.
In pochi mesi si susseguono presentazioni di libri, Per-Corsi,
festival di editoria indipendente e concerti, aperti a tutti.
Ascanio Celestini, Marco Philopat e Gustavo Esteva sono solo
alcuni degli autori che sono passati dalla libreria, non come
“ospiti” ma come simili, affini, sodali.
 |
| Milano, Università Statale, 6 maggio 2013. Il locale
dell'ex Cuem dopo gli interventi che durante
il week end hanno
reso inagibile il luogo |
Oltre alle iniziative organizzate, l'aspetto più interessante
è ovviamente la nuova modalità di gestione della
libreria: assemblee quotidiane aperte agli studenti scandiscono
la vita del luogo e producono documenti, dibattiti in cui finalmente
la dimensione del nozionismo accademico si mescola con le esperienze
di vita degli studenti in modo diretto, autogestito. È
anche un'occasione più unica che rara di confluenza e
confronto per persone provenienti da percorsi politici di diversa
matrice, dentro e fuori dall'università.
La reazione del rettorato all'occupazione non si fa attendere:
in pochi mesi sono due gli sgomberi, ad agosto e settembre.
Ogni volta vengono chiuse le entrate, ogni volta gli occupanti
vi rientrano. Le destinazioni previste dal rettorato sono, nell'ordine,
distributori di merendine, servizi ai disabili e infine “servizi
agli studenti”, solo dopo aver emesso un bando per le
associazioni studentesche che viene forzato dall'evidente impossibilità
di utilizzare ormai quegli spazi in un modo non gradito agli
studenti. L'ex Cuem decide di non prendere parte al bando, che
comunque viene disertato e di cui non sono ancora stati resi
noti i risultati.
Nel frattempo la vita dell'ex Cuem procede come al solito e
ad aprile 2013 si festeggia un anno di vita con una tre giorni
di eventi in ateneo, fra cui un murales per Primo Moroni e il
primo festival universitario di editoria indipendente.
Poi, lunedì 6 maggio, la sorpresa. Nel week end l'università
ha fatto sgomberare la libreria. Sgomberare non è il
termine adatto: “Stamattina, arrivati in università,
abbiamo trovato una sorpresa che non ci aspettavamo. La libreria
è parecchio cambiata. I libri, gli scaffali, il bancone,
la cucina, la sala prove non ci sono più. Il pavimento
è stato divelto, i muri abbattuti, le bacheche distrutte.
Il caos che regnava in libreria ha lasciato il posto a un surreale,
inumano ordine,come quello che si percepisce dopo un incendio.
Quindi, questo è un comunicato di ringraziamento.
Grazie per aver lavato gli ultimi piatti che rimanevano dalla
cena di venerdì. Grazie per averci spostato quella fotocopiatrice
che nessuno si azzardava a toccare per paura di trovarci sotto
forme di vita sconosciute. Grazie per aver tolto i tavoli, quel
colore arancione faceva a pugni col grigio delle pareti. Grazie
per aver tolto le porte – da tempo si pianificava di rendere
più attraversabile lo spazio Cuem. Grazie per aver abbattuto
il muro, il muro non è un concetto che ci piace, anzi
già che ci siete la prossima volta abbattete anche quelli
esterni, così saremo liberi di scorrazzare tutti i giorni
per l'università. La Cuem è casa nostra. Per questo,
ce la riprenderemo”.
Quella che inizia è una settimana intensa, convulsa.
Alla notizia dello sgombero si raduna una grossa folla, che
dopo una partecipata assemblea nell'atrio principale dell'università
decide di fare un corteo interno all'ateneo, conclusosi con
l'occupazione di un'auletta vuota, utilizzata unicamente per
affittarla ai privati. Nel frattempo giunge la notizia che la
celere si è posizionata fuori dall'università.
Anche se un effettivo intervento sembra improbabile, l'assemblea
decide di opporre resistenza passiva. Ma improvvisamente la
celere entra e carica a freddo per spingere gli studenti fuori
dall'università: quattro studenti in ospedale.
La rabbia è tanta, la Statale è stata sfregiata:
da lungo tempo la celere non entrava in università, doveva
venire eletto il progressista Vago perché la dialettica
interna all'ateneo venisse nuovamente intesa come questione
di mero ordine pubblico. A questo punto lo scenario è
paradossale: l'assemblea-presidio continua, ma si trasferisce
fuori dai cancelli dell'università, mentre centinaia
di studenti sono “chiusi dentro” dalla polizia,
che blocca gli accessi.
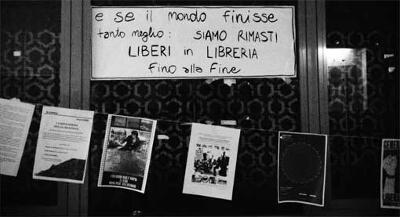 |
| Milano,
Università Statale, maggio 2013.
L'ex Cuem itinerante, nei giorni dello sgombero |
I giorni successivi si susseguono fra assemblee partecipate,
digos nei cortili interni all'ateneo e una lettera in cui Gianluca
Vago rivendica la decisione di chiamare le forze dell'ordine,
una “scelta difficile, presa a salvaguardia dei diritti
degli studenti e dell'intera comunità universitaria,
oltre che a tutela della dignità dell'istituzione pubblica”.
Ma la notizia più importante è che la ex Cuem
è stata già rioccupata e sono iniziati immediatamente
i lavori di ripristino.
Mercoledì il giorno dello sfregio ulteriore: il Cda e
il senato accademico votano in seduta congiunta a favore di
una mozione che approva l'operato del rettore. Le liste studentesche
si allineano senza eccezioni, l'unico voto contrario proviene
dai lavoratori della Statale iscritti a Cgil e Usb.
Infine venerdì il rettore diserta una conferenza sottraendosi
nuovamente al confronto diretto con gli studenti, nonostante
i proclami. Inoltre si decide di rimanere in università
anche al week end, per evitare un altro sgombero.
Assordante è il silenzio del corpo docente e del sindaco
di Milano. Non una parola viene spesa per quello che è
un atto intollerabile per una città sedicente civile.
Non da meno è la freddezza con cui molti, troppi studenti
hanno avallato il comportamento del rettore, fino all'incredibile
voto unanime in senato accademico. L'università è
stata scossa e il grosso degli studenti non ha saputo prendere
una posizione, interrogarsi su quanto è accaduto, forse
nemmeno comprendere cosa succede sopra le loro teste. Molti
si augurano un nuovo sgombero, e le macchinette al posto dei
libri. Forse, prima o poi, verranno accontentati. Nel frattempo
però il contagio non si ferma: è stata occupata
anche l'ex libreria Cuesp a scienze politiche.
Dario Clemente
Ricordando
Silvia Francolini
Se n'è andata mercoledì 10 aprile, dopo una lunga
lotta contro la malattia, Silvia Francolini. Accade a Losanna,
città in cui aveva scelto di vivere con il suo compagno
Ismael Zosso, ed Emilio, il loro figlio di appena due anni.
Nata a Fano nel 1977, Silvia si era laureata in lingue e letterature
straniere moderne, contemporaneamente lavorando e impegnandosi
nei collettivi libertari fanesi, primo fra tutti quello che
negli anni '90 mise sotto l'attenzione cittadina il grave problema
dell'assenza di spazi autogestibili dai giovani nella città
addomesticata dai partiti e dalla convivialità commerciale
(epiche alcune occupazioni di stabili sfitti sotto la giunta
Pd).
Silvia, proveniente da una famiglia di solida cultura operaia,
è culturalmente molto preparata sulla storia dei movimenti
antirazziali e del movimento Black panters, e ha portato a Fano
in quegli anni interessanti iniziative, tra le quali quelle
di sensibilizzazione contro la pena di morte negli Usa (ricordiamo
la campagna per la vita di Mumia Abu Jamal o quella per il nativo
americano Leonard Peltier). Nel frattempo si è occupata
dell'attività della sezione fanese della Federazione
dei comunisti anarchici, attiva nel movimento politico provinciale
per le lotte sindacali, i diritti civili, l'antirazzismo, nella
piccola sede di via G. da Serravalle 16, ora Infoshop, e ha
anche di recente contribuito alla costruzione del Centro studi
Franco Salomone, con sala riunioni e biblioteca, nel quartiere
“dormitorio” di Fano2.
Da alcuni anni viveva in Svizzera, lavorava come insegnante,
era attiva presso il Centro internazionale di ricerche sull'anarchismo,
Cira, di Lausanne, luogo internazionalmente noto presso il quale
si era formata come archivista, dando manforte al lavoro di
archiviazione di documenti in lingua italiana e supportando
molte attività multilingue. È stata presente a
iniziative “ponte” tra lingue e culture nell'ambito
dell'anarchismo, in ultimo al raduno internazionale di Saint
Imier.
Il suo amore per la sua città d'origine, Fano, l'ha vista
tentare diverse volte un ritorno, nonostante la congiuntura
economica sfavorevole; Silvia, amava il sole e il mare, il dialetto
e la cucina fanese, proprio a lei e al suo compagno si deve
il varo di un'impresa di pedagogia tutta mirata al porto di
Fano e al mare, “Passaporto”, integrata e originale.
Nonostante i tanti interessi che la legavano al territorio (ricordiamo
anche la sua partecipazione a seminari e spettacoli del centro
danza Hangart di Pesaro), come succede per tante giovani persone
italiane, il lavoro l'ha tenuta a lungo altrove. Certo è
riduttivo parlare di “fuga dei cervelli” per persone
che come lei hanno dato tanto in calore umano, passione politica
e affetto, alla sua città. Silvia è riuscita,
anche in questi ultimi anni, a costruire ponti tra due realtà
apparentemente lontane, come le sue due città, Losanna
e Fano, e da questo pensava di trarne un pamphlet ironico che
raccontasse la Svizzera vista da una italiana, anzi da una marchigiana.
Quante risate alla descrizione del vago odore di benzina che
si sollevava dal lago di Losanna al primo raggio di sole primaverile,
quando le famiglie svizzere fanno capolino per una grigliata,
e i capifamiglia armeggiano al barbecue in pantaloncini rigorosamente
color kaki!
In questo momento in cui sembra sempre che, dopo tanti passi
in avanti su quei ponti, la sua scomparsa ci faccia improvvisamente
tornare indietro, siamo vicine/i al suo compagno, Ismael Zosso,
e al piccolo Emilio, perché quei ponti, fatti di umanità,
di presenze tangibili e corporee, di sapori e parole, restino
percorribili in entrambi i sensi, e il senso della passione
umana e politica di Silvia, siamo sicure/i, ci sosterrà
sempre nei tragitti.
Animiamo questo momento di sconforto e gelo con gli ideali e
il vino rosso che condividiamo con Silvia.
Francesca
per Femminismi.it
Ricordando Roberto Denti/1
Se l'editoria italiana per l'infanzia...
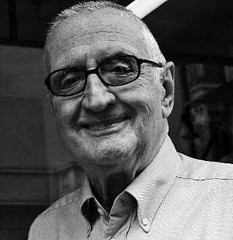 |
| Roberto
Denti |
Lo scorso marzo, quando ho chiesto a Gianna, la sua inseparabile
compagna, se ci saremmo visti, come ogni anno, a cena di una
comune amica bolognese in occasione della fiera del libro per
ragazzi, mi aveva detto che si sentivano tutti e due stanchi
e che per la prima volta avrebbero disertato Bologna. Ma era
il cinquantesimo della fiera e alla fine eccoli lì, mano
per mano come sempre, e Roberto, che per mezzo secolo era stato
tra i principali animatori e protagonisti della fiera, non si
era risparmiato, con interventi, incontri e conferenze e la
voglia di raccontare la sua esperienza, di trasmettere la sua
passione per la letteratura per l'infanzia. L'ho visto così
l'ultima volta, alla fine di marzo, in un padiglione della fiera,
circondato da giovani, mentre parlava instancabilmente di libri,
di progetti, di illustrazioni...
Per qualcuno Roberto Denti è stato solo il titolare della
Libreria dei ragazzi. Dico “solo”, ma tanto basterebbe
per ricordarlo in modo degno. La sua è stata la prima
libreria dedicata ai piccoli e ai giovani lettori nata in Europa,
nel 1972, ed è stata di esempio per tante altre iniziative
analoghe che dagli anni sessanta a oggi sono nate e continuano
a nascere. È tra quegli scaffali che ha promosso la lettura
dei libri di tanti scrittori italiani per l'infanzia, che non
a caso sono stati suoi amici, come Gianni Rodari, Pinin Carpi
o Bianca Pitzorno.
Ma Roberto è stato anche un prolifico scrittore, autore
di libri per bambini, dai quali emerge costante il gusto di
raccontare e una riflessione sulla diversità, di libri
per adolescenti, come Tra noi due il silenzio, dove non
esita a parlare direttamente di sessualità, di libri
per adulti, come Incendio a Cervara, un romanzo mascherato
da inchiesta etnografica, sull'evoluzione e i cambiamenti sociali
di un borgo dell'Appennino. Anche i suoi interventi di saggistica
sono stati decisivi. Mi limiterò qui a ricordare I
bambini leggono, che è un'analisi delle vicende culturali
italiane dal punto di vista dei piccoli lettori, e le fondamentali
Conversazioni con Marcello Bernardi, pubblicato
da Elèuthera nel 1991, che affronta tutti i temi delle
relazioni tra bambini e adulti in un'ottica libertaria.
L'impegno politico e antifascista della sua giovinezza –
non ancora ventenne si era unito alla lotta partigiana, come
racconta nel suo libro autobiografico La mia Resistenza
– si è costantemente tradotto in uno schierarsi
costantemente dalla parte dei più piccoli, contro ogni
forma anche subdolamente autoritaria che cerca di impedirne
una libera crescita.
Ma qui voglio soprattutto ricordarlo come un uomo gentile, pronto
ad ascoltare le opinioni degli altri, generoso, capace di profonde
amicizie e sempre disposto a dare una mano a tanti autori e
illustratori come lui impegnati a offrire letture e immagini
preziose per le bambine e i bambini.
Se l'editoria italiana per l'infanzia ha oggi una certa qualità
e gode di un prestigio notevole sul piano internazionale, è
in parte non secondaria per merito suo.
Guido Lagomarsino
Ricordando Roberto Denti/2
Partigiano, libraio, educatore, scrittore
Ho avuto la fortuna di conoscere Roberto Denti alla fine degli
anni settanta. Lui, insieme a Gianna Vitali, aveva aperto nel
1972 la Libreria dei ragazzi che presto era diventata un punto
di riferimento per insegnanti e ragazzi e luogo di riflessione
su temi pedagogici. Noi avevamo aperto all'inizio del 1977 la
Libreria Utopia con il progetto di diffondere la cultura libertaria
e nei cicli di conferenze che periodicamente organizzavamo il
tema della pedagogia e dell'educare alla libertà era
inevitabilmente presente, e di conseguenza c'era lui che intorno
alla lettura creava mondi meravigliosi. E insieme a lui venivano
a parlare altri due grandi “educatori” suoi amici
fraterni: Marcello Bernardi, pediatra fuori dagli schemi e autore
di libri che hanno “formato” intere generazioni
di genitori intelligenti, e Mario Lodi, maestro elementare a
Piadena e fantastico animatore del Movimento di cooperazione
educativa che ha portato una ventata di libertà nella
asfittica e ingessata scuola italiana.
Le nostre ultime occasioni di incontro sono state nel 2003 durante
un ciclo di conferenze sulla scuola (insieme a lui c'erano Mario
Lodi, Raffaele Mantegazza, Giuseppe Pontremoli, Marco Rossi
Doria per i maestri di strada di Napoli...) e nel 2004 in occasione
di un incontro per ricordare Giuseppe Pontremoli, scrittore
per ragazzi scoperto proprio da Roberto Denti e grandissimo
insegnante. Sempre, in ogni occasione, lui sapeva trasformare
ogni domanda in racconto, ogni racconto in avventura, ogni avventura
in occasione di crescita e divertimento. Non è così
comune, no? Forse davvero per essere buoni educatori è
necessario aver mantenuto vivo il bambino che siamo stati, come
ha fatto lui.
Fausta Bizzozzero
Ricordando Nunzio Pernicone/
Dentro la storia dell'anarchismo di lingua italiana negli Usa
Nella notte fra il 29 e il 30 maggio si è spento negli
Stati Uniti, stroncato da un male incurabile, Nunzio Pernicone,
professore di storia alla Drexel University di Filadelfia.
In Italia il suo nome non è noto a tutti. Di suoi lavori
sono apparsi da noi solo l'autobiografia di Carlo Tresca e l'introduzione
a un volume delle Opere complete di Malatesta. Tuttavia,
nel mondo di lingua inglese il suo nome è sinonimo di
storia dell'anarchismo italiano. Figlio di un anarchico, Pernicone
aveva respirato sin da ragazzo l'atmosfera dell'anarchismo italo-americano
newyorkese, acquisendo familiarità con gli ambienti dell'Adunata
dei refrattari. Questi contatti costituiranno il suo legame
diretto col movimento di cui poi scriverà la storia.
Il suo Italian Anarchism, 1864–1892, del 1993,
è il testo base in lingua inglese sull'argomento. Sua
è anche la biografia Carlo Tresca: Portrait of a Rebel.
Entrambi i volumi sono stati recentemente ristampati da AK Press.
Pernicone è apparso in tre documentari e un programma
radio sul caso Sacco e Vanzetti. Fra i suoi più importanti
articoli vi sono: “Carlo Tresca and the Sacco-Vanzetti
Case”; “Luigi Galleani and Italian Anarchist Terrorism
in the United States”; “Murder Under the 'El': The
Greco-Carrillo Case”; e “The Case of Pietro Acciarito:
Accomplices, Psychological Torture, and Raison d'État”.
Aveva due progetti in cantiere: la prosecuzione fino al 1900
della sua storia dell'anarchismo italiano, e il libro Propaganda
of the Deed: Italian Anarchists and Political Violence in the
19th Century, del quale aveva completato da poco il manoscritto.
Dopo Paul Avrich, suo amico, l'anarchismo perde con Pernicone
un'altra voce preziosa, che molto ha fatto per restituire ad
esso la dignità storica spesso negatagli.
Davide Turcato
|