|
letture
Il pane e l'arsenico
Intervista ad Alberto Prunetti di Giuseppe
Ciarallo
Lo scrittore toscano Alberto Prunetti parla del suo ultimo romanzo: una storia operaia ma anche un diario familiare. Lotte di classe e ricordi di infanzia in “un grumo ribollente di acciaio, incazzatura e ironia devastante”.
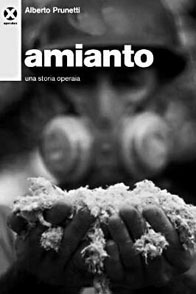
Alberto Prunetti, nato a Piombino
(Li) nel 1973 e cresciuto in provincia di Grosseto, è
scrittore, traduttore, fotografo e insegnante di italiano per
lavoratori immigrati. Per Stampa Alternativa ha pubblicato i
romanzi Potassa (2004) e Il fioraio di Perón
(2009); per la stessa casa editrice ha curato l'antologia L'arte
della fuga (2005); ha poi curato e tradotto due “classici”
di Osvaldo Bayer: Patagonia rebelde (Elèuthera,
2009) e Severino Di Giovanni (Agenzia X, 2011). Ha scritto
per il Manifesto, Carta, A rivista, Nuova rivista letteraria
e al momento è redattore di Carmilla. È uscito
a fine 2012 il suo ultimo lavoro Amianto – Una storia
operaia (Agenzia X), racconto a metà strada tra il
reportage sulle fabbriche della morte nel nostro paese e il
diario intimo, nel quale narra le vicende di Renato (padre dell'autore),
operaio saldatore tubista deceduto in seguito al prolungato
contatto con la micidiale sostanza che dà titolo al libro.
Dunque Alberto, raccontaci come nasce l'idea di narrare
la storia di tuo padre Renato, operaio saldatore tubista, morto
a 59 anni dopo aver lavorato una vita intera a contatto con
l'amianto. Immagino che la scintilla sia scoppiata nel rovistare
tra i suoi tanti documenti, spesso citati nel libro...
«La scintilla è stata piuttosto la scelta di mia
madre di continuare una pratica iniziata da mio padre nel 1992
per ottenere il riconoscimento professionale all'amianto e poter
andare in pensione con alcuni anni di anticipo. Il prepensionamento
– chissà – forse gli avrebbe salvato la vita:
dopo anni passati nei peggiori cantieri italiani, come saldatore
e tubista, tra acciaierie e raffinerie, aveva davvero il fiato
corto. Siamo riusciti a sapere solo nel 2011 che Renato aveva
diritto di andare in pensione con sette anni e mezzo di anticipo.
Gliel'hanno detto sette anni dopo che era morto per un tumore
ai polmoni. Purtroppo sono questi i tempi della giustizia.»
Qual è la difficoltà che hai incontrato
nel far sì che una storia così personale, privata,
finisse per diventare qualcosa di interessante non solo per
te stesso, ma per il potenziale lettore?
«La scommessa è stata quella di fare di Renato
lo specchio dei tanti Renati, dei figli dell'officina che hanno
mangiato pane e arsenico. Che hanno lavorato sull'onda di riflusso
del boom economico. La crisi che respiriamo oggi, per gli operai
comincia nel 1973 con la crisi petrolifera, quando i salari
reggono solo grazie alla forza delle tutele sindacali. Poi,
negli anni ottanta, arriva la vera ristrutturazione del capitale:
i sindacati sono più deboli, arriva la cassa integrazione,
poi falliscono le raffinerie e iniziano i licenziamenti. Nel
frattempo la fabbrica ha dato da mangiare a tante famiglie,
ma era un pane avvelenato. Lo stipendio dei nostri padri ha
permesso a noi di studiare, di laurearci, per poi rimanere disoccupati
al primo ciclo di ricambio generazionale della manodopera nel
mondo del lavoro. Da qui il precariato e la disoccupazione a
lungo termine.»

In un momento storico come quello che stiamo vivendo,
con il lavoro percepito più come un “problema sociale”
che come motore di un'intera nazione (problema di cui tutte
le forze politiche dicono di volersi occupare, ma che nella
realtà perde di giorno in giorno di valore e peso), non
pensi che l'arte, e la letteratura in particolare, dovrebbero
ricominciare a trattare questa nodale tematica? Mi sembra che
oltre al tuo Amianto e a pochi altri esempi,
quello del lavoro non pare essere ultimamente un argomento ritenuto
degno di nota. Non senti un po' di nostalgia per la cosiddetta
“letteratura industriale” degli anni '60 e '70?
«Le librerie classificano Amianto - una storia operaia
proprio come letteratura industriale. A Renato sarebbe piaciuto.
Io sono rimasto preso in contropiede, da questo libro, dalle
risposte di lettori e recensori, dai tentativi di catalogarlo.
In realtà ero così immerso in quel mondo –
avendo fatto le scuole in una ferriera dell'Ilva dismessa, in
cui ho trascorso sia i miei pomeriggi di calcio che le giornate
di studio in biblioteca, tutto dentro all'ex Ilva – che
non potevo che raccontarlo così. Ma non pensavo né
a Levi né a Volponi, mentre scrivevo. Quelle vicende
erano sangue del mio sangue. C'era più industria che
letteratura, nel mio dna. Ho mescolato le parole saldando giunti
come mio padre giuntava tubazioni e saldava tondini. Ho raccordato
un pezzo di storia industriale italiana con i ricordi d'infanzia,
con l'eclisse che Renato mi fece vedere attraverso le lenti
di una maschera da saldatore. Il risultato è la storia
operaia che ho raccontato. Me ne accorgo solo adesso che in
certo modo è letteratura industriale. Ma è prima
di tutto la mia storia.»
Di recente ho riletto Vogliamo tutto
di Nanni Balestrini. In quelle pagine la fabbrica pulsa di energia,
l'arroganza dell'azienda è efficacemente controbilanciata
da una presenza operaia forte e agguerrita, e forse, allora,
sarebbe stata impensabile una figura come quella di Marchionne,
paradossalmente ritenuto da tutti un innovatore pur utilizzando
metodi più da padronato capitalista dell'ottocento che
da manager d'industria moderno, incapace com'è di vedere
nel lavoratore una risorsa insostituibile dell'azienda –
e soprattutto un essere umano con una propria vita e propri
bisogni – e non un mero costo da tagliare...
«Lo dico anche nel libro, che gli anni settanta... altro
che anni di piombo, sono stati anni felici di alta conflittualità
e quindi di alti salari... i problemi iniziano sì allora,
con la crisi petrolifera, ma la classe operaia li percepisce
negli anni ottanta, quando la conflittualità diminuisce
e il capitale, che non è in crisi ma è la crisi,
è la crisi permanente, fa i conti con gli operai e fa
pagare loro tutto e caro... la guerra di classe non l'hanno
mai interrotta, i padroni del capitalismo fallimentare. Vedi
quel che sta facendo Marchionne, appunto, che usa la chiusura
delle fabbriche come arma di ricatto verso gli operai.»
A mio avviso, un altro grande merito di Amianto,
oltre quello di aver messo il dito nella piaga sempre aperta
della nocività e della mortalità nel mondo del
lavoro, è quello di aver sfatato o quantomeno correttamente
inquadrato il mito italiano del boom economico, come a dire:
sì, negli anni '60 c'è stata indubbiamente una
ripresa e una crescita sull'onda della ricostruzione post-bellica,
ma queste si sono potute realizzare solo a costo di immani sacrifici
da parte dei lavoratori (emigrazione, sradicamento e lontananza
dagli affetti, condizioni abitative precarie, salari appena
sufficienti alla sopravvivenza, scarsa attenzione alla sicurezza,
cioè infortuni, malattia e a volte morte, ecc.), i quali
spesso non potevano permettersi i beni che producevano. Ricordo
mio padre, ad esempio, operaio dell'Innocenti dove si producevano
le famose Lambrette, il quale dovette comperarne una a rate,
dall'azienda stessa, da lui utilizzata esclusivamente per andare
in fabbrica per i turni di notte, quando i mezzi pubblici non
effettuavano servizio...
«Certo. Direi che già Bianciardi aveva raccontato
ne La vita agra il lato oscuro del miracolo economico
e della “dolce vita”. Io racconto il seguito: finisce
il miracolo mentre Nada canta Ma che freddo fa e comincia
il tracollo... l'inizio di una crisi che viene percepita solo
adesso dai ceti medio alti, mentre il proletariato, che viene
investito dal primo colpo molti anni fa, regge per la forza
di contrapposizione dei movimenti e dei sindacati per quasi
un decennio e poi crolla negli anni ottanta. Gli strascichi
di tutto questo sono adesso sotto gli occhi di tutti, ma c'è
chi già da lungo tempo li subisce. Tutto questo, io non
lo racconto in chiave sociologica o saggistica, ma con i ricordi
d'infanzia e le buste paga di mio padre. O meglio: metto assieme
i ricordi, la trama narrativa della finzione, l'indagine sociologica,
l'investigazione giornalistica... tutto saldato assieme. Pare
che tenga.»
Mi è piaciuta molto la franchezza con cui nomini
cose e persone. Non pensi che la manipolazione linguistica (il
chiamare “imprenditore” il padrone, “forza
lavoro” l'operaio) sia un imbroglio teso a spersonalizzare
le parti in causa e dunque deresponsabilizzare chi invece dovrebbe
rispondere personalmente degli errori e delle proprie colpe?
Come quando si parla del fantomatico “mercato”,
nel nome del quale si compiono i peggiori misfatti...
«Guai a dire padrone invece che imprenditore, vero? In
anni di finto interclassismo, Amianto è anche
un romanzo di classe, che racconta dal basso la realtà.
Chi dice che le classi non esistono, camuffa pro domo sua la
società. La cosa buffa è che il libro non è
un ponderoso saggio veteromarxista ma un racconto a tratti divertente
e quasi fiabesco che, mi dicono i lettori, ti fa però
venir voglia di prendere a morsi il libro. Io le cose le racconto
come le ho percepite e vissute, e quel grumo ribollente di acciaio,
incazzatura e ironia devastante era l'aria che si respirava
in casa quando babbo si toglieva la tuta verde del metalmeccanico.»
Per concludere, oltre alla bellissima (in senso letterario)
storia che sei riuscito a raccontare in perfetto equilibrio
tra forza narrativa e ironia, nonostante la tragicità
dei fatti, cosa ha lasciato dentro di te l'esperienza straordinaria
di Renato, ennesima vittima di un capitalismo sempre più
spietato e vorace?
«Ogni tanto Renato mi portava al cimitero di Rosignano
Marittimo. Mia madre andava a visitare la tomba di mio nonno.
Siccome nell'epica operaia del periodo un uomo non poteva versare
lacrime o pregare, mentre mamma sistemava i fiori lui mi portava
a giro per le tombe passeggiando come fanno i contadini a luglio
in mezzo ai filari della vigna: si guardano attorno, sistemano
qualcosa, strappano due foglie, hanno l'aria di tenere tutto
sotto controllo, no? Facevamo “manutenzione”. Poi
si arrivava alla zona delle tombe vecchie, quelle dei “vecchi
comunisti”, come li chiamavamo noi, vecchi rosignanini
che non volevano la croce sul marmo ma avevano preferito la
falce e il martello. Alla fine inevitabilmente si arrivava davanti
a una tomba monumentale in marmo con la statua di un uomo dall'aria
vissuta, con dei virili baffoni a incorniciargli il viso. In
basso c'era scritto: “l'apuana operaia dedicò”.
Babbo mi diceva ogni volta: “boiadé, che pezzo
d'omo...”. Era Pietro Gori. Ecco cosa m'è rimasto.»
Giuseppe Ciarallo
|