|
percorsi di vita

a
cura di Alessio Lega
 Cento anni di canzoni - 1 Cento anni di canzoni - 1
Napoli in testa
Io non vi so né voi mi conoscete,
ma resta in me se accanto mi passate
tutto il profumo che per via spandete
e il cuore mio passando vi portate.
Chi siete? Io non lo so...
Ma so che gli occhi ardenti
hanno la forza di rubarmi il cuor.
Questa è la canzone che ho scelto per aprire una lunga
carrellata. Cerco di rintracciare il filo della canzone d'autore,
ben prima che questo termine sia utilizzato (e noi sappiamo
che lo utilizzò per primo il giornalista veronese Enrico
de Angelis nel ’69). I cantautori erano decisamente di
là da venire nel 1917, anno della rivoluzione d'ottobre
e della pubblicazione di questa canzone.
È una scelta innanzi tutto emotiva la mia: Chi siete?
è il ritornello che accennava più spesso la nonna
Mìlli (Camilla detta...) – che era sempre stata
una grande e appassionata canterina – quando, a 90 anni,
con la memoria sbriciolata, scendeva gli ultimi scalini della
vita aggrappata al passamano delle canzoni, unica cosa che ricordava.
Ma Chi siete?, oltre ad essere una bella domanda da rivolgere
per saluto al pubblico, in una sera casuale in giro per qualche
palco del mondo, testimonia di quell'inquietudine esistenziale
e sentimentale, di quel mistero melodioso, che è sempre
stato alla base della poesia cantata nel nostro paese.
La rese di nuovo nota al pubblico italiano degli anni '60 e
'70 la cantante Milly (Carla Mignone), che ne fece un pezzo
forte del proprio repertorio. Ho concepito questo primo capitolo
della mia antologia della canzone del '900 come un doppio omaggio
a tre grandi interpreti: Roberto Murolo e Sergio Bruni per quanto
riguarda il repertorio napoletano e, appunto, Milly per quello
in lingua dei primi 30 anni del secolo.
La canzone italiana nasce... napoletana. Napoli è la
città delle canzoni, fino a metà del '900 il suo
dominio è incontrastato a livello planetario. Non si
tratta solo dell'oleografia: la pizza e i mandolini, il sole
e Posillipo delle cartoline filigranate sul cartoncino pressato
nell'anima. Non è solo il fatto che “tutto qui
si dica in canzone” e che il popolo napoletano nasca e
muoia, e soprattutto viva e ami cantando.
Non è solo questo, non è proprio questo, anche
se una particolare disposizione della lingua e delle abitudini
comunicative, un'estrema ironia e un estremo sentimentalismo,
una vita corale e una feroce chiave d'individualismo, spiegano,
per contrasti, qualcosa del perché qui, prima che in
qualsiasi luogo al mondo, il canto sia diventato un fiorente
artigianato, se non proprio un'industria.
|

|
|
Roberto
Murolo |
Era de maggio e te cadéano 'nzino,
a schiocche a schiocche, li ccerase rosse.
Fresca era ll'aria, e tutto lu ciardino
addurava de rose a ciento passe.
(...)
E diceva: “Core, core! core mio, luntano vaje,
tu mme lasse e io conto ll'ore... chisà quanno turnarraje?”
Rispunnev'io: “Turnarraggio quanno tornano li rrose.
si stu sciore torna a maggio, pure a maggio io stóngo
ccá.”
E so' turnato e mo, comm'a 'na vota,
cantammo 'nzieme lu mutivo antico;
passa lu tiempo e lu munno s'avota,
ma 'ammore vero no, nun vota vico.
De te, bellezza mia, mme 'nnammuraje,
si t'allicuorde, 'nnanze a la funtana:
Ll'acqua llá dinto, nun se sécca maje,
e ferita d'ammore nun se sana.
Nun se sana: ca sanata, si se fosse, gioia mia,
'mmiez'a st'aria 'mbarzamata, a guardarte io nun starría !
E te dico: “Core, core! core mio, turnato io so'.
Torna maggio e torna 'ammore: fa' de me chello che vuo'!”
Era de maggio è una delle più celebri,
delle più celebrate canzoni napoletane: i suoi versi
sono del poeta Salvatore Di Giacomo. Sono versi che si liquefanno
in una melodia dall'inflessione arabeggiante per quel che riguarda
la strofa – sospesa e inafferrabile, tutta un incedere
e un tornare su sé – per aprirsi a un valzer verdiano
nel ritornello. È una canzone al confine fra due mondi,
una canzone ponte fra mare e terra, fra porto e agrumeto. Una
canzone disperata, emotiva eppure di struggente compostezza.
Prima di arrivare all'epoca d'oro – sospesa fra fine '800
e inizio '900 – la canzone napoletana fa una lunga strada
che affonda nel medioevo dei ritornelli popolari giunti per
trasmissione orale fino a noi, come il canto detto delle lavandare
del vomero, un canto di lavoro e di dolente rivendicazione,
se non proprio di protesta.
| 
|
| Sergio
Bruni |
Tu m'aje prummise quatto muccatore
I' so' venuto se mme le vuo' dare.
E si no quatto embè dammene doje,
chello ch'è 'ncuollo a te n'è robba toja.
La popolarità dell'Opera buffa e del teatro musicale
napoletano viene accresciuta anche dall'abitudine dei musicisti
che vi operavano di inserire canti anonimi (detti villanelle)
nel tessuto drammaturgico, col doppio effetto di trascrivere
e dunque conservare un grande repertorio
altrimenti destinato all'oblio e di abituare l'orecchio a una
versione còlta, finemente armonizzata delle melodie spontanee
e fresche della tradizione. Ecco perché la canzone napoletana
appare più definita, più elaborata, più
pura anche all'epoca degli autori anonimi, ed ecco perché
appare credibile l'attribuzione di alcuni capolavori dell'inizio
dell'800 a Vincenzo Bellini (Fenesta ca lucive) o a Gaetano
Donizetti.
Pecché quanno me vide te 'ngrife comm' a ggatto?
nenne' che t'haggio fatto ca nun me puo' vvede'?
Io t'haggio amato tanto e t'amo e tu lo saie:
Io te voglio bbene assaie
e tu nun pienze a mme.
L'equilibrio fra popolare e còlto è proprio l'elemento
distintivo delle canzoni dell'epoca classica. Così la
struttura reiterativa, da filastrocca infantile, un certo gusto
surreale (ante litteram) e un giocoso erotismo, vengono armonizzati
da un controllo letterario di cesello squisito...
Nu juorno mme ne jette da la casa
jenno vennenno spingule francese
Mme chiamma na figliola «Trase trase
quanta spingule daje pe' nu turnese»
Dich'io «si tu mme daje tre o quatto vase
te dongo tutt''e spingule francese
Pizzeche e vase nun fanno purtose
e puo' ghienchere 'e spingule 'o paese»
E io che songo nu poco veziuso
subbeto mme 'mmuccaje dint'a 'sta casa
«Ah chi vo' belli spingule francese,
ah chi vo' belli spingule ah chi vo'».
Le Spingule francese – sempre del Di Giacomo –
per chi non lo sapesse sono le spille da balia, e il dialogo
fra il
venditore e la figliola – nella cui casa s'è introdotto,
in quanto “un po' vizioso” – allude all'idea
di un rapporto “senza rischi”, dove pizzicotti,
baci ed effusioni varie non lascino irreparabili buchi. Niente
male per essere una canzone del 1888, ma la palma dell'erotismo
va forse a Furturella (1894) di Pasquale Cinquegrana.
Tiene a vetella comm' 'a vucchella Furture'
piccerenella piccerenella Furture'
che dice, che ffaie, che pienze, m' 'a daie Furture' ?
io mo moro mo moro mo moro mo moro pe te
uh! comm' e' bbello a ffa' ammore cu tte
ah ah ah ah uh! quanta vote te voglio vasa'.
L'immagine del basso ventre dell'amata che sembra una “piccola
bocca” è già una metafora piuttosto esplicita
del sesso femminile – “che dici, che pensi, che
fai: me la dai?”, aggiunge subito il cantore – ma
l'apice della poesia erotica si tocca allorché, in un
musicalissimo sdilinquirsi nello scioglilingua dei gemiti, si
chiede all'agognata Furturella di poggiare la sua mano taumaturgica
sulla propria “spina” che non dà pace:
Miette sta mano ca tocca e sana Furture'
'ngoppa a sta spina che m'arruvina Furture'
che dice, che ffaie, che pienze, m' 'a daie Furture'?
Non è certo per suscitare pruriginose facezie che sottolineo
la portata erotica di alcuni canti partenopei, ma per rendere
esplicita la dignità che il tema del corpo assume in
una forma d'arte così evoluta da un lato e così
intimamente popolare dall'altro. Sensualità e musicalità
squisita si fondono in queste canzoni, che suscitano l'immagine
della libertà più che quella della trasgressione,
soprattutto se le collochiamo in una società sessuofoba
come quella dell'Italia post-unitaria.
Tenendo a mente questo giocoso erotismo come cartina di tornasole
dell'evoluzione e della maturità di un genere, porgo
un esempio che sottolinea bene il passaggio dalla canzone in
napoletano a quella in lingua.
Due canzoni celeberrime sono Reginella (1917) e Signorinella
(1931). Sono entrambe di Libero Bovio e appartengono a un'ispirazione
simile: dolci memorie d'amor perduto.
| 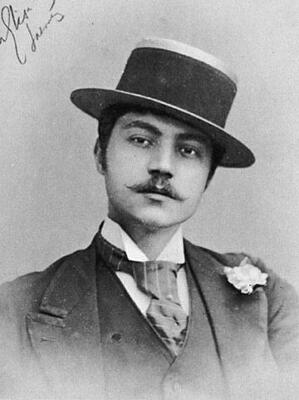
|
| Salvatore
Di Giacomo |
Te si' fatta na vesta scullata,
nu cappiello cu 'e nastre e cu 'e rrose
stive 'mmiez'a tre o quatto sciantose
e parlave francese, e accussí?
Fuje ll'autriere ca t'aggio 'ncuntrata
fuje ll'autriere a Tuleto, 'gnorsí...
T'aggio vuluto bene a te!
Tu mm'hê vuluto bene a me!
Mo nun ce amammo cchiù,
ma ê vvote tu,
distrattamente,
pienze a me!
Reginè', quanno stive cu mico,
nun magnave ca pane e cerase
Nuje campávamo 'e vase, e che vase!
Tu cantave e chiagnive pe' me!
E 'o cardillo cantava cu tico:
“Reginella 'o vò' bene a stu rre!“
T'aggio vuluto bene a te!
Tu mm'hê vuluto bene a me!
Mo nun ce amammo cchiù,
ma ê vvote tu,
distrattamente,
parli 'e me!...
Oje cardillo, a chi aspiette stasera?
nun 'o vvide? aggio aperta 'a cajóla!
Reginella è vulata? e tu vola!
vola e canta... nun chiagnere ccá:
T'hê 'a truvá na padrona sincera
ch'è cchiù degna 'e sentirte 'e cantá
T'aggio vuluto bene a te!
Tu mm'hê vuluto bene a me!
Mo nun ce amammo cchiù,
ma ê vvote tu,
distrattamente,
chiamm' a me!
Signorinella pallida,
dolce dirimpettaia del quinto piano,
non v'è una notte ch'io non sogni Napoli,
e son vent'anni che ne sto' lontano!
Al mio paese nevica,
il campanile della chiesa è bianco,
tutta la legna è diventata cenere,
io ho sempre freddo e sono triste e stanco!
| 
|
| Libero
Bovio |
Amore mio!
Non ti ricordi che, nel dirmi addio,
mi mettesti all'occhiello una pansè
e mi dicesti, con la voce tremula:
“Non ti scordar di me!”
Bei tempi di baldoria,
dolce felicità fatta di niente:
Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua
al nostro amore povero e innocente.
Negli occhi tuoi passavano
una speranza, un sogno, una carezza
avevi un nome che non si dimentica,
un nome lungo e breve: giovinezza!
Il mio piccino,
sfogliando un vecchio libro di latino,
ha trovato, indovina, una pansè...
perché negli occhi mi spuntò una lacrima
Chissà, chissà perché!
E gli anni e i giorni passano,
uguali e grigi, con monotonia,
le nostre foglie più non rinverdiscono,
signorinella, che malinconia!
Tu innamorata e pallida
più non ricami innanzi al tuo telaio,
io qui son diventato il buon don Cesare,
porto il mantello a ruota e fo' il notaio.
Lenta e lontana,
mentre ti penso, suona la campana
della piccola chiesa del Gesù...
e nevica, vedessi come nevica...
ma tu... dove sei tu?
Reginella è intrisa di una nostalgia vicina e
lancinante “mo nun ce amammo cchiù”, ora
non ci amiamo più. Il colpo di genio dell'autore sta
in quel dolorosissimo “distrattamente”, una pennellata
esistenziale nel disastro della morte dell'amore. Il linguaggio
comune, quel lessico unico e irripetibile che sempre si costituisce
fra due amanti – comprensibile solo a loro – è
una rinuncia inaccettabile quanto ineluttabile. Lascia però
dei detriti che emergono via via... e così, quando nella
foga di una chiacchierata casuale, nell'improvviso agguato di
un ricordo, nel pantano del rimpianto e nel rancore del tradimento,
si abbassa la soglia di sorveglianza su sé stessi, allora
distrattamente si parla, si chiama, si pensa all'amato, all'amata
di un tempo. È un tema che troveremo intatto mezzo secolo
dopo in un capolavoro di Luigi Tenco, Lontano lontano.
Signorinella potrebbe essere un pensiero rivolto a quella
medesima Reginella, quando quindici anni ulteriori, un matrimonio,
un figlio e una remunerativa carriera notarile, hanno un po'
temprato l'argento vivo e la ferita fresca dell'abbandono. Con
occhi di memoria più nostalgici e meno affilati il “buon
don Cesare” (“don” a sud non allude ad occupazioni
religiose, è solo un titolo dato ai notabili) ricorda
la pallida sartina del quinto piano concupita ai tempi dell'università.
L'autore, nel rivolgersi al pubblico italiano con la lingua
di Dante, mantiene intatta la sua carica poetica, ma candeggia
la lingua, che risulta più antica del suo stesso napoletano
di 15 anni prima.
In quest'operazione si perde anche un miracoloso equilibrio
che permette a una bassa allusione da taverna – allorché
in Reginella il monologo col proprio uccello il “Cardillo
in gabbia” richiama senz'altro intenzioni tutt'altro che
auliche “ti devi trovare una padrona più degna
di sentirti cantare” – di non inficiare il tono
struggente del brano.
L'Italiano è una lingua astratta, poco parlata dal popolo
e a ritrovare il tono insieme colloquiale e poetico che la canzone
napoletana aveva già ai primi del secolo ci metterà
altri 50 anni, passando attraverso l'oppressione fascista, l'orrore
del conflitto mondiale, le macerie del dopoguerra e le false
promesse del boom economico. “Chi siete? Io non lo so”,
potremmo dire... o quanto meno, in quegli anni, la canzone italiana
ha un'identità ancora indistinta.
 Alessio Lega
Alessio Lega
alessio.lega@fastwebnet.it
|