|
Migranti
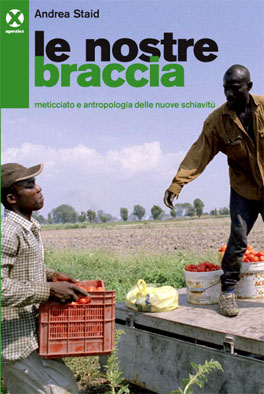
Lo
sfruttamento dei migranti
di Elena Violato
Contro gli identitarismi e contro
l'avanzare di questa globalizzazione la proposta contenuta nel
libro di Andrea Staid è quella del meticciato, che non
dev'essere necessariamente un dato di fatto ma innanzitutto un
atteggiamento mentale.
Migranti,
immigrati, stranieri, clandestini, rifugiati, richiedenti asilo,
arabi, asiatici, africani, sudamericani... insomma Loro... e
Noi.
Noi abbiamo tanti pareri diversi su Loro, più o meno
tante quante sono le forme del razzismo contemporaneo. Anche tra
i benpensanti, tra quelli che magari con fare caritatevole
cercano di dare sempre almeno un euro alla ragazza incinta fuori
dalla chiesa che chiede l'elemosina, c'è sempre l'idea di fondo
che Loro hanno bisogno di un aiuto e Noi, l'unica cosa che
possiamo fare in tal senso, se non si ha cuore di rispedirli a
casa, è tentare di farli integrare, invitarli, imporre loro di
integrarsi...
Integrazione: Loro che vengono da Paesi
politicamente e culturalmente arretrati devono adattarsi a Noi,
diventare come Noi, esponenti dei Paesi civilizzati e
democratici.
Come Noi che spingendo il capitalismo oltre ogni
limite stiamo devastando un pianeta intero, l'economia mondiale e
le vite di milioni di persone che proprio a causa Nostra sono
costrette ad emigrare dalle loro terre e venire da Noi, solo per
poi scoprire che per Loro qua non c'è felicità, e che a Noi
possono andar bene solo come schiavi.
Noi che emulando
l'efficienza delle macchine, aneliamo spasmodicamente di
eliminare i basilari bisogni umani e dobbiamo fare i conti con un
aumento di suicidi, di consumo di alcolici, di droghe, di
psicofarmaci, un aumento che sembra essere direttamente
proporzionale alla velocità con la quale aumenta il ritmo di
“crescita”, di “evoluzione”, di “progresso”.
Noi
che crediamo di essere il centro del mondo e al massimo siamo una
delle maggiori cause della rovina del Mondo. Noi che vorremmo che
anche chi non è Noi, incominci a vedere, a credere come Noi.
Se
giunti a questo punto il termine “razzismo” per alcuni può
apparire, nonostante tutto, troppo forte, allora si potrebbe
proporre di parlare di “etnocentrismo”, cioè del mettere la
propria cultura (intesa in senso antropologico) come chiave unica
e giusta di lettura del reale.
E a proposito di questo risulta
interessante il libro di Andrea Staid, “Le nostre braccia”,
che lungi dal voler fare la classica esaltazione delle classi
migranti oppresse e sfruttate, con l'intento di investirle della
carica di soggetto rivoluzionario del ventunesimo secolo, tenta
di andare oltre ed eliminare definitivamente il binomio
Noi-Loro.
Lo fa primariamente mettendo in discussione il
concetto di identità chiusa e definita una volta per tutte,
mostrando come la storia del genere umano sia stata
caratterizzata da continui cambiamenti, rimescolamenti e
mutazioni, tant'è che in nessun caso si può parlare di culture
“pure”, incontaminate da influssi esterni. Inoltre, continua
Staid, oggi più che mai è assurdo inneggiare ad un'originalità
dei costumi dato che con la globalizzazione e la mobilità
internazionale, molte delle cose che mangiamo, facciamo, diciamo
e pensiamo provengono da altre parti del pianeta e la tendenza è
sempre di più quella di un appiattimento generale su un'unica
grande monocultura, mix artificioso di tutte le culture del
pianeta, il cui cavallo di battaglia rimane, nonostante la crisi,
il lifestyle americano.
Contro gli identitarismi e contro
l'avanzare di questa globalizzazione la proposta contenuta in
questo testo è quella del meticciato, che non dev'essere
necessariamente un dato di fatto ma innanzitutto un atteggiamento
mentale.
La
paura è debolezza, nient'altro,
scrive Bruno Barba nella prefazione del libro Un'identità
in costruzione
- consapevole
di esserlo
-, accogliente,
attenta, curiosa, aperta, non avrebbe nulla da temere.
Panta
rei, tutto scorre, e Noi vorremmo fermare il mondo, non per
scendere, ma per dominare.
Così non è e così non
dev'essere, secondo Andrea Staid e secondo molti altri che vedono
nella mutazione culturale una componente essenziale di qualsiasi
processo che voglia anche solo vagamente definirsi
“rivoluzionario”.
 Elena
Violato
Elena
Violato
Migranti
Le voci dei migranti
di Andrea Staid
Tra le numerose testimonianze riportate nel
libro, abbiamo scelto di riproporre qui quelle di due migranti,
rispettivamente dalla Mauritania e dal Ghana.
Dalla Mauritania / Moktar
Ho
27 anni arrivo dalla Mauritania, da una città vicino al deserto,
molto povera con pochissime possibilità di trovare il lavoro. In
Europa ci sono arrivato nel 2006. Sono approdato in Spagna
passando per Ceuta. In quel periodo insieme ad altri amici
marocchini avevamo iniziato delle lotte contro i muri che
separavano il Marocco dalle vostre città. Non so se lo sai, ma
Ceuta, che è nel nord del Marocco, in realtà è Europa,
Spagna.
Insieme ad altri abbiamo cercato di scavalcare quei
recinti per riuscire ad arrivare in Europa. I primi tentativi
sono andati bene e io sono riuscito a passare, il problema è
stato che nelle settimane a seguire la Guardia Civil ha aperto il
fuoco contro i ragazzi e ci sono stati feriti e morti, ma nessuno
se lo ricorda.
Nel marzo del 2006 arrivo ad Algeciras in
Spagna senza permesso. Speravo tramite dei parenti che avevo nel
sud della Spagna di trovare lavoro in fretta e dimenticare le
tragedie che avevo vissuto. Ma non è andata così. I miei
parenti non riescono a trovarmi lavoro e soprattutto non posso
regolarizzare i miei documenti. Comincio a fare piccoli lavori
nelle serre ma la paga è molto bassa e le ore di lavoro sono 12
tutti i giorni. Parlando con i miei parenti decido di partire
verso l’Italia, a Genova dove il fratello di mio padre avrebbe
dovuto trovarmi lavoro.
 Verso
la fine di Agosto del 2006 parto con un treno, compro il
biglietto per me costosissimo visto i pochi soldi che ero
riuscito a mettermi da parte. Il viaggio inizia bene incontro
degli ottimi compagni di viaggio spagnoli. I problemi cominciano
quando arrivo alla frontiera con la Francia. Dei poliziotti mi
chiedono i documenti e si accorgono che il mio passaporto è
senza permesso di soggiorno e mi fanno scendere dal treno. Verso
la fine di Agosto del 2006 parto con un treno, compro il
biglietto per me costosissimo visto i pochi soldi che ero
riuscito a mettermi da parte. Il viaggio inizia bene incontro
degli ottimi compagni di viaggio spagnoli. I problemi cominciano
quando arrivo alla frontiera con la Francia. Dei poliziotti mi
chiedono i documenti e si accorgono che il mio passaporto è
senza permesso di soggiorno e mi fanno scendere dal treno.
Non
ricordo precisamente il nome della stazione dove sono sceso mi
sembra Cerbère. Io per fortuna parlo francese e almeno capivo la
lingua, il problema era quello che mi dicevano. Non ho mai capito
legalmente cos’è successo, io so soltanto che sono stato
trattenuto delle ore in stazione fino a che mi hanno portato in
un qualcosa di molto simile a una prigione. Dopo alcune ore che
sono rinchiuso, mi dicono che mi avrebbero rimandato a casa mia.
Io gli ho chiesto se potevano farmi tornare in Spagna e il
poliziotto si è messo a ridere e mi ha fatto portare in una
stanza con altre otto persone. In questa stanza eravamo tutti
africani c’erano due ragazzi senegalesi, quattro marocchini e
due egiziani.
Ero disperato e i ragazzi cercavano di tirarmi
su di morale. Il giorno dopo comincio a capire grazie ad Hamed
che sono in una prigione per immigrati e che dovevo fare qualcosa
se non volevo tornare a casa da mia madre e le mie sorelle come
uno sconfitto che non era stato in grado di trovarsi un lavoro.
Dopo quasi una settimana all’interno di questa prigione
iniziano delle proteste, i primi giorni soltanto con le guardie
che ci controllavano, a cui chiedevamo di poter telefonare alle
nostre famiglie o a dei parenti che vivevano in Francia. Io non
riuscivo a capire cosa fare non avendoli e soprattutto non sapevo
come fare con mio zio a Genova che mi aspettava ormai da
tempo.
Dopo qualche giorno le proteste diventano più forti ed
è proprio Hamed uno dei più incazzati. Io decido di seguirlo
nella protesta anche perché mi aveva detto che erano i giorni
giusti per riuscire a scappare. Il capo guardia era uno distratto
che si addormentava spesso durante le ore notturne. Era un
martedì notte, mi ricordo bene, io e Hamed con altri due
decidiamo che è il momento giusto per scappare ma per farlo
dovevamo accettare di non correre il rischio di essere presi e
portati in un’altra prigione che Hamed diceva essere ancora
peggio.
 Però i soldi mi servivano
Però i soldi mi servivano
Quella notte anche se ho avuto paura è stata
una bella esperienza perché alla fine ce la abbiamo fatta. La
cosa più difficile non è stato uscire dalla prigione ma una
volta fuori muoversi a piedi con il buio senza sapere dove
andare. Decidiamo di dividerci per non farci notare e ognuno va
per la sua strada io riesco ad arrivare in poche ore di cammino
al primo paese, Millas. In questo posto che non avevo mai sentito
nominare, ho avuto fortuna di trovare dei ragazzi che mi hanno
offerto una sigaretta chiedendomi come ero arrivato lì. Dopo che
gli ho raccontato la mia storia, uno di loro mi dice che può
aiutarmi. Mi parla di suo zio che ha della terra e che se volevo
poteva farmi lavorare da lui. Io accetto anche se in realtà
pensavo a come proseguire il mio viaggio e alla telefonata a mio
zio. Però i soldi mi servivano per forza e soprattutto non
sapevo come muovermi, dove andare. Provavo un senso di totale
spaesamento e ripensavo alle mie giornate prima della partenza
per il Marocco e se devo dirti la verità le rimpiangevo ma come
ti dicevo prima non potevo tornare a casa.
 Il
giorno dopo conosco lo zio di Jean e comincio subito a lavorare,
mi dice che per un mese posso stare li, dormire in una specie di
casa costruita sul suo terreno, la paga per me era buona e in un
mese avrei fatto i soldi che mi servivano per riaffrontare il
viaggio e soprattutto mi sarei fatto un’idea su come arrivare a
Genova. Il
giorno dopo conosco lo zio di Jean e comincio subito a lavorare,
mi dice che per un mese posso stare li, dormire in una specie di
casa costruita sul suo terreno, la paga per me era buona e in un
mese avrei fatto i soldi che mi servivano per riaffrontare il
viaggio e soprattutto mi sarei fatto un’idea su come arrivare a
Genova.
Il lavoro era semplice, ma la fatica comunque era
tanta, lavorare la terra non è una cosa che mi piace troppo…
Quando andavo a lavorare provavo sempre un senso di paura, non
sapevo se mi stavano cercando perché ero scappato dalla prigione
e quindi non mi muovevo mai. Per un mese la mia giornata era
occupata soltanto dal lavoro, mi alzavo, facevo colazione e
andavo a raccogliere nel campo, una pausa per il pranzo e poi
ritornavo a lavorare. Alla sera ero distrutto e non me la sentivo
di andare in giro quindi se non passava Jean per fare due
chiacchiere, mi mettevo a dormire. Molte volte mi distendevo,
occhi chiusi e un milione di pensieri su cosa sarebbe potuto
ancora accadere alla mia vita. Quando stavo in Mauritania
lavoravo poco e la mia vita si ripeteva simile tutti i giorni,
non mi sentivo pronto per un viaggio in un mondo sconosciuto,
infatti rispetto ai miei amici, sono quello che ha iniziato il
viaggio per l’occidente da più grande, avevo già 24 anni e
nel mio paese non sono pochi come qua. Da noi a 24 anni sei un
uomo e devi lavorare per la tua famiglia. Per questo che mi sono
sentito costretto a partire.
Insomma ero agitato e soprattutto
volevo arrivare in Italia dai miei parenti, ma non sapevo come
fare. Ero spaventato dalla possibilità di finire rinchiuso
un’altra volta.
In quel mese Jean mi ha aiutato a capire il
modo migliore per arrivare a Genova e alla fine un suo amico che
lavorava con il furgone mi ha offerto un passaggio fino al
confine con l’Italia.
Luc, l’amico di Jean non se la sente
di attraversare con me il confine e lo capisco. Quindi decido di
passarlo da solo a piedi. Va tutto bene, il confine lo passo ed
entro finalmente in Italia. Credevo di metterci qualche giorno
invece ci ho messo mesi. A Sanremo prendo un treno per Genova e
per fortuna va tutto per il verso giusto. Alla stazione di Porta
Principe mi viene a prendere mio zio che non vedevo da quando
avevo 12 anni. L’emozione è stata forte ma mio zio mi dice
subito che è meglio andare via dalla stazione che in Italia la
polizia fa ancora più controlli che in Francia. Questa frase me
la ricordo ancora perché dalla felicità di pochi secondi prima
ho pensato con terrore che potevano rimettermi in una prigione
per immigrati.
 Quando esco di casa, ci penso sempre
Quando esco di casa, ci penso sempre
Anche a Genova non è stato semplice, grazie a
mio zio avevo cibo e un letto nella sua casa. Ho cominciato a
lavorare con lui nei mercati. Ma il problema dei documenti
rimaneva.
Visto che mio zio non poteva regolarizzarmi dovevo
cercarmi un lavoro in regola, ma il problema è che non avendo i
documenti nessuno me lo voleva dare. Quindi tutti quelli da cui
andavo a chiederlo mi dicevano che dovevo lavorare in nero perché
non avevo il permesso di soggiorno.
La situazione oggi per me
è ancora difficile, sì, sono riuscito dopo quattro anni a
trovarmi una stanza con altri amici, ho imparato l’italiano ma
non ho il permesso di soggiorno. Quando esco di casa ci penso
sempre, ho paura anche di prendere un treno, perché so che se
vengo fermato vado a finire in prigione. Quest’anno ho
cominciato a informarmi con altri ragazzi africani e sud
americani sulle possibilità che abbiamo di rivendicare i nostri
diritti. Ho partecipato a manifestazioni per il permesso di
soggiorno per i lavoratori immigrati ma se ti devo dire la verità
sono pessimista, non riesco a credere in una vittoria, la mia
speranza è di riuscire a sposarmi e di trovare un lavoro con il
contratto.
Dal Ghana / Ajene
Il
mio viaggio per arrivare in Italia è iniziato nel deserto tra
l'Africa sub-sahariana e i Paesi del Maghreb. Io abitavo in
Ghana. Ho iniziato la mia traversata a bordo di un camion guidato
da un ragazzo di Tripoli.
Durante il viaggio siamo stati
fermati tante volte dalla polizia e ci hanno rubato tutto quello
che avevamo. Ho visto con i miei occhi persone costrette dai
militari a bere acqua sporca per provocare problemi intestinali,
per costringere a espellere le palline con le banconote
arrotolate nel cellophane che avevano ingoiato per non farsi
derubare. Due ragazzi sono stati ammazzati come cani perché non
volevano dargli tutto1. Queste cose sono dure da sopportare e il
viaggio è stato lungo e difficile. Non abbiamo mangiato mai
nulla e avevamo soltanto una bottiglia d’acqua, siamo entrati
in Libia nei pressi della frontiera di Toummo se non ricordo male
anche perché ora comincio a dimenticare, sono passati quasi
dieci anni da quei giorni. Io sono stato molto fortunato perché
ero riuscito a nascondere bene i miei soldi. Arrivato in Libia
dalla frontiera sono riuscito a raggiungere in poco tempo Tripoli
e da li ho cominciato a capire cosa devo fare per imbarcarmi e
per arrivare in Italia. Non vedevo l'ora di iniziare la mia nuova
vita.
Sapevo che non sarebbe stato facile e che mi sarebbe
costato tanto, sia per i soldi sia per la mia testa, ma non
pensavo così tanto. A Tripoli sono riuscito a mettermi in
contatto con alcuni ragazzi che volevano andare in Italia a
lavorare e che sapevano a chi chiedere, ma il prezzo per il
“passaggio” era veramente troppo alto. Speravo di trovare
qualcosa di meglio ma alla fine ho capito che dovevo aspettare…
Trovarmi un lavoro in Libia, mettere da parte i soldi e partire.

 All'epoca non parlavo italiano
All'epoca non parlavo italiano
A Tripoli ho lavorato tre mesi per accumulare
soldi, mangiavo il meno possibile, non uscivo mai e non conoscevo
quasi nessuno, facevo una vita orribile. Ma alla fine avevo i
soldi che mi chiedevano e sono partito. Era una notte nell’estate
del 2002. Il viaggio in mare è stato se possibile ancora più
duro di quello nel deserto, prima di tutto perché io non avevo
mai viaggiato in mare e poi perché la barca era piccola e noi
eravamo tanti, quasi tutti uomini africani, poche donne e solo
due o tre bambini, se non ricordo male. Parlando poi in Italia
con tanti amici africani penso che io sono stato fortunato perché
nella nostra barca non è morto nessuno, anche se in molti sono
stati male.
A Lampedusa la polizia ci consegna un numero,
acqua e cibo e ci porta in una specie di carcere. Lì capisco che
devo lottare ancora per riuscire a vivere libero e trovarmi un
lavoro. All’epoca non parlavo italiano e anche questo era un
problema perché non capivo quello che mi dicevano. Da Lampedusa
però riesco ad andarmene abbastanza in fretta, anche perché
quasi tutte le sere arrivavano altre barche e non ci stavamo più.
Ci hanno spostato in Puglia ma non ne sono sicuro, in un centro
che sembrava meno carcere come quello di Lampedusa. C’era poca
polizia e soltanto una rete all’entrata. Dopo tre giorni in
questo centro, conosco Labaan e con lui decidiamo di andarcene
senza aspettare il permesso perché avevamo capito che ci
volevano rimandare a casa nostra e dopo tutti i sacrifici fatti
per arrivare e cambiare vita, era una cosa che non poteva proprio
succedere.
Andiamo via di notte, non è stato difficile perché
come ti dicevo c’era solo una rete e la polizia sembrava non
guardasse troppo quello che facevamo, infatti andò tutto bene.
Una volta scavalcata la rete nessuno ci fermò.
Da lì abbiamo
passato la notte a pochi chilometri dal centro, ci siamo messi a
dormire in un campo ben nascosti. Con la luce siamo andati alla
ricerca di una stazione per riuscire ad andare via dal sud Italia
verso il nord che ci aspettavamo ricco e pieno di lavoro.
Troviamo la stazione dopo poche ore di cammino e decidiamo
che è meglio separarci per non dare nell’occhio anche perché
il primo problema da affrontare era come pagare il treno, visto
che non avevamo i soldi italiani.
Io mi presento alla
biglietteria ma non concludo nulla, capisco che però è
impossibile prendere un solo treno per arrivare a Milano, ne devo
prenderne almeno due. Visto che non potevo pagare con i miei
soldi, avevo anche 20 dollari ma non li hanno voluti. Salgo sul
treno per Roma senza biglietto. Anche Labaan sale sullo stesso
treno anche se non ci mettiamo nello stesso vagone. Da lì non ci
siamo più rivisti e spero che anche per lui il viaggio sia
continuato senza troppi problemi. A Roma riesco a cambiare i miei
dollari e a fare il biglietto per un treno fino a Modena, la
città dove ho fatto il mio primo lavoro italiano.

 Sinceramente mi sento afritaliano
Sinceramente mi sento afritaliano
A Modena scendo in stazione molto presto di
mattina, sono totalmente spaesato e anche se dentro di me sono
felice, capisco che la mia situazione è complicata, non ho
nessuna carta che dice che posso stare in Italia. Per fortuna
incontro dopo poche ore dei ragazzi Ghanesi che mi aiutano
subito, mi invitano a mangiare nella loro casa e mi spiegano che
è meglio se non me ne vado in giro troppo senza il permesso di
soggiorno. Questi ragazzi sono stati la mia salvezza perché per
un mese mi hanno fatto dormire sul loro divano, facendomi
conoscere gli italiani giusti che mi hanno aiutato a trovare
lavoro. Sono stato nelle campagne per sei mesi, venivo pagato
poco ma almeno riuscivo a mangiare e a permettermi una stanza in
affitto. Il problema del permesso però rimaneva perché non
lavoravo in regola.
Dopo questo lavoro ne ho trovato uno meno
faticoso e pagato meglio, lavoravo da un benzinaio dove sono
rimasto quasi un anno, il padrone era tranquillo ma anche lui mi
diceva che non aveva i soldi per regolarizzarmi. I miei amici
italiani mi dicevano che entro poco ci sarebbe stata una
sanatoria per tutti i migranti e di non preoccuparmi e io ci
speravo anche perché sinceramente mi stavo trovando bene. Nella
mia testa c’era ancora la voglia di andare a Milano, la città
dove avrei potuto fare un vero lavoro e guadagnare bene per
mettermi da parte dei soldi.
Dopo 5 anni a Modena senza
permesso di soggiorno e altri due lavori, uno in un forno e uno
in una cooperativa edile, trovo un lavoro vicino a Milano in una
fabbrica metal-meccanica come operaio, questo lavoro l’ho
trovato grazie a un amico, Mario che erano anni che cercava una
possibilità per la mia regolarizzazione. In questa fabbrica ho
lavorato duramente per due anni, mi hanno fatto subito il
contratto, con varie difficoltà ma alla fine ce la abbiamo fatta
e ho ottenuto un permesso di soggiorno legato al mio contratto.
Guadagnavo più di mille euro al mese, finalmente potevo avere
una casa e una vita tutta mia. In quei due anni 2007\8 ho
conosciuto vari amici e amiche, uscivo la sera e mi occupavo
insieme ad africani e italiani di una scuola di italiano per
migranti.
È stata un’esperienza molto bella e soprattutto
ho conosciuto Monica, mia moglie, una ragazza toscana di Firenze
ma che stava a Milano. Adesso siamo sposati e io sono diventato
italiano. Sinceramente non mi sento proprio italiano, ma
afritaliano, nel senso che non vivo più da Ghanese ma non sono
neanche un italiano al 100%. Certo tante cose della vostra
cultura ormai fanno parte di me, le ultime esperienze si sono
incontrate e mescolate con la mia parte africana. Anche se non è
stato facile, adesso amo l’Italia, mi piace la musica, la
cucina, il cinema, ma amo anche l’Africa, il mio paese dove
finalmente posso tornare senza paura per stare con la mia
famiglia.
Quando vado in Ghana per i figli di mia sorella sono
un italiano con la faccia nera e che parla la loro lingua ma per
gli italiani sono un africano che lavora in Italia, insomma un
casino ma finalmente sono felice. Anche se non finirò mai di
pensare a tutti i fratelli che non ce la fanno, che muoiono nel
viaggio o che vengono riportati a casa dalla polizia. Io alla
fine sono stato fortunato e adesso devo lottare per i diritti di
tutti quelli che non sono arrivati o che vogliono arrivare.
 Andrea Staid
Andrea Staid
Per chi rimane senza soldi il viaggio si
tramuta in tragedia. Secondo diverse testimonianze le oasi del
deserto nigerino e libico sarebbero disseminate di schiavi.
Giovani partiti dall'Africa occidentale alla volta dell'Europa e
rimasti bloccati senza soldi per proseguire né per ritornare.
|
Interviste non strutturate, perché...
L’intervista riveste un ruolo importante
nella ricerca sociale e antropologica, sottolinea il grande
valore dell’oralità, della visualità, della partecipazione
e dell’osservazione, rende fondamentale il contatto diretto
per la costruzione di uno studio antropologico.
Si possono
usare diverse tipologie di interviste, per esempio interviste
non strutturate, semistrutturate e strutturate.
Io ho
scelto, per la costruzione della mia ricerca, l’intervista
non strutturata. Con questo tipo di intervista, che racconta
storie di vita, ho tentato di realizzare una comprensione
profonda, complessa del punto di vista e della situazione
degli intervistati.
Desideravo scoprire le esperienze, le
sofferenze delle donne e degli uomini che ho intervistato, ho
cercato di esaminare a fondo le loro storie di vita da
migranti, permettendogli di comunicare liberamente. Proprio
per questo motivo questo tipo di intervista è denominata non
strutturata.
Ho lasciato l’intervistato libero di
parlare delle esperienze importanti, con una mia influenza
poco direzionale, cercando di stabilire dei rapporti umani,
fondamentali perché dovevano fidarsi di me per rivelarmi
informazioni intime della loro vita.
Per questo è
importante lasciare ora la parola ai migranti, lavoratori
precari, sfruttati che vivono con noi e che troppo spesso non
vogliamo ascoltare. Le interviste costituiscono parte
integrante del testo, sono i racconti delle donne e degli
uomini che hanno vissuto i fatti che raccontano, sono le
storie orali, documenti di grande importanza per capire la
complessità della vita quotidiana.
In una società che ci
sottopone a un continuo sovraccarico informativo gli eventi ci
vengono raccontati da altri quasi in tempo reale, facendo
perdere agli individui la capacità di sentirsi testimoni o
narratori delle situazioni di cui si è stati
protagonisti.
Rendersi protagonisti, e non meri spettatori,
della memoria, significa invece saper ascoltare, significa
ricostruire esattamente gli eventi e il loro significato, ma
anche riuscirli a rappresentare attraverso i protagonisti
diretti. Senza aver parlato, discusso con i migranti questo
testo non sarebbe esistito.
 A.S.
A.S.
|
Migranti
I piatti dei migranti
di Andrea Perin
Che cosa mangiano i migranti? Si può parlare
di meticciamento anche a tavola?
In appendice al libro “Le
nostre braccia” questo scritto di Andrea Perin ci fa sedere a
tavola e scoprire che....

Si
può definire meticcia una cucina? Se la si affronta nel suo
percorso storico nessuna tradizione è pura, ognuna si è
modificata nel corso tempo con scambi e ingressi. La stessa
cucina italiana, una delle più ricche e articolate al mondo, non
è un modello codificato e unitario bensì una rete di saperi e
pratiche, strutturatisi in secoli di storia grazie anche alla
posizione centrale che la penisola occupa nel Mediterraneo e che
ha portato a secoli di occupazioni subite (e imposte), commerci
con tutto il mondo, immigrazioni ed emigrazioni (1).
Da ultimo, i poderosi trasferimenti che portarono milioni di
persone dal sud al nord, che hanno rimescolato ancora gusti e
ingredienti.
Si tratta di una storia spesso dimenticata,
oppure omessa per superficialità o interesse: la tipicità non
di rado viene spacciata per tradizione, e la stessa tradizione
viene presentata come un fattore statico che attraversa i secoli
immutabile. Si vagheggia di un passato fatto di natura e
sincerità, mentre per la maggior parte della popolazione la
quotidianità era fatta di fame e miseria. La cucina italiana è
diventata in molti casi un astratto elemento identitario da
difendere, una barricata rispetto all’invasione di
“stranieri”.
In questo contesto il termine meticcio può
essere utile per definire un tipo di cucina: non la moda fusion
dei ristoranti glamour e neppure le fantasie dei blogger
gastrofanatici, ma la contaminazione casalinga di ricette,
ingredienti e conoscenze delle diverse culture che si confrontano
nella società, una pratica che supera nella consuetudini le
barriere culturali che limitano l’incontro e lo scambio. È un
termine che trova giustificazione nell’impatto accelerato che
la contemporaneità comporta nei cambiamenti rispetto al passato
quando le modifiche delle abitudini richiedevano decenni o anche
secoli (2). E soprattutto nella conseguente
possibilità di scegliere.
 Orgoglio culturale
Orgoglio culturale
«È l’era del politeismo alimentare che
spinge le persone a mangiare di tutto, senza tabù, generando
combinazioni soggettive di alimenti e anche di luoghi ove
acquistarli, neutralizzando ogni ortodossia alimentare». Nel
primo rapporto Coldiretti/Censis del 2010 sulle abitudini
alimentari degli italiani si evidenzia che “il rapporto con il
cibo è una dimensione sempre più soggettiva, espressione
dell’io che decide e che, a partire dalle proprie preferenze,
abitudini, prassi e aspettative, nonché dalle risorse di cui
dispone, definisce il contenuto del carrello e della tavola”.
Solo per il 30,4% la propria alimentazione deriva ormai dalla
tradizione familiare (3).
Se
l’immigrazione, con l’arrivo di nuovi gusti e nuovi prodotti,
è anche un’occasione per allargare le possibilità a tavola
degli italiani, la situazione per i migranti è sicuramente più
complessa. Si sono scritti fiumi di inchiostro per raccontare
come il cibo sia un fattore identitario, sull’importanza che
assume per uno straniero costretto a cambiare tutti gli aspetti
della sua vita. Per molti, specialmente qualche anno fa quando le
comunità erano meno organizzate, è stata in effetti
un’autentica sofferenza doversi cibare solo di pietanze
italiane è «L’inizio è stato un po’ faticoso soprattutto
perché non si trovava il nostro riso o altri ingredienti”
(Hasina, Bangladesh) (4). Spesso era
difficoltoso trovare alimenti compatibili con la propria
religione.
Per tutte le comunità la cucina è un orgoglio
culturale e una esternazione di appartenenza. Basta scorrere le
pubblicazioni o partecipare alle feste dove sono i migranti
stessi a raccontare o eseguire i proprie piatti per verificare
come le ricette siano riproposte uguali a quelle eseguite a casa,
come se centinaia o migliaia di chilometri di distanza fossero
annullati.
«Quando ero un po’ più grande mia madre mi ha
detto: “Quando finirai la scuola tu dovrai andare in un altro
paese a cercare lavoro, qui non ci sono soldi, devi andare in un
altro paese. Non ci sarò più io a cucinare per te, e chi
aiuterà te? Devi imparare adesso, guarda bene come faccio, sei
grande abbastanza per imparare a cucinare”» (Somot e Raju,
Bangladesh) (5).
In realtà per il
migrante l’alimentazione più che veicolare un’astratta
appartenenza a una patria o definire una specificità culturale,
rappresenta un legame emotivo e sensoriale soprattutto con la
famiglia lontana, con i sapori condivisi sin dall’infanzia: i
modelli gastronomici sono la cucina della mamma e della nonna,
che sommati e condivisi con gli altri costruiscono un gruppo, una
comunità (6). «Sono molto contento di
cucinare questo piatto perché mi ricorda la mia famiglia,
specialmente mia nonna, che cucinava i Domoda per noi, sempre. Ho
mangiato cose diverse in Italia, ma non ho ancora trovato il cibo
che mi ricorda la mia famiglia. - racconta Muhammed del Gambia -
Quando mi hanno informato della cena, sono stato molto contento
di cucinare i Domoda per ricordare la mia famiglia. Questo
incontro è molto importante perché mi sento come con la mia
famiglia» (7).
Bahaa, egiziano: «Quando
cucino questo piatto mi sento come dentro a casa mia in Egitto,
con la mia famiglia. Ogni volta che cucino questo piatto mi sento
come dentro le braccia di mia madre. Perché è troppo buona,
come un dolce» (8).

 Accorciare le distanze
Accorciare le distanze
Il cibo definisce chi appartiene e per
esclusione identifica lo straniero, ma non è solo questo: è
anche il primo grado di scambio e di riconoscimento dell’altro.
Mangiare il cibo del diverso, dello straniero, vuol dire
accorciare le distanze e appropriarsi di un pezzetto
dell’identità altrui, farla propria. Se è vero che il “sapore
è sapere”, è sempre possibile imparare nuovi gusti.
La
realtà per i migranti è meno lineare della semplice
conservazione della propria tradizione perché il consumo
alimentare risulta assai pragmatico e comprende spesso la cucina
italiana, sia sui luoghi di lavoro o a scuola che a casa.
«Fino
a pochi anni fa pensavo che il cibo senegalese fosse il più
buono al mondo. Ora penso che sia stata una gran fortuna
conoscere anche quello italiano» (Aliou, Senegal) (9).
«Io
e mio marito preferiamo le cose fast tipo pasta, cose insomma che
si preparano rapidamente durante la settimana, quando siamo di
corsa. Quando c’è tempo cucino marocchino, o se c’è gente a
cena o pranzo o durante le feste religiose. Le cose italiane sono
più veloci da preparare» (Sara, Marocco) (10).
I risultati di un’indagine svolta nel biellese nel 2006 sui
consumi alimentari di un piccolo campione di migranti hanno
mostrato ad esempio una notevole familiarità e assimilazione con
il modello italiano, insieme a un allontanamento dalle usanze più
tradizionali: la maggior parte quotidianamente mangia e beve
«all’italiana» (81,3%) o consuma «cibi e bevande
internazionali» (20,5%). I cibi del paese d’origine vengono
consumati saltuariamente (32,5%) o addirittura mai (17,5%)
(11).
Questa disinvoltura a tavola nasce
in buona parte dalla comodità, visto che la cucina italiana è
ritenuta più facile e veloce, spesso è desiderio di
omologazione al modello della cultura ospite: sono sempre di più
i corsi di cucina italiana per migranti, anche per obbligo
professionale (colf, collaboratrici, etc.).
I migranti poi
sono inseriti stabilmente nei processi produttivi della catena
alimentare italiana. Sono già oltre 38mila nel 2010 le imprese
del settore gestite da migranti secondo una ricerca del FIPE,
pari al 12,1% del totale, e se oltre 2.500 sono i ristoranti
etnici è ormai evidente a tutti come molti ruoli siano coperti
da «stranieri» anche nei bar, nelle panetterie, nelle pizzerie,
nelle cucine di ristoranti e trattorie. Senza contare le persone
impiegate nella produzione, come nei prosciuttifici emiliani o
nei caseifici del grana padano e della fontina valdostana
(12).
Tanto che, in un provocatorio
articolo il New York Times di qualche anno fa
si chiedeva: “Is the Cuisine Still Italian Even if the Chef
Isn’t?”. Sebbene la a cucina italiana sia una delle più
impermeabili alle modifiche, scriveva il corrispondente, sarà
sempre uguale o comincerà a subire modifiche dai suoi cuochi
«stranieri»? (13).
Senza scomodare gli
chef professionali sono le cucine casalinghe i laboratori del
cambiamento, dove nella quotidianità dell’alimentazione si
fondono i sapori, le esperienze si incrociano, i gusti si
adattano. Se nelle feste si mangia come lo preparavano la mamma o
la nonna, e agli amici si offre la cucina tradizione per
soddisfare le aspettative, per sé e per i propri familiari e gli
amici più stretti ci si comporta come in ogni cucina del mondo:
ci si adatta alla disponibilità della dispensa e del
frigorifero.
Sono modifiche quasi clandestine, al di fuori
delle regole, che si possono al momento cogliere solo per singoli
fotogrammi senza una visione generale: alle feste o nei libri non
compaiono o si negano, qualche volte si leggono in trasparenza,
quasi mai sono oggetto di specifiche attenzioni o sono
protagoniste di avvenimenti. D’altro canto, quando mai un
ricettario è specchio fedele della realtà?

 Una sorta di meticciato industriale
Una sorta di meticciato industriale
Una prima causa di meticciamento, forzata, è
dovuta alla sostituzione degli ingredienti originali con le con
materie prime del luogo: «Questa ricetta che vi presento oggi è
il bulz come l’abbiamo mangiato a Pasqua in Romania a Moeciu
preparato però quando siamo tornati a casa con la farina di mais
italiano, la salsiccia bolognese e il formaggio che abbiamo
comprato in Romania.» (14)
La differenza
è data proprio dal sapore che il mercato e la produzione
italiana conferiscono a verdure, frutta e carne, spesso anche
all’acqua : “In realtà però, quando si tratta di
ingredienti freschi, utilizzati sia nella cucina russa sia in
quella italiana (...), devo ammettere che il gusto è
notevolmente diverso da quello dei prodotti della mia terra”
(Alla, Russia) (15).
È probabilmente
facile adattare le ricette italiane ai propri gusti, tenendo
presente che i piatti più conosciuti e apprezzati sono
soprattutto i primi o la pizza, ottime basi cui aggiungere e
modificare sapori. «Io ad esempio, preparo una carbonara
speciale con modifiche al dosaggio e con l’aggiunta di panna
acida» (Daniel, Romania) (16), mentre la
giapponese Ayame condisce gli spaghetti con tonno, daikon e alghe
nori (17) e Alexandra, di madre cretese,
mette la cannella nel ragù delle lasagne (18).
«Le spezie sono tipiche di giù e ce le portiamo qui, poi le
usiamo sulla pasta e viene un mix ottimo» (Shaima, Marocco)
(19).
In ritardo di anni rispetto
all’Europa, sta iniziando una produzione industriale di cibo
italiano «halal», una sorta di meticciato industriale, che
rende lecite ai mussulmani le ricette che conterrebbero
ingredienti non assimilabili (20).
Un
processo meno scontato è l’intervento e la modifica sui propri
piatti identitari, ad esempio con l’introduzione di ingredienti
italiani prima sconosciuti. «Quando cucino piatti peruviani
aggiungo spesso formaggi italiani, anche perché mi piace fare
degli esperimenti» (Maritta, Perù). «Il riso che comunemente
si mangia in Romania, lo modifico con l’aggiunta di funghi,
zucchine e quant’altro» (Daniel, Romania) (21).
Oppure con una semplificazione dei piatti tradizionali, come fa
Modou tramutando in risotto il senegalese ceebu jn (22)
(senza dimenticare che in patria spesso gli uomini non cucinano).
Ma chi opera questi cambiamenti, e perché? La sensazione è
che in generale non esistano regole ma solo situazioni,
disponibilità e curiosità, e che diventa una scelta
programmatica e consapevole solo in alcuni casi, come ad esempio
quello delle coppie miste: qui l’incontro dei sapori assume
spesso il valore anche orgoglioso di uno scambio riconosciuto, di
una metafora della propria condizione, a volte rappresenta un
equilibrio per conciliare le diverse tradizioni e abitudini.
«Non
posso passare la vita a escludere mio marito dalla cucina
italiana che amo tanto, ma troppe ricette prevedono vino, per
sfumare, soffriggere, aromatizzare, pancetta dolce o affumicata
per aggiungere sapore - scrive Cristina - Ho provato e ho
scoperto ottimi compromessi, le ricette si ‘sporcano’ un po’
e noi ci mescoliamo» (23).
Per quelle che
vengono chiamate burocraticamente «Seconde generazioni», e che
rispecchiano condizioni assai variegate tra loro, le abitudini di
consumo alimentare esprimono in maniera evidente la doppia
appartenenza culturale, spesso non vi sono rigide preferenze per
i cibi italiani o quelli della propria tradizione, che vengono
consumati indifferentemente. Vista la giovane età raramente
cucinano e si confrontano con la creazione di sapori, ma spesso
il soddisfacimento congiunto delle diverse appartenenze culturali
a tavola è una via potenzialmente aperta a nuove forme di
meticciamento, anche a quelle che incrociano tradizioni diverse
da quella italiana.
Per concludere, se la cucina meticcia è
un’esperienza casalinga e dispersa, resterà qualcosa di
condiviso? «L’unica grande regola del meticciato è l’assenza
di regole. (...) Ciò che nascerà dall’incontro rimane
sconosciuto» (24). Sono troppe le variabili
per fare previsioni, e in fondo non importa. La cucina è
un’attività libera, fuori dai controlli e in sostanza
refrattaria alle imposizioni, anche da quelle fintamente benevole
dei ricettari tradizionali e non.
Ed è bello vedere come le
barriere culinarie, erette a difesa delle identità, si possano
superare in un boccone.
 Andrea Perin
Andrea Perin
Note
Alberto
Capatti, Massimo Montanari, La
cucina italiana. Storia di una cultura,
Laterza, Roma-Bari 1999; Massimo Montanari, L’identità
italiana in cucina,
Laterza, Roma-Bari 2010.
Montanari
Massimo, Il
cibo come cultura,
Laterza, Roma-Bari 2004; Arjun Appadurai, Modernità
in polvere,
Meltemi, Roma 1996.
http://www.coldiretti.it/docindex/cncd/informazioni/747_09.htm.
Reza
Rashidy (a cura di), Mi
racconto... Ti racconto. Storie e ricette del nostro mondo,
Editrice Coop Consumatori, Bologna 2007, p. 44.
Testimonianza
raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”, nella
serata dedicata al “Piacere”, cena aperta di condivisione di
piatti, svoltasi nel circolo arci La Scighera di Milano, 13
maggio 2010. A cura di Naga e arci Scighera, in collaborazione
con Associazione Asinitas di Milano.
Klaus
E. Müller, Piccola
etnologia del mangiare e del bere,
Il Mulino, Bologna 2005, p. 109-116.
Testimonianza
raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”.
Testimonianza
raccolta durante la rassegna “Parole di frontiera”.
Le
ricette di Sunugal. Scambio di sapori e saperi tra Italia e
Senegal,
Milano 2011, pp. 27,28.
Laura
Fontana Sabatini, I
consumi e i cultural bridging: le seconde generazioni di donne
egiziane e marocchine a Milano,
Tesi di Laurea Specialistica in Marketing Management, Università
Commerciale Luigi Bocconi, Facoltà di Economia di Milano, Anno
Accademico 2007-2008, p. 63.
Emilio
Sulis (a cura di), Abitudini,
opinioni e consumi migranti. Un approfondimento nel contesto
biellese,
in Carla Fiorio, Enzo Mario Napolitano e Luca Massimiliano
Visconti (a cura di), Stili
migranti, i quaderni di welcome marketing etnica,
2007, p. 169-199.
http://www.confcommercio.it/home/Inchieste/Il--melting-pot--della-ristorazione-italiana.htm_cvt.htm.
Lo
spunto per l’articolo furono il premio del Gambero Rosso per
la miglior carbonara a Nabil Hadj Hassen, chef d’origine
tunisina, e il secondo posto del premio conferito dalla
prestigiosa rivista gastronomica a un ristorante il cui capo
cuoco è indiano. Ian Fisher, Is
the Cuisine Still Italian Even if the Chef Isn’t?,
New York Times, 7 aprile 2008.
http://lacucinadicrista.blogspot.com/2011/06/bulz-ca-la-moeciu-like-i-eat-at-moeciu.html.
Benedetta
Cucci (a cura di), Ricette
delle nuove famiglie d’Italia,
Pendragon, Bologna 2010, p.94.
Reza
Rashidy (a cura di), op.
cit.,
p. 216
Intervista
in JallaJalla,
Radio Popolare di Milano dell’11 marzo 2011, in studio Andrea
Perin e Nello Avellani. Vd. Anche
http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2011/07/08/jallajalla-storia-della-pasta/.
Intervista
in JallaJalla,
Radio Popolare di Milano del 30 aprile 2010, in studio Andrea
Perin e Paolo Maggioni. vd. Anche
http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2010/05/03/jallajalla-alexandra-e-le-lasagne-alla-cannella/.
Laura
Fontana Sabatini, op.cit.,
p. 62.
Ad
esempio http://www.trealfierihalal.com.
Reza
Rashidy (a cura di), op.
cit.,
p. 200 e p. 216.
Intervista
in JallaJalla,
Radio Popolare di Milano del 6 febbraio 2010 – in studio
Andrea Perin e Paolo Maggioni. Vd. Anche
http://ricettescorrette.noblogs.org/post/2010/03/04/jallajalla-modou-e-il-riso-alla-modouu.
http://cribaba.blogspot.com/2011/04/brasato-al-barolo-per-palati-islamici.html.
François
Laplantine, Alexis Nouss, Il
pensiero meticcio,
Elèuthera, Milano 2006, p. 10.
|