|
Bruma sul ponte
Non conosciutissimo in Italia (anche se ultimamente molti suoi
romanzi sono stati pubblicati da Fazi Editore), ma ammirato
quasi al pari di Simenon in Francia, il giallista Léo
Malet (Montpellier 1909-Parigi 1996), personaggio singolare
nel panorama letterario d’oltralpe, fu assiduo frequentatore
degli ambienti anarchici parigini e, anche se le sue peripezie
lo allontanarono, negli anni della maturità, dalle amicizie
giovanili, il suo distacco dal mondo e, soprattutto, dal pensiero
libertario, non fu mai totale. Di modeste origini e uomo dai
mille mestieri (lavabottiglie, fattorino, chansonnier,
operaio, impiegato, scaricatore, strillone), quella di Malet
è una biografia ricca e movimentata. Negli anni venti
e trenta, dopo un breve periodo trascorso in carcere, lo troviamo
fra i collaboratori e diffusori di riviste quali «l’en-Dehors»,
«L’Insurgé», «La Revue Anarchiste»,
poi esponente del movimento surrealista, amico di Breton e Dalì,
quindi occasionale aderente al movimento trotzkista. Nel 1940
è nuovamente in prigione con l’accusa di avere
attentato «alla sicurezza interna ed esterna dello Stato»
e poco dopo viene catturato dai tedeschi e inviato, per quasi
due anni, in campo di concentramento. Tornato in libertà,
inizia la sua carriera di giallista (sono circa settanta i suoi
lavori) dando vita a numerosi personaggi, tra i quali il più
conosciuto è l’investigatore privato Nestor Burma,
anch’esso anarchico in gioventù e ancora fortemente
influenzato, nel giudicare il mondo e le situazioni nelle quali
si trova ad indagare, dalle idee libertarie che avevano infiammato
la sua giovinezza.
Inevitabile, dunque, viste queste frequentazioni e le caratteristiche
della sua creatura, che il milieu dell’anarchismo
parigino diventi quasi una costante delle sue opere. Così
nel famoso Chilometri di sudari il deus ex machina
è un miliziano francese morto nel 1936 combattendo nella
Colonna Durruti, e non è un caso che in Nebbia sul
ponte di Tolbiac, uscito nel 1956 e giudicato
fra i suoi lavori più riusciti, i protagonisti siano
alcuni degli ex componenti di un Centro vegetaliano anarchico
situato nel cuore del XIII Arrondissement. Uno di loro, Abel
Benoit Lenantais, ex calzolaio soprannominato Liabeuf ed ora
rigattiere, rimasto fedele anche in tarda età ai rigorosi
costumi libertari, viene misteriosamente accoltellato nella
propria abitazione, ma prima di morire riesce a raggiungere,
con un messaggio affidato a una misteriosa gitana, l’antico
compagno Burma, avvertendolo così del pericolo che incombe
su altri camarades già frequentatori del vecchio
sodalizio. Nel corso delle indagini, complicate dalla misteriosa
presenza della bella zingara e ricche degli immancabili colpi
di scena di un «giallo» che si rispetti, l’investigatore
ritrova altre antiche conoscenze, più o meno memori degli
antichi ideali, ma tutte ancora significativamente segnate da
quella specie di imprinting che deriva da una adesione
anche saltuaria all’anarchismo. Va da sé che l’intreccio,
lo svolgimento di questa intricata storia piena di ombre e di
luci, nasca e muoia nell’ambito degli antichi habituées
della comune vegetaliana, in una fosca resa dei conti di avventurose
vicende e ambigue complicità, nate trent’anni prima
e quindi amaramente svelate e risolte da Nestor Burma. E l’amarezza
dell’investigatore, quando si ritrova a riannodare i fili
di storie nate nell’entusiasmo dell’ideale e risoltesi
nella banalità del delitto, è la stessa che Léo
Malet affida, cinicamente, alle parole con cui l’assassino
confessa il proprio misfatto: «Abbiamo litigato e l’ho
pugnalato. Ho reso un servizio alla società perché
quel Lenantais era un puro. Vale a dire molto più pericoloso
per la società di molti altri».
Personaggi originali e strampalati
Senza dubbio, nell’invenzione di queste storie «anarchiche»,
c’è una certa condiscendenza, da parte di Malet,
verso la sensibile curiosità di un lettore facilmente
affascinabile dalla descrizione di situazioni e personaggi originali,
stravaganti e vagamente strampalati, quali appaiono, ad esempio,
nelle pagine sulla Comune vegetaliana. Ma l’ironico distacco
con il quale l’autore rimarca la frattura definitiva con
le sue precedenti esperienze politiche e sociali, lascia trasparire
pur sempre una venatura di affetto, e anche di rispetto, che
non fatichiamo a credere più che sincera e motivata dall’avere
riconosciuto, invecchiando, la peculiare dimensione spirituale
ed intellettuale del pensiero libertario. E del resto l’anarchismo
francese, forse perché cosmopolita crocevia delle obbligate
migrazioni degli anarchici di mezzo mondo, non ha mancato di
dar vita a personaggi e correnti filosofiche che spesso, ben
più che in Italia, hanno rischiato di apparire come bizzarre
caricature di un estremismo esistenziale da noi sostanzialmente
sconosciuto.
Se, infatti, le correnti organizzatrici e sindacaliste sono
state, in Francia, particolarmente forti e capaci di influenzare
anche il percorso del nostro anarchismo organizzato, altrettanta
importanza e diffusione hanno avuto quelle tendenze che esprimevano
un rifiuto totale dell’azione sociale e di propaganda
per rifugiarsi ora nell’illegalismo più o meno
estremo, ora nella edificazione di una vita «altra»
e separata rispetto alla società. Tendenze che non hanno
mancato di esprimersi ovunque fossero diffuse le idee libertarie,
ma che in Francia più che altrove hanno trovato fortuna
e ragion d’essere. Se da una parte, infatti, i lettori
del «Père Peinard» ritrovavano nello scoppiettante
argot di Emile Pouget e dei suoi collaboratori il linguaggio
dei bassifondi e di quel sottoproletariato urbano, tanto generoso
quanto tenacemente illegalista e pericoloso per l’ordine
borghese, a cui appartenevano, dall’altra parte diversi
discepoli della diade Libertà e Uguaglianza sperimentavano,
nella più coerente delle pratiche nonviolente, anche
se non sempre legalitarie, gli insegnamenti della scuola neo-Malthusiana,
precorritrice della liberazione sessuale degli anni sessanta,
espressi dai vari Charles Albert, Eugéne e Jeanne Humbert,
Mauricius, René Chaughi, Sebastien Faure ed E. Armand.
Profeti di un mondo nuovo, libero dai condizionamenti di una
morale codina e repressiva, assertori della necessità
che un’umanità sempre più soffocata dalle
convenzioni sociali trovasse finalmente la capacità di
uniformarsi alle sole leggi accettabili (vale a dire quelle
naturali), questi anarchici, che alcuni begli spiriti avrebbero
potuto trovare stravaganti, pagarono comunque con lunghi anni
di carcere e di emarginazione il fio della loro irriducibile
estraneità ad ogni forma di potere. Liberi dagli schematismi,
attenti solamente al rispetto delle individualità altrui
e delle rispettive differenze, gli uni e gli altri, tanto i
proletari illegalisti quanto i sognatori di un mondo nuovo,
si ritrovavano a discutere, probabilmente, nel Centro anarchico
vegetaliano del XIII Arrondissement, quello stesso al quale
Malet, avendolo evidentemente frequentato, si è ispirato,
in questo suo Nebbia sul ponte di Tolbiac.
 Massimo Ortalli
Massimo Ortalli
«Maledetto anarchico!»
di Léo Malet
Gli restituii prima la stretta, poi la mano e risi:
«Per fortuna che non sono un poliziotto. Altrimenti la
segnalerei ai suoi superiori. Cos’è questo vocabolario?
Aderisce forse a una cellula comunista?».
Replicò anche lui ridendo:
«È a lei che bisogna chiederlo».
«Io non sono comunista».
«È stato anarchico. Forse lo è ancora. Per
me, è la stessa cosa».
«È ormai molto tempo che non lancio bombe»,
sospirai.
«Maledetto anarchico!», ridacchiò l’ispettore.
Sembrava divertirsi sul serio.
«Oh! Ma smettiamola! Signor Mac Carthy», dissi.
«Ha mai sentito parlare di Georges Clemenceau?».
«La Tigre?».
«Si, la Tigre. O, se preferisce, il Primo Poliziotto di
Francia, come si è autodefinito lui. Purché mi
lasci in pace, le ripeterò quello che ha detto un giorno
la Tigre, detto o scritto, cito a memoria: “L’uomo
che a sedici anni non è stato anarchico è un imbecille”».
«Davvero? La Tigre ha detto questo?».
«Si, vecchio mio. Non lo sapeva?».
«Ma si, certo...».
Sospirò:
«…La Tigre!…».
E con un gesto automatico gettò uno sguardo in direzione
dell’orto botanico.
Poi, tornando a me:
«…La sua citazione mi sembra incompleta. Non ha
per caso aggiunto: “…ma lo è – imbecille
– anche chi è ancora anarchico a quaranta”,
o qualcosa del genere?».
«È esatto. Ha aggiunto qualcosa del genere».
«E allora?».
Sorrisi:
«Tra le affermazioni di Clemenceau bisogna fare una cernita.
Io ne scarto non poche».
Sorrise a sua volta:
«E lei però non è un imbecille!».
«Un buon amico»
di Léo Malet
«Forse non si considerava né Martine Carol, né
Juliette Greco. Era un tipo originale».
«Sì. Mi dia qualche informazione su di lui. Al
punto in cui siamo… tanto è morto. Le chiacchiere
non possono più fargli alcun male».
«Cosa vuole che le dica? Era un bel tipo, un buon amico.
Era calzolaio e, a causa del suo mestiere, che esercitava a
intermittenza, lo chiamavamo il Ciabattino. Sempre per via del
suo mestiere lo chiamavamo anche Liabeuf sebbene non avesse
mai ucciso nessuno, né uno dei vostri colleghi né
un normale cittadino».
«Effettivamente sono i nomi che figurano nel casellario
giudiziario. Allora? Nessun errore?».
Prima di rispondere esaminai un’altra volta, e molto a
lungo, il viso severo, indurito dalla morte. Gli tolsi i baffi,
gli aggiunsi i capelli biondi indisciplinati, capelli da anarchico.
Quello e il naso, tornava tutto.
«Un malfattore onesto»
di Léo Malet
«Torniamo al tatuaggio», disse. «Ricorda
cosa rappresenta?»
«Tatuaggi, al plurale. Una moneta sul braccio e “Né
Dio né Padrone” sullo stomaco».
«Esatto», disse il poliziotto.
«… una moneta».
Prese il lenzuolo da sotto il mento del morto per abbassarlo
fino alla vita. L’iscrizione sovversiva, che decorava
i suoi pettorali, era di un blu slavato. La D di Dio non era
più visibile. Una brutta ferita d’arma bianca l’aveva
cancellata in modo più definitivo di quanto avrebbe saputo
fare un professionista. Un altro profondo sfregio sottolineava
la parola “Padrone”. Sul grasso del braccio destro
era disegnata una moneta con l’immagine della Seminatrice.
«Né Dio né Padrone», sospirò
l’ispettore. «Non molto originale per un anarchico».
«E stupido, soprattutto», dissi. «Anche se
ero più giovane di lui, e di parecchio, all’epoca
ero un ragazzino, ricordo di averlo rimproverato per esserselo
fatto».
«Non le piaceva lo slogan? Credevo che…».
«Non amavo, e continuo a non amare, i tatuaggi. Bisogna
essere imbecilli per farsi tatuare».
«Oh! Lo sono spesso anche i re!».
«Una cosa non nega l’altra. E poi, i re hanno la
pappa pronta. Possono concedersi qualsiasi fantasia. Mentre…
Cerchiamo di capirci, ispettore, non era esattamente un santo,
per lo meno non del genere che viene abitualmente venerato…».
Tirai su il lenzuolo fino alla calvizie quasi oscena del cadavere.
Il guardiano in casacca grigia completò l’opera
con un gesto preciso e meticoloso, quasi materno.
«… Anche se non era apertamente favorevole all’illegalità,
Lenantais non era nemmeno del tutto contrario», proseguii.
«Prima che lo conoscessi era stato coinvolto in una storia
di banconote false. Ecco perché ho fatto riferimento
alle sue impronte. Ad ogni modo, era stato al fresco, vero?»
«Esatto. Si è preso due anni».
«Quando l’ho conosciuto era tranquillo e, glielo
ripeto, anche se non si dichiarava apertamente a favore dell’illegalità
perché non voleva fare proselitismi, la questione non
era risolta, si capiva che, presto o tardi, l’illegalismo
lo avrebbe sedotto di nuovo. E io pensavo che quando uno è
destinato a entrare in aperto conflitto con la società
non deve esporsi e attirare inutilmente l’attenzione.
I mezzi di identificazione dei recidivi sono già sufficientemente
numerosi. Inutile fornirne dei supplementari ai poliziotti».
I1 guardiano spalancò gli occhi rotondi. L’ispettore
rise:
«Benissimo! Vedo che, malgrado la giovane età,
dava già ottimi consigli!».
Gli feci eco. A ciascuno il suo turno:
«Ho conservato questa qualità”.
«Bene, e dove ha conosciuto questo fuorilegge?».
«Non lontano da qui. Anche questo è buffo, no?
In trent’anni non si può dire di aver fatto molta
strada. L’ho conosciuto al Centro vegetaliano di rue de
Tolbiac».
«…riano. Voleva dire vegetariano».
«No, vecchio mio. Ma cosa vi insegnano a scuola? Vegetaliano.
I vegetariani non mangiano carne, ma si concedono uova e latticini.
I vegetaliani invece mangiano, mangiavano, almeno quelli che
ho conosciuto io, non so se ne esistano ancora, esclusivamente
vegetali, con appena un filo d’olio di oliva per condirli.
E nemmeno loro erano dei puri. Ce n’era uno che sosteneva
che l’unico modo accettabile di consumare l’erba
era brucarla a quattro zampe in un campo».
«Ma dice sul serio? Che mondo!».
«Sì, uno strano mondo. Ho passato la vita a circondarmi
di fenomeni. Ne ho una bella collezione nei miei ricordi».
Puntò l’indice verso il corpo rigido:
«E Lenantais? Sappiamo che non fumava, non beveva, non
mangiava carne. Era anche lui un pazzo di quel genere?».
«No. Cioè, ai vostri occhi potrebbe anche sembrare
un pazzo, ma di un’altra categoria. Le racconto un episodio.
C’è stato un periodo in cui era quasi un barbone.
Anzi, senza il quasi. Viveva alla bell’e meglio…».
«Rubacchiando qua e là?».
«Non credo. Oppure visitava solo negozi da fame, perché
non mangiava tutti i giorni. Ora, a quell’epoca era tesoriere
di una piccola organizzazione. Gli avevano dato l’incarico
prima che si riducesse in miseria…».
«Capito. Ha sgraffignato il malloppo?».
«No, appunto. C’erano cento o duecento franchi in
cassa. Era il 1928 e allora erano una discreta somma. Gli altri
se ne erano fatti un vero e proprio cruccio e non osavano parlarne,
pensando, come lei, che lui se ne fosse accaparrata sicuramente
una parte. E invece no! Restava giorni senza mangiare accanto
a quel malloppo senza toccarlo. Erano i soldi degli amici, dell’organizzazione.
Ecco che tipo di uomo era Albert Lenantais quando l’ho
conosciuto».
«Insomma, un malfattore onesto!», ironizzò
l’ispettore.
A dieci gradi sottozero
di Léo Malet
Tornò a sedersi sullo sgabello. Poco dopo l’adolescente
raggiunse il proprio letto e vi si distese. Da dove si trovava,
con le mani incrociate sotto la nuca, poteva vedere la sveglia.
Alle quattro sarebbe dovuto andare al lavoro. Maledetta neve!
Se fosse caduta fitta come il giorno prima non sarebbe stato
per niente piacevole vendere i giornali sotto la burrasca, ma
bisognava pur mangiare. Non doveva lasciarsi abbattere come
lo spagnolo. No, non doveva. «Albert Lenantais sembrava
disapprovarmi», pensò l’adolescente, «quando
ho parlato di viaggiare senza biglietto». E però…
se quello che si raccontava era vero, il Ciabattino aveva fatto
due anni di prigione per complicità con dei falsari.
L’adolescente si sorprese a porsi delle domande su Lenantais,
detto il Ciabattino, detto Liabeuf. Cosa che si rimproverò
l’istante dopo. Tra anarchici non si fanno domande. L’adolescente
smise di fissare le lancette della sveglia, si sistemò
sul letto e abbracciò con lo sguardo l’intera fila
di miseri letti. In fondo alla stanza, tre uomini quasi mescolavano
le loro opulente capigliature per discutere aspramente un punto
delicato di argomento sociobiologico. Più vicino, steso
sul letto, sognante, calmo e solitario, un giovane fumava beatamente
una pipa dal lungo cannello. Lo chiamavano il Poeta, ma nessuno
aveva mai letto i suoi versi. Sotto le coperte, lo spagnolo
si agitava. Il suo vicino russava protetto da un manifesto che
annunciava per la sera stessa, alla Casa dei Sindacati, boulevard
Auguste-Blanqui, la seduta del «Club degli Insorti».
Argomento trattato: Chi è il colpevole? La Società
o il Bandito? Oratore: André Colomer. Quello che russava
aveva passato la notte, con un bicchiere di latte in pancia
come unico viatico, a incollare quei manifesti in tutto l’arrondissement,
a dieci gradi sottozero, e da bravo attacchino clandestino si
era preso cura di strappare un angolo di ogni manifesto, per
ingannare la polizia, per farle credere che in quel brandello
scomparso, verosimilmente strappato da vandali, fossero stati
apposti i sigilli obbligatori. Il suo armamentario, un secchio
da marmellata da cui emergeva il manico di un pennello, riposava
alla testa del letto, accanto a uno zaino vuoto e a una cassa
straripante di giornali.
 |
Mancanza di sincerità
di Léo Malet
«Ma lascia perdere, Lacorre», intervenne Lenantais
senza muoversi dalla sua postazione, senza nemmeno sollevare
gli occhi dal volantino che stava leggendo. «Lascia perdere.
Cosa vuoi che faccia? Ti credi forse più anarchico di
lui?».
La sua voce era fredda, tagliente come una lama. Lenantais non
amava Lacorre. Sentiva istintivamente, sotto gli eccessi verbali,
una mancanza di calore interiore e di sincerità.
«Certamente», rispose l’altro.
Lenantais abbandonò il volantino:
«Mi domando se tu sappia anche solo lontanamente cosa
significhi. È bello arrivare un giorno e dire “Sono
un compagno”. È molto bello, semplice e facile.
Da noi chiunque può entrare e uscire come vuole. Non
si fanno domande a chi si presenta».
«Ci mancherebbe altro!».
«Ciò non significa che secondo me un anarchico
sia un’altra cosa, ecco tutto».
«Spiegamelo allora!».
«Non ho tempo da perdere».
«In ogni caso», disse Lacorre, «un anarchico
che ha il senso della dignità non adotta un’attitudine
passiva e rassegnata come questo giovanotto. Non si abbassa
a vendere questa robaccia borghese. Si difende, se la cava,
si mette a rubare…».
«Eccoci al punto!».
«Esattamente!»
«Sono tutte stronzate! Ognuno è libero di fare
la vita che vuole purché non offenda in nulla la libertà
dei compagni. Lui vende i giornali. Tu simuli incidenti sul
lavoro. Siamo tutti liberi…».
«Se gli illegalisti…».
Lenantais si alzò:
«Gradirei non essere seccato con l’illegalismo e
la riconquista individuale», articolò. (Il naso
di traverso fremeva). «È un argomento vietato agli
incapaci che simulano incidenti sul lavoro e sudano di paura
all’annuncio di una visita di controllo nella sede dell’assicurazione.
Fino a quando non hai assalito un esattore, devi solo chiudere
il becco. Parlare! Parlare! Ne ho conosciuti anche troppi di
questi teorici bravi a parlare che però restavano tranquilli
a casa loro mentre altri poveri coglioni passavano all’azione
e si facevano beccare».
«Soudy, Callemin, Garnier…», cominciò
Lacorre.
«Hanno pagato», l’interruppe Lenantais. «Hanno
pagato due volte. Hanno pagato e io li rispetto. Ma tu, se li
avessi capiti almeno un po’, se avessi capito quanto erano
superiori a un semplice furfante come te, non li offenderesti
con i tuoi omaggi».
Lacorre si imporporò:
«Per parlare così hai forse assalito anche tu un
bancario?».
«Anch’io ho pagato. Mi sono beccato due anni di
prigione per aver falsificato del denaro, i compagni te lo possono
raccontare. Non ne vado assolutamente fiero, ma mi sembra un’altra
cosa rispetto ai finti incidenti sul lavoro».
«Non continuerò così per sempre»,
gridò Lacorre. «Un giorno mi ci butterò
davvero e vedrete di cosa sarò capace. Lo farò
ruzzolare anch’io un esattore».
«Oh! Non ne dubito», lo canzonò Lenantais.
«Mi stupirebbe se tu non riuscissi a fare una cosa così
intelligente. E quando avrai fatto fuori uno di quegli imbecilli
che portano in giro delle fortune in cambio di un tozzo di pane,
finirai in galera o salirai alla ghigliottina, senza nemmeno
aver avuto il tempo di comprarti un cappello con il ricavato
del colpo. Io ci tengo alla mia vita. E non mi sorride affatto
l’idea di dispiegare la mia individualità tra quattro
assi o in galera. L’ideale, vedi…». (Si mise
a ridere). «… sarebbe assalire un esattore senza
spargimento di sangue e senza che la cosa si venga a sapere,
e vivere di quella fortuna acquisita in modo disonesto, ammesso
che esistano fortune che non siano state acquisite in modo disonesto,
nella totale impunità. Ammetto però che un progetto
del genere non è per niente facile da realizzare».
Lacorre alzò le spalle con uno sguardo di pietà:
«Direi di sì. Queste sono fesserie. E grosse anche.
Mi fanno venire il mal di pancia!».
Si alzò e si avviò verso l’uscita. Furioso,
sbatté la porta dietro di sé. Il suo interlocutore
rise piano e, siccome la notte iniziava ad allungare dappertutto
le sue ombre, andò a manovrare un interruttore. Qualche
lampadina anemica, fissata al soffitto dell’ampia sala,
diffuse una luce giallastra. Lenantais tornò a sedersi
accanto alla stufa. Gli uomini dai capelli lunghi continuavano
a discutere a voce bassa, troppo assorti nel loro dibattito
per interessarsi a ciò che aveva visto opporsi –
ancora una volta – Lenantais a Lacorre. Il Poeta aspirava
silenziosamente dalla pipa. L’adolescente si dedicava
ai propri calcoli. Lo spagnolo e l’attacchino dormivano.
Brani tratti da: Léo Malet, Nebbia sul ponte di
Tolbiac, Fazi Editore, Roma, 2002.
Una specie riconoscibile
di E. Armand
Della solidarietà imposta
L’uomo è un essere socievole e l’individualista
che fa parte del genere umano non fa eccezione alla regola.
L’essere umano non è socievole per puro caso, poiché
la sua organizzazione o costituzione fisiologica lo costringe
a ricercare, per completarsi, per riprodursi, uno dei suoi simili
di sesso diverso. In linea di massima, si può pertanto
costatare che gli uomini praticano la sociabilità senza
riflessione o sotto la minaccia di una violenza: a scuola, in
caserma, più tardi all’officina, essi vivono una
gran parte della loro esistenza in comune con degli individui
verso i quali nessuna simpatia li spinge; nelle grandi città,
dimorano in immensi edifici, altra specie di caserme, uscio
a uscio con dei vicini ai quali non li unisce alcuna affinità
intellettuale o morale. Sovente, si sposano anche senza conoscersi,
senza avere alcuna conoscenza dei rispettivi bisogni.
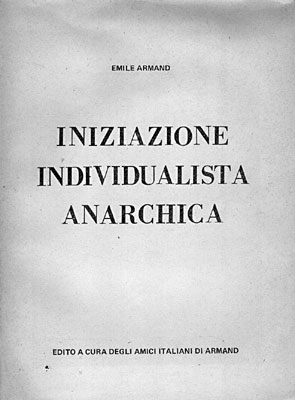 |
Gli individualisti anarchici considerati come “una
specie”
Ora, è appunto questo che non vuole l’individualista
anarchico. Egli non intende essere schiavo della sociabilità
imposta, più di quanto intenda mettersi sotto il giogo
della solidarietà forzata. Egli potrà associarsi
ai suoi compagni, agli individualisti, a quelli del «suo
mondo», della «sua specie». «A quelli
della sua specie» è proprio la espressione adatta,
giacché non è possibile negare che gli individualisti
formino, in mezzo al genere umano, una specie riconoscibile
da delle caratteristiche psicologiche ben determinate. Gli individui
che, scientemente, ripudiano le dominazioni e gli sfruttamenti
di ogni specie, vivono o tendono a vivere senza idoli o padroni:
cercano di riprodursi in altri esseri al fine di perpetuare
la loro specie e di continuare la loro fatica intellettuale
o pratica, la loro opera di emancipazione e, insieme, di distruzione:
codesti individui formano bene una specie a parte, nel genere
umano, una specie assai differente dalle altre specie di uomini,
così come, nella specie canina, il terranova differisce
dal botolo.
Intendiamoci bene: non si tratta già di fare dell’individualista
anarchico un “superuomo” fra gli uomini, più
di quanto non si tratti di fare del terranova un “supercane”
fra i cani. Esiste pertanto una differenza: il terranova è
un tipo fisso che non evolverà; il tipo individualista
evolverà. Esso compie nel genere umano, la funzione esercitata
dalle specie dei veggenti e dei precursori nella evoluzione
degli esseri viventi. Si può anche assimilarlo a quei
tipi meglio dotati, più vigorosi, più atti alla
lotta per la vita, che appaiono ad un certo momento in seno
ad una specie e finiscono con determinare il divenire di questa
specie. Con le loro imperfezioni, le loro manchevolezze, i loro
errori, gli individualisti anarchici, costituiscono, noi pensiamo,
allo stato latente il tipo dell’uomo futuro: l’individuo
dallo spirito libero, dal corpo sano, dalla volontà educata,
pronto all’avventura, disposto all’esperienza, vivente
pienamente la vita, ma che non vuole essere un dominato più
che un dominatore.
Il «mutuo appoggio» nella specie. Il cameratismo
L’individualista non è, dunque, un isolato nella
sua specie. Fra di loro gli individualisti praticano il «cameratismo»:
come tutte le specie in costante pericolo d’essere attaccate,
essi tendono istintivamente alla pratica del «mutuo appoggio
nella specie». Ritorneremo più tardi su talune
delle forme che può assumere questo «mutuo appoggio».
Comunque, esso tende alla scomparsa della sofferenza evitabile
nella specie: non è un compagno chiunque tenda, al contrario,
a prolungare o ad aumentare la sofferenza dei propri compagni.
L’individualista incita colui che vuol procedere con lui
a ribellarsi praticamente contro il determinismo dell’ambiente
sociale, ad affermarsi individualmente, a forgiare la propria
personalità interiore, a rendersi quanto più possibile
indipendente da tutto l’ambiente morale, intellettuale,
economico che lo circonda. Egli spingerà l’ignorante
ad istruirsi, l’indolente a reagire, il debole a diventar
forte, il supino a raddrizzarsi. Egli indurrà coloro
che sono male dotati ed i meno atti a trarre soltanto da loro
stessi tutte le risorse possibili, ed a non fare assegnamento
su gli altri.
Brani tratti da: Emile Armand, Iniziazione individualista
anarchica, Firenze, 1956.
|