|
Anarchici a Pisa
Una città proletaria. Con questo bel titolo
esce nel 1989 un romanzo dello scrittore Athos Bigongiali (A.
Bigongiali, Una città proletaria, Palermo, Sellerio,
1989) completamente incentrato sulle caratteristiche anarchiche
e libertarie profondamente connaturate alla città di
Pisa. Ambientato nei primi decenni del secolo, quando fioriscono
le lotte e le iniziative popolari intese a migliorare le condizioni
di vita e di lavoro del proletariato pisano, forte e combattivo
come non mai, il romanzo, mantenendosi abilmente sullo spartiacque
fra narrazione e ricerca storica, ricostruisce con tratti suggestivi
le vicende dei numerosi personaggi, donne, uomini, intere famiglie
di compagni, che segnarono quel periodo con il loro impegno
sociale. Nel raccontare le lotte alla Saint Gobain e nelle numerose
fabbriche pisane, le battaglie contro l’influenza clericale
e per la libertà di pensiero, le polemiche fra interventisti
e antimilitaristi allo scoppio della Grande Guerra, l’autore
descrive un mondo affascinante ed eterogeneo, costellato di
protagonisti dai nomi improbabili. Pompeo, Pirro, Acratica,
Nilo, Sguardo, Jessa, Selica, Catullo, Gusmano, Priscilla, Ricciotti,
Germinal … nomi che esprimono lo spirito anticonformista, ribelle
e schiettamente anticlericale del popolo pisano, che con proletaria
fantasia manifesta la propria estraneità all’ordine costituito
anche nel rifiuto di chiamare i figli con i nomi canonici di
santi e beati.
Fra i tanti protagonisti di quel periodo così significativo
della vita sociale della città toscana, intendo qui ricordare
due personaggi ampiamente citati nel romanzo e le cui biografie,
tanto simili quanto diverse, procedono per lunghi tratti sul
percorso parallelo della lotta di classe e dell’affermazione
dell’ideale anarchico. Una è l’operaia Jessa Fontana
(1883-1961), che nella sua lunga e interessante esistenza non
si è mai mossa dalla città natale, l’altro è
Augusto Castrucci (1872-1952), che da semplice ferroviere è
diventato uno dei più stimati esponenti sindacali del
secolo trascorso. Della prima ben pochi hanno sentito parlare,
del secondo ci si è interessati con l’attenzione che
meritava solo negli ultimi anni. Entrambi hanno dato un contributo
determinante a favore di quella classe lavoratrice alla quale
tanto orgogliosamente, e consapevolmente, appartennero.
Nata a Pisa nel 1883, Jessa appartiene a una delle tante famiglie
anarchiche della città in riva all’Arno. Il padre Ettore
e la madre Priscilla Poggi sono due attivi militanti del movimento
libertario come del resto gli altri figli, Severo, Vasco e Selica.
A soli 14 anni Jessa è già in grado di dare il
proprio contributo all’anarchismo, tanto che viene segnalata
dalla questura per la partecipazione alle manifestazioni anticlericali
e per la costante presenza nella Camera del lavoro. Il suo primo
arresto, e conseguente condanna a due mesi di carcere per “istigazione
a delinquere”, risale al 1901. Frequenta assiduamente gli ambienti
sovversivi portandovi con determinazione il suo entusiasmo e
il suo desiderio di lottare. In fabbrica è sempre fra
gli elementi più battaglieri ed esempio costante per
le sue compagne di lotta. Dopo alcuni anni di convivenza, di
“libero amore” come orgogliosamente lo si chiamava, nel 1910
si unisce in matrimonio con l’anarchico Giuseppe Pieroni, e
dalla loro unione nasceranno Elso e Unico, anch’essi poi attivi
nel movimento anarchico. Frequenta gli ambienti de “L’Avvenire
anarchico”, il combattivo settimanale pisano che per anni sarà
un importante foglio di lotta, propaganda e riflessione teorica
a livello nazionale. Si spegne a Pisa nel giugno del 1961.
Augusto Castrucci nasce a Pisa nel 1872. Segnalato come anarchico
nel 1891, entra ben presto in ferrovia e aderisce alla Lega
Ferrovieri nel 1897, il primo organismo sindacale di categoria.
Stimato rappresentante fra i compagni di lavoro, nel corso dello
sciopero generale dei ferrovieri è uno degli elementi
più in vista della combattiva categoria, e come tale
viene fatto oggetto di particolari attenzioni poliziesche. Dopo
la fondazione del Sindacato Ferrovieri Italiani, dà vita
nel 1908 al glorioso giornale “In marcia!” di cui diventa direttore
e uno dei più assidui collaboratori. Negli anni convulsi
segnati da frequenti lotte e agitazioni e dai diversi orientamenti
all’interno del sindacato sull’adesione o meno alla CGdL, Castrucci
dapprima propende per l’autonomia sindacale per poi avvicinarsi,
dopo la “settimana rossa” all’Unione Sindacale Italiana, con
la quale condivide il maggiore slancio rivoluzionario che la
contraddistingue. La partecipazione al movimento sindacale non
lo allontana dall’attività nel movimento specifico, e
infatti lo troviamo presente al I congresso anarchico italiano
tenutosi a Roma nel 1907 e al convegno nazionale di Pisa nel
1915 dove si “riafferma l’avversione irriducibile degli anarchici
nei confronti di ogni conflitto”. Anche nel dopoguerra, durante
il “biennio rosso”, Castrucci è fra gli elementi di punta
fra i compagni di lavoro, non solo per le capacità organizzative
ma anche per la stima e la fiducia che lo circondano. Continua
a sostenere la necessità di mantenere il SFI autonomo
dalla CGdL e questo naturalmente non gli attira le simpatie
né dei socialisti riformisti né dei comunisti
“rivoluzionari”. Dopo aver subito una violentissima aggressione
fascista a Pisa nel 1922, si trasferisce a Milano e l’anno successivo
viene esonerato dal servizio per rappresaglia. Mantiene comunque
la direzione di “In marcia!” fino alla cessazionedelle pubblicazioni
nel 1926. Durante il fascismo subisce denunce, fermi, arresti
e confino, persecuzioni che continuano fino al 1944. Caduto
il fascismo riprende il proprio posto nel Sindacato di categoria,
diventandone poi Segretario generale onorario. Muore a Milano
nel 1952, all’età di 80 anni, lasciando nei compagni
il ricordo di una figura integerrima.
 Massimo Ortalli
Massimo Ortalli

Bibliografia
Su Castrucci si vedano
A. Castrucci, Battaglie e vittorie dei Ferrovieri italiani.
Cenni storici dal 1877 al 1944, Milano, La Prora, 1945,
ristampato nel 1988 da Edizioni Zero in Condotta di Milano;
E. Ordigoni, (a cura di), 80 anni di storia dei macchinisti
attraverso la rivista “in Marcia”, Firenze, Ancora In Marcia!,
1988; Aa.Vv., Il Sindacato ferrovieri italiani dalle origini
al fascismo 1907-1925, a cura di M. Antonioli e G. Checcozzo,
Milano, Unicopli, 1994; G. Sacchetti, Il Sindacato ferrovieri
italiani dalla “settimana rossa” alla grande guerra, in
Aa.Vv., Il Sindacato ferrovieri italiani dalle origini al
fascismo, cit.; M. Antonioli, Il sindacalismo italiano.
Dalle origini al fascismo, Pisa, BFS Edizioni, 1997; C.
Ferrari, La vita del macchinista Augusto Castrucci, in
G. Sacchetti, C. Ferrari, M.C. Cabassi, Ricordo di uomini
e lotte del 900, Firenze, ancora in marcia!, 2000.
Su Pisa proletaria e anarchica
F. Bertolucci, Anarchismo e lotte sociali a Pisa 1871-1901,
Pisa BFS Edizioni, 1988; A. Marianelli, Movimento operaio,
forme di propaganda e cultura sovversiva a Pisa tra ’800
e ’90, Pisa, BFS Edizioni, 1990; F. Bertolucci (a cura di),
La Camera del lavoro di Pisa 1896-1922. Atti e documenti,
Pisa, Camera del Lavoro, 1990; Id., Gli anarchici pisani
e la costituzione dell’Unione Comunista Anarchica Italiana,
relazione inedita presentata al Convegno di Studi L’esperienza
dell’Unione Anarchica Italiana dal Biennio rosso alle leggi
eccezionali (1919-1926), Imola, 10 ottobre 1999 (da cui
traggo le notizie biografiche su Jessa Fontana); Aa.Vv. Galilei
e Bruno nell’immaginario dei movimenti popolari tra otto e novecento,
a cura di F. Bertolucci, Pisa, BFS Edizioni, 2001.
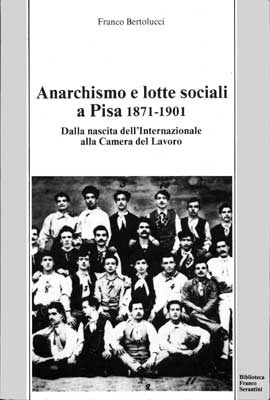
I cavalieri erranti
di Athos Bigongiali
6. Il delegato di polizia che nel maggio del 1905 compilò
i cenni particolari della schedatura del ferroviere Augusto
Castrucci non immaginò certo di aver affidato ai riposti
archivi dello Stato l’ elogio dell’anarchismo pisano.
Il Castrucci aveva all’epoca ventisette anni, moglie e cinque
figli: Spartaco, Bruno e Germinal i maschi; né poteva
mancare, tra le bambine, una Tosca.
Già nella descrizione fisionomica il delegato si diffondeva
sugli accattivanti tratti dei baffi arricciati e la barba alla
Nazareno, le spalle quadrate, l’andatura dinoccolata, lo sguardo
ardito. Addentrandosi nella di lui personalità egli segnalava
poi la ‘pronta e sveglia intelligenza’ e la felice frequentazione
della scuola d’arte e mestieri, malgrado il mai abbastanza contestato
‘contegno sprezzante verso l’Autorità’.
L’‘influenza’ del Castrucci tra i compagni di partito e gli
impiegati delle Ferrovie si ‘estendeva anche ad altre città
del Regno’ fino a diventare ‘influentissima anima direttiva’
quando si trattava di sottolinearne il ruolo nei vari Comitati
di agitazione e di resistenza: del resto era grazie all’arte
oratoria e al ‘fascino che esercita sul personale’ che egli
riusciva sempre ad ottenenerne la ‘completa astensione dal lavoro’.
Cosa ha voluto dirci, il delegato, con queste lusinghiere parole?
È azzardato supporre che abbia voluto compiere un bel
gesto, un cavalleresco present’arm alle qualità del nemico?
È probabile che egli non avesse di tali pretese, e dunque
fosse del tutto inconsapevole della gaffe che stava consegnando
agli archivi della storia. Dopotutto appena pochi anni prima
un anarchico di altrettanto fiero e bell’aspetto aveva ucciso
il Re d’Italia.
Eppure lo specchio dell’ignoto poliziotto riflette un ‘immagine
non inconsueta. Non era forse Ruffo Sarti, che estrasse per
primo il revolver nel non voluto duello con il brigadiere G.
M., un giovane ‘ardito, colto e intelligente’? E Pompeo Scipione
Barbieri un ‘conferenziere autodidatta’ ma tanto trascinante
coi suoi ‘molti argomenti’ da richiedere ogni volta al Commissario
di turno la spiccia interruzione del suo dire? E Gino Del Guasta
non possedeva, con l’innata bontà prodiga di ‘vasta e
buona fama nell’opinione pubblica’ il dono dell’alata parola?
« Il movimento anarchico è politica » scriverà
pochi anni più tardi Antonio Gramsci «solo perché
nella società attuale tutto diventa politica. Il movimento
anarchico è una tendenza dello spirito umano come tale
(dei borghesi e dei proletari)...».
È il destino contro il quale, più o meno coscientemente
lottavano i libertari pisani.
Nella incerta Pisa del primo Novecento la lotta dell’anarchismo
per farsi politica e storia scandisce, nelle scomposte e irripetibili
forme che le furono proprie, i primi veri passi della città
verso un sentire collettivo.
Il complicato gioco degli specchi e del tempo – da cui
hanno origine i miti e le leggende – offre alla nostra
memoria storica la facoltà di ordinare logicamente la
vicenda altrimenti davvero casuale di Augusto Castrucci e del
suo ignoto elogiatore. Costui intingeva la penna inconsapevole
in un inchiostro che gli dettava le parole; ed esse sono oggi
la visibile traccia di un potente immaginario locale, di un
sogno che umanamente la città sognò.
C’è del vero nella leggenda, ormai dimenticata, dei «cavalieri
erranti».
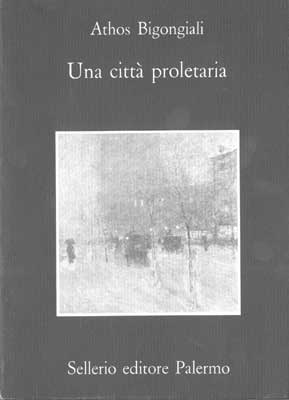
Capitolo sesto
1. A.C.S./C.P.C. 2108 - Fontana Jessa. Di Ettore e Poggi
Priscilla, nata a Pisa il 18 giugno 1883, abitante in via Livornese
183, operaia, nubile, anarchica.
Nell’opinione pubblica riscuote cattiva fama per le idee sovversive
che professa. È di carattere docile. Ha una discreta
educazione e pronta intelligenza... frequenta le persone del
partito anarchico e specie l’anarchico Mazzoni Virgilio di questa
città. È stata portabandiera della Camera del
Lavoro di Pisa. Ha influenza nel partito ma è circoscritta
dove risiede… È accanita propagandista tra le persone
del partito e ottiene qualche profitto. Non è capace
di tenere conferenze ma ha parlato diverse volte in pubblico...
leggendo scritti di compagni di partito. Ha preso parte alla
manifestazione del 25 agosto 1901 in occasione dell’ anniversario
di Giordano Bruno e di tutti i comizi pubblici e privati tenutisi
a Pisa dal marzo 1901 ad oggi... Risulta pericolosa.
«Compiango coloro che sono preposti a compilare le schedature
di noi anarchici. Il mestiere che fanno opprime il loro umano
istinto, e talvolta i loro stessi sensi. Così talvolta
può succedere che costoro sappiano tutto di noi, senza
sapere nulla. Può succedere che essi guardino senza vedere.
«Nel 1903, quando è stata scritta la mia scheda,
io avevo vent’anni, e le stesse speranze e volontà che
ho adesso – 1908. Dicono che frequentavo la casa di Virgilio
Mazzoni: lo dicono come fosse una colpa, per malignare sulla
nostra concezione del libero amore. E invece in quella casa
io incontravo Pasquale Binazzi e sua moglie Zelmira, Pietro
Gori e la Bice: lì ho imparato a comporre le frasi secondo
un ordine logico, in modo che divenisse più chiaro lo
scopo dello scritto e quindi più convincente. Ora sono
io che posso preparare conferenze per altri. Ma il delegato
che registrava le entrate e le uscite a casa Mazzoni “doveva”
pensare che ce ne stessimo con le mani in mano, ad amoreggiare,
o a fantasticare e inventare attentati, magari contro il nuovo
Re o contro il direttore della Saint Gobain. Egli non si preoccupava
del fatto che i miseri operai della Vetraria, dopo tre mesi
di sciopero, avevano deciso con 272 sì e solo 3 no il
proseguimento ad oltranza dello sciopero. Egli non pensava che
“quello” era a quei tempi il nostro attentato preferito.
«Quel 1903 è stato tremendo. Da chi, come me, aveva
passato il Natale e il Capodanno in carcere niente poteva essere
paragonato, malgrado il freddo che di febbraio e marzo a Pisa
gela i piedi, alle ritrovate camminate sui lungarni e nel tardo
pomeriggio sul fosso a parlare coi navicellai. Quando ero più
piccola quella prua dove le famiglie dormivano mi pareva un
nido tanto era calda, poi crescendo ho preferito rinunciare
agli inviti, anche di compagni: purtroppo non mancano nemmeno
in un rione proletario i cattivi interpreti del libero amore.
«Quell’anno abbiamo fatto i conti con la politica: ho
visto con i miei occhi quanto è degradante per il nostro
fermo ideale accettarne le regole. Se avessimo avuto la convinzione,
e la forza, di dichiarare lo sciopero generale, forse la Saint
Gobain avrebbe ritirato le sue pretese galeotte. Noi abbiamo
avuto paura per le paghe di altri poveri proletari; insomma
non eravamo pronti.
«Noi ragazze – Selica ed io – passammo molte
sere di quella estate sul fosso a parlare. Tutti i giorni qualcuno
che conoscevamo finiva in prigione: come ci sembrava lontana
l’anarchia e lontani la fratellanza e l’amore universali!
«Amina, la nostra cuginetta, ci faceva piangere con le
sue canzoni: guardandola, lei così piccola e così
innocente, mi sentivo oppressa da tutta l’ingiustizia del mondo
e non riuscivo, come avrei dovuto, a “dare l’esempio” che ci
raccomandava nostra madre. Quando pioveva, parlavamo in casa
al buio, per risparmiare la candela ».
da Una città proletaria di Athos
Bigongiali, Sellerio editori, Palermo 1989, pagg. 83-88.
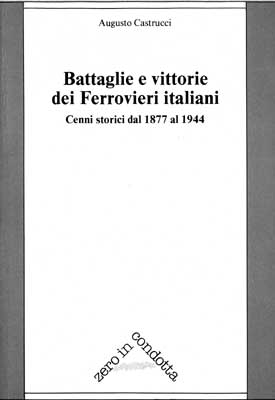
Alleanza del lavoro e
sciopero “legalitario”
di Augusto Castrucci
Fu verso il 1921-1922 che ad uno ad uno cadevano i fortilizi
operai, dopo che Cooperative, Camere del Lavoro, Sezioni del
Sindacato Ferrovieri o comunque organismi proletari, venivano
distrutti, incendiati dalle camicie nere, che per arginare tanta
cieca e brutale furia omicida e devastatrice, sorse l’«Alleanza
del Lavoro».
L’«Alleanza» era costituita dalla «Confederazione
Generale del Lavoro» dalla «Unione Sindacale Italiana»,
e dal «Sindacato Ferrovieri», dalle «Federazioni
dei Lavoratori del Mare e dei Porti» e dai partiti politici
di avanguardia.
Un organismo, dunque, numericamente potente di qualche milione
di organizzati...
Pensiamo oggi, come pensavamo allora, che sarebbe stato sufficiente
che l’«Alleanza» esortasse, invitasse gli organizzati
a munirsi ciascheduno di un forte e nodoso «randello»
da contrapporsi all’omicida «manganello» perché
tanti lutti e tanta rovina venissero risparmiati all’Italia
proletaria e perché venisse fugato l’ambizioso sogno
dell’avvento del regime fascista.
Ma questo non si volle e non si fece; si volle invece perseverare
nel metodo e nell’azione «legalitaria». Non è
compito di quest’opuscolo mettere in rilievo l’assurdo e l’inanità
di questo metodo, ed attardarci a polemizzare su questo pietoso
quanto tragico argomento!
Passiamo dunque ad altro, passiamo allo sciopero generale ordinato
dall’«Alleanza del Lavoro», sciopero che passò
poi alla storia col nome di Legalitario! e che ebbe luogo –
come ebbe luogo... – il l° e 2 agosto del 1922.
Intanto, possiamo affermare che i dirigenti dell’«Alleanza»
avevano diramato l’ordine di sciopero, in tutta Italia, basandosi
su di un fatto che avrebbe dovuto avvenire, ma che in realtà
non avvenne!
E questo fu il grave errore e la grande responsabilità
che grava sui massimi organizzatori di detto organismo e che
decise Mussolini di «serrare i tempi» per gettare
il proletariato italiano nella più imbelle ed ignobile
schiavitù morale, materiale, politica e sindacale!
Sicuro, sta di fatto che, secondo i dirigenti dell’«Alleanza»
avrebbe dovuto accadere questo:
«Che i fascisti della Toscana, a mezzo di treni straordinari,
si sarebbero riversati su Sarzana, per commemorare i loro morti
caduti nei conflitti coi sovversivi il 1° agosto del 1921,
e per compiere le loro spietate rappresaglie, si procedeva dunque
ad una strage di sovversivi, in grande stile, un mare di sangue...
Si diceva che capo ed esponente di queste milizie, in camicia
nera, fosse il ben noto Amerigo Dumini».
Cosa avvenne, invece? Che i treni speciali non furono effettuati,
che l’adunata a Sarzana non ebbe più luogo, che il mare
di sangue non vi fu, che il sentimento d’orrore, di esecrazione,
di appassionata protesta che avrebbe dovuto pervadere non solo
i proletari sovversivi ma tutta la Nazione, in quel fatale,
storico e sanguinoso 1° agosto... non ebbe più ragione
di essere!
Perché questo avvenne? Perché fu sospesa, soppressa
la sagra di Sarzana? Perché? Perché?!…
Oh! purtroppo, purtroppo; noi possiamo rispondere a tutti questi
suggestivi «perché»!
Perché qualcuno dell’«Alleanza» scientemente
tradì, o con condannabile leggerezza riferì a
qualche gerarca fascista, l’ordine di sciopero – che per
ovvie ragioni avrebbe dovuto restare segretissimo – diramato
dall’ Alleanza, sciopero che avrebbe dovuto effettuarsi il 1°
agosto, quale atto spontaneo e possente di condanna e di protesta
del Popolo italiano, per la eccezionale «spedizione punitiva»
compiuta su Sarzana, per il mare di sangue versato da proletari
italiani!
I gerarchi fascisti, spontaneamente ed anche facilmente, compresero
subito la grande importanza della... rivelazione diretta o casuale
ricevuta e diedero subito l’ordine della soppressione dei treni
speciali anzidetti; la sagra di Sarzana era rimandata...
Questo avvenne nel pomeriggio del 31 luglio e se anche l’Alleanza
fosse venuta a conoscenza che la spedizione punitiva su Sarzana
non avrebbe avuto più luogo, non avrebbe potuto, non
poteva affatto diramare un ordine perché lo sciopero
non venisse proclamato.
Così, pel tradimento, o per la inqualificabile leggerezza
di qualcuno, avemmo l’inevitabile catastrofe, che si ripercosse
poi sui fatali avvenimenti successivi.
Venuto l’ormai famoso 1° agosto, i ferrovieri, i lavoratori
italiani, senza entusiasmo, senza fede né convinzione,
né volontà, senza rendersi conto del «perché»
abbandonavano il lavoro, pur tuttavia l’abbandonarono, ma per
indurre specie il lavoratore italiano, a resistere, a sfidare
tutto e tutti, nell’atto di ribellione che compie, occorre,
è indispensabile che sia convinto, che sia conscio, che
apprezzi ed intimamente approvi quanto gli si ordina di fare...
Tutto ciò mancava affatto in quel tristissimo giorno
e quindi, specialmente nelle piccole città, dove non
c’è il grande agglomerato operaio per la mancanza di
grandi officine e stabilimenti e quindi difetta l’esempio e
l’aiuto solidale delle grandi masse organizzate, fu facile esercitare
un po’ di violenza... concentrata; fra poliziotti e fascisti
per indurre, in special modo i ferrovieri, a riprendere il lavoro!
da Battaglie e vittorie dei Ferrovieri italiani. Cenni
storici dal 1877 al 1944 di Augusto Castrucci, Zero in condotta,
Milano 1988, pagg. 59 - 61.

|