cultura
 Buddhismo
zen
fra osterie e bordelli «Ikkyu non è affare per deboli di spirito. Gli
osservanti del politicamente corretto, i rispettosi dei valori
costituiti farebbero bene ad astenersi. Meglio che a varcare
il limen di questa poesia sia solo chi è disposto
a correre il più temibile dei rischi, chi può
accettare di finire scaraventato nel malfermo territorio del
dubbio». In questa maniera esordisce l'introduzione di
Ornella Civardi, eccellente curatrice del volume Nuvole vaganti.
La raccolta di un maestro zen di Ikkyu Sojun, (Astrolabio
Ubaldini, 2012, pagg. 216, € 18,00) in cui sono antologizzati
centocinquanta componimenti poetici del monaco zen giapponese,
che, come una sorta di diario intimo, accompagnano l'indagine
e la ricerca interiore dell'autore lungo le varie tappe della
vita, dall'adolescenza alla vecchiaia.
Ikkyu Sojun! Chi era costui? Vissuto fra la fine del trecento
e la prima metà del quattrocento è considerata
come una delle figure più significative dello buddhismo
zen giapponese. Ad esempio Yasunari Kawabata – premio
Nobel per la letteratura nel 1968 – ebbe a definirlo come
«il più rigoroso e profondo dei maestri zen».
È infatti fuori discussione la sua importanza come innovatore
(seppur critico) e divulgatore della pratica zen, per non dire
del suo ruolo di animatore di un cenacolo culturale da cui sono
scaturite alcune fra le più elevate espressioni artistiche
del tempo. Per il lettore di “A” si può a
piena ragione aggiungere che Ikkyu trova adeguata collocazione
all'interno di quella categoria/non-categoria che va sotto il
nome di “anarchismo religioso”; intendendo quest'ultimo
non come l'adesione da parte di uomini di religione a un'ideologia
politica (l'anarchismo), bensì come l'espressione di
una sensibilità religiosa libera da dogmi e imposizioni.
Per riprendere alcuni versi di Ikkyu: «Secondo natura
è la condotta / più giusta e senza leggi: / La
saggezza di ieri / oggi è stupidità». O
ancora: «Verità innata / è una grande illusione.
/ Innata illusione / è la vera accezione». D'altro
canto Linji, il fondatore della scuola zen rinzai a cui apparteneva
lo stesso Ikkyu così insegnava: «Se incontrate
il Buddha, uccidetelo. Se incontrate un maestro uccidetelo».
(Ciò ha fatto dire a Hakim Bey: «Il commento di
Bakunin su Dio, che se esistesse dovremmo ucciderlo, dopo tutto
passerebbe come pura ortodossia all'interno dello zen buddhista»).
Una vita in cammino
Figlio illegittimo dell'imperatore Go Komatsu e di una dama
di corte proveniente da un'antica famiglia caduta in disgrazia,
andò a vivere sin da piccolo presso il tempio di Ankoku-ji,
a Kyoto, per essere iniziato alla vita monastica. Già
a quell'epoca il buddhismo zen aveva perso il contenuto delle
origini, scegliendo di adagiarsi in una profittevole istituzionalizzazione
in perfetta sintonia con l'establishment economico e
politico del tempo. I maggiori monasteri, che già si
trovavano in possesso di ingenti proprietà fondiarie,
si premuravano di accumulare nuove fortune svolgendo l'attività,
ampiamente remunerativa, del prestito a interesse. D'altro canto
le più alte cariche religiose venivano acquisite o per
lignaggio o per intrigo, tramite la complice approvazione del
governo. Se per divenire priore di un tempio era necessario
esibire un attestato di illuminazione, quest'ultimo si poteva
sempre acquisire pagando oppure attraverso particolari favori
o appoggi altolocati.
Ben presto Ikkyu insorge contro “i venditori di zen”
e contro ogni mercificazione dello spirito. Abbandona l'ambiente
raffinato ed estetizzante dell'Ankoku-ji, scegliendosi maestri
poveri e marginali. In seguito prediligerà lo stile di
vita del monaco itinerante, in contatto con il popolo e la natura,
alternando così i ritiri in qualche eremo malandato –
raccolto nella pratica meditativa, nella composizione di poesie
e nel lavoro della terra – all'immersione nella vita cittadina,
frequentando taverne e bordelli, infrangendo, uno dopo l'altro,
tutti i precetti della regola monastica, per dare in questo
modo forma compiuta a una personalissima accezione dello zen,
finalmente libera dai lacci e lacciuoli dei dogmi e delle convenzioni
sociali. Lascerà scritto: «A furia di coltivare
la testa / abbiamo smarrito il cuore».
Verso i settant'anni incontra una cantante cieca di un tempio,
di diversi decenni più giovane di lui, nei confronti
della quale nutre, ricambiato, una passione ardente in grado
di ridare nuova ricchezza alla sua vita, che volge ormai al
tramonto. In verità poteva ben accadere che un monaco,
infrangendo i voti, intrecciasse una relazione con una donna;
ciò veniva tollerato a condizione che la relazione restasse
segreta, salvaguardando così forme e apparenze. Per Ikkyu
invece la resa all'amore è assoluta: fuori da ogni ipocrisia
curiale e da ogni senso di colpa, egli canta l'amore come dono
straordinario lungo il cammino di senso compiuto dall'uomo nella
vita. Come in questa poesia: «La mia cieca la notte /
viene a sentirmi far poesia. / Sotto le coltri chiocciamo /
fitto fitto come due mandarine. / Sorgerà forse un giorno
/ un'alba di salvezza alle genti, / ma il decrepito dio che
ho dentro / già diffonde sul mondo la sua primavera».
Infine, a ottant'anni, un editto imperiale lo nomina priore
del Daitoku-ji, uno dei più importanti monasteri zen,
all'epoca distrutto a causa delle guerre che imperversavano.
Egli riuscirà, prima di morire, nel portare a compimento
la faticosa impresa di ricostruzione. Ai discepoli che l'avevano
seguito prima di morire lascerà detto: «Dopo che
me ne sarò andato, potrete ritirarvi sui monti o in un
bosco, oppure mettervi a bazzicare bordelli e osterie. In entrambi
i casi avete la mia benedizione. Ma quelli che pretenderanno
di possedere lo zen, di sapere la Via, quelli saranno i veri
impostori, i nemici della Parola».
Federico Battistutta
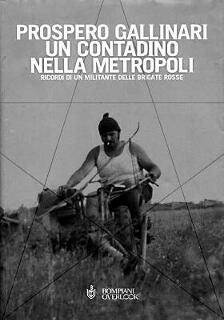 Ricordi
di
un militante Br (e contadino) Parlare in un libro di vicende politiche non è facile,
soprattutto se il libro in questione è la biografia di
un brigatista (Prospero Gallinari, Un contadino nella metropoli,
Bompiani, Milano 2006, pagg. 350, € 8,50).
Prospero Gallinari, recentemente scomparso nella sua Reggio
Emilia, è stato tra i fondatori delle Brigate Rosse e
militante delle stesse fino al fatidico anno 1988 nel quale
dichiararono definitivamente concluso il loro percorso politico.
Responsabile del sequestro Moro e di molte altre azioni che
gli valsero tre ergastoli, pena scontata con 17 anni di prigione
e in seguito, con l'aggravarsi delle sue condizioni fisiche,
con i domiciliari.
Avevo in mente già da diverso tempo di scrivere del suo
libro Un contadino nella metropoli e quando pochi giorni
fa ho appreso la notizia della sua scomparsa, questo desiderio
è divenuto una necessità. Prospero non lo ho mai
conosciuto di persona, e di questo mi rammarico, ma leggendo
il suo libro ho avuto modo di conoscere la sua vita, dalle origini
contadine rivendicate più volte con sincero orgoglio,
alla militanza politica con tutti i suoi retroscena. Certo l'approccio
con un libro di questo genere non è facile, quantomno
non lo è per me, c'è sempre il timore di trovare
falsature o omissioni riportate dall'autore, accompagnate da
pentimenti o da un ostinata retorica. Il libro di Prospero non
è nulla di tutto questo.
Ho conosciuto la vita di un uomo che ha vissuto come bracciante
nelle campagne reggiane, dove il fermento politico era forte
e ancora vivo era il ricordo della Resistenza tradita, il suo
impegno e la voglia di riscattarsi con la politica e in seguito
le delusioni, l'uscita dal Pci e la fondazione delle Brigate
Rosse.
La scelta della militanza armata, condivisa o no dal lettore,
non viene giustificata con ragionamenti e scuse ipocrite da
Gallinari, ma appare come un percorso della sua vita e del suo
impegno politico, lascia così che sia la sua storia a
giustificare tale scelta.
Interessante è la descrizione dell'organizzazione e della
gestione di tutte le “colonne” dislocate nella penisola,
l'importanza dell'appoggio esterno di alcuni membri e le vicende
che porteranno alla sua prima incarcerazione e in seguito alla
sua evasione. Nel libro non mancano alcune sue riflessioni e
dettagli descrittivi, che ci trasportano emotivamente nelle
vicende narrate, dai momenti più ironici a quelli più
tesi e intensi.
In conclusione, trovo questo libro un appassionante testimonianza
della vita di un uomo e allo stesso momento dell'Italia quegli
anni, lo consiglio a chiunque crede che ogni evento nella storia
sia frutto di un percorso e soltanto conoscendolo potremo dire
di averlo compreso e aver appreso da esso qualche insegnamento,
se dovessi descriverlo in una sola parola lo definirei onesto.
Ogni umano ha diritto alla sua Utopia.
Al libro di Prospero Gallinari è ispirata la canzone
Martino e il ciliegio del rapper reggiano Murubutu, vi
consiglio il suo ascolto.
Giuseppe Di Giulio
 Il
potere, i miti
noi stessi Quando fu firmato il Trattato di Maastricht, nel 1992, sapevamo
che stavamo consegnando le nostre vite nelle mani di un pugno
di banchieri: un vero e proprio colpo di mano consumato nell'inconsapevolezza
e nell'indifferenza dei più. Eppure anche i più
accorti sono rimasti attoniti e sgomenti quando la troika formata
da Fmi, Bce e Ue ha messo letteralmente in ginocchio un'intera
nazione, la Grecia, con un'arroganza e una ferocia cui abbiamo
assistito con un doloroso e frustrante senso di impotenza. E,
nonostante siamo ormai esperti di analisi sul potere, ci siamo
chiesti che volto abbia assunto ai giorni nostri: perché,
se non lo si conosce e riconosce, diventa anche impossibile
combatterlo, o quanto meno difendersene.
È a questa vicenda che si ispira Marco Revelli nel suo
ultimo saggio, I demoni del potere (Laterza, Bari-Roma,
2012, pagg. 97, € 14,00), leggendola come una sorta di
matricidio compiuto dall'Europa, le cui radici affondano appunto
nella antica civiltà greca. E proprio da questa Revelli
è voluto partire nella sua indagine sul potere, andando
a rileggere due miti fondativi nel cammino dell'uomo verso la
civiltà; un gioco, ci avverte, soltanto un gioco, considerato
che i miti sono polisemantici e si prestano ad interpretazioni
anche contrastanti.
Entrambi i miti scelti da Revelli, “Medusa e Perseo”
e “Ulisse e le Sirene”, possono essere letti come
archetipi dei conflitti a volte mortali tra uomini e donne.
Vediamo chi sono queste donne. Medusa è una bellissima
fanciulla che Poseidone sedusse (o stuprò) nel tempio
di Atena, la quale la trasformò in un mostro che pietrificava
col proprio sguardo chiunque la guardasse. Questo in tempi molto
remoti. Per Ovidio e Pindaro, invece, continua ad essere una
fanciulla così bella che gli uomini, affascinati, guardandola
restano pietrificati. Medusa è una delle Gorgoni: le
sue sorelle, Euriale e Steno, che rappresentano rispettivamente
la perversione sessuale e quella morale, sono immortali; lei,
invece, è mortale, e rappresenta la perversione intellettuale.
Il che significa che se gli uomini possono sopportare le perversioni
sessuali e morali delle donne, visto il grande diletto che ne
traggono, non possono invece accettare il loro modo di pensare,
e quindi cosa c'è di meglio che tagliar loro la testa?
Ed è esattamente quello che fa Perseo che, dopo averne
fatto largo uso per liberarsi dei suoi avversari, la dona ad
Atena (che simboleggia anche l'invidia delle donne verso le
altre donne). La testa però resta viva, e il suo sguardo
mortifero; Atena la fonde nel proprio scudo, così che
i nemici, guardandola, restino pietrificati.
Non è difficile riconoscere, in questo mito, la “demonizzazione
della donna” che iniziò con la prima moglie di
Adamo (vedi Renato Sicuteri: Lilith e la luna nera) e,
attraversando allegramente i millenni, si insinuò nel
topos della Belle dame sens merci (vedi Mario
Praz: La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica),
per entrare pimpante ed evergreen nel cinico e sgamato duemila.
Mi concedo una pausa autobiografica: non più di un anno
fa un amico che da anni cercava inutilmente di infilarsi nel
mio letto, una volta, alzandosi di scatto dalla sedia, mi apostrofò:
“Ma tu non sei una donna, sei il diavolo!”...
Anche le Sirene, come le Gorgoni, sono delle figure ctonie,
anticamente rappresentate con ali e testa di uccello, in seguito
con la coda; simboleggiano la sessualità femminile che
seduce e uccide. Afrodite, dea dell'amore, viene spesso raffigurata
in forma di donna e pesce. Ancora oggi il termine sirena indica
la donna fatale.
Revelli, citando tra gli altri J.P. Vernant e Italo Calvino,
ci offre una diversa interpretazione della Gorgone e del significato
della sua uccisione da parte di Perseo. Medusa, in greco “colei
che domina” o “La sovrana”, simboleggia il
potere allo stato naturale; fissarla induce a “perdere
se stesso, la propria capacità di guardare e di appartenersi:
questo è lo sguardo terrifico del potere... in questa
caduta in balia dell'altro sta la natura della pietrificazione”.
Perseo è il fondatore di città, l'uccisore di
mostri e, soprattutto, colui che usa degli artifici (nella lotta
contro Medusa si tratta dello scudo in cui si riflette la sua
immagine e che gli consente di tagliarle la testa senza guardarla);
è l'eroe che doma le potenze infernali e le passioni
in nome dell'ordine razionale istituito dalla polis.
L'episodio di Ulisse e le Sirene si colloca nel canto centrale
dell'Odissea, e “segna il passaggio (e il distacco) da
un passato emotivamente intenso e l'inizio di un nuovo ciclo
di avventure e di lotte”. Prerogativa delle Sirene è
il loro irresistibile canto; “la trasposizione poetica
di un passato di cui godere, in cui riconoscersi e, nel contempo,
arrestarsi. Dunque morire”. Mentre con la Gorgone ci si
perdeva guardando, con le Sirene è l'ascolto ciò
che annulla, in un duplice senso. Da un lato le Sirene concedono
a Ulisse un privilegio: la narrazione delle proprie gesta, e
quindi la fama ottenuta da vivo. Ricorrendo come Perseo a un
artificio (le corde per legarsi), sicuro del proprio passato
e quindi della propria identità, Odisseo potrà
presentarsi alla corte di Alcinoo come l'aedo di se stesso.
Ma, come suggerisce Peter Sloterdijk, citato da Revelli, è
la forma che la narrazione assume, cioè il canto, ciò
che affascina e incanta nelle Sirene, cioè “la
musica che assorbe le parole e in ragione di ciò riesce
a forzare i confini dell'io... il codice comunicativo più
efficace per abbassare le barriere di difesa nei confronti dell'altro”.
Entrambi i miti, dunque, raccontano dell'io messo di fronte
alla proprio doppio, che annienta. Sia Medusa che le Sirene
non esercitano una potenza diretta ma quello che Revelli definisce
un soft power, distruttivo quanto l'hard power,
ma esercitato “a distanza”, senza spargimento di
sangue. Soprattutto (qui Revelli cita Blanchot), il mito di
Ulisse e le Sirene segna il passaggio dal mito al racconto,
che si separa del proprio oggetto (l'evento narrato) e dal proprio
soggetto (narrato), ponendosi come ente autonomo.
Dopo un interessante passaggio dedicato alla storia, Revelli
approda di nuovo ai giorni nostri, all'inenarrabile orrore che
caratterizzò il '900, che già si era mostrato
nella Grande Guerra, e che nel 1917 Kafka anticipò profeticamente
in un suo scritto intitolato emblematicamente Il silenzio
delle Sirene.
Con la fine dell'800 le grandi narrazioni della letteratura,
da Le opere e i giorni a Guerra e pace, che trasmettevano
alle nuove generazioni le tradizioni e le esperienze del passato,
scompaiono per lasciare il posto allo storytelling, racconto
postumo, “che non racconta l'esperienza del passato, ma
disegna i comportamenti, orienta i flussi di emozioni, sincronizza
la loro circolazione [...] che produce il proprio ordine, creando
un vissuto artificiale altro rispetto al soggetto... il mondo
raccontato come unico mondo possibile”. Un esempio? La
balla spaziale delle armi di distruzione di massa in Iraq, che
“crearono” l'evento dei bombardamenti sulle città
di quel martoriato paese.
L'ultimo grande narratore che mostrò il volto pietrificante
del potere fu Pasolini nel film Salò. Le centoventi
giornate di Sodoma, il quale volle indagare “come
agisce il potere dissociandosi dall'umanità e trasformandola
in oggetto”.
È un saggio impegnativo, I demoni del potere,
e molto più di un gioco, ma al termine della lettura
ne sapremo un po' di più non solo delle dinamiche del
potere, ma anche di noi stessi: e questa è la cosa più
importante.
Sandra D'Alessandro
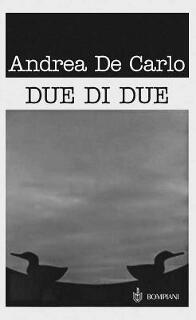 Quel
maggio
rampante italiano Chi, come colui che scrive, vive se stesso proiettato al futuro
rischia di prestare meno attenzione di quanto meriti alla narrazione
storica sulle recenti vicende e, in particolare, a quella che
prende la forma della biografia e/o del romanzo storico.
La rilettura recente di un libro che già decenni addietro
avevo letto è stata, da questo punto di vista, decisamente
utile a riflettere su quest'ordine di questioni.
La prima edizione di Due di due di Andrea De Carlo (Bompiani,
Milano, 2010, € 10,50) è del 1989. Non ricordo bene
come mi capitò fra le mani, di regola non acquisto romanzi,
se si escludono quelli di Vance et similia, di autori viventi.
Sono certo di non averlo comprato né rubato e che non
me l'hanno prestato, probabilmente mi è pervenuto in
occasione di un trasloco, uno dei tanti che ho fatto o nei quali
ho dato mano.
Ammetto che non avevo alcuna notizia sull'autore ma, considerando
che egli non ha presumibilmente alcuna notizia su di me, non
credo di avergli fatto un gran torto. Era, per di più,
di un genere che non amavo molto, un romanzo storico ambientato
durante il maggio rampante italiano e avente a oggetto, fra
l'altro, un romanzo di denuncia sulla natura mefitica di Milano
ai tempi.
Lo lessi insomma ma non lo amai, lo lessi per vedere, come avrebbe
detto il Principe Antonio Foca De Curtis, come sarebbe andata
a finire.
Solo dopo averlo terminato, mi resi conto delle ragioni del
mio fastidio. Mi ricordava singolarmente Il riposo del guerriero
di Christiane Rochefort, un libro che avevo letto da fanciullo
e che invece mi era piaciuto, forse perché ero meno coinvolto.
Per chi non ne ricordasse la trama, basta sapere che tratta
di una giovane signora di buona famiglia che rompe, per disgusto
e noia, i rapporti con il suo ambiente e diventa l'amante fedele
e appassionata di un alcolizzato con tendenze suicide.
Il rapporto fra i due principali personaggi di Due di due,
Mario, l'io narrante amico fedele e subalterno e Guido, il maudit,
avventuriero, sciupafemmine, tormentato eroe del nostro tempo,
è simile, ovviamente se si esclude la relazione erotica
fra i due.
Non saprei dire perché De Carlo non abbia reso la vicenda
più intrigante introducendo un cotè omosessuale,
in fondo Porci con le ali era già uscito.
Il romanzo è diviso in due parti. Nella prima i due ragazzi,
entrambi studenti del liceo classico Berchet di Milano, vivono
gli altrettanto classici turbamenti adolescenziali, si trovano
coinvolti con volenterosa disponibilità negli accadimenti
del 1968, vivono diverse tumultuose vicende. Come si diceva,
dei due la figura trainante è Guido, che legge, conosce,
sperimenta, è un leader sia pur eretico del movimento
degli studenti, Mario lo seconda.
De Carlo pone l'accento sulla precoce fine della dimensione
libertaria ed innovatrice del movimento degli studenti ad opera
degli orridi gruppi marxisti leninisti, in particolare il Movimento
Studentesco della Statale divenuto poi Mls. Io, che ero da quelle
parti, posso per un verso confermare che tali gruppi tendevano
all'orrido ma, soprattutto, rilevare che le dinamiche che si
svilupparono anche nei primi anni '70 furono infinitamente più
ricche ed interessanti della descrizione riduttiva e caricaturale
che ne dà De Carlo.
Guido, e Mario nel ruolo di ombra fedele, diventano anarchici,
d'altronde potevano mancare gli anarchici? Dalla lettura del
libro parrebbe che i due abbiano frequentato il Circolo Anarchico
di via Scaldasole descritto come uno stanzone polveroso, cosa
che effettivamente era. A questo punto del romanzo si dà
un passaggio che oltre vent'anni addietro mi colpì molto
e di cui allora, a differenza di oggi, non mi riuscì
di darmi una spiegazione. Ritrovo, a pagina 104 della quindicesima
edizione, quella del 2010, un'affermazione che trovai, e trovo,
sgradevole: «I piccoli gruppi anarchici si sono dispersi,
i loro membri mandati in prigione con accuse false o scappati
o anche solo troppo demoralizzati per fare più niente».
Andrea De Carlo tratta di quanto avvenne immediatamente dopo
la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969 e visto che
il suo eroe, Guido, e l'io narrante, Mario, frequentano un circolo
anarchico deve fornire una spiegazione del loro abbandono della
“politica” che non contrasti con i caratteri propri
dell'eroe e persino con quelli del più modesto io narrante
e la fine del movimento anarchico gli pare efficace. Quando
però si scrive un – sia pur modesto – romanzo
storico una qualche attenzione ai particolari, soprattutto se
non irrilevanti, sarebbe opportuna visto che, in realtà,
il movimento anarchico, che certo non pretendeva di essere l'Orda
d'oro, tenne botta. Visto che Guido viene presentato come uomo
di carattere, il suo sparire nel vento nel momento di massimo
pericolo sarebbe non coerente con il personaggio e, di conseguenza
Andrea De Carlo fa sparire nel vento l'intero movimento anarchico.
Una licenza letteraria notevole.
La seconda parte del romanzo è invece dedicata alla trasformazione
di Mario da studente svogliato in operoso contadino ecocompatibile
nei dintorni di Gubbio, al suo divenire padre amoroso e critico
intransigente della civiltà industriale, al suo inserirsi
nella deriva che porterà all'attuale sviluppo dell'economia
verde.
Naturalmente Guido non scompare, anzi. Viaggia per il mondo,
trova e lascia compagne, scrive, come già dicevo, un
romanzo di denuncia contro Milano, l'inquinamento, il cemento,
il ceto politico, la sua opera viene equivocata e mercificata
e, alla fine, muore giovane lasciando, come si diceva ai tempi,
un bel cadavere.
Il cuore storico politico del romanzo, quello che più
mi ha interessato, emerge da ciò che viene valorizzato
e, ancora di più, da ciò che viene occultato.
Invano si cercherebbe nell'opera un cenno anche marginale al
conflitto di classe che pure qualche peso nel maggio rampante
lo ebbe. La questione delle classi appare in qualche misura
solo nella forma della relazione problematica fra Guido, figlio
di una portinaia, e diverse delle sue socie di volo che, immancabilmente
sceglie, chissà come mai?, fra borghesi affette da mal
de vivre. Al contrario la partita si gioca sulla dialettica
infelice fra tensione distruttiva, incarnata dal saturnino Guido,
e tensione all'alternativa positiva, incarnata dallo scialbamente
solare, mi si passi l'ossimoro, Mario.
In altri termini, la passione sovversiva viene consegnata, e
in questo modo liquidata, alla condizione giovanile e ad una
critica estetica dell'orrore della civiltà urbano-industriale
e la rivoluzione sociale si riduce ad una sperata rete di cooperative
di produzione e consumo eque e solidali. Un triste e, spero,
precoce funerale.
Cosimo Scarinzi
Lo scrittore Brassens,
questo sconosciuto
 Un
libero flusso di pensieri ed emozioni che raccontano del poeta
Georges Brassens: ecco G. Brassens 5h40' (Riflessioni e appunti
tra un treno, un pullman e una quenelle di quinoa) (Medea,
Pavia, 2011, pagg. 300, € 18,00). Un
libero flusso di pensieri ed emozioni che raccontano del poeta
Georges Brassens: ecco G. Brassens 5h40' (Riflessioni e appunti
tra un treno, un pullman e una quenelle di quinoa) (Medea,
Pavia, 2011, pagg. 300, € 18,00).
L'autrice Daniela Soave Vighesso ripercorre la storia di questo
cantautore utilizzandone le canzoni e raccogliendo appunti che
ne indagano la personalità, cercando di scovare l'uomo
dietro all'artista e dando libero sfogo a quello che appare
come il suo intimo fantasticare su una diretta conoscenza con
questo affascinante cantore.
Un vero e proprio innamoramento, a tratti un po' celebrativo
ma in alcuni casi più lucidamente analitico. Il racconto
di un'esperienza assolutamente personale, con interventi e interpretazioni
a volte intuitive e interessanti altre più arbitrarie
e congetturate.
È onesto il tentativo di riconoscere a Brassens un ruolo
di apripista, più che di una personalità da idolatrare
(salvo cadere in qualche contraddizione) e di tener conto della
possibilità che vi siano stati anche artisti in grado
di sviluppare meglio di lui i diversi spunti che egli stesso
ha offerto.
Tra una confessione e l'altra l'autrice rivela un'appassionata
e intensa conoscenza dell'intera opera del cantautore (ma, forse,
una meno puntuale conoscenza di altri artisti citati) e la mette
a disposizione di chi legge, offrendo un'occasione per riflettere
e per immergersi fra le canzoni di Brassens, anche in assenza
di musica, o per immaginare una personalità in fondo
sconosciuta.
Probabilmente è un libro scritto più per sé
che per chi lo leggerà, ma questo non impedisce di lasciare
un prezioso contributo con la parte dedicata a Brassens scrittore,
frequentemente liquidata dalla bibliografia già presente
in italiano e considerata invece, all'interno di questi appunti,
con attenzione e devozione.
Elisa Sciuto
| 
|
Bela Lugosi nei panni
del Conte Dracula |
Letteratura gotica/
Sul concetto di “normalità”
Sfogliando un qualsiasi dizionario della lingua italiana potrebbe
facilmente accadere di imbattersi nel termine “normale”
e di leggervi accanto una definizione più o meno di questo
tipo: “conforme alla consuetudine e alla generalità,
regolare, usuale, abituale”. Ciò che ho finora
detto non rappresenta una novità per nessuno, ma vale
la pena interrogarsi più a fondo su questo termine e
sulle ripercussioni che esso genera sulle nostre esistenze.
Innanzitutto sorge spontaneo domandarsi da dove nascano e su
quale base siano concepiti tutti quei paradigmi e modelli di
normalità a cui ognuno di noi cerca quotidianamente di
uniformarsi con lo scopo di garantirsi un ruolo nella comunità
umana. Va chiarito il fatto che la normalità, così
come noi siamo abituati a concepirla, non è assolutamente
un “fatto naturale”, ma soltanto un mero prodotto
culturale, un insieme di regole non scritte che quotidianamente
la società ci propina e che noi inconsapevolmente introiettiamo
e proiettiamo sul nostro corpo: ad aver intercettato tutto questo
sono stati vari autori inglesi dell'800 che per primi hanno
introdotto i concetti di “artificialità della natura
umana” e di “essere umano come prodotto culturale”;
il ricorrere nei loro romanzi di un certo tipo di tematiche
ha portato, negli anni, a definire l'insieme di queste opere
con il nome di letteratura gotica.
Fin dalla sua nascita il gotico si è posto come genere
portatore di critica culturale e sociale in grado di mostrare
quanto falso fosse il mito del progresso; è un genere
che sostanzialmente dà voce alle “alterità”
e le esalta a tal punto da rendere visibile a tutti il meccanismo
della loro marginalità e la “fabbrica dei criteri”
che si cela dietro a tutto questo. Senza nemmeno rendercene
conto siamo proprio noi, attraverso i nostri giudizi e le nostre
azioni quotidiane, che permettiamo a questi criteri di prosperare,
di perpetrare e di radicarsi in maniera sempre più irrimediabile
nella società: non facciamo altro che comportarci come
ingranaggi e, per citare Michel Foucault, come “cinghie
di trasmissione del potere”.
Uno di questi autori è senza dubbio Edgar Allan Poe,
che nel suo racconto del 1840 intitolato L'uomo interamente
consumato ci descrive un generale John A.B.C. Smith come
un modello di perfezione, un uomo che incarna perfettamente
la categoria del “consueto”; tuttavia, con l'evolversi
del racconto, si scoprirà che quest'emblema della normalità,
così come ci è stato descritto, in realtà
non è che un ammasso di protesi artificiali. In questo
modo Poe ci sta dicendo che un uomo è tanto più
“normale” e risponde tanto più alle aspettative
del potere quanto più il suo significato di “essere
umano” viene meno. Ad aver tracciato il sentiero seguito
poi da Poe è stata sicuramente Mary Shelley nell'opera
del 1818 intitolata Frankenstein in cui, per la prima
volta, si parla di una vita artificiale e di un corpo-macchina.
Altro autore che mira a scardinare le fondamenta su cui poggia
il concetto di normalità è senza ombra di dubbio
Bram Stoker che nel 1897 con Dracula ci racconta di un
vampiro che esercita il suo fascino indistintamente su uomini
e donne. Parlandoci della sessualità polimorfa e sregolata
del vampiro, l'autore non fa altro che parlarci del terrore
dell'epoca (spesso rintracciabile anche ai nostri giorni) nei
confronti di quelle sessualità che si discostano rispetto
alla “consuetudine” (eterosessuale e finalizzata
alla procreazione). Così facendo l'autore sembra voler
attaccare anche l'unico modello sociale legittimato dal potere,
e cioè quello familiare.
L'ossessione instancabile del potere finalizzata all'affermazione
della normalità si è tradotta in passato anche
nella creazione di vere e proprie discipline scientifiche che
si occupassero di individuare e analizzare le diverse “categorie”
di esseri umani: fra queste la fisiognomica, che attraverso
i suoi studi mirava proprio a creare modelli “più
conformi” rispetto ad altri.
Stabilendo dei modelli di normalità in ogni sfera della
vita si genera ghettizzazione, conflitto e odio; si trasforma
in questo modo una risorsa così preziosa come la diversità,
capace di arricchire tutti coloro che ne sanno cogliere il vero
significato, in un qualcosa di negativo, in un qualcosa capace
di generare odio tanto più profondo quanto più
è ampia la differenza rispetto al modello da imitare.
I criteri di normalità hanno lo scopo di rendere gli
uomini dei corpi privi di anima e destinati alla semplice produzione,
di imbrigliare la mente e di renderci dei gusci vuoti totalmente
impotenti e alienati, proprio come degli zombie.
In questo modo il corpo si devitalizza e diviene cosa: questo
è quanto ci dice anche Oscar Wilde nel suo celebre Ritratto
di Dorian Gray, con cui vuole rompere il concetto di autenticità,
defininendoci “nient'altro che copie”, copie di
modelli preesistenti e da cui siamo stati influenzati, dei “prigionieri
all'interno di un copione già scritto”.
L'unico modo per essere davvero liberi è rimuovere quel
filtro che trattenendo “l'insolito” lascia passare
soltanto il “consueto”; una volta conseguito questo
nuovo stato di visione del mondo potremo aspirare ad un cambiamento
che porti finalmente alla vera eguaglianza sociale!
Alessio Gentili
 La
fame
è un bel gioco Per una volta partiamo dalla coda: “Quiz finale”
a pagina 113 (vi dirò dopo di che libro si tratta). “Semplici
domande” che servirebbero a valutare se lettori-lettrici
hanno ben capito le 112 pagine precedenti ma io ve le giro “al
buio”. Sarebbero 8 quesiti ma io mi limito ai primi 4.
Vediamo quante risposte pensate di sapere. Il criterio però
non è il “giusto” ma ciò che accade
in questo XXI secolo.
1. La finanza è:
- Un mezzo al servizio dell'economia produttiva e dell'insieme
della società.
- Il mercato dei soldi.
- Un fine in sé, per fare soldi dai soldi nel più
breve tempo possibile.
- Un divertente gioco di società in cui vincono tutti
e i soldi si creano dal nulla per magia.
2. L'agricoltura:
- Serve a dare un reddito dignitoso ai contadini e alle loro
famiglie, e a sfamare le persone tutelando l'ambiente e la biodiversità.
- Serve a produrre quelle cose che bisogna aggiungere ai conservanti,
pesticidi e coloranti prima di venderli sui banconi dei nostri
supermercati.
- Serve a produrre cibo, il cui unico scopo è costruirci
sopra derivati e altri strumenti finanziari sempre più
complicati in modo da poterci guadagnare su.
- È una cosa superata, qui pensiamo a far soldi, non
certo a perder tempo nel mangiare.
3. Che cosa dovremmo fare?
- Regolamentare la finanza, proibire derivati speculativi e
scommesse sul cibo, tassare le transazioni finanziarie.
- Raggiungere la sovranità alimentare per ogni popolo
del pianeta.
- Abolire le ultime regole e controlli in vigore nella finanza
internazionale.
- Giocarci fino all'ultimo euro nei mercati finanziari perché
siamo più furbi di tutti.
4. Nel solo 2009 Goldman Sachs ha ottenuto più
di un miliardo di dollari e Barclays 340 milioni di sterline
grazie agli scambi su materie prime e cibo. Da dove vengono
questi profitti?
- L'operazione ha creato ricchezza reale. Le banche hanno guadagnato
ma hanno tirato l'economia e contribuito al benessere di tutti.
Che bello il mondo in cui viviamo.
- Sono soldi creati dal nulla. Non fanno nessun danno, anzi
è un gioco di prestigio molto divertente.
- Se le banche hanno vinto è scommettendo contro qualcuno
che evidentemente ha perso, probabilmente tanti piccoli risparmiatori
che si sentono molto furbi e comprano Etf e Etc.
- Le operazioni che hanno fatto aumentare i prezzi del cibo
e il guadagno vengono da lì, a rimetterci sono le persone
che testardamente insistono a usare il cibo per mangiare.
Se le domande e soprattutto le possibili risposte vi sconcertano,
il mio suggerimento è di andare in una buona libreria
o su www.altreconomialibri.it/libri
e di acquistare Il grande gioco della fame (Altreconomia,
2011, pagg.128, € 8,00) – sottotitolo: “Scommetti
sul cibo e divertiti con la finanza speculativa” –
di Andrea Baranes che, fra l'altro, è attivo nella Campagna
per la riforma della Banca mondiale (www.crbm.org)
e autore di Come depredare il Sud del mondo edito appunto
da Altreconomia.
Non so se conoscete Modesta proposta di Jonathan Swift
(sì, proprio l'autore de I viaggi di Gulliver
che in Italia gira perlopiù in edizione ridotta così
che viene spesso scambiato per una favola o un libro d'avventura):
questo feroce pamphlet spiega, in modo freddamente scientifico,
come risolvere il problema della miseria... mangiando i bambini
(irlandesi) poveri. In qualche modo Andrea Baranes espone con
la stessa tranquilla ferocia come la finanza internazionale
usa il cibo per far soldi: un gioco vero, con milioni di morti
veri che corrispondono agli utili.
Crudele. Ma purtroppo vero. Il gioco (orribile ma efficace)
è provare a essere come “loro”. Scrive Baranes:
«Il ruolo più divertente da scegliere resta probabilmente
quello dello speculatore [...] Grazie a queste semplici linee-guida
potrete trarre il massimo del divertimento dal gioco e incontrare
nuovi amici che – come voi – realizzano enormi profitti
e impongono prezzi insostenibili a persone che stanno morendo
di fame». Divertente. Da morire.
Daniele Barbieri
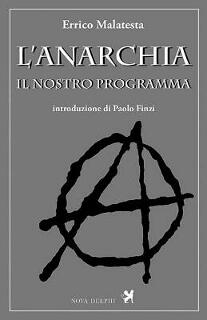 L'anarchia
spiegata dal buon Malatesta La giovane e vivace casa editrice Nova Delphi Libri (info@novadelphi.it
/ www-novadelphi.it)
ripubblica, nella collana Ithaca, due classici scritti dell'anarchico
Errico Malatesta: L'anarchia e Il nostro programma,
che costituiscono il titolo di questo libretto (pagg. 112, €
8,00). Ne ripubblichiamo qui l'introduzione di Paolo Finzi,
della redazione di questa rivista.
Errico Malatesta è morto nel 1932, 19 anni prima che
io nascessi.
Eppure è stato un mio compagno di vita quotidiana per
almeno un ventennio, a partire da quando – nel 1967 –
lo incontrai in alcuni articoli sulle pagine del settimanale
anarchico Umanità Nova e poi l'anno successivo
– il mitico 1968 – negli opuscoli e nei libri che
ebbero a suggerirmi, e poi a vendermi o a prestarmi, gli anarchici
del Circolo “Ponte della Ghisolfa” e in particolare
Pino Pinelli, che del serrvizio-libreria e della biblioteca
di quel circolo era l'appassionato responsabile.
In quel periodo di entusiastica adesione al movimento anarchico
e ai movimenti di lotta dell'epoca, nell'ambito della preparazione
culturale e storica che tanti di noi giovani sentivano come
un “dovere” e che comunque ci veniva proposta dai
vecchi (e il quarantenne Pinelli, nato 23 anni prima di me,
era nella mia percezione assolutamente un vecchio, penso mi
sembrasse il nonno che non avevo), mi lessi più o meno
tutti i classici dell'anarchismo, da Bakunin a Kropotkin, da
Galleani a Gori, da Fabbri a Malatesta. L'età giovanile,
con i suoi entusiasmi e l'eccitazione della “scoperta”,
mi portavano ad apprezzarli tutti, ognuno con le proprie caratteristiche.
Mi riconoscevo allora anche nel linguaggio di un Galleani, che
più avanti mi sarebbe sembrato irrimediabilmente “datato”,
con quel suo infarcire a volte i propri scritti di citazioni
latine o comunque “classiche”, con quella retorica
roboante. E anche il Gori del terribile “Al tuo amor fanciulla
cara, ben altro amor io preferia, è un'idea l'amante
mia...”, che certo non corrispondeva alla situazione ormonale
e ai desideri di un ragazzo che aderiva all'anarchismo senza
per questo escludere di trovarsi una concreta e carnale “amante
mia”: insomma anche quel Galleani e quel Gori mi andavano
benissimo. Ora un po' meno, per certi aspetti molto molto meno.
Ma Malatesta era un'altra cosa. Quello fu sì “amore
a prima vista”. Uno che era morto quasi 40 anni prima
di quando iniziai a leggere i suoi scritti non poteva certo
essere considerato un contemporaneo. Ed era morto prima della
rivoluzione spagnola, della seconda guerra mondiale (quindi
di Auschwitz e Hiroshima, tanto per citare due luoghi-simbolo
di un “mai più” etico che fatica anche solo
a sopravvivere), della coscienza ecologista, del femminismo,
ecc..
Eppure in quegli anni Malatesta si presentava agli occhi di
tanta parte dei giovani che si avvicinavano all'anarchismo come
un pensatore “attuale”. Uno che intanto scriveva
bene, con semplicità (che è tutt'altra cosa dalla
superficialità e dalla banalità): senza concessioni
al lirismo e alla retorica – anche alla sua epoca tanto
in voga – con uno stile al contempo asciutto ed essenziale,
ma mai freddo. Mi colpì in tanti suoi scritti l'uso della
parola “amore”, come riferimento etico ma non solo.
Una parola e un concetto essenziali in Malatesta e che solo
per questo uso (mai abuso) già marca la differenza con
altri pensatori anche anarchici. E ancora una volta non è
tanto la frequenza della parola nei suoi scritti, quanto la
sua positività fondante, nella vita dei singoli come
della società.
D'altra parte lo slogan degli anni '70 “il personale è
politico”, con tutto quello che gli sta dentro, è
presente e a tratti visibile negli scritti del rivoluzionario
campano. E, credo, lo sia stato in alta misura nella sua stessa
vita, per quanto se ne possa sapere. Personalmente mi sono occupato,
proprio in quei primi anni '70, di ricostruire sette mesi della
vita militante di Malatesta, in particoare del periodo che va
dal suo rientro in Italia nel dicembre 1919 fino al congresso
dell'Unione Anarchica Italiana a Bologna nel luglio 1920: una
lunga sfilza di comizi, articoli, la fondazione del quotidiano
Umanità Nova, i rapporti con socialisti, repubblicani,
Ordine Nuovo: uno dei periodi in cui maggiormente appare
come un personaggio di statura nazionale, un protagonista -
assolutamente a suo modo – delle vicende sociali del Paese.
Eppure anche in quel periodo così “politico”,
se non si riesce a leggere in filigrana la sua prorompente ed
equilibrata umanità, la sua concezione concreta della
vita e delle relazioni tra le persone, non se ne può
cogliere – a mio avviso – la vera cifra: quella
di un progetto di vita e di lotte che, anche se pudicamente
espresso meno esplicitamente di quanto la mia sensibilità
di oggi richiederebbe, si basa sull'etica, sull'etica che non
credo improprio definire innanzitutto un'etica fondata sull'amore.
E anche oggi, a più di ottant'anni dalla sua morte, è
questo uno dei suoi lasciti più belli.
Per almeno un ventennio gli scritti di Errico Malatesta –
in particolare i mitici tre volumi curati da Luigi Fabbri e
pubblicati poco dopo la sua morte e quindi ripubblicati “a
cura del Movimento Anarchico Italiano” a metà degli
anni '70 – hanno fatto bella mostra di sé sul comodino
accanto al mio letto. Li leggevo, li rileggevo, e poi articoli
su di lui, tante conferenze in giro per l'Italia, i rari incontri
con anziane compagne e compagni che l'avevano visto e conosciuto.
Un rapporto intenso, quotidiano, che si intrecciava con il diuturno
impegno sociale (e redazionale) mio e di tutta una generazione,
anzi di più generazioni di militanti anarchici.
D'altra parte, visti dall'interno dell'anarchismo, alcuni temi
fondamentali sono da sempre gli stessi: la questione dell'organizzazione,
il sindacalismo, la violenza, l'individualismo, ecc.. Su tutti
questi temi, Malatesta ha scritto pagine di mirabile chiarezza,
che si possono condividere o meno, ma restano un esempio di
lucidità di pensiero, trasparenza espositiva e serenità
d'animo. A questo proposito, è importante rilevare che
non esiste un “pensiero unico” malatestiano, perché
il suo pensiero è in continua evoluzione ed esperienze
e riflessioni lo portano ad aggiustamenti e anche a cambi di
prospettiva. In Malatesta c'è, a mio avviso, una coerenza
di fondo che attiene all'etica, alla scelta dei valori e della
parte da cui stare e lottare, ma dentro questa coerenza di riferimento
ci sono – e guai se non ci fossero – differenze
anche grosse.
Malatesta è stato di sicuro la figura storicamente più
rilevante dell'anarchismo di lingua italiana e una delle principali
a livello mondiale. Ma appartiene non solo al filone di pensiero
e al movimento cui ha dedicato tutta la propria esistenza, a
costo di sacrifici notevoli e prolungati che sono stati propri
di intere generazioni di anarchici.
Era un uomo aperto, attento agli altri, e in lui la convinzione
per le proprie idee (accentuata dalle necessità della
“propaganda”: lui scriveva articoli per orientare
le lotte, non saggi accademici) non diventava mai sottovalutazione
o peggio disprezzo per le altre. E anche questa è una
piccola lezione, in realtà per niente piccola.
Dicevo all'inizio che Malatesta è stato un mio quotidiano
compagno di vita per un ventennio. Proprio leggendolo e rileggendolo,
ho maturato a un certo punto un'esigenza di distacco, di approfondimento
di altri personaggi e tematiche. Sul mio comodino i tre volumi
dei suoi scritti hanno lasciato spazio ad altre letture, anarchiche
e spesso non-anarchiche.
Come un figlio che fisiologicamente senta la necessità
di “separarsi” da un padre “troppo”
(troppo bravo, troppo giusto, comunque ingombrante), ho in qualche
modo guardato “altrove”. E ho trovato tanti pensatori,
esperienze storiche, riflessioni personali, confronti, dibattiti,
tante cose interessanti che in Malatesta non c'erano e non potevano
e non possono esserci.
Il mondo, la cultura, tutto scorre, si arricchisce di nuovi
capitoli, idee, lotte. E guai a chiudersi in se stessi, in rigide
e rassicuranti certezze, che impediscono di “stare sui
tempi”, di cogliere il nuovo che sempre c'è anche
se spesso non vogliamo coglierlo.
Dopo essermi definito per tanti e tanti anni “malatestiano”,
oggi mi rendo conto che gran parte del merito del mio attuale
rifiuto di definirmi in relazione a chicchessia (compreso Malatesta)
è proprio di quel piccolo grande uomo, che di fronte
al vero e proprio coro di consensi, a tratti adulatori, con
cui venne salutato al suo rientro in Italia nel dicembre 1919
e nel ciclo di comizi e conferenze che subito intraprese, scrisse
poche righe sul quotidiano Umanità Nova di cui
era il direttore: e il titolo è già un programma,
“Grazie ma basta”.
Quindi, paradossalmente, anche nel rifiutare l'auto-definizione
di “malatestiano”, mi ritrovo sulla stessa lunghezza
d'onda di Errico Malatesta e del suo rifiuto del culto della
personalità.
Mettiamola così: se per un attimo io accettasi di definirmi
in relazione ad una persona, l'unica con cui potrei farlo resta
Errico Malatesta.
E la lettura dei suoi scritti riproposti in queste pagine, al
contempo così datati e così universali, ci rende
un Malatesta con cui credo che sempre dovremo fare i conti,
nell'affannata e profonda ricerca delle vie migliori e più
efficaci per rendere più umano, libero e solidale il
mondo che ci circonda. In altre parole, per avvicinarci alla
realizzazione di quel sogno anarchico di cui il buon Malatesta
è stato uno degli espositori più lucidi e uno
dei realizzatori più efficaci.
Paolo Finzi
|

