
I nuovi confini/
Non più demarcazione, ma condizione di vita (e sofferenza)
Confini, mobilità e migrazioni. Una cartografia dello
spazio europeo (Milano 2020, pp. 268, € 15,00), la
raccolta di saggi che Lorenzo Navone ha curato per Agenzia X,
si pone l'obiettivo di mappare il territorio europeo tenendo
conto della recente e continua opera di riconfigurazione dei
confini che l'Unione Europea ha messo in atto negli ultimi anni
per rendere più salda la propria “fortezza”
dopo che, dal 2011 in poi, una serie di avvenimenti di portata
globale ha compromesso i presupposti in base a cui l'Europa
aveva fino ad allora governato le proprie frontiere esterne.
 Davanti
a questi processi di «riconfigurazione architettonica
dall'alto», ai migranti e a coloro che sostengono
il diritto all'attraversamento dei confini non resta che reagire
adattandosi e modificando strategie e itinerari: le rotte migratorie
sono in continua ridefinizione e si assiste alla costruzione
di nuove pratiche e nuove reti di solidarietà; è
di questo fenomeno articolato, precario e in movimento che gli
autori compiono un'approfondita analisi. Davanti
a questi processi di «riconfigurazione architettonica
dall'alto», ai migranti e a coloro che sostengono
il diritto all'attraversamento dei confini non resta che reagire
adattandosi e modificando strategie e itinerari: le rotte migratorie
sono in continua ridefinizione e si assiste alla costruzione
di nuove pratiche e nuove reti di solidarietà; è
di questo fenomeno articolato, precario e in movimento che gli
autori compiono un'approfondita analisi.
I saggi raccolti in questo volume propongono un'immagine del
confine che supera la dimensione lineare tradizionalmente diffusa:
i confini appaiono come «centri di gravità che
attirano verso di sé forze, saperi, beni e persone»,
non linea e non margine, ma spazio. Partendo dal significato
che aveva per i romani, Claudia Moatti dimostra come la frontiera
sia una categoria del pensiero la cui interpretazione varia
secondo i tempi e i luoghi e ci invita, oggi, a «decentrare
il nostro sguardo» pensando a tale frontiera come a uno
spazio e lavorando sulla sua indeterminatezza. Quest'idea di
confine come centro alternativo e luogo di interazione viene
confermata dal filosofo francese Étienne Balibar, che
intervistato da Lorenzo Navone e Federico Rahola riflette sul
sistema di accoglienza istituzionale e sulle pratiche informali
di solidarietà. Balibar afferma che è proprio
alla frontiera che «si trovano delle forze tra loro eterogenee
il cui incontro e il cui conflitto è il fermento di una
nuova invenzione del politico per gli anni a venire»,
e che il soggetto politico da cui dipende il destino dell'Europa
è costituito dall'incontro di individui che provengono
«da una parte e dall'altra di una frontiera»: i
migranti e i militanti.
Tra le pratiche adoperate dall'Europa per mantenere il controllo
sui propri confini vengono analizzati l'utilizzo delle infrastrutture
aeree, nello specifico il recente impiego dei voli charter,
come strumento di deportazione per espellere dal territorio
i corpi indesiderati, e il fenomeno dell'esternalizzazione dei
confini osservato attraverso il ruolo delle ONG nei paesi cosiddetti
“di transito”, fenomeno multiforme e dinamico per
cui si suggerisce di usare il paradigma della delocalizzazione
del confine, più adatto a coglierne le sfumature.
Se nella prima parte del volume i contributi si concentrano
maggiormente sui confini intesi nel loro significato politico
e nella loro dimensione spaziale, nella seconda parte, attraverso
i resoconti etnografici, ci si sofferma sui luoghi caldi della
frontiera europea per dare spazio e voce ai migranti e alle
loro esperienze. Qui il confine emerge come una «condizione
esistenziale permanente», come un elemento che segna il
corpo e la vita di coloro che si accingono ad attraversarlo
per rimanervi impresso anche dopo il suo superamento. Scorrendo
le diverse vicende umane emerge come il confine sia in grado
di stravolgere la temporalità delle persone migranti
e delle strutture in cui esse sono contenute: viene descritto
il ciclo temporale dell'hotspot con il suo alternarsi
di momenti di attesa e di urgenza, ma soprattutto è sottolineata
la dimensione di sospensione tipica dei migranti in transito
che condiziona anche il loro modo di abitare gli spazi e di
relazionarsi con gli altri, come emerge dalla ricerca etnografica
sulla quotidianità dei migranti sudanesi nella Giungla
di Calais.
Le esperienze del senegalese Omar e del maliano Abdoulaye Diarra,
che in tempi diversi hanno cercato di attraversare la frontiera
ispano-marocchina a Melilla, provano quanto la dimensione dell'attesa,
che può dilatarsi in maniera imprevedibile, possa a lungo
andare essere distruttiva per i corpi, e quanto tale dimensione
non si arresti una volta superato il confine, che il più
delle volte è tra l'altro solo uno dei tanti.
Il confine in quanto «condizione esistenziale» in
grado di stravolgere la temporalità si manifesta non
solo come permanente ma anche come ereditabile, ciò emerge
in relazione al caso del confinamento e della segregazione scolastica
dei migranti italo-magrebini in Francia, a Strasburgo. Anche
se nati in Italia, e quindi liberi di superare la frontiera
interna, questi giovani portano i segni del confine “scomodo”
attraversato dai loro genitori prima che nascessero, quando
dal Nord Africa si diressero in Italia; a causa di questa colpa
ereditata, si vedono spesso negare, nonostante il loro plurilinguismo,
la possibilità di partecipare alle elitarie sezioni internazionali
e si ritrovano invece parcheggiati in classi-dispositivo subalterne,
luoghi «simbolo di una provvisorietà infinita,
in cui diverse temporalità si dilatano».
I contributi sulla rotta balcanica, sul confine italo-francese
e sui contro-rivelamenti ai confini marittimi dell'Europa ci
mostrano la brutalità di un potere che è disposto
a tanto – forse a tutto – pur di esercitare il controllo
sull'attraversamento dei propri confini. È disposto a
respingere con efferata violenza chi osa sfidare le sue frontiere,
a vietare e perseguire la solidarietà e a temporeggiare
anche di fronte a esseri umani che chiedono aiuto nel mar Mediterraneo,
talvolta con esiti drammatici.
Ma questi stessi contributi ci mostrano anche la tenacia e la
creatività dei migranti, in grado di adattarsi rapidamente
alle ridefinizioni dei confini e di non arrendersi di fronte
ai muri vecchi e nuovi, ci mostrano la capacità degli
attivisti e di parte della società civile di pensare
a nuove pratiche e di costruire reti di supporto, ci mostra
infine il successo dell'uso da parte di attivisti e migranti
di tecnologie e strumenti innovativi «per ribaltare la
sorveglianza» e costringere gli stati a intervenire anche
laddove preferirebbero fingere di non avere visto o sentito.
Confini, mobilità e migrazioni ci accompagna nello
spazio di frontiera, tra i confini interni e quelli esterni
d'Europa, nelle strutture di contenimento e di deportazione,
fra i migranti, gli attivisti e i solidali, ci mostra pratiche
di resistenza individuale e collettiva, mobilitazioni comuni
che rivendicano «il diritto di movimento, ma anche di
critica e di trasformazione del governo delle mobilità
umane». Questa “cartografia aggiornata” ci
invita a ripensare il nostro concetto di confine e ci suggerisce
che un'opposizione e una resistenza all'attuale regime delle
frontiere sono non solo possibili, ma anche necessarie.
Diana Galletta
Mister No/
La fine di una storia (con dubbi e senza eroi)
«Questo è il quartiere in cui sono cresciuto,
Harvey, dove ho imparato per la prima volta come funziona il
mondo! È da molto tempo che desideravo tornarci, ma..»
«...Ma adesso che ci sei vorresti non averlo mai fatto,
vero?»
Anni di film sul Vietnam, la guerra ingiusta e sporca per antonomasia,
hanno cristallizzato la narrazione del ritorno a casa dei soldati.
Gli incubi, gli amici caduti, la gioventù sprecata in
battaglia, il compagno paralitico: la vita civile è forse
un inferno peggiore della foresta dell'Indocina. Ultima spiaggia,
il dialogo con lo psicologo dell'associazione dei veterani,
spesso un altro reduce. Un copione già visto che però
potrebbe essere utile per parlare con un veterano di un'altra
guerra, a patto di pescarlo fra i bar e le sale da gioco di
Manaus, Brasile.
«Tu sai soltanto che hai l'ordine di uccidere e allora
fai una bella picchiata e TATATA-TATA tutti morti! Semplice,
no? Poi si torna alla base... Ci si sbronza per non pensare
a quanto è successo, ci si applica magari un grado in
più sulla manica e si continua così, aspettando
la fine, anche se dentro ti senti il terribile sospetto che
la fine non arriverà mai».
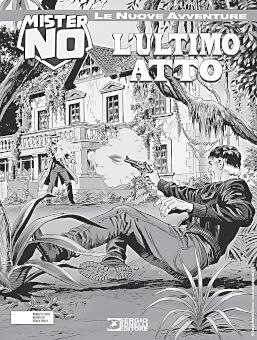 Quel
mondo te lo ritrovi cucito addosso, anche con la pace. Altrimenti,
perché continuare ad indossare, nella soffocante umidità
della Foresta amazzonica, il giubbotto di pelle da pilota e
presentarsi con quel vecchio nome di battaglia? Tributo alla
memoria di un paio d'amici a cui si deve tutto - in primis il
mestiere - e il privilegio di scegliere la propria identità,
abbandonando quella di Jerry Drake da New York per essere semplicemente
Mister No (Sergio Bonelli Editore). Un eterno burlone
e scavezzacollo che però si sente veramente a suo agio
solo in compagnia di vecchi commilitoni o, al massimo, con dei
vecchi nemici che hanno sulle spalle le medesime delusioni,
come l'ex soldato dell'Afrika Korps Kruger, il vecchio Esse-Esse. Quel
mondo te lo ritrovi cucito addosso, anche con la pace. Altrimenti,
perché continuare ad indossare, nella soffocante umidità
della Foresta amazzonica, il giubbotto di pelle da pilota e
presentarsi con quel vecchio nome di battaglia? Tributo alla
memoria di un paio d'amici a cui si deve tutto - in primis il
mestiere - e il privilegio di scegliere la propria identità,
abbandonando quella di Jerry Drake da New York per essere semplicemente
Mister No (Sergio Bonelli Editore). Un eterno burlone
e scavezzacollo che però si sente veramente a suo agio
solo in compagnia di vecchi commilitoni o, al massimo, con dei
vecchi nemici che hanno sulle spalle le medesime delusioni,
come l'ex soldato dell'Afrika Korps Kruger, il vecchio Esse-Esse.
Un reduce in tutto e per tutto.
«Non sei stufa di sentirmi raccontare le mie imprese di
guerra?»
«Niente affatto. Tu sei molto più chiuso di quanto
sembri, Mister No. Questi racconti, in fondo, sono le uniche
occasioni in cui mi parli di te!»
Non è con il nostro immaginario terapeuta che sta parlando.
Anche una donna amata e rispettata come l'archeologa Patricia
Rowland, per andare oltre le solite chiacchiere da bar, deve
scavare in una memoria scandita dalle date della Seconda guerra
mondiale. 1941 in Cina con la squadriglia aerea delle Tigri
volanti, l'anno successivo Birmania e Guadalcanal, 1944 Italia
e l'inferno delle Ardenne. Poi il conto si perde, nel disastro
del ritorno a casa.
Anni duri quelli in patria. Tutto è cambiato. L'America
degli anni Trenta, quella in cui Jerry era cresciuto, creava
criminali, tanto a New York quanto a Des Moines, ma lasciava
intuire il nuovo corso. Il sogno americano del secondo dopoguerra
produce invece solo marginali disperati. Nel 4 luglio del 1947,
a Oakland in California si riuniscono 4000 motociclisti, quasi
tutti reduci: la gente perbene brontola e si organizza per cacciarli
via. Licenziato dall'ennesimo lavoretto, Mister No viene accolto
dagli Hell's Angels, con i quali scopre l'amara verità:
eroe o no, per i vagabondi della frontiera, gli hobos, non c'è
posto. Se neanche al West c'è più libertà,
un nuovo altrove lo raggiungi con un biglietto per l'Amazzonia.
A Manaus non importa chi tu sia e al bar di Paulo Adolfo un
bicchiere e due parole non si negano a nessuno.
«Jerry, hai trovato ciò che cercavi. Ora è
finita la tua fuga?»
Dietro la fuga, c'è un ricordo che brucia. Jerry aveva
già comprato un biglietto di sola andata nel 1938, l'anno
in cui il professor Jerome Drake, reduce deluso della Guerra
in Spagna, era entrato in carcere per l'omicidio del suo miglior
amico, il giornalista Logan. Di fronte al silenzio del padre
il figlio era partito e non è più rientrato.
«Perché ora non torni a casa, Jerry?»
New York è una città dannata. Nel 1949 stava per
lasciarci la pelle in quelle vecchie strade e ci ha rimesso
piede solo quando il suo rifugio in Brasile stava andando in
frantumi per colpa della Legione dei Non-vivi. Alla fine ha
ottenuto la sua vendetta chiudendo i conti con Ishikawa ma i
mesi successivi sono scivolati via in tante bottiglie, senza
il gusto della sbronza allegra di Manaus. È massacrante
rendersi conto che per difendere la propria pace sia necessario
scendere di nuovo in guerra, come è logorante contare
i giorni per rompere quel silenzio che dura da vent'anni. Un'attesa
che gli eventi prolungheranno ulteriormente.
Prima del definitivo chiarimento, si scontreranno ancora una
volta il padre severo con il figlio ribelle, riprendendo al
punto in cui si era bloccato il loro rapporto. Del resto, il
lutto della separazione non fa altro che acuire degli atteggiamenti
che abbiamo sviluppato nell'infanzia: per Drake Junior fuga
e guerra non sono state che risposte al dolore. È per
questo che Mister No ha sempre precisato di non essere un eroe:
se lo è stato, non è stato per vocazione. E infatti
quando vedrà la sua Manaus sgretolarsi per il ritorno
del Capitale malgrado la coraggiosa resistenza degli ambientalisti,
sentirà che rispetto ad una nuova guerra forse è
meglio voltare pagina. La Bolivia, l'ennesima fuga, certo: però
che ci resti come ultimo diritto quello di scegliere le battaglie
da combattere.
«Se fossi un bambino avrei risolto il problema: mi metterei
a piangere e buona notte. Ma siccome non sono un bambino, mi
è negato anche questo conforto. Bah! E chi l'ha detto
che non sono un bambino?»
Mister No è stato il primo personaggio “reale”
della casa Bonelli: un reduce schiacciato dalle trasformazioni
storiche delle Americhe metafora dell'uomo che, con dignità,
sbaglia e soffre. Una sensibilità figlia del suo creatore
Guido Nolitta, nom de plume di Sergio Bonelli, in evidente
contrapposizione con il carattere del padre Gianluigi e della
sua più celebre creatura Tex Willer. «Mio padre
non aveva dubbi: lui era un ammiratore del coraggio, dell'eroe,
quindi le sue storie erano decisamente avventurose. Io all'eroe
ci credo un po' meno [...]. Mio padre si identifica molto in
Tex perché è un uomo che non ha mai dubbi, che
pensa di essere capace di amministrare il mondo intero da solo.
Io invece sono un uomo pieno di dubbi». L'attenzione alla
voce del figlio che tutti abbiamo dentro ha aggregato attorno
alla testata un folto seguito per anni.
«Mister No è un personaggio che ha vissuto serenamente.
Non dobbiamo essere viziati da Tex che ha quarant'anni e ancora
va. Bisogna accettare serenamente che un personaggio che ha
vissuto un certo periodo buono e ha avuto il suo successo, passato
quello, se si perde il feeling con quella generazione, non funzioni
più». Se Bonelli e Mister No hanno capito di dover
chiudere un capitolo, serve proprio riaprirlo? Probabilmente
no.
Jacopo Frey
Resistenza antifascista/
Il ruolo delle donne (e quello degli anarchici?)
La Storia della Resistenza di Marcello Flores e Mimmo
Franzinelli (Laterza, Bari 2019, pp. 671, € 35,00) rappresenta
un'originale sintesi dei risultati finora raggiunti dalla ricerca
storica intorno al periodo – cruciale e controverso –
compreso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.
La caratteristica principale di quest'opera è quella
di adottare una concezione aperta e plurale di Resistenza, nella
quale trovano posto, accanto alla lotta armata delle formazioni
partigiane operanti nelle zone di montagna e dei gruppi guerriglieri
operanti nelle città – di cui gli autori ricostruiscono
con precisione consistenza, organizzazione, azioni, dinamiche
di collaborazione e conflitto tra bande di diverso orientamento
politico – le molteplici “resistenze civili”
che contribuirono alla sconfitta del nazifascismo.
 Quella
delle operaie e degli operai che con scioperi e atti di sabotaggio
cercarono di inceppare e indebolire la macchina bellica del
Terzo Reich e dei suoi alleati repubblichini; quella degli internati
militari che preferirono la detenzione in condizioni disumane
alla collaborazione con nazisti e fascisti; quella delle donne
e degli uomini (contadini, commercianti, impiegati pubblici)
impegnati a ostacolare con coraggio e creatività l'esercito
occupante e le milizie e istituzioni fasciste. Quella
delle operaie e degli operai che con scioperi e atti di sabotaggio
cercarono di inceppare e indebolire la macchina bellica del
Terzo Reich e dei suoi alleati repubblichini; quella degli internati
militari che preferirono la detenzione in condizioni disumane
alla collaborazione con nazisti e fascisti; quella delle donne
e degli uomini (contadini, commercianti, impiegati pubblici)
impegnati a ostacolare con coraggio e creatività l'esercito
occupante e le milizie e istituzioni fasciste.
Ne emerge l'immagine della Resistenza come di un'esperienza
collettiva in cui una minoranza di antifascisti di lungo corso
– caparbiamente sopravvissuti tra carcere, confino ed
esilio – riuscì a coinvolgere nella lotta al nazifascismo
strati sempre più ampi della popolazione. E in particolare
riuscì a dare una prospettiva e un'organizzazione ai
giovani che, indottrinati nel ventennio mussoliniano e mandati
al macello nella Seconda Guerra Mondiale, dopo l'8 settembre
passarono risolutamente all'opposizione antifascista.
Di grande interesse il capitolo dedicato alle “donne resistenti”.
Sulla base degli studi di numerose storiche femministe –
tra le quali va senz'altro ricordata Anna Bravo, da poco scomparsa
– gli autori denunciano come nel dopoguerra “l'universo
maschile (e maschilista) della resistenza armata abbia ridimensionato,
stravolto ed escluso, fino quasi a tacerla, la presenza femminile”,
e dimostrano il ruolo rilevante occupato dalle donne nella lotta
al nazifascismo. Sia nelle formazioni combattenti in cui –
contrariamente alla vulgata corrente – ricoprirono
spesso posizioni di grande responsabilità. Sia nelle
diverse forme di “resistenza civile”, come, ad esempio,
negli scioperi che tra il marzo 1943 e la primavera del 1945
minarono alla base il consenso di cui fino ad allora il regime
sembrava godere anche tra le classi popolari; nella mobilitazione
a sostegno dei giovani renitenti alla leva, degli ebrei, degli
internati e confinati politici, degli ex prigionieri alleati;
nelle manifestazioni di piazza contro la guerra e il carovita.
Dalle testimonianze di queste donne emerge con forza la rivendicazione
del fatto che la partecipazione alla lotta contro il nazifascismo
avesse rappresentato per loro anche un atto di rivolta contro
il ruolo di “angelo del focolare” in cui la Chiesa
e il fascismo le avevano confinate. E l'amarezza per il fatto
che i loro stessi compagni, a guerra finita, avessero tentato
– più o meno consciamente – di costringerle
ancora una volta in ruoli subalterni.
E gli anarchici?
Flores e Franzinelli citano – è vero – alcune
luminose figure di libertari. Camillo Berneri, di cui ricordano
la presenza determinante tra le fila degli antifascisti accorsi
in Spagna a combattere il franchismo nel 1936; Gino Manetti,
antifascista irriducibile, prelevato dal carcere delle Murate
a Firenze e fucilato dai fascisti il 2 dicembre 1943; Italo
Cristofoli “Aso”, comandante del battaglione Garibaldi
“Carnia”, morto durante l'assalto a una caserma
della milizia fascista a Sappada (Belluno) il 27 luglio 1944;
Renato Perini, comandante della colonna Giustizia e Libertà
fucilato dai tedeschi a Adelano di Zeri (Massa Carrara) il 21
gennaio 1945 insieme ai due figli, Giocondo e Emilio. Manca
però una ricostruzione, sia pure sintetica, del ruolo
complessivamente svolto dagli anarchici nella resistenza al
fascismo. Eppure – come è ormai ampiamente documentato
– questa presenza, soprattutto nelle zone di tradizionale
radicamento del movimento libertario, è stata tutt'altro
che marginale.
Ivan Bettini
Musica/
La banda, un laboratorio di uguali
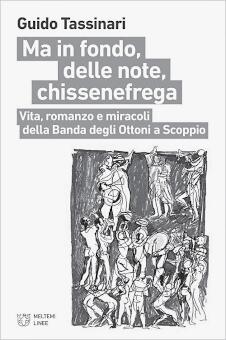 Chiunque
abbia vissuto a Milano tra la metà degli anni '80 e oggi
non può non aver incontrato, almeno una volta, la “Banda
degli Ottoni a Scoppio”, un collettivo di pittoreschi
musicisti di ogni età che imbracciano gli strumenti in
piazza come gesto di azione politica. Probabilmente li avrete
visti a un corteo, un presidio, una commemorazione, magari un
funerale, come quello di Dario Fo in piazza Duomo. Fo, infatti,
era amico degli Ottoni, che furono ritratti in uno degli acquerelli
da lui presentati alla cerimonia di consegna del Nobel, oltre
a Franca Rame, Jannacci, Ivan Della Mea, Primo Moroni e il gastronomo
Luigi Veronelli. Potreste aver visto la banda in tv, insieme
a Giorgio Bracardi, oppure nel film Aprile di Nanni Moretti. Chiunque
abbia vissuto a Milano tra la metà degli anni '80 e oggi
non può non aver incontrato, almeno una volta, la “Banda
degli Ottoni a Scoppio”, un collettivo di pittoreschi
musicisti di ogni età che imbracciano gli strumenti in
piazza come gesto di azione politica. Probabilmente li avrete
visti a un corteo, un presidio, una commemorazione, magari un
funerale, come quello di Dario Fo in piazza Duomo. Fo, infatti,
era amico degli Ottoni, che furono ritratti in uno degli acquerelli
da lui presentati alla cerimonia di consegna del Nobel, oltre
a Franca Rame, Jannacci, Ivan Della Mea, Primo Moroni e il gastronomo
Luigi Veronelli. Potreste aver visto la banda in tv, insieme
a Giorgio Bracardi, oppure nel film Aprile di Nanni Moretti.
Oggi finalmente la storia di questo strano “esperimento
sociale”, la banda che dà voce a chi non ce l'ha,
viene narrata in un libro scritto da un membro del gruppo (Guido
Tassinari, Ma in fondo, delle note, chissenefrega. Vita,
romanzo e miracoli della Banda degli Ottoni a Scoppio, Meltemi,
Sesto San Giovanni – Mi 2020, pp. 230, € 18,00),
assemblando in coro le voci dei protagonisti, così da
ricostruire un puzzle che è memoria collettiva e che,
grazie al tono ironico quando non tragicomico, riesce a snocciolare,
tra un sorriso e l'altro, anche profonde riflessioni sul contemporaneo.
“Quando ancora non c'erano i carri dei centri sociali,
portare il motocarro con la banda in giro per la manifestazione
fu un'idea fantastica”. E fu così che diventò
prassi tra mille occasioni, legali e illegali, organizzate e
improvvisate: una performance contro la guerra del Golfo, un
alzabandiera contro la guerra in Serbia, raduni di bandisti
(le cosiddette “sbandate”), lotte per la casa, cortei
alla frontiera in sostegno dei migranti, presidi anti-sgombero,
concerti fuori e dentro le carceri, per il Telefono Viola, gli
operai, il G8 di Genova, i cortei NoTav, e poi ancora viaggi
in Europa, spedizioni umanitarie a Cuba, in Palestina, a Sarajevo,
fino alla creazione di “Unza!”, un'associazione
per musicisti di strada stranieri prevalentemente di etnia rom.
La lista degli spazi occupati che hanno ospitato le prove degli
Ottoni prima del ventennale sodalizio con la Cascina Torchiera
include l'occupazione pre-Cox18 del cosiddetto “acquario”
di porta Genova, Sqott di Viale Bligny, casa Gorizia, circolo
Torricelli, Leoncavallo... Tutti sono stati contagiati dalla
loro singolarità: “La Banda, un laboratorio di
uguali. Esperimento collettivo, pluralismo, trasversalità,
rendere divertente la noia politica.” E in molti hanno
capito che la loro unicità risiede nella modalità,
fuori dalle comuni concezioni di tempo e spazio, con cui l'impegno
è profuso collettivamente: “Fu fondamentale, nel
senso più stretto, l'esperienza di quel collettivo musicale
e politico: le discussioni che mi aprivano la testa, il modo
di suonare, libero e collettivo. [...] Suonare in banda non
era suonare fine a se stesso, ma aderire a un modo di partecipare
alla vita sociale. [...] Sono le stesse cose che faresti da
solo ma che da solo non puoi fare: suoni e intorno ci sono gli
altri, suonano con te, e il risultato diventa energia. Vai alla
manifestazione e magari c'è un momento in cui la tensione
si alza e la Banda passa avanti per evitare che tutto scoppi
e tu ti trovi lì di fronte ai poliziotti, rabbia, paura,
ma sempre gli altri intorno. [...] Quante volte, suonando stretti
tra la polizia in guerra e giovani incazzati che cercavano lo
scontro abbiamo fatto calare la tensione con interventi da clown”.
|
| La
Banda degli Ottoni a Scoppio durante la “Sbandata”
(festa popolare della musica), 2003
foto di Danilo kiver Borrelli |
|
| La
Banda degli Ottoni a Scoppio, manifestazione contro Expo 2015
foto di Danilo kiver Borrelli |
|
| La
Banda degli Ottoni a Scoppio, la “Sbandata” del 2003
foto di Danilo kiver Borrelli |
Una di queste volte, purtroppo, non ce l'hanno fatta e, nonostante
il video che sembra scagionarli, due membri della Banda sono
attualmente sotto processo per fatti accaduti il giorno della
prima della Scala il 7 dicembre 2014, nel pieno della protesta
contro Expo 2015. Chiunque sia interessato ad aggiornamenti
sulla situazione può visitare www.ottoniascoppio.org,
ma sicuramente l'acquisto di questo splendido libro è
il modo più immediato per sostenerli a distanza, oltre
che per rievocare delle storie che scopriremo essere un po'
nostre, e per regalarci dei momenti di semplice poesia: “Scoprii
lo spessore del collettivo politico del caos. Abbracciai la
causa dei militanti del rintronamento. Partecipai al tribale
lancio di vibrazioni scagliate nel petto della cittadinanza
inerme. Feci mia l'ideologia rivoluzionaria dell'assolo alcolico.
Camminai incordonato nelle fila della ribellione acustica. Risposi
con colpi e colpi ad altro genere di colpi e colpi; che la pelle
arrivasse a gridare. [...] La musica fatta insieme cambia la
vita! Fraternità! Iconoclastia!”
Tobia D'Onofrio
Contro l'auto/
Recuperiamo il (nostro) tempo
Forse è bene cominciare dall'ingombro: al momento per
il mondo circolano (o meglio, stanno soprattutto ferme al parcheggio)
circa un miliardo e 300 milioni di automobili. Moltiplicando
questo numero per l'area di un'auto di media grandezza, si ottiene
una cifra spaventosa – più o meno il doppio dello
spazio occupato dagli esseri umani. È solo uno dei dati
che riporta Andrea Coccia nel suo breve e incisivo pamphlet
Contro l'automobile (Eris, Torino 2020, pp. 64, €
6,00), il cui scopo iniziale è demistificare la retorica
pubblicitaria sulle autovetture, con i suoi valori di “velocità,
avventura, privilegio, libertà” – e con quelle
immagini tutte uguali di auto che sfrecciano solitarie su strade
ampie e sicure. “Insomma”, scrive l'autore, “ci
hanno convinti che la nostra libertà e la nostra possibilità
di essere felici siano legate a qualcosa che, in realtà,
è più simile a una prigione che a un vettore di
libertà”.
 Naturalmente
non si tratta solo di persuasione occulta: sarebbe una spiegazione
troppo schematica e comunque non più applicabile alla
situazione odierna, dove il dominio dell'auto si basa su decisioni
politiche e urbanistiche di amplissimo raggio: il modo in cui
abitiamo, mangiamo, condividiamo esperienze è ormai influenzato
per intero da tale mezzo di trasporto. Che con la sua diffusione
planetaria “passa dall'essere una rivoluzione, una comodità
e quasi un lusso, all'essere una prigione, una condanna, una
schiavitù. Se tutti si muovono, nessuno si muove.” Naturalmente
non si tratta solo di persuasione occulta: sarebbe una spiegazione
troppo schematica e comunque non più applicabile alla
situazione odierna, dove il dominio dell'auto si basa su decisioni
politiche e urbanistiche di amplissimo raggio: il modo in cui
abitiamo, mangiamo, condividiamo esperienze è ormai influenzato
per intero da tale mezzo di trasporto. Che con la sua diffusione
planetaria “passa dall'essere una rivoluzione, una comodità
e quasi un lusso, all'essere una prigione, una condanna, una
schiavitù. Se tutti si muovono, nessuno si muove.”
In effetti la realtà quotidiana è quella che ogni
pendolare conosce: una rabbiosa colonna di autovetture che procedono
lente (”la velocità media di una automobile in
Italia in questo momento è 29 km/h, e non certo in città”),
inquinando terribilmente, isolandoci e causando tremila morti
al giorno. Il tutto con costi enormi in proporzione all'uso,
sia per quanto riguarda l'acquisto che la manutenzione.
Come siamo finiti così? Coccia ricostruisce in poche
pagine la “cospirazione della General Motors”, un
grande piano d'assalto alla mobilità pubblica affinché
sia sostituita dal traffico su gomma. A restare colpita innanzitutto
è la rete ferroviaria, il che contiene “un dettaglio
politico che ha uno sfondo inquietante e quasi militare. Marginalizzare
e in molti casi smantellare il tessuto ferroviario significa
anche smantellare un tessuto sociale e politico tra i più
forti del Novecento. Colpire i ferrovieri, in particolare, che
erano per lo più socialisti e anarchici, significa colpire
al cuore un movimento, quello del sindacalismo anarchico che
portava avanti istanze comunitariste, federaliste e autonomiste,
esattamente opposte a quelle individualiste, nazionaliste e
centraliste degli Stati Nazione, ovvero i principali finanziatori
dell'industria automobilistica”. È appena il caso
di ricordare che una delle figure più luminose e tragiche
del movimento anarchico italiano fu proprio un ferroviere: Pino
Pinelli.
In sintesi, annota Coccia, “l'automobile è il cuore
pulsante del capitalismo”: dopo aver duramente colpito
il trasporto collettivo e iniziato la sua escalation, contribuisce
a polverizzare il tessuto sociale delle piccole e grandi città;
e nell'odio istintivo di ogni guidatore per tutti gli altri
– che lo ostacolano e lo rallentano – si riflette
lo stile di pensiero individualista, per cui il cittadino è
un concorrente o un nemico. Come accennato, inoltre, l'avvento
dell'auto di massa ha pesantissime ricadute sull'abitare: “L'idea
delle banlieue e delle cinture residenziali suburbane infatti
non sarebbe mai stata possibile senza l'esistenza e l'accesso
di massa all'automobile. I nuclei residenziali satelliti alle
grandi città [...] senza l'auto non avrebbero il minimo
senso.”
Nascono quei luoghi anonimi, a metà fra grande parcheggio
e dormitorio, dove è estremamente difficile creare connessioni
politiche – innanzitutto perché i luoghi di connessione
umana su base quotidiana sono scomparsi. È qui che la
battaglia all'automobile (che tende a divorare qualsiasi possibilità
alternativa di movimento) diventa molto complessa.
Sono cresciuto e ho vissuto per molti anni in un posto del genere,
a una ventina di chilometri da Milano, dove per svolgere gran
parte delle attività l'auto era già indispensabile
nei primi anni Novanta. Eppure l'ho visto anche peggiorare:
l'aumento delle strade e dei parcheggi, i piccoli negozi soffocati,
l'automatismo del recarsi ai centri commerciali, l'assurdità
di prendere l'auto anche solo per fare cinquecento metri. Così
il corto-circuito si alimenta senza fine.
Coccia peraltro è molto consapevole: “Un mondo
in cui le auto sono poche è semplicemente impossibile”,
scrive. “Fuori dalle grandi città la situazione
è disperata. Il mondo è pieno di angoli pensati
esclusivamente per le automobili”. Battere continuamente
il tasto sull'iniziativa individuale rischia di deprimere più
che alimentare le possibilità rivoluzionarie, perché
pretendere molto da sé – benché importante
– non basta per opporsi allo stato di cose globale. Come
ha scritto Colin Ward nel suo magnifico Dopo l'automobile
(elèuthera), nume ispiratore del libro di Coccia, “Il
possesso di un'auto comporta troppi vantaggi per troppe persone
perché si possa pensare di lanciare una campagna puramente
politica per il suo abbandono. Non si può «disinventare»
la macchina.”
E allora? Allora la ricetta è sempre la stessa: lavorare
per un movimento sociale il più ampio possibile capace
di confrontarsi col vero cuore del problema. A questo punto
il saggio di Coccia si fa molto acuto, procedendo verso il suo
scopo finale e militante: invece di combattere direttamente
le automobili, combattiamole indirettamente recuperando il nostro
tempo. Il tempo è la chiave: “lottiamo [...] per
far diventare l'atto di spostarsi qualcosa che sia legato soltanto
alla nostra scelta e non all'obbligo di presentarsi in un luogo
di lavoro come se fosse una caserma dove firmare per la propria
libertà vigilata. Pretendiamo il telelavoro ovunque sia
possibile, ma non per starcene ognuno nella propria stanza davanti
al proprio computer esasperando ancora di più quella
solitudine esistenziale di cui l'auto è il simbolo semovente
e su cui basa il suo dominio.”
Solo una chiosa: tale invito è quanto mai benvenuto,
ma anche più facilmente realizzabile, per i vari professionisti
del terziario; per chi lavora nel vasto campo della produzione
o della manifattura – dai campi alle fabbriche –
le cose sono assai più difficili. Ma sul loro bisogno
di una mobilità sostenibile e comunitaria si gioca la
parte più radicale della lotta.
Giorgio Fontana
Pippa Bacca/
Sogni di candore e di bellezza
Se si pensa al macellaio di guerra e al violatore dei diritti
umani che negli ultimi dieci anni è diventato il rais
turco Recep Tayyip Erdoğan, fa un certo effetto vederlo
nel nuovo docu-film di Simone Manetti, Sono innamorato di
Pippa Bacca (2019), quando nelle vesti di primo ministro
manifestava pubblicamente il proprio cordoglio e la condanna
per la violenza con cui era stata ammazzata Giuseppina Pasqualino
di Marineo, in arte Pippa Bacca. E sempre dal nuovo lavoro di
Manetti, sono un brivido lungo la schiena quelle sequenze iniziali
che mostrano le immagini di un matrimonio girate proprio con
la videocamera dell'artista milanese portata via dal suo assassino
(sta scontando una pena di trent'anni).
Doveva arrivare in questi giorni nelle sale il lavoro del quarantunenne
regista livornese, ma la serrata a cui è stata sottoposta
tutta la cultura italiana per il virus Covid-19 ne ha procrastinato
l'uscita a data da destinarsi.
Il film di Manetti giunge dopo che a Pippa Bacca, stuprata e
uccisa nel marzo di dodici anni fa, sono stati dedicati i brani
E se poi di Malika Ayane e Velo di sposa dei Radiodervish,
due opere letterarie e un giardino recentemente inaugurato a
Milano.
Sullo schermo viene ricostruita la vita dell'artista e il suo
ultimo viaggio-performance fatto in abito da sposa per simboleggiare
il matrimonio tra le genti. Ma il docu-film vuole essere pure
un attestato di gratitudine verso un'artista sì bizzarra
ma speciale, una visionaria che sognava un mondo-altro, eretto
anche col contributo dell'arte e inondato di candore e bellezza.
Nata a Milano nel 1974, nipote di Piero Manzoni (la madre è
la sorella del noto creatore delle boîtes di cacca
d'artista), l'8 marzo del 2008 Pippa Bacca, insieme a un'altra
performer, Silvia Moro, partì dal capoluogo lombardo
per dar vita al tour “Spose in viaggio”. Vestite
da abito nuziale su delle scomodissime scarpe coi tacchi, Pippa
e Silvia si proposero di percorrere in autostop circa seimila
chilometri fino a Gerusalemme (“la città a cui
salgono le tribù del Signore”) passando per le
terre martoriate dalla guerra dell'ex-Jugoslavia, Bulgaria,
Siria, Libano, Egitto, Giordania e Cisgiordania. Una performance-viaggio
che voleva essere il lancio di un messaggio di pace o, come
dichiarò alla partenza la stessa Pippa Bacca: “È
un modo per affidarsi al prossimo, dimostrare che dando fiducia
si riceve solo bene”.
Purtroppo accadde che, quando le due amiche si separarono prevedendo
di ritrovarsi di nuovo insieme a Beirut, Pippa prese il passaggio
sbagliato e il 31 marzo il suo corpo venne trovato senza vita
in un bosco di Gebze, cittadina a una cinquantina di chilometri
da Istanbul. Sulle testimonianze di Silvia Moro e di amici,
sul ricordo della madre, delle quattro sorelle e sulle immagini
girate con la videocamera dalla stessa artista, Simone Manetti
riesce a riportare sullo schermo il coraggio, la purezza, la
vita tutta che si è lasciata passare addosso la giovane
donna.
Dal film – che chiede allo spettatore un occhio complice
– è giovevole ritrovare la Pippa Bacca coraggiosa,
perennemente in stato di grazia per indicare il viatico di un'arte
sviante le convenzioni, fare di ogni suo atto creativo una scelta
d'amore per qualcosa, per qualcuno.
Mimmo Mastrangelo
I media digitali e noi/
Una fame ossessiva di identità
La storia degli ultimi 40 anni ci ha lasciato in eredità
un deserto sociale privo di punti di riferimento che ha impoverito
e rimpicciolito il nostro mondo relazionale, condannandoci a
un radicale isolamento narcisistico. Questo mondo, attraversato
dal richiamo scomposto al godimento consumistico, è supportato
e alimentato da un capitalismo digitale senza scrupoli che,
sorvegliandoci, alimenta la nostra costitutiva instabilità
per assicurarsi un'adeguata produzione di dati. Dati che, opportunamente
analizzati, ci trasformano in target pubblicitari o elettorali
da vendere al miglior offerente.
È questa la tesi di fondo del saggio del giornalista
Pablo Calzeroni, Narcisismo digitale. Critica dell'intelligenza
collettiva nell'era del capitalismo della sorveglianza (Mimesis,
Sesto San Giovanni – Mi 2020, pp. 144, € 10,00).
È una tesi che riprende la critica, ormai nota da diversi
anni, della grande utopia libertaria dell'intelligenza collettiva
formulata negli anni Novanta del secolo scorso. La novità
è che quell'utopia viene qui decostruita – con
strumenti filosofici, sociologici e psicoanalitici – per
problematizzare la relazione tra il piano di immanenza del capitale
e l'enigma della macchinizzazione dell'umano.
L'idea che la digitalizzazione stesse per portarci verso un
pensiero collettivo distribuito tra noi e le macchine, come
riteneva Pierre Lévy insieme ad altri esponenti del partito
del determinismo tecnologico, è oggi un nonsense
di fronte a un medium digitale integrato infarcito di fake
news, spionaggio, odio, cyberbullismo. Invece di liberarci
dal messaggio allucinatorio dei mass media analogici, la digitalizzazione
della comunicazione ha mostrato la nostra radicale fragilità
e la nostra incapacità di elaborare, al contempo, una
progettualità esistenziale personale e un pensiero di
specie. Al posto di un'intelligenza collettiva ha preso corpo,
senza che ce ne accorgessimo, un'inquietante intelligenza tecnico-algoritmica,
nel senso di efficiente, che ora governa, sregolandolo sempre
di più, il nostro rapporto malato con la vita e con l'ambiente.
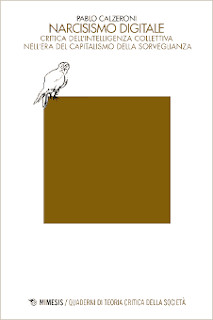 Ciò nonostante, come fa notare Calzeroni riprendendo
alcune tesi di Morozov, l'utopia tecno-razionalista “ritorna”
puntualmente, con lo stesso entusiasmo del passato, quando,
ad esempio, consideriamo la “liberazione digitale”
e il protagonismo del singolo attivista armato di smartphone
fattori strategicamente determinanti in un qualsiasi processo
rivoluzionario, in Egitto come in Iran. Oppure quando, a casa
nostra, ci affidiamo agli slogan del cyberpopulismo pentastellato
in nome di una fantomatica cyberdemocrazia diretta senza più
distinzione tra amministratori e amministrati. O ancora quando,
come capita in certe letture sovversive dell'economia politica,
poniamo aprioristicamente l'accento sul potere costituente del
lavoro vivo immateriale, già di per sé orientato
– se non ci fosse di mezzo lo zampino del capitale –
a una razionale (nel senso di organizzata e organizzabile) cooperazione
intersoggettiva.
Ciò nonostante, come fa notare Calzeroni riprendendo
alcune tesi di Morozov, l'utopia tecno-razionalista “ritorna”
puntualmente, con lo stesso entusiasmo del passato, quando,
ad esempio, consideriamo la “liberazione digitale”
e il protagonismo del singolo attivista armato di smartphone
fattori strategicamente determinanti in un qualsiasi processo
rivoluzionario, in Egitto come in Iran. Oppure quando, a casa
nostra, ci affidiamo agli slogan del cyberpopulismo pentastellato
in nome di una fantomatica cyberdemocrazia diretta senza più
distinzione tra amministratori e amministrati. O ancora quando,
come capita in certe letture sovversive dell'economia politica,
poniamo aprioristicamente l'accento sul potere costituente del
lavoro vivo immateriale, già di per sé orientato
– se non ci fosse di mezzo lo zampino del capitale –
a una razionale (nel senso di organizzata e organizzabile) cooperazione
intersoggettiva.
L'errore, in questi casi, è dovuto a due sviste diverse.
La prima è quella di considerare il “progresso”
tecnologico come il vero motore della storia, senza minimamente
tener conto della realtà dei conflitti sociali che lo
intersecano. La seconda, riferita in particolare alla scuola
di pensiero critico materialista in salsa post-operaista o accelerazionista,
è quella di non riuscire a interpretare correttamente
il sintomo che si rende evidente negli scambi comunicativi,
ovvero il malessere del soggetto, la sua destabilizzazione.
L'essere umano contemporaneo è stato singolarizzato e
scollegato dalla dimensione sociale che dovrebbe costituirlo
al punto da diventare ingovernabile, chiuso in se stesso, preda
di patologie narcisistiche che nascondono il suo bisogno di
equilibrio. In termini psicoanalitici, l'autore ritiene che
la realtà esterna sia diventata una terra arida e inospitale
che impedisce all'individuo di trovare accesso all'altro e di
elaborare, attraverso l'altro, un limite in grado di dare un
senso erotico alla propria corporeità.
Il soggetto è oggi annegato nel suo delirio narcisistico
e allo stesso tempo è costantemente bersagliato da un
potere biopolitico che ha messo a nudo la propria carica iper-repressiva
e autoritaria proprio per il fatto di non essere più
in grado di penetrarlo e riprodurlo. Ne consegue che l'intelligenza
algoritmica estrae valore dalle nostre vite in due modi contrapposti
e paradossalmente complementari: da una parte le organizza in
modo asfissiante quando siamo al lavoro, come ci ha mostrato
Ken Loach nel film Sorry we missed you, dall'altra amplifica,
sul lavoro e fuori dal lavoro, la nostra destabilizzazione interna,
capitalizzando la nostra ricerca incessante e mortifera di oggetti
e performance di godimento. Oppure amministrando la nostra fame
ossessiva di identità, tesoro di ricchezza e fortuna
per gli spin doctor della politica più reazionaria.
Dopo la pars destruens, l'autore suggerisce una possibile
soluzione riprendendo il concetto di immaginario di Castoriadis,
sospeso tra le potenze creative individuali e le forze sociali-storiche
collettive: per uscire dall'incubo della desoggettivazione non
resterebbe altro che tornare al centro propulsivo della nostra
vita, la corporeità, cercando di rovesciare la virtualità
dissipativa del nostro immaginario antisociale che tende a imbrigliarla
nei modi sregolati offerti dal capitale. Occorrerebbe allora
scendere in strada, creare occasioni di incontro e confronto,
tornare nelle piazze, partecipare ad assemblee. E lì
sperimentare nuovi modelli societari inclusivi che possano permetterci
di avere cura, nel nostro essere elementi di un più vasto
ecosistema, della nostra socializzazione e del nostro godimento.
“Le tecnologie di per sé non ci salveranno”,
conclude Calzeroni. L'unica possibilità che abbiamo è
quella di metterci in gioco, fisicamente, e nel gioco collettivo
trovare nuovi ordini aperti e vitali in grado di arginare le
forze entropiche dello sfruttamento.
Eugenia Lentini
Il mutuo appoggio/
Attualità di un'idea e di una prassi
La giornalista Rebecca Solnit, considerata in molti ambienti
come l'erede di Susan Sontag, in un suo importante lavoro di
storia dei disastri che hanno segnato la contemporanea vita
di milioni di americani (del nord e del sud), così si
esprime: «Mutuo appoggio si opponeva a un'intera
visione del mondo [...] Kropotkin mise in dubbio le basi di
questa visione del mondo [...] Kropotkin mostra in modo meraviglioso
come la collaborazione e non la competizione possa essere fondamentale
ai fini della sopravvivenza».
Nel libro Un paradiso all'inferno del 2009 questa acuta
scrittrice ci dice che la storia dei disastri dimostra che per
la maggior parte siamo animali sociali alla ricerca famelica
di legami solidali. Nel sostenere questo, Solnit ci conduce
dentro alcuni tragici accadimenti che hanno segnato drammaticamente
la vita e la morte di milioni di persone per evidenziare come
sia proprio questa forza straordinaria di mutuo aiuto, di solidarietà,
di condivisione, di auto-organizzazione, in grado di sostenere
concretamente la vita delle persone, molto di più e molto
più efficacemente di ogni organizzazione formale e burocratizzata.
E grande importanza la nostra scrittrice assegna proprio a questa
idea di mutuo appoggio che Pëtr Kropotkin ha così
ben sintetizzato nel suo importante e basilare libro, di cui
esce proprio in questo periodo la prima traduzione italiana
(a cura di Giacomo Borella) direttamente dalla lingua inglese
(in cui era stato scritto): Pëtr Kropotkin, Il mutuo
appoggio. Un fattore dell'evoluzione (Elèuthera,
Milano 2020, pp. 392, € 20,00).
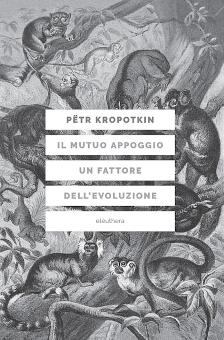 Perché
è fondamentale, oggi più che mai, leggere e riflettere
su questo scritto del grande rivoluzionario anarchico russo?
Perché, a mio modo di vedere, in esso sono contenuti
importanti considerazioni, significative intuizioni, e soprattutto
tante tracce di possibili sviluppi organizzativi concreti e
di prospettiva etica, quanto mai urgenti in questa tragica epoca. Perché
è fondamentale, oggi più che mai, leggere e riflettere
su questo scritto del grande rivoluzionario anarchico russo?
Perché, a mio modo di vedere, in esso sono contenuti
importanti considerazioni, significative intuizioni, e soprattutto
tante tracce di possibili sviluppi organizzativi concreti e
di prospettiva etica, quanto mai urgenti in questa tragica epoca.
Kropotkin pubblica una serie di articoli (tra il 1890 e il 1896)
nella rivista inglese “Nineteeth Century”, per confutare
le tesi sostenute dal biologo Thomas Huxley che trasponeva la
teoria della lotta per l'esistenza di Darwin alla vita della
società umana (il darwinismo sociale e l'eugenetica).
Gli stessi articoli costituiranno poi gli otto capitoli del
libro che sarà editato nel 1902, Mutual Aid. A Factor
of Evolution (London).
Kropotkin, oltre ad aver dedicato la sua vita alla militanza
politica anarchica, rappresenta la figura del savant
(sapiente), un intellettuale che oggi diremmo in qualche modo
olistico, in quanto volgeva lo sguardo alla realtà
in modo multi, inter e trans-disciplinare: era infatti geografo,
zoologo, antropologo, filosofo, biologo, sociologo, storico.
Il suo tentativo è stato quello di descrivere, per valorizzarle
in senso libertario, le pratiche di mutuo aiuto e di cooperazione
presenti in tutti gli esseri viventi (dai microrganismi ai vegetali,
dalle varie specie animali fino agli esseri umani). Sforzo titanico
sicuramente, ma che intanto mette in evidenza come la conoscenza
vera e profonda non possa risolversi nella specializzazione
fine a se stessa ma si debba nutrire di una varietà di
sguardi e di approcci, nel quadro di una fondamentale visione
etica che si nutre anche di un metodo scientifico, mai però
assolutizzato in direzione autoritaria e divinizzata. Una conoscenza
che proprio perché autenticamente scientifica cerca conferme
continue nella realtà senza piegare la stessa ai propri
dogmi aprioristici o rispondere a interessi specifici e spesso
corrotti.
Un secondo insegnamento che possiamo trarre da queste pagine
è che la rappresentazione che il dominio ci continua
a imporre (che si nutre della massima secondo cui a prevalere
è la legge del più forte e che la competizione
è il fattore principale del progresso), viene smentita
in modo evidente da uno sguardo obliquo rispetto a quello del
Potere. Kropotkin capovolge questa visione del mondo che ha
reso tossico il nostro pianeta e i nostri rapporti sociali,
a favore della valorizzazione di pratiche di auto-organizzazione
e di mutuo appoggio che rappresentano l'unica vera e possibile
alternativa. Questo aspetto si rivela particolarmente importante
oggi, ma rappresenta anche la base su cui ricostruire nuove
forme di socialità e nuove configurazioni organizzative.
Solo una vera sperimentazione di altri modi di vivere può
sminuire la rappresentazione autoritaria delle relazioni umane,
solo l'esempio può smontare un immaginario deleterio
e avvilente e far trionfare la nostra scelta etica.
Un altro elemento significativo che giustifica la lettura e
l'approfondimento di questo libro è rappresentato dalla
sua portata generale e complessa che gli è oggi riconosciuta
da diversi studiosi in molteplici ambiti disciplinari. Stefano
Mancuso, neurobiologo vegetale di fama internazionale, riconosce
proprio nel pensiero di Kropotkin ciò che è oggi
più che mai utile per comprendere il mondo vegetale,
la sua straordinaria varietà, il suo significato per
la vita di ogni essere vivente. Osservando la miriade di relazioni
che governano i sistemi naturali noi troviamo proprio il mutuo
appoggio come fondamento della interazione tra le varie piante.
Questa prospettiva, oltreché ecologica ante-litteram,
è anche priva di quell'antropocentrismo che concorre
a determinare le catastrofi e i disastri a cui assistiamo impotenti.
Primatologi della fama di Frans de Waal e biologi evoluzionisti
come Stephen Jay Gould hanno messo in evidenza come tra gli
esseri animali (uomo compreso) lo stile cooperativo che conduceva
al mutuo aiuto, non solo predominava in generale, ma caratterizzava
le creature più avanzate di ogni gruppo: le formiche
tra gli insetti, i mammiferi fra i vertebrati. Il mutuo aiuto
diventava perciò un principio più importante della
competizione e della strage per ogni società che si potesse
sostenere. Riconoscendo il loro debito nei confronti di Kropotkin
questi studiosi hanno argomentato, con ulteriori ricerche, quanto
la lotta per l'esistenza non sia tanto del singolo individuo
contro tutti gli altri ma dell'insieme degli organismi contro
un ambiente ostile. Piante, animali, e persino microrganismi
come le cellule eucariote (come ha dimostrato Lynn Margulis)
fondano la loro esistenza e la loro vita evolutiva sul mutuo
appoggio (simbiosi).
Questi, e molti altri, contributi che provengono da studiosi
diversi non fanno che confermare che quanto sostenuto da Kropotkin
è vero. Ma ciò che maggiormente ci interessa è
l'aspetto etico che emerge da tutta questa teoria evolutiva.
Vale a dire che, leggendo il corso dello sviluppo storico, possiamo
trovare tra gli esseri umani utili insegnamenti per progettare
e soprattutto sperimentare un altro modo di vivere. I contributi
antropologici che hanno voluto cercare esempi di un'organizzazione
sociale basata su fondamenti libertari sono diversi e interessanti
ed è qui impossibile ricordarli. Il mutuo appoggio allora
diventa non solo un modo per soddisfare le esigenze della vita
(integralmente intesa) molto più appropriato della competizione
e della guerra ma, a mio modo di vedere, anche il fine verso
cui tendere nell'immaginare una società diversa.
L'insegnamento che possiamo trarre dal punto di vista complessivo
è dunque molto significativo, soprattutto oggi, in questa
epoca tragica e pericolosa, il monito che si evidenzia nelle
pagine di questo testo può essere utile riferimento per
le nostre azioni qui e ora. Parole di saggezza e al contempo
di incitamento all'azione libertaria sono più volte espresse
nel corso del libro: «A meno che gli uomini non siano
resi folli sui campi di battaglia, essi non possono sentir chiedere
aiuto e non rispondere [...] Tutte queste associazioni, società,
confraternite, unioni, istituti, e così via, che oggi
si contano a decine di migliaia nella sola Europa, ognuna delle
quali rappresenta una quantità immensa di lavoro volontario,
disinteressato, gratuito o poco pagato, che cosa sono se non
altrettante manifestazioni, in un'infinita varietà di
forme, della stessa tendenza sempre viva nell'uomo verso l'aiuto
reciproco e il mutuo appoggio?» (pp. 321-325).
Una prospettiva, questa, indicataci in queste pagine, che possiamo
fare nostra e trasformare in un nuovo stimolo all'azione tenendo
conto (anche) delle riflessioni sui grandi temi che vengono
affrontati e che qui sono stati solo parzialmente enunciati.
Trovare le risposte organizzative autonome secondo un modello
antiautoritario è il modo più efficace per rendere
inutile la presenza dello Stato.
Francesco Codello
Memoria anarchica/
Quella fiaccola empolese
Empoli, città metropolitana di Firenze, 49.871 abitanti.
Una delle tante città toscane, siano esse capoluogo di
provincia o meno, che costituiscono parte importante di una
regione – la Toscana, appunto – in cui la presenza
delle idee e delle attività anarchiche affonda le proprie
origini agli inizi della storia del movimento socialista, operaio
e contadino. Una storia di un secolo e mezzo, che dalle origini
della Prima Internazionale (Rimini, 1872) arriva ai giorni nostri,
senza soluzione di continuità rispecchiando le grandi
vicende nazionali (la nascita dei sindacati, la prima guerra
mondiale, il fascismo e la multiforme opposizione, la Resistenza,
il secondo dopoguerra, la strategia della tensione, il terrorismo,
ecc.) sempre con una forte connotazione locale, con un radicamento
e una passionalità particolari.
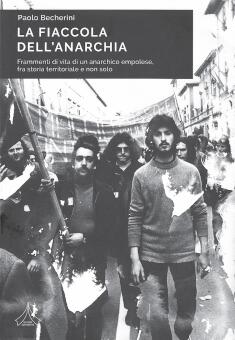 Va
dato grande merito all'amico fraterno e militante anarchico
Paolo Becherini (Empoli, 1956) di aver pubblicato, a proprie
spese, con la curatela della figlia Emma, questo librone (La
fiaccola dell'anarchia, Edizioni autogestite, Empoli 2019,
pp. 512, € 20,00) ricchissimo di foto, manifesti, volti,
manifestazioni. La vita militante di Paolo è la ragione
e il collante di queste pagine, che pur strettamente legate
appunto all'impegno militante di un singolo, non indulgono ad
alcun autoreferenziale personalismo, ma si proiettano sul territorio,
ad Empoli innanzitutto, ma anche in tante cittadine e borghi
circostanti delle campagne e colline circostanti, tra l'Arno
e l'Arbia, verso Firenze, Siena, Prato, Pistoia. Una bella terra,
che tante volte percorsi negli anni '70 quando quasi in ogni
paese c'era almeno un compagno, a volte un piccolo collettivo,
un gruppetto anarchico, un collettivo di donne. Va
dato grande merito all'amico fraterno e militante anarchico
Paolo Becherini (Empoli, 1956) di aver pubblicato, a proprie
spese, con la curatela della figlia Emma, questo librone (La
fiaccola dell'anarchia, Edizioni autogestite, Empoli 2019,
pp. 512, € 20,00) ricchissimo di foto, manifesti, volti,
manifestazioni. La vita militante di Paolo è la ragione
e il collante di queste pagine, che pur strettamente legate
appunto all'impegno militante di un singolo, non indulgono ad
alcun autoreferenziale personalismo, ma si proiettano sul territorio,
ad Empoli innanzitutto, ma anche in tante cittadine e borghi
circostanti delle campagne e colline circostanti, tra l'Arno
e l'Arbia, verso Firenze, Siena, Prato, Pistoia. Una bella terra,
che tante volte percorsi negli anni '70 quando quasi in ogni
paese c'era almeno un compagno, a volte un piccolo collettivo,
un gruppetto anarchico, un collettivo di donne.
Tanta gente, complessivamente, tipi del '68 e anni immediatamente
successivi, parte di quella generazione – come me –
affacciatasi in quegli anni all'impegno politico. Ma in questa
calda terra toscana, con forti analogie con altre regioni del
Centro Italia (Umbria, Marche, Emilia Romagna) l'antica e profonda
tradizione del movimento socialista e libertario, contadino
e operaio, offriva la presenza meravigliosa di (ancora) tante
anarchiche e anarchici, libertari che nelle iniziative pubbliche
indossavano il fiocco alla Lavaliere, si vestivano bene, amavano
l'opera.
Il libro del nostro Paolo per me, che negli anni '70 più
volte partecipai nella sede anarchica empolese a riunioni dei
Gruppi Anarchici Toscani, ma anche ad Empoli andai con mio suocero
Alfonso Failla a trovare Oberdan Degli Innocenti – chi
non lo conosceva in quel pezzo di Toscana libertaria? –
è un vero e proprio tuffo nella memoria. Ma anche per
chi più giovane non ha simili ricordi da Mesozoico, è
un quaderno di appunti freschi e densi di storia umana e politica
vissuta fino in fondo, nelle lotte per l'autogestione, le occupazioni,
la diffusione della stampa, il dibattito sulla violenza, le
conferenze e tante altre iniziative di cui Paolo è stato
(e rimane) allegro e inossidabile punto di riferimento.
Procuratevelo questo librone, bell'esempio di quanto tante altre
compagne e compagni della nostra generazione, dopo decenni di
presenza militante, potrebbero fare. Ma quasi nessuna/o di noi
l'ha fatto e ancora una volta val la pena citare quanto Gaetano
Salvemini disse ad Armando Borghi, per invitarlo a scrivere
la propria autobiografia (cosa che poi Borghi fece e in più
di un libro). “Se non la scrivete voi anarchici la vostra
storia, chi altro potrebbe farlo?”
Il gigantesco patrimonio di umanità, relazioni, attività,
contatti, tipi di persone che Paolo ha incrociato nel sua perdurante
militanza anarchica ci viene incontro attraverso la sua scrittura,
semplice, chiara, a tratti romantica come lo conosco da mezzo
secolo.
Il libro è acquistabile sul sito www.etsy.com.
Paolo Finzi
Libertà e potere/
I corpi al centro
Il libro di Arianna Sforzini Michel Foucault. Un pensiero
del corpo (Ombre Corte, Verona 2019, pp. 138, € 13,00)
focalizza una delle costanti analizzate da Foucault: il corpo,
tanto centrale quanto sottovalutato dai commentatori della sua
opera, come lamenta l'autrice. Un testo sintetico e ricco di
rimandi, efficace nello scandire gli sviluppi delle elaborazioni
del filosofo, storicizzati in maniera tanto minuziosa da evidenziarne
gli aspetti attuali. Le riflessioni e le battaglie sociali di
oggi attorno al genere; l'ingerenza di una bioetica che, attenendosi
alla metafisica e alla centralità dell'anima, sancisce
paradigmi che eludono il libero arbitrio, proprio laddove soltanto
ogni singola persona dovrebbe poter scegliere... perché
dare centralità al corpo significa comprendere quanto,
per ogni potere, esso funga da pretesto per instaurare verità
ipocrite e arroganti.
 “Nulla
è più materiale, nulla è più fisico,
più corporeo dell'esercizio del potere” (M. Foucault
in Microfisica del potere). “Nulla
è più materiale, nulla è più fisico,
più corporeo dell'esercizio del potere” (M. Foucault
in Microfisica del potere).
Corporeità saccheggiate, sottomesse, schiavizzate, segregate,
ingannate, recluse, represse, svilite a tal punto da essere
enumerate come “casi” per studi statistici, o annullate
d'individualità e massificate tanto da apparire incorporee.
Scrive Sforzini: “La filosofia di Foucault è uno
straordinario gioco eterotopico attraverso la storia, il
teatro dei corpi. Per Foucault, la realtà ha senso
solo a partire dalla scena dei corpi che, realizzando i diversi
giochi di verità, li imita, li caricaturizza, li trasfigura
e li contesta”. In questa teatralità emerge la
volontà di opposizione e mutamento: un'insubordinazione
che produce scandalo all'autoritarismo simbolico e lo smentisce.
E la trasformazione può impersonare l'utopia, perché
dal corpo si dipana il movimento, il linguaggio, l'energia,
il pensiero, il trucco, il desiderio di essere altro, o altrove,
per inoltrarsi in una progettualità che, sottraendosi
ai paradigmi, falsifica i regimi di verità.
Ecco che l'approccio di Foucault, risolvendo il dualismo anima/corpo,
pone sul piano della contestazione anche quello di psiche/corpo,
senza cadere nell'ambiguità del binomio mente/cervello.
La mente è energia, immaginazione: i corpi si appropriano
di una scena che spiazza gli artifici disciplinari. Foucault
si sofferma sulle isteriche, ricoverate da Charcot alla Salpêtrière
di Parigi a fine '800, che fecero fallire le declinazioni misogine
(l'isteria sarebbe stata causata da un'alterazione dell'utero)
proprio grazie alle loro doti di simulazione.
Così le streghe: catalizzarono sui loro corpi l'opposizione
all'espansione del potere ecclesiastico che, non a caso, si
servì anch'esso di costrutti misogini e crudeli applicando
torture per estorcere confessioni con epiloghi processuali platealmente
invasivi. Altro esempio: le possedute, attrici di una rappresentazione
fisiologica atta a rendere visibile la scacciata del “male”
tramite una gestualità diretta da un esorcismo maschile.
E fra questi corpi femminili in rivolta, come ben evidenzia
Sforzini, “la strega è un soggetto di diritto”
in quanto sceglie e rivendica quell'estraneità codificata
al patto con il diavolo, mentre l'ossessa si adegua ad un esame
penitenziale in vista di una reintegrazione nella comunità
teologica, pur in conseguenza ad una potente riluttanza che
induce alla ripetizione dei riti di liberazione dal maligno.
Aspetti diversi di donne resistenti: caparbietà, impulsi
inconfessabili e inammissibili per una morale religiosa che
troverà continuità nella medicina alienista, cioè
nei nuovi regimi di verità che si concentreranno sul
sistema nervoso e sulle “anomalie” dell'apparato
riproduttivo, senza mai togliere del tutto al clero il potere
di interpretare le convulsioni come effetto di un male diabolico
penetrato nelle viscere della peccatrice. Il corpo è
“bersaglio e rivelatore privilegiato: tutti i rapporti
di potere si esercitano su, attraverso e per mezzo dei corpi.
Il corpo è un operatore fondamentale per definire le
tecniche di governo e di dominazione. Le relazioni di potere
assumono consistenza e circolano attraverso di lui” sottolinea
l'autrice; più la costrizione è oggetto di una
verità non riconosciuta, più la resilienza è
rottura drammatica e drammatizzata.
I regimi di verità ora invadono altre formulazioni disciplinari
attraverso linguaggi mediati dalla virtualità tecnologica,
emozioni schermate da teatralità scomposte come navigassero
fra l'appagamento e la sospensione. Da quando poi abbiamo conosciuto
la segregazione per proteggerci dal contagio del Covid-19, le
analisi sul corpo potrebbero richiedere una prospettiva di trasformazione
storica inquietante opponendo la necessità alla libertà?
Visioni distopiche che aprono nuove riflessioni...
Chiara Gazzola
Con le maschere di Dalì/
Banalizzazione della resistenza?
Da poco, come molti, mi sono imbattuta nella serie TV La
casa di carta (La casa de papel di Álex Pina),
che sta avendo enorme successo e a cui si fanno incessanti riferimenti
soprattutto per l'iconografia. Il caso de La casa de papel
è peculiare: si tratta di una piccola produzione
spagnola per la tv, trasmessa nel 2017 con un successo non eccezionale
che andava calando durante la seconda serie. Venne invece notata
e poi comprata da Netflix e senza bisogno di grande pubblicità
è diventata un fenomeno mondiale.
Il successo credo sia legato alla capacità di inserire
una specie di favola in un contesto realistico e attuale: un
gruppo di aspiranti eroi deve superare una serie di prove per
raggiungere il proprio obiettivo. In questo caso gli eroi sono
dei disoccupati senza futuro che si trasformano in un gruppo
di moderni Robin Hood decidendo di rapinare niente di meno che
lo Stato e prendendo in giro in modo spudorato le forze dell'ordine.
Infatti il piano studiato nei dettagli e in cui veniamo subito
coinvolti prevede di non rubare a nessuno bensì di assaltare
la Zecca di Stato e stampare i propri soldi. Il riferimento
immediato è alla crisi spagnola del 2008 e alle successive
“iniezioni di liquidità” dello Stato e della
BCE alle banche: perché lo Stato interviene per salvare
i pesci grossi invece che pensare a quelli piccoli?
|
| Una scena de La casa di carta |
Il piano è geniale e tutti i trucchi e gli escamotage
organizzati dal “professore”, la mente della rapina,
ci mantengono incollati allo schermo sul quale sfilano personaggi
che risultano subito simpatici alla maggior parte della platea:
non solo iniziamo a condividere i loro obiettivi, ma si prova
grande empatia anche perché rappresentano un gran numero
di minoranze e vari tipi di carattere con i quali lo spettatore
è portato ad identificarsi.
Intanto i personaggi hanno un'età tra i 20 e i 50 anni,
e formano un gruppo coeso che permette alla maggior parte di
noi di pensare che siano nostri coetanei. Gli amori che nascono
tra i protagonisti sono la parte più scontata della trama,
ma ci stanno anche quelli visto che grazie all'amore avvengono
addirittura due cambi di fazione, persone che una volta innamorate
si innamorano anche dei valori portati avanti dalla banda.
Infatti fa parte del piano anche conquistare l'opinione pubblica:
averla dalla propria parte sarà una potente arma contro
la polizia e le forze dello Stato, spesso messe alle strette
dalla denuncia pubblica di metodi non proprio democratici per
cercare di fermarli. E sarà anche un grosso aiuto nel
momento della fuga.
L'egregio lavoro del direttore artistico ha poi scelto di identificare
i rapinatori con un simbolo molto estetico e riconoscibile:
una tuta da lavoro rossa e una maschera di Dalí, che
hanno contribuito a consacrare la serie al successo. In realtà
questa trovata era già presente nell'immaginario collettivo
grazie alla maschera di V per Vendetta. La trovata geniale del
“professore” è di farle indossare ai numerosi
ostaggi trasformandoli in involontari complici, visto che in
quel modo la polizia non poteva più riconoscere i membri
della banda dalle persone da salvare.
I colpi portati a termine hanno bisogno di tempo per funzionare:
una volta asserragliati nell'edificio quindi devono resistere
più tempo possibile per preparare il bottino e creare
la via di fuga. Per questo motivo, dopo aver fermato i primi
tentativi della polizia di entrare, iniziano a parlare di Resistenza.
Oltre al simbolo delle tute rosse che caratterizza la serie
e riesce a bucare lo schermo, la banda si identifica anche con
una canzone che viene intonata più e più volte
nella serie: Bella Ciao, come simbolo della Resistenza. Usato
forse a sproposito, l'inno dei partigiani italiani risuona nelle
tv del mondo. Senza chiari riferimenti storici, Bella Ciao diventa
la colonna sonora di chi lotta contro un'ingiustizia.
Ognuno ha fatto propria l'immagine della Resistenza verso un
sistema ingiusto e corrotto. E di un piccolo gruppo di eroi
mascherati che riesce a vincere con l'intelligenza (e un grande
armamentario che spera di non dover usare).
Non so fino a che punto sia positiva la banalizzazione del concetto
di Resistenza e la celebrazione del conflitto con le istituzioni
non tanto per un ideale quanto per ottenere dei soldi... D'altra
parte alcuni spunti che offre la serie possono essere interessanti,
in quanto salta la classica divisione tra il bene e il male,
e c'è un'ingenuità di fondo di voler mettere in
pratica una grande impresa senza che ci rimetta nessuno. È
condivisibile anche il modo in cui si parla di femminismo nella
serie, così come la già accennata inclusione sociale
dei protagonisti che provengono da famiglie disastrate o sfortunate
che vogliono solo migliorare la loro situazione.
Per aumentare poi la possibilità di identificazione con
i protagonisti si aggiungono alla banda un argentino, un colombiano,
un francese e un'ambientazione tutta italiana, con tanto di
canzoni di Tozzi e Battiato cantate da un coro di monaci che
fanno anche scadere la scelta di Bella Ciao a puro intrattenimento
per i telespettatori. Per assicurarsi un tripudio di consensi
tra i monaci scopriamo niente di meno che il calciatore Neymar.
La produzione è ancora in corso, visto che manca almeno
la quinta serie, conclusione della seconda rapina, e anche se
il regista è lo stesso possiamo affermare che la vendibilità
del prodotto ha avuto decisamente il sopravvento su una bella
idea di favola moderna.
Valeria Giacomoni
|

