
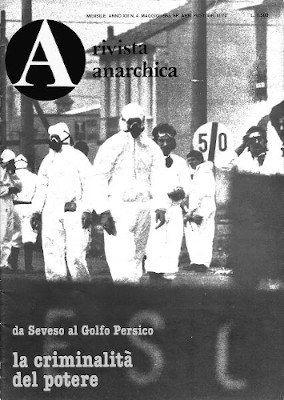 L'immagine
dei tecnici dell'ambiente nei loro scafandri bianchi occupa
la prima e la quarta di copertina di “A” 110 (maggio
1983) e le scritte di copertina indicano con chiarezza tema
e posizione della redazione: “Da Seveso al Golfo Persico,
la criminalità del potere”. I quattro articoli
di riferimento, con cui si apre questo numero, sono tutti di
autori significativi: i primi due sono affidati al Nucleo anarchico
Cesano Maderno, il raggruppamento anarchico più vicino,
geograficamente, alla centrale di Seveso, in Brianza, dalla
quale si è sviluppata una “perdita” tossica
che le autorità cercarono in ogni modo di coprire e negare,
provocando così immensi danni alla salute collettiva
e all'ambiente. Ne scrivono poi Dario Paccino, una delle figure
di punta dell'ecologismo “contro” di allora, e Agostino
Manni, giovane anarchico salentino residente alla Casa dello
Studente di Milano, che un decennio dopo sarà tra i fondatori,
ed è tuttora uno dei partecipanti, della comune Urupia
a Francavilla Fontana (Br). Dell'ecologia, di un modo di vivere
e produrre alternativo, questa comune è stata ed è
un esempio concreto e palpitante, proprio in contrasto con il
modello di sviluppo anti-ecologico dominante. Che è poi
il tema della copertina e del dossier di questo numero di “A”
che hai in mano, aprile 2020, 37 anni dopo quella copertina
e quel numero 110 della nostra rivista. A sottolineare che tutto
si tocca e si stringe: compreso il ruolo critico di questa piccola
rivista, nel corso dei decenni. L'immagine
dei tecnici dell'ambiente nei loro scafandri bianchi occupa
la prima e la quarta di copertina di “A” 110 (maggio
1983) e le scritte di copertina indicano con chiarezza tema
e posizione della redazione: “Da Seveso al Golfo Persico,
la criminalità del potere”. I quattro articoli
di riferimento, con cui si apre questo numero, sono tutti di
autori significativi: i primi due sono affidati al Nucleo anarchico
Cesano Maderno, il raggruppamento anarchico più vicino,
geograficamente, alla centrale di Seveso, in Brianza, dalla
quale si è sviluppata una “perdita” tossica
che le autorità cercarono in ogni modo di coprire e negare,
provocando così immensi danni alla salute collettiva
e all'ambiente. Ne scrivono poi Dario Paccino, una delle figure
di punta dell'ecologismo “contro” di allora, e Agostino
Manni, giovane anarchico salentino residente alla Casa dello
Studente di Milano, che un decennio dopo sarà tra i fondatori,
ed è tuttora uno dei partecipanti, della comune Urupia
a Francavilla Fontana (Br). Dell'ecologia, di un modo di vivere
e produrre alternativo, questa comune è stata ed è
un esempio concreto e palpitante, proprio in contrasto con il
modello di sviluppo anti-ecologico dominante. Che è poi
il tema della copertina e del dossier di questo numero di “A”
che hai in mano, aprile 2020, 37 anni dopo quella copertina
e quel numero 110 della nostra rivista. A sottolineare che tutto
si tocca e si stringe: compreso il ruolo critico di questa piccola
rivista, nel corso dei decenni.
Luciano Lanza si occupa di uno dei suoi temi preferiti, da quando
è nata – dodici anni prima – la rivista:
l'Iri, Istituto per la Ricostruzione Industriale, il carrozzone
statale nato in era fascista e da sempre punto di incontro tra
il potere politico e quello economico. Gli scritti di Lanza
in materia sono stati decine, nel tentativo di cogliere evoluzione
e involuzioni di questo fondamentale rapporto, visto non in
un'ottica di “tradizionale” capitalismo ma come
uno degli indicatori più interessanti dell'affermarsi
di un sistema tecno-burocratico, non solo a livello italiano.
Paolo Finzi, della redazione, si occupa della situazione politico-sindacale
in Polonia colloquiando con il militante anarchico belga Roger
“Babar” Noel, una delle figure di punta dell'anarchismo
europeo di quegli anni, attento analista delle realtà
“sovietiche”, a partire proprio dalla Polonia –
ai militanti clandestini attivi in quel paese sono destinati
i proventi di una sottoscrizione internazionale cui “A”
aderisce e che rilancia.
Nello stesse pagine si pubblicizza la rivista francese libertaria
“Iztok”, un periodico di informazione sui paesi
sotto il tallone di Mosca. Siamo 7 anni prima della caduta del
muro e “A” non si fa prendere alla sprovvista. Non
c'è solo Walesa si intitola il pezzo, facendo riferimento
al mediaticamente predominante e cattolicissimo leader di Solidarno.
Sempre al sindacalismo d'opposizione, ma in questo caso alla
situazione della Confederación Nacional del Trabajo (l'anarco-sindacalista
CNT spagnola), è dedicato il successivo report di Pasquale
Piergiovanni, altro giovane pugliese allora residente a Milano
e ora attivo nell'Usi-Cit nelle sue terre d'origine, e da Luís
Andrés Edo, allora vivace militante anarchico catalano,
storico amico di “A” e nostro referente privilegiato
ai tempi delle lotte clandestine e poi, dopo la morte di Francisco
Franco, nella entusiasmante ricostruzione di una presenza organizzata
libertaria nella società e tra i lavoratori iberici.
Nella rubrica delle Cronache Sovversive tante notizie di lotta,
dalla Polinesia al XVI congresso della Federazione Anarchica
Italiana svoltosi a Reggio Emilia. Non manca mai l'antimilitarismo,
questa volta con la notizia del nuovo arresto del giovane obiettore
totale Mauro Zanoni, di Asola (Mn): il primo interno di copertina
è dedicato al suo caso e riporta parte della sua dichiarazione
pubblica.
Il redattore di “A” Giuseppe Gessa si occupa dell'astensionismo
e delle schede bianche alle recenti elezioni. E poi due recensioni
di film, una lunga recensione a firma di Monica Giorgi di un
libro su August Strindberg, un intervento come sempre illuminante
di Luce Fabbri sull'esperienza spagnola del '36/'37, stralci
da un'antologia di scritti di E. Armand curata da Gian Paolo
Prandstraller per le Edizioni Antistato (Elèuthera sarebbe
nata due anni dopo), un ricordo di Gilbè della Cooperativa
Tipolitografica di Carrara.
Da segnalare resta solo la terza di copertina dedicata agli
altri due periodici anarchici “nazionali” di quegli
anni: “L'Internazionale” e “Umanità
Nova”. Un ulteriore segno di quell'apertura pluralistica,
mai limitata al proprio orticello, di cui orgogliosamente questa
testata è sempre stata un esempio voluto e concreto.

|

