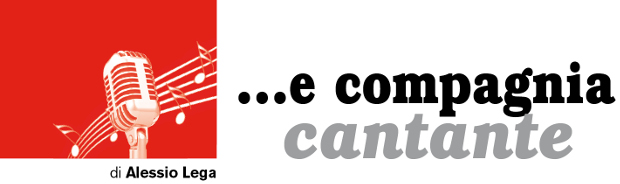
Ci vuole
un fiore
Nel centenario di Gianni Rodari,
i suoi testi cantati da Sergio Endrigo
Il contesto di Rodari
Qualche generazione, compresa la mia, fu fortunata...
Sono nato nel 1972, prima di noi i bambini erano degli adulti ancora troppo giovani, presi in considerazione solo come degli uomini in potenza, tavole rase, recipienti da riempire con l'imbuto. Poi la televisione, davanti alla quale venivano parcheggiati, li scoprì come i clienti perfetti, i più influenzabili, i più indifesi: da allora sono la pancia debole per ogni esperimento commerciale.
Ci fu un breve periodo però, fra gli anni sessanta e i primi ottanta, nei quali i bambini vennero scoperti per ciò che erano: dei bambini. Il loro diritto al gioco, l'esigenza del rispetto, la complessa architettura di un'educazione libertaria si diffusero con i più svariati esperimenti.
Fu in quegli anni che una serie di artisti, poeti, illustratori, cantori, teatranti cominciarono a parlare per davvero ai bambini, senza pantomime o parodie.
Se c'è il nome di uno scrittore che riassume questo cambio di passo è quello di Gianni Rodari. Assieme alle Fiabe popolari tratte dalle tradizioni regionali, nella meravigliosa riscrittura di Italo Calvino, le sue Favole al telefono - nella storica edizione Einaudi con la copertina di Bruno Munari - furono la lettura fondamentale della mia infanzia.
Rodari entrò anche nella storia della canzone italiana nel corso degli anni settanta (dopo qualche pionieristico tentativo del gruppo torinese Cantacronache) per l'impegno di due grandi artisti, Virgilio Savona (noto al grande pubblico per la sua militanza nel Quartetto Cetra), che alle filastrocche si dedicò per primo e con più continuità, e Sergio Endrigo, che incise un disco con una canzone diventata famosissima, forse la più nota e riuscita canzone italiana per bambini Ci vuole un fiore, che dava il titolo all'intero disco. Appunto a questo disco voglio dedicare qualche riflessione.
Voglio anche precisare che in tempi molto più recenti anche il cantore e chitarrista virtuoso Paolo Capodacqua (noto per essere anche stato lo storico accompagnatore di Claudio Lolli) ha lavorato molto bene sui testi di Rodari.
Non starò nemmeno a tentare una disamina del valore pedagogico,
o letterario in assoluto, dell'opera di Gianni Rodari. Al netto
delle molte pagine anacronistiche o delle favole superate (anche
per merito della sua stessa opera di divulgatore e teorico),
io penso che fosse un gran poeta e un eccellente narratore:
emotivo ma sempre un passo indietro al rischio del sentimentalismo
(rischio che molti narratori per l'infanzia anche successivi
subiscono più o meno consapevolmente), forse a tratti
un po' cerebrale, ma mai guittesco, mai consolatorio. Se penso
a un altro genio della narrativa per ragazzi del novecento quale
Roald Dahl, a tratti crudelmente compiaciuto proprio come un
bimbo che gioca, trovo in Rodari l'asciuttezza di una strada
diversa e consapevole: un adulto che ha trovato il modo di parlare
ai bambini, divertendosi a farlo, ma senza confondere i reciproci
ruoli. Per questo egli è un imprescindibile classico
del secondo novecento, pur in un contesto così radicalmente
cambiato dai suoi Giochi nell'URSS o dal bellissimo testo
teorico La grammatica della fantasia.
Per fare tutto ci vuole un fiore?
Le cose di ogni giorno raccontano segreti
A chi le sa guardare ed ascoltare
Per fare un tavolo ci vuole il legno
Per fare il legno ci vuole l'albero
Per fare l'albero ci vuole il seme
Per fare il seme ci vuole il frutto
Per fare il frutto ci vuole il fiore
Ci vuole un fiore, ci vuole un fiore
Per fare un tavolo ci vuole un fiore
Per fare un fiore ci vuole un ramo
Per fare il ramo ci vuole l'albero
Per fare l'albero ci vuole il bosco
Per fare il bosco ci vuole il monte
Per fare il monte ci vuol la terra
Per far la terra ci vuole un fiore
Per fare tutto ci vuole un fiore.
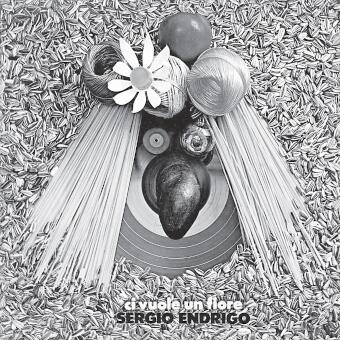 Come
dicevo, questo è il classico per antonomasia della canzone
per bambini, la più famosa e intramontabile per tutte
le generazioni. Il testo è costruito su un modulo reiterativo,
che troviamo in tante filastrocche e canzoni popolari, ma il
processo logico del testo è quasi scientifico, la relazione
causa-effetto, l'idea della trasformazione permanente... se
non che l'ultimo verso ribalta completamente l'assunto, riportandolo
su una dimensione metaforica, per fare tutto ci vuole un
fiore, ovvero ci vuole la delicatezza, la bellezza, la caducità,
l'amore. Come
dicevo, questo è il classico per antonomasia della canzone
per bambini, la più famosa e intramontabile per tutte
le generazioni. Il testo è costruito su un modulo reiterativo,
che troviamo in tante filastrocche e canzoni popolari, ma il
processo logico del testo è quasi scientifico, la relazione
causa-effetto, l'idea della trasformazione permanente... se
non che l'ultimo verso ribalta completamente l'assunto, riportandolo
su una dimensione metaforica, per fare tutto ci vuole un
fiore, ovvero ci vuole la delicatezza, la bellezza, la caducità,
l'amore.
A Sergio Endrigo l'idea di registrare un disco coi testi di
Gianni Rodari viene dopo l'esperienza innescata dall'amicizia
e la collaborazione con Vinicius de Moraes, il grande poeta
brasiliano, alla fine degli anni sessanta in esilio in Italia,
era stato fortemente spalleggiato da Sergio e dal suo gruppo
di fedeli collaboratori Sergio Bardotti e Luis Bacalov. Insieme
avevano appunto prodotto il caleidoscopio Lp “l'Arca”,
con una serie di canzoni, sempre per bambini, ispirate al mondo
degli animali, fra le quali spicca Il pappagallo. Altro
brano di straordinaria poesia, ma a ben vedere anche sottilmente
inquietante, è La casa uscito come singolo: Era
una casa molto carina / senza soffitto senza cucina / non si
poteva entrarci dentro / perché non c'era il pavimento
/ non si poteva andare a letto / in quella casa non c'era il
tetto / non si poteva far la pipì / perché non
c'era vasino lì che sembra alludere alla vita dei
senzatetto.
L'ottimo successo di queste operazioni lo convince a lanciarsi
in qualcosa di più grandioso, e diciamo pure di molto
coraggioso per un autore da sempre considerato un malinconico
e romantico. Nel 1974 - dopo aver chiesto l'autorizzazione direttamente
a Gianni Rodari, che gli affida dei testi sparsi - esce dunque
“Ci vuole un fiore”, un disco arrangiato in pompa
magna, con una copertina sgargiante, il cui libretto interno
era composto da un album interno di fogli bianchi, pensati per
poter disegnare qualcosa di relativo ai temi cantati.
Fra poesia, ironia e critica sociale
Il disco, dopo la folgorante partenza col brano Ci vuole un fiore, si presenta come connotato da posizioni esistenziali e sociali, e non lesina critiche al nozionismo scolastico. Prima che parta l'introduzione musicale del secondo brano Un signore di Scandicci, una voce petulante e inespressiva attacca con un breve parlato
Problema: i confini della Toscana hanno uno sviluppo di 1.330 km, di cui 329 costieri, 249 insulari, 752 terrestri, che la dividono da Liguria, Emilia, Marche, Umbria e Lazio. La sua superficie è di 22.940 km quadrati, di cui 5.800 di montagna, 1.930 di pianura e di 15.260 di collina. I fiumi della Toscana sono: l'Arno (lungo 241 km), il Serchio (lungo 103 km), l'Ombrone (lungo 161 km), il Cecina (lungo 76 km). Si domanda: quanto è alta la torre di Pisa?
Un signore di Scandicci
Buttava le castagne e mangiava i ricci
Quel signore di Scandicci
Un suo amico di Lastra a Signa
buttava via i pinoli e mangiava la pigna
quel suo amico di Lastra a Signa
Tanta gente non lo sa, non ci pensa e non si cruccia
La vita la butta via e mangia soltanto la buccia.
La canzone prosegue elencando il cugino di Prato che buttava il cioccolato e mangiava la carta, il parente di Figline che butta via via le rose e odorava le spine, lo zio di Firenze che buttava in mare i pesci e mangiava le lenze, tutti coloro che la vita la butta(no) via e mangia(no) soltanto la buccia. La surreale scansione di paesi e città tutti della Toscana, trova il suo senso nella morale universale, che invita a vivere la vita nella sua pienezza, mangiarne il frutto e non la buccia o l'involucro. È proprio su questa e su altri momenti che potrebbero apparire un po' didascalici che la dolcezza stilistica di Endrigo e la sua voce melodiosa arricchiscono di elementi sognanti i versi.
Tutto il disco è punteggiato di brevi parlati, per lo più ironici o grotteschi, di suoni e suonini evocativi, e le orchestrazioni sono estremamente ricche, ora occhieggianti al gusto tipico dell'epoca per le colonne sonore, ora alla passione sinfonica e ai contrappunti bachiani dell'orchestratore Bacalov.
Onnipresenti ovviamente i cori dei bambini (fra i quali i figli stessi degli autori) molto ben gestiti e registrati, senza bamboleggiamenti con dizione chiara e voci stonate quel tanto che basta per essere belle ed espressive. All'ascolto potrebbero apparire un po' ridondanti, ma hanno la funzione didascalica di guidare la ripresa delle strofe e dei ritornelli anche dai singoli ascoltatori del vinile, come dire “cantate insieme a noi”.
Questa, che non vuole essere una semplice raccolta di brani da ricantare, ma una vera e propria variegata opera per bambini, si prende i suoi rischi, accostando a canzoni fortemente ritmate e allegre altre ballate pensose e sospese, come questo capolavoro:
Abbiamo parole per vendere,
parole per comprare,
parole per fare parole.
Andiamo a cercare insieme
le parole per pensare.
Abbiamo parole per fingere,
parole per ferire,
parole per fare il solletico.
Andiamo a cercare insieme,
le parole per amare.
Abbiamo parole per piangere,
parole per tacere,
parole per fare rumore.
Andiamo a cercare insieme
le parole per parlare.
Il disco avviato così potentemente si snoda fra i brani più giocosi - come un'impagabile Zucca Pelata, una filastrocca dal gusto popolare adattato sull'aria di celebri canzoni - e altri che riescono ad essere ironici e istruttivi, come la tirata su quel Napoleone che, a dispetto di tutta la prosopopea di cui si circondava, faceva cose normalissime:
C'era una volta un imperatore, si chiamava Napoleone
e quando non aveva torto, di sicuro aveva ragione.
Napoleone era fatto così
se diceva di no, non diceva di sì
quando andava di là, non veniva di qua
se saliva lassù, non scendeva quaggiù
se correva in landò, non faceva il caffè
se mangiava un bignè, non contava per tre
se diceva di no, non diceva di sì.
I bambini di gesso
La summa del pensiero di Gianni Rodari si trova nel penultimo brano, uno dei più interessanti anche a livello sonoro e dei più riusciti nel mix fra la vis polemica del testo e la dinamica giocosa e fisica di un rock per bimbi piuttosto scatenato, introdotto da un parlato ossessivo, in cui i divieti crocefiggono la vitalità del bambino al noioso mondo di regole degli adulti:
Sta fermo! Sta zitto! Non metter i gomiti sulla tavola! Non essere distratto! Guarda dove metti piedi! Sta attento a non rovesciare l'acqua! E non lasciar cadere la penna! E non perdere i pastelli! Non giocare in cortile! Non correre sulle scale! Non fischiare! Non sbattere le porte! Non strusciare le scarpe! Non prendere a calci i sassi! Sta buono, perché la mamma ha il mal di testa, perché la maestra ha il mal di testa, perché la zia ha il mal di testa, perché la portiera ha il mal di testa.
Non correva, non saltava
pantaloni non strappava
non diceva parolacce
non faceva le boccacce
non sporcava i pavimenti
si lavava sempre i denti
non strillava, non rideva
i bottoni non perdeva
senza macchie sui guantini
senza buchi nei calzini.
Era proprio un bambino di gesso
respirava se aveva il permesso
stava dove l'avevano messo
come un bravo bambino di gesso
che non risponde e non dice mai di “no”
Ora grande è diventato
ma non è molto cambiato:
compitissimo, prudente
ossequioso, diligente
dice “grazie” al superiore
dice sempre “Sì, signore”
se gli danno sulla testa
dice grazie e non protesta
passa il giorno a fare inchini
non ha buchi nei calzini
Ora è proprio un brav'uomo di gesso
che respira se ottiene il permesso
e rimane dov'è stato messo
come un bravo brav'uomo di gesso
che non discute e non dice mai di “no”.
Dopo questo climax, il tono si abbassa per uno dei brani più poetici e rarefatti, che più ancora che consolare, invita i bambini a non usare l'elemento ricattatorio e catartico del pianto. A ben vedere è un brano esistenziale anche questo, con cui si conclude una delle perle della nostra discografia, noto quasi solo per la canzone che gli dà il titolo, ma meritevole di essere riscoperto. Se anche a questo può servire questo centenario, allora non esitiamo a ripetere: buon compleanno e lunga vita alla tua opera, Gianni Rodari.
Non piangere, non piangere
se piangi non vedi più niente
vedi solo le tue lacrime, e se tu le bevi
non sono dolci ma salate come il mare
Se piangi non vedi più il sole
vedi solo pioggia e nuvole
non puoi più giocare a rimpiattino
ma soltanto a mosca cieca
Non vedi più il cielo sopra il grattacielo
gli uccelli volare e le stelle brillare!
non vedi i colori dell'arcobaleno
vedi solo il tuo naso, non vedi più in là.
Alessio Lega
|

