|
individualismo
Max Stirner (forse) non era anarchico
di Enrico Ferri
A questa conclusione problematica sembra giungere Enrico Ferri, curatore della recente traduzione della nota biografia di Henry Mackay, Max Stirner. La sua vita e la sua opera in uscita presso l'editore Rubbettino. E sul pensiero del filosofo tedesco Johann Caspar Schmidt (vero nome di Stirner), considerato da molti il primo individualista anarchico, si riapre il dibattito.
La biografia di Stirner -Max
Stirner, sein Leben und sein Werk- redatta da John Henry
Mackay in tre diverse edizioni (1897-1910-1914) non ebbe una
particolare fortuna editoriale, seppure esistesse già
in quegli anni, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, un
potenziale pubblico di estimatori di Stirner, interessato a
conoscere la vita del Filosofo, tanto sul versante culturale
che su quello politico. Quando esce la prima edizione della
biografia, già da qualche anno il nome e l'opera di Stirner
erano tornati d'attualità: nel 1893 l'editore Reclam
aveva pubblicato la prima edizione economica de L'unico e
la sua proprietà.
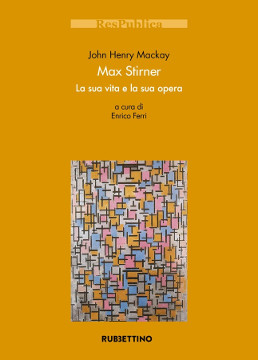 Per
un altro verso, negli anni del Mackay era presente ed organizzata,
attraverso una serie di riviste, gruppi, circoli, comitati,
case editrici, associazioni di lavoratori, ecc., la galassia
degli anarchici, che ricomprendeva la corrente alla quale lo
stesso Mackay apparteneva, quella degli anarchici individualisti.
Ciò nonostante la biografia di Stirner nelle tre diverse
edizioni non riuscì a vendere che poche centinaia di
copie, cosa di cui lo stesso autore si rammarica. Diversi motivi
sono all'origine di questa limitata fortuna: la biografia era
scritta in tedesco, pertanto inaccessibile al pubblico francofono
e italiano, come all'anarchismo anglofono e latino delle Americhe.
Seppure la biografia di Stirner sia redatta da un poeta ed un
romanziere, non siamo in presenza di una scrittura piana e ben
articolata; al contrario, persino la descrizione di Stirner,
del suo carattere come delle sue fattezze fisiche, è
mal fatta e spesso contraddittoria. Mackay, per giunta, non
riesce mai a separare la vita del Filosofo, di quello che di
essa riesce a ricostruire, dai suoi giudizi, sempre finalizzati
a presentare sotto la luce migliore la vita e l'opera di Stirner.
Mackay, infatti, è un fervente ammiratore di Stirner
che considera un genio, un maestro ed il teorico per eccellenza
dell'anarchismo, cioè di una corrente politica e filosofica
che al tempo di Stirner non esisteva. Nell'opera principale
di Stirner, come nei cosiddetti “Scritti Minori”,
il termine “anarchia” non compare mai. Per
un altro verso, negli anni del Mackay era presente ed organizzata,
attraverso una serie di riviste, gruppi, circoli, comitati,
case editrici, associazioni di lavoratori, ecc., la galassia
degli anarchici, che ricomprendeva la corrente alla quale lo
stesso Mackay apparteneva, quella degli anarchici individualisti.
Ciò nonostante la biografia di Stirner nelle tre diverse
edizioni non riuscì a vendere che poche centinaia di
copie, cosa di cui lo stesso autore si rammarica. Diversi motivi
sono all'origine di questa limitata fortuna: la biografia era
scritta in tedesco, pertanto inaccessibile al pubblico francofono
e italiano, come all'anarchismo anglofono e latino delle Americhe.
Seppure la biografia di Stirner sia redatta da un poeta ed un
romanziere, non siamo in presenza di una scrittura piana e ben
articolata; al contrario, persino la descrizione di Stirner,
del suo carattere come delle sue fattezze fisiche, è
mal fatta e spesso contraddittoria. Mackay, per giunta, non
riesce mai a separare la vita del Filosofo, di quello che di
essa riesce a ricostruire, dai suoi giudizi, sempre finalizzati
a presentare sotto la luce migliore la vita e l'opera di Stirner.
Mackay, infatti, è un fervente ammiratore di Stirner
che considera un genio, un maestro ed il teorico per eccellenza
dell'anarchismo, cioè di una corrente politica e filosofica
che al tempo di Stirner non esisteva. Nell'opera principale
di Stirner, come nei cosiddetti “Scritti Minori”,
il termine “anarchia” non compare mai.
Le difficoltà delle ricerche del Mackay
Mackay si considerava, in quanto anarchico individualista,
assieme agli altri militanti di questo movimento, l'erede testamentario
di Stirner, parte di quanti avrebbero dovuto raccoglierne l'eredità,
tutelarne l'identità e divulgarne il messaggio di liberazione
radicale e definitiva.
I due limiti su ricordati sono di tipo soggettivo: una scrittura involuta, ripetitiva e non di rado contraddittoria e poco chiara, accanto ad un approccio ermeneutico eccessivamente empatico, se non apologetico. Accanto a questi, nella biografia di Mackay ne è presente un altro che solo in minima parte coinvolge la responsabilità dell'autore; un limite che è una conseguenza delle difficoltà oggettive incontrate nel reperimento di materiali e testimonianze sulla vita di Stirner.
Si possono così riassumere: distanza di più di
tre decenni fra la morte di Stirner e l'inizio delle ricerche
biografiche; mancanza di una raccolta, di un lascito dei materiali
di Max Stirner, per motivi diversi: vanno ricordati almeno sei
o sette traslochi che coinvolsero Stirner nei dieci anni che
andarono dall'uscita del L'unico alla morte e la dispersione
dei suoi libri e delle sue carte, prima affidati a Buhl e divenuti
introvabili dopo la morte di quest'ultimo. Anche la ricerca
e la raccolta di informazioni attraverso quanti condivisero
con Stirner varie vicende, in ambito filosofico, umano ed esistenziale,
non diede mai esiti significativi.
La distanza fra la data della morte di Stirner (1856) –ancor
più significativa se consideriamo quella dell'uscita
del libro (1845)- e la data dell'inizio delle ricerche da parte
del Mackay (1888) da sola spiega molte delle difficoltà
che il biografo di Stirner dovette affrontare. Nella biografia
Max Stirner, la sua vita e la sua opera troviamo poche
notizie su Stirner, quasi sempre insignificanti, un'attenzione
maniacale nel riportare ricerche e contatti con personaggi che
poca o nulla luce fecero sul Filosofo e sull'uomo Stirner, fornendo
elementi utili alla biografia. Non è raro infatti che
Mackay, pagina dopo pagina, ci illustri una serie di ricerche
che portarono a risultati modesti quanto non nulli.
Le reticenze di Marie Dähnhardt, “Frau Schmidt”
Un esempio paradigmatico delle difficoltà incontrate dal Mackay lo offre la vicenda della moglie di Stirner, vicina a Stirner sul piano intellettuale ed umano per alcuni anni: con Stirner frequentava il circolo berlinese dei Freien, “I Liberi”, l'ambiente radicale dei giovani hegeliani berlinesi, dove troviamo personaggi come i fratelli Bauer, Arnold Ruge, Buhl e Engels. Con Stirner condivise, come moglie,poco più di due anni di vita. Il libro di Stirner, com'è noto, porta come epigrafe dedicatoria: “Al mio amore Marie Dähnhardt”. “Frau Schmidt”, come la chiama Mackay, dopo la separazione da Stirner, aveva abbandonato la Prussia per il Regno Unito, dove aveva continuato a frequentare ambienti radicali, per poi trasferirsi in Australia nel 1852, dove visse anni difficili e si avvicinò ad associazioni di cattolici che oggi definiremmo integralisti. Una consistente eredità la spinse a tornare in Inghilterra, nel 1870 o nel 1871, dove continuò il suo impegno confessionale, che coltivò fino alla morte. Mackay cercò in ogni modo di incontrare e di intervistare la donna, che si rifiutò sempre. Marie Dähnhardt aveva radicalmente rinnegato e preso le distanze dalle esperienze politiche ed intellettuali giovanili, come dal suo sodalizio con Max Stirner, considerato responsabile della dilapidazione della cospicua dote matrimoniale e del fallimento del loro matrimonio. Tutto quello che Mackay riuscì a cavare dalla “vecchia bigotta” furono alcune lapidarie e poco encomiastiche considerazioni sul suo ex consorte, definito “egoista” e “pigro”, senza però motivare tali giudizi.
Mackay, inoltre, come viene annunciato già nel titolo
della sua biografia, Max Stirner, la sua vita e la sua opera,
si propone di descrivere non solo la vita ma pure l'opera di
Stirner, cercando allo stesso tempo di stabilire un nesso speculare
tra queste due dimensioni, in termini di “coerenza”,
come se lo stile di vita di Stirner rispecchiasse il modello
filosofico de L'unico e viceversa. Un intero capitolo
è dedicato all'interpretazione de L'unico e la sua
proprietà, in cui si gettano la basi di quello che
può dirsi il “mito” dello Stirner anarchico,
anzi, per essere più precisi, dello Stirner proto-teorico
dell'anarchismo individualista.
L'“invenzione” dello Stirner anarchico
L'individualismo stirneriano è interpretato da Mackay
come la più compiuta espressione della filosofia dell'anarchismo,
operando a dir poco una forzatura perché, per evidenti
motivi temporali, Max Stirner è estraneo al movimento
anarchico (che non esisteva ai suoi tempi ) e solo per alcuni
aspetti può essere ricompreso tra i filosofi dell'anarchismo.
Il termine anarchia ed anarchismo, ad esempio, non si trovano
nella sua opera ed uno dei filosofi con cui polemizza è
Pierre Joseph Proudhon. Senza considerare che i due principi
condivisi da tutti gli anarchici (almeno da quelli “socialisti”
e “comunisti”), cioè l'uguaglianza e la libertà,
non sono certo rivendicati da Stirner, che all'uguaglianza contrappone
l'unicità ed alla libertà la proprietà.
L'uguaglianza viene ridotta al riconoscimento di una unicità
condivisa, cioè propria ad ogni uomo, una (pseudo) uguaglianza
che si esprime come un' “uguale differenza” (ogni
individuo è originale ed irriducibile ad un modello condiviso)
e sulla cui base è possibile solo fondare un'unione di
tipo utilitaristico, motivata dall' “interesse reciproco”
e che si esprime nell' “uso reciproco”. Ciò
che sostiene l'uguaglianza, nella prospettiva stirneriana, non
è la solidarietà degli altri uomini, ma la capacità
propria ad ognuno di appropriarsi di una parte di mondo (fatto
di “cose” e di “relazioni”), cioè
di farsi “proprietario”.
Per decine di pagine Mackay ci offre una confusa e libera interpretazione
del testo di Stirner, un'interpretazione che in molti passi
appare una volgarizzazione “creativa”, nel senso
che attribuisce a Stirner tesi delle quali ne L'unico
non c'è traccia, come in varie occasioni faccio notare
nel mio commento al testo. Un altro elemento altera l'interpretazione
del Mackay, la scarsa o nulla conoscenza del contesto storico-
filosofico nel quale Stirner elabora la sua opera, come pure
degli interlocutori di Stirner. Mackay ha assai scarse conoscenze
della filosofia di Hegel e dei filosofi della sinistra hegeliana,
cioè dei presupposti e degli interlocutori principali
de L'unico, del suo stesso terreno di coltura.
|
| Profilo di Max Stirner disegnato a memoria,
alcuni decenni dopo la sua morte,
da Friedrich Engels |
Le origini dello Stirner “individualista anarchico”
I limiti delle ricerche e delle interpretazioni presenti nella
biografia del Mackay stanno ad indicare la scarsa fortuna del
libro Max Stirner, sein Leben und sein Werk, non solo
al tempo delle prime tre edizioni del testo, ma pure negli anni
successivi alla morte del suo autore, come pure le mancate traduzioni
in altre lingue.
Anche dal punto di vista storiografico la biografia del Mackay
non è di molta utilità; in essa non ci sono notizie
di una qualche novità ed utilità e una prova di
questo ci viene anche dallo scarso rilievo che essa ha avuto
ed ha tra gli studiosi di Stirner, che di rado vi fanno riferimento
e quando ciò avviene è spesso per note di colore,
come nel caso della scena del matrimonio di Stirner e Marie
Dähnhardt, di cui Mackay ci ha lasciato una vivida descrizione.
Ciò nonostante, esistono altri validi motivi che rendono
interessante la biografa di Stirner,considerata parte importante
dell'opera di valorizzazione del filosofo di Bayreuth compiuta
dal Mackay. Lo stesso biografo di Stirner si riteneva il principale
artefice della riscoperta del filosofo dell'egoismo avvenuta
nei decenni a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Pretesa
solo parzialmente vera, ma di una qualche consistenza. Per circa
quarant'anni Mackay si occupò di Stirner, fece ricerche
sulla sua vita, raccolse materiali, intervistò decine
di persone che in modo più o meno diretto potevano ricollegarsi
a Stirner. Trovò la tomba di Stirner nel cimitero berlinese
di Sophienkirhhof, sepoltura che era in uno stato di
semi abbandono e invasa dai rovi; la ripulì e la ricoprì
con una lastra di granito nero, comprata attraverso una sottoscrizione.
Allo stesso tempo, Mackay trovò e raccolse gran parte
degli scritti giornalistici e degli articoli stirneriani, che
pubblicò nel 1897. in una raccolta che portò il
titolo di Kleinere Schriften (Scritti Minori), un volume
importante perché aiuta a comprendere lo sviluppo del
pensiero di Stirner in un periodo che va dal 1842 al 1847, anni
di preparazione e di pubblicazione de L'unico (ottobre
1844), poi di repliche ai critici del libro, personaggi come
Ludwig Feuerbach e Hess, che meglio definiscono il pensiero
di Stirner su questioni come il “nulla”- alla base
di tutto il sistema dell'egoismo-, il ruolo dell'“interesse
personale” e dell'“unione degli egoisti”.
Articoli come Il falso principio della nostra educazione:
umanesimo e realismo, Lo Stato fondato sull'amore o il primo
scritto noto di Stirner, la recensione al saggio di Bruno Bauer,
La tromba del giudizio universale, Hegel ateo e anticristo,
che rappresentò la chiave di svolta rivoluzionaria di
quella che sarà definita la “sinistra hegeliana”.
Per un altro verso, molti contributi raccolti nei così
detti Scritti Minori ci danno l'opportunità di
vedere la filosofia stirneriana, la prospettiva dell'egoismo,
applicata ad una serie di diversi problemi di politica interna
ed internazionale: dalla questione del “mandato revocabile”
a quella del divorzio, dall'educazione dei bambini, all'organizzazione
federale.
La biografia di Stirner, nelle sue diverse edizioni, si colloca
in quest'opera di diffusione e divulgazione del pensiero anarchico
e stirneriano, che vengono riportati ad una stessa matrice,
anzi, per molti versi, il “vero” pensiero anarchico
è stato considerato quello più coerente con la
filosofia stirneriana, interpretata ovviamente alla maniera
del Mackay, come dottrina anarchica.
Engels e lo Stirner “precursore” di Bakunin
Il primo ad avvicinare il pensiero di Stirner all'anarchismo fu Friedrich Engels nella sua recensione al libro Ludwig Feuerbach del filosofo danese Carl Nicolai Starcke, recensione apparsa in due diversi fascicoli di “Neue Zeit” nel 1886 e poi pubblicata come testo autonomo con il titolo Ludvig Feuerbach e il punto d'approdo della filosofia classica tedesca, che aveva in appendice le XI glosse di Marx a Feuerbach, fino ad allora inedite. Nel testo, come lo stesso titolo annuncia, attraverso l'analisi della filosofia di Feuerbach si ricostruisce la vicenda della “sinistra hegeliana”, interna alla più generale storia della “filosofia classica tedesca”. La tesi di fondo della recensione di Engels è che tutta la filosofia tedesca “classica”, cioè meramente speculativa, si è sviluppata fino ad esiti materialistici e rivoluzionari, come avviene nei discepoli rivoluzionari di Hegel. Ciò nonostante questi filosofi per Engels restano sul piano puramente teorico, di riflessione e di interpretazione del mondo, giudizio che riprende le note affermazioni di Marx nelle Tesi a Feuerbach, riportate in appendice al volumetto di Engels, dove ad esempio Marx sostiene: “Fino ad ora i filosofi hanno interpretato il mondo, ora bisogna trasformarlo”. La filosofia classica sarebbe stata, in questa prospettiva, quella della contemplazione e dell'interpretazione del mondo, mentre il marxismo rappresenterebbe la vera filosofia rivoluzionaria, dove la comprensione della realtà si presenta come la premessa per la sua trasformazione: è una filosofia della prassi dove l'interpretazione è il primo momento della trasformazione, ciò che attiva il rivoluzionamento della realtà.
In questo lavoro Engels ricostruisce una falsa cronologia delle
vicende della sinistra hegeliana, anche attraverso una serie
di opere particolarmente rappresentative del pensiero dei loro
autori. Scrive Engels: “Alla fine arrivò Stirner
il profeta dell'odierna anarchia –Bakunin ha preso molto
da lui e sorpassò la sovrana 'autocoscienza' [di
Bauer]con il suo 'unico' sovrano”. Infine, scrive
Engels, “apparve” L'essenza del Cristianesimo
di Feurbach (1841) che andò oltre Stirner (1845), cioè
superò un testo che sarebbe uscito solo quattro anni
dopo. Questa cronologia manipolata serviva a ripresentare gli
argomenti di Marx nelle undici tesi a Feuerbach: che Marx e
lui fossero andati oltre la filosofia classica tedesca, con
una teoria che era un primo momento della trasformazione rivoluzionaria,
insieme critica e anima della prassi rivoluzionaria.
Oltre Mackay: L'Unico uno, nessuno e centomila
La lettura che John H. Mackay ci offre di Stirner nella biografia che curò, non esaurisce certo le interpretazioni del pensiero del Filosofo di Bayreuth, anche se rappresenta quella che ha avuto più seguito e fortuna: Stirner Filosofo e Padre dell'anarchismo. La centralità della filosofia di Stirner, però, è data dal ruolo che in essa gioca l'individuo, considerato come originale, “unico” e non rappresentabile in quanto in continuo sviluppo e trasformazione. Tutto il sistema stirneriano è finalizzato alla tutela ed alla garanzia dello sviluppo di tale unicità e della irriducibilità dell'individuo ad ogni categoria collettiva: dalla famiglia al partito, dalla società alla nazione, dalla classe al partito. La centralità e la salvaguardia dell'individuo, la sua esaltazione che a volte assume toni titanici, come quando Stirner definisce l'unico, l'egoista, “der Gewaltige”, “il potente”, hanno fatto si che Max Stirner nel corso del Novecento sia stato anche associato al liberalismo e all'esistenzialismo, al dadaismo come all'anarchismo di destra. Stirner se avesse potuto commentare queste varie interpretazione del suo pensiero, avvolto nel fumo di uno dei suoi amati sigari, probabilmente avrebbe detto che in tutte queste letture c'è un riflesso dell'unico, ma che l'unicità anche nella sua dimensione filosofica non si può ridurre ad una dottrina codificata. Non a caso, Stirner nel suo libro non usa mai espressioni come “la mia filosofia” e “il mio pensiero”, spiegando in più di un'occasione che non sono i pensieri a creare l'individuo, ma è il soggetto a crearli e a disfarsene a suo piacimento. Codificare un pensiero, a maggior ragione la riflessione su L'Unico, significherebbe trasformare la libera creazione dell'egoista in un sistema e in una catena.
Enrico Ferri
|

