
Sud/
La rabbia di chi non si rassegna
Dopo i racconti di Qualcuno è uscito vivo dagli anni
Ottanta (Stilo 2014), ispirati alla musica punk e
post-punk, con protagonisti anarchici e appassionati
di controculture formatisi intorno alla figura leggendaria di
Sante Cannito, Francesco Dezio, scrittore pugliese, torna in
libreria con La gente per bene (TerraRossa, Alberobello
2018, pp. 207, € 15,00).
 Il
suo romanzo d'esordio Nicola Rubino era stato il primo
esempio di letteratura postindustriale degli anni Duemila, ambientato
com'era in una multinazionale produttrice di motori Diesel dell'hinterland
barese, nella quale un giovane lavora con un contratto di formazione
a tempo determinato, inutilmente sperando nel posto fisso e
disilludendosi anche sull'ideale della solidarietà di
classe, poiché gli operai ingaggiano tra loro una guerra
spietata fatta di sgambetti, mobbing, cooptazioni sleali. Tutto
lo spazio narrativo di Nicola Rubino era occupato dalla
fabbrica, un mondo concentrazionario chiuso in sé stesso.
La gente per bene invece allarga lo sguardo ad un intero
tessuto sociale compromesso, anzi necrotizzato, dandoci uno
spaccato di un pezzo di provincia italiana, attraverso una focalizzazione
molto mobile nei vari capitoli. Il
suo romanzo d'esordio Nicola Rubino era stato il primo
esempio di letteratura postindustriale degli anni Duemila, ambientato
com'era in una multinazionale produttrice di motori Diesel dell'hinterland
barese, nella quale un giovane lavora con un contratto di formazione
a tempo determinato, inutilmente sperando nel posto fisso e
disilludendosi anche sull'ideale della solidarietà di
classe, poiché gli operai ingaggiano tra loro una guerra
spietata fatta di sgambetti, mobbing, cooptazioni sleali. Tutto
lo spazio narrativo di Nicola Rubino era occupato dalla
fabbrica, un mondo concentrazionario chiuso in sé stesso.
La gente per bene invece allarga lo sguardo ad un intero
tessuto sociale compromesso, anzi necrotizzato, dandoci uno
spaccato di un pezzo di provincia italiana, attraverso una focalizzazione
molto mobile nei vari capitoli.
A differenza di Nicola Rubino, qui il destino del protagonista
è assodato dalle prime pagine: il primo racconto di lavoro
inizia con la comunicazione del licenziamento, e poi procede
a ritroso fino al momento dell'assunzione per tornare, in modo
circolare, alla fatalità inevitabile di una disoccupazione
cronica e senza scampo.
In un'opera che sembra un rantolo crudo, proveniente dalla pancia
di un Sud abbandonato a se stesso, l'antinomia “personaggio
inetto – imprenditore” riattualizza la dialettica,
che qualcuno pensa passata di moda, tra chi ha i mezzi di produzione
e chi non ce li ha. La struttura narrativa “deformata”,
“scorciata” di questo romanzo, che sostituisce all'io
narrante dell'ex lavoratore l'epopea in terza persona dell'imprenditore
(semplicemente perché il protagonista non ha più
nulla da dire di sé) ripropone nella morfologia della
trama questo scippo: questa rapina può anche chiamarsi
lotta di classe, colta nel suo stadio terminale, nella
disamina disperata e insieme liberatoria di molti fallimenti
storici. Si tratta di un affresco allucinato del gigantismo
industriale che nel Sud Italia è collassato su se stesso
più rapidamente che altrove per una connaturata fragilità,
che non poteva reggere il confronto con le economie dei giganti
asiatici, le delocalizzazioni e le crisi strutturali.
Ma è anche una critica radicale all'inadeguatezza della
politica a trovare vie di emancipazione per le masse, nelle
sue forme organizzative tradizionali, nella delega rituale ai
rappresentanti (dei partiti, sindacati, movimenti: anche questi
sono annoverati tra la gente per bene), nell'usura del
suo stesso linguaggio, che finisce per diventare cantilena autocaricaturale
e retorica (e infatti la lingua di Dezio spesso preferisce attingere
ai registri linguistici bassi, dando voce agli ultimi).
Anche per questo viene fuori, nelle ultime pagine, la rabbia
di chi non è ancora disposto a rassegnarsi e nell'analisi
condotta con gli strumenti della ragione trova l'energia per
un ultimo estremo scatto libertario, per un'ulteriore resistenza.
Claudia Mazzilli
LGBTQI/
Anni '70 e oggi. Dalla radicalità alla normalizzazione
Per presentare il libro di Porpora Marcasciano AntoloGaia (Alegre edizioni, Roma 2014, pp. 272, € 15,00), autobiografia in cui si ripercorrono le battaglie dei movimenti LGBTQI negli anni Settanta, abbiamo fatto alcune domande all'autrice, presidente del MIT (Movimento identità transessuale).

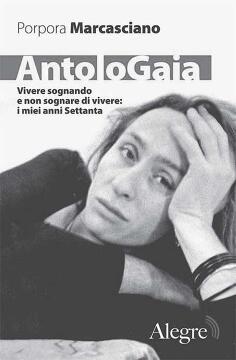 Porpora,
puoi dirci com'è cambiato l'ambiente LGBTQI dagli anni
'70 ad oggi? Porpora,
puoi dirci com'è cambiato l'ambiente LGBTQI dagli anni
'70 ad oggi?
È cambiato molto, profondamente, ma dipende dai punti
di vista se dire in meglio o in peggio.
Per quanto mi riguarda, credo ci sia stato un progressivo miglioramento
in termini di visibilità, ma non altrettanto per quanto
riguarda i diritti e il riconoscimento. Ho la sensazione che
tutto sia progredito fin quando è durata la spinta propulsiva
degli anni '70 poi si è innescata una controtendenza,
che non so datare con esattezza, che ha prodotto una involuzione
in termini di pregiudizio e violenza.
L'Italia è attestata al primo posto in Europa per crimini
contro le persone trans, ma anche gay e soprattutto delle donne,
cos'altro dire? La parola più usata dai bulli nelle scuole
è “frocio” cosa altro aggiungere?
Evidentemente una causa c'è e va ricercata sicuramente
nella propaganda catto-fascista fondamentalista che negli ultimi
anni ha avuto una grossa recrudescenza.
Dagli anni delle rivolte e dei moti di Stonewall si è
passati a richieste più istituzionali e normalizzanti.
Dov'è finita la radicalità del movimento?
Dalla metà degli anni '80 il movimento mainstream
si è piegato ai partiti, o meglio al partito, manipolando
tutte le questioni sui diktat di palazzo. Tutto è stato
riportato alla battaglia per le unioni civili tralasciando il
resto.
La parte più radicale del movimento LGBTQ è stata
attaccata e fagocitata, mentre la parola d'ordine diventava
“normalizzazione”. Oggi ci si comincia a rendere
conto che quel vuoto ha prodotto mostruosità e non so
dire se è troppo tardi.
Puoi parlarci del MIT? Qual è la sua storia e quali
sono state le sue conquiste?
La storia del MIT (Movimento Italiano Transessuali prima e Movimento
Identità Trans poi) è nata nel 1981 ponendo l'associazione
come la più longeva di tutto il panorama LGBTQ.
La sua conquista principale è datata 1982 ed è
l'ottenimento della Legge 164 che permette di cambiare sesso.
L'unica insieme alla Germania. Oltre alla possibilità
di intervenire chirurgicamente era un primo grande riconoscimento
dell'esperienza trans fino a quel momento negata.
In seguito il MIT nel suo percorso bolognese realizza e struttura
grandi servizi e progetti come il primo Consultorio per la salute
delle persone trans, il progetto di riduzione del danno nel
mondo della prostituzione, lo sportello legale, quello per il
lavoro, l'intervento in carcere, le case di accoglienza e il
Festival del cinema trans denominato Divergenti.
Cosa c'è nel futuro del MIT?
C'è il cambiamento della realtà trans, quella
del paese e di tutto il mondo. Abbiamo appena cominciato e dobbiamo
eliminare dalla storia il pregiudizio e la violenza che ne consegue.

Sacra Bottega/
Uno sguardo critico e un po' di aria fresca
Left è una rivista settimanale che esce da oltre
12 anni, in diretta continuità con Avvenimenti,
analoga rivista con cui oltre una ventina di anni fa stabilimmo
la possibilità di un abbonamento (unico) cumulativo alle
due riviste. Abbiamo buoni rapporti personali con la direttora
Simona Maggiorelli e un positivo dialogo con Federico Tulli,
uno dei 3 redattori di Left e in un paio di occasioni
nostro stimato collaboratore. Stimato e significativo, perchè
è un giornalista e scrittore che ha un pallino che ci
accomuna: l'interesse critico, molto critico, per le cose vaticane,
per l'influenza della Chiesa cattolica nella società,
la critica alla sinistra istituzionale (e anche a quella “estrema”)
per la sua rinuncia a qualsiasi spirito critico verso il Vaticano
e il suo inquilino più famoso.
 Lo
scorso anno il quotidiano comunista Il Manifesto –
tanto per ricordarci in che tempi grami viviamo – se n'era
uscito con un libretto dedicato a Bergoglio, ai suoi scritti
contro il capitalismo ecc. ecc. E Francesco, come ormai viene
chiamato dai mass–media come fosse un nostro fratello,
membro di ciascuna delle nostre famiglie, riceveva così
un'ulteriore consacrazione quale figura di punta della sinistra
attuale. Una specie di novello Che Guevara, paladino delle periferie
geografiche e sociali del mondo. Lo
scorso anno il quotidiano comunista Il Manifesto –
tanto per ricordarci in che tempi grami viviamo – se n'era
uscito con un libretto dedicato a Bergoglio, ai suoi scritti
contro il capitalismo ecc. ecc. E Francesco, come ormai viene
chiamato dai mass–media come fosse un nostro fratello,
membro di ciascuna delle nostre famiglie, riceveva così
un'ulteriore consacrazione quale figura di punta della sinistra
attuale. Una specie di novello Che Guevara, paladino delle periferie
geografiche e sociali del mondo.
Il libro che qui segnalo – edito sostanzialmente da Left
– va nella direzione opposta, come già indica il
titolo: Il falso mito di Bergoglio (Editoriale Novanta,
Roma 2018, pp. 223, € 19,70). Si tratta di 42 articoli
apparsi su Left, tra il 2013 e il 2018, scritti da 15
persone: più della metà (ben 23) dal citato Tulli.
Per capire il contenuto e soprattutto lo “spirito”
di questo libretto, di veloce e piacevole lettura, è
sufficiente, forse, citare i titoli di alcuni articoli (abbiamo
scelto quelli di Tulli): I massoni di San Pietro / Il paradiso
degli affari sporchi / La chiesa sconfessata / M.G.Gatti: La
violenza non è sessualità / A chi giova la morte
del prete che “odiava” i bambini / Chi confessava
i torturatori / Il paradiso può attendere / G. Nuzzi.
Per il Vaticano parlare con i giornalisti è reato / Che
fine ha fatto il Giubileo? / Pedofilia: i fantasmi di Bergoglio
/ Caccia al diavolo / Desaparecidos. Il Vaticano apre gli archivi.
Ma non troppo / Le narrazioni tossiche della Santa Sede / Renzi
ha messo in ginocchio la Rai / Quando l'autorità (non)
è garante / Chiesa e pedofilia: i complici di papa Francesco
/ Un tipo sinistro / Sì allo ius soli, dice il papa.
Ma fuori del Vaticano / Stefano Incani: Viviamo in uno Stato
ipotecato dalla Chiesa / Pedofilia, un papa dalla memoria corta.
I chierichetti del papa, l'orco e i monsignori / Croci, padelle
e pappagalli / Il senso di Bergoglio per la pedofilia.
Non entro nel merito di alcuno degli scritti contenuti in questo
libretto. Chi ha a cuore la difesa della società civile
dall'invasiva presenza della Chiesa, anche partendo da premesse
e da una concezione molto diversa dalla nostra prospettiva anarchica,
troverà in queste pagine aria fresca e stimolante, così
difficile da trovare oggi in materia di Vaticano, papa, Chiesa
e dintorni.
Più volte abbiamo lamentato su queste colonne il progressivo
ritirarsi – come avviene per i ghiacciai – di quello
spirito laico, anticlericale, che ha sempre cercato di denunciare
e arginare la nefasta influenza del Vaticano nella vita quotidiana,
soprattutto in Italia. Alcuni soggetti di quelle battaglie sono
scomparsi o si sono trasformati, penso ai repubblicani, ai liberali
(con l'eccezione importante di Critica liberale). E poi
tanta parte dei socialisti, una piccola minoranza dei comunisti,
gli stessi radicali che dall'esaltazione delle Pagine anticlericali
di Ernesto Rossi (uno dei testi della mia formazione politica
giovanile, mezzo secolo fa) sono passati alle marce, pasquali
e non, “nel nome di Marco (Pannella) e Francesco (Bergoglio)”.
Il caso dei radicali è davvero clamoroso, per chi –
come me – ha vissuto la loro stagione anticlericale sia
dal lato degli anarchici (quando facemmo iniziative comuni anticlericali)
sia da parte familiare (mia madre, in particolare, impegnata
accanto a loro nelle lotte per il divorzio, l'aborto, la denuncia
dei Patti Lateranensi).
Fa piacere che una rivista come Left, in assoluta controtendenza,
mantenga acceso e attento lo sguardo sulla Sacra Bottega. Forse
Left non sarà, come si autoproclama, “l'unico
giornale di sinistra”, ma fosse anche solo per questa
sua attenzione costante sull'invasività clericale, merita
di essere seguita, come sempre con attenzione critica (che noi
rivolgiamo anche a noi stessi).
Comunque, il libro che ho qui segnalato non può mancare
nella libreria di chi – indipendentemente dal proprio
personale ateismo o fede in qualsiasi religione – ritenga
il clericalismo, qualsiasi clericalismo, tossico per la società,
gli individui, la libertà. E, appunto, voglia respirare
un po' di aria laica e fresca.
Paolo Finzi
Louise Michel/
Quella “follia creativa” di cui abbiamo tanto bisogno
È la tua forza interiore a farti libero, nonostante tutte le costrizioni esterne.
Il filosofo e alpinista norvegese Arne Naess sosteneva che il benessere è
collegato a due elementi: ardore e dolore. L'ardore –
cioè gioia, passione, coinvolgimento – secondo
il suo pensiero, può compensare molto dolore. Al contrario,
se si “arde” poco o niente, il livello di benessere
sarà basso, anche se nella vita si avesse avuto la fortuna
di incrociare poco dolore. Coerentemente con questa riflessione,
secondo Naess sarebbe più importante accrescere l'ardore
che non ridurre il dolore per avere maggiore benessere. (cfr.
Erling Kagge, Camminare. Un gesto sovversivo, Torino,
Einaudi, 2018).

Oltre al fatto che trovo interessante il tipo di riflessione,
ho voluto introdurre con questo pensiero la recensione a Il
tempo delle ciliegie perché l'intera vita di Louise
Michel - raccontata da Marco Rovelli in centoventi pagine per
quelli di Elèuthera (Milano 2018, pp. 128, € 14,00)
mi è apparsa come l'esatta applicazione di questo principio:
la passione, la speranza, la fede più di tutto, a sostegno
di molto dolore.
La storia è quella di una ragazza di nome Louise che
nasce nel maggio del 1830 in Francia – a Vroncourt-la-Cote,
nello Champagne – da una donna che lavorava come domestica
presso i signorotti del paese. Il padre era “relativamente
ignoto” perché semplicemente si trattava del padrone
o – questo non è certo – del figlio del padrone.
Sta di fatto che Louise, anche se in maniera non ufficiale,
verrà accettata e grazie a questo riceverà una
buona istruzione che, oltre a infonderle amore per la letteratura
e la cultura in generale, le permetterà di diventare
istitutrice e quindi, a soli ventidue anni, aprire una scuola
vicina ai suoi ideali, un luogo dove venivano applicati metodi
pedagogici, assolutamente all'avanguardia per quell'epoca, basati
su sperimentazione e creatività.
A ventisei anni, continuando a lavorare come istitutrice, si
trasferisce a Parigi dove sposerà idee repubblicane e
rivoluzionarie e incomincerà a battersi per il diritto
all'istruzione per le donne. Da qui alla primavera 1871, quando
la si vede in prima linea sulle barricate della Comune, la sua
vita sarà sempre un susseguirsi di gesti compiuti in
favore degli ultimi, per un tempo di giustizia e uguaglianza
che prima o poi sarebbe arrivato.
Di Louise si dice che fosse una splendida follia creativa
e Marco Rovelli, nella prima parte del libro, ne segue le tracce
come se di lei raccontassero tutti quelli che l'avevano conosciuta,
già a partire dall'infanzia. Si delinea una personalità
che si esprimeva in un modo d'essere pieno di fede nella possibilità
di riscatto per gli esseri umani e intollerante verso ogni genere
di sopruso, ancor prima dell'adesione a qualsiasi idea o ideologia.
Poi vengono i giorni della Comune durante i quali le donne non
rimasero mai in disparte, anzi si dice che furono un “esempio
luminoso di speranza” nonostante – allora come sempre
– dovessero sostenere un doppio scontro, entrando spesso
in conflitto con gli uomini compagni di ideali, come fu in quella
manciata di giorni carichi di sogni e passati per sempre alla
storia. Dopo arrivarono gli anni di carcerazione e quindi la
deportazione in Nuova Caledonia, ma, come suggerisce la quinta
parte del libro, il racconto a un certo punto si fa mito
(...) gli eventi vengono isolati e posti in un meraviglioso
eterno presente, carichi di una potenza universale che si riverbera
su ogni possibile futuro.
Ed è così. Ma proprio per questo val la pena riportare
ancora qualcosa di quanto ci viene raccontato, idee di fondo
che il tempo non ha invecchiato.
La prima riguarda il potere, sul quale Louise, durante il viaggio
che la portava verso l'Oceania, pare abbia riflettuto a lungo:
Potere che non può che essere “comune”,
dal basso, esercitato da un popolo in cui tutti e ciascuno abbiano
per prima cosa la dignità della vita: e non può,
soprattutto, essere un potere, se non inteso come modo infinito
del verbo. Il potere è l'ostacolo principale della liberazione
dell'umanità.
La seconda – tratta da un ricordo di Pietro Gori a pochi
anni dalla morte di Louise Michel (riportato da Marco Rovelli)
– estende il discorso sul potere andando a coinvolgere
i cosiddetti “esseri inferiori” e dice così:
Ah, gli esseri inferiori, ecco il pretesto d'ogni dominazione!
(...) Inferiori perché? Perché altri più
violenti, o più astuti, riuscirono ad assoggettarli o
a ucciderli? (...) Ma io conosco un'altra legge, che non è
di oppressione né di morte, ma di libertà e di
vita, quella della solidarietà. (...) Diversi sì,
inferiori no. (...) “Ma tra l'umanità e le altre
specie zoologiche ...” azzardai io. “Ebbene –
incalzò l'ardente vegliarda - è appunto perché
l'umanità volle calpestare gli altri esseri, che voi
chiamate inferiori, che essa si trovò esercitata ad inferocire
e a dilaniare se stessa. Le razze inferiori, le classi inferiori,
il sesso inferiore, che per dileggio chiamate gentile, ecco
la stessa classificazione trasportata dal campo animale a quello
umano...”
Oggi abbiamo ancora sfruttamento, violenza sulle donne, discriminazioni
in base alla razza e all'orientamento sessuale, soprusi sui
migranti e – privilegio dei nostri tempi – allevamenti
intensivi, distruzione delle risorse naturali... Allora a cosa
ci serve leggere questa storia accaduta centocinquant'anni fa?
Forse perché, come al cinema, è sempre bello immedesimarsi
in avventure piene di coraggio e altruismo? Oppure per constatare
come va sempre a finir male e quindi, disillusi e rassegnati,
tornare al grigiore quotidiano?
Io penso che libri di questo genere abbiano la funzione di confermare
la teoria citata all'inizio e spingerci alla messa in gioco,
proprio se ci sta a cuore il benessere di tutte/i e tutto. Non
si può pensare di star sempre di lato, poco coinvolti,
di passare indenni tra conflitti e contraddizioni, esplorando
solo la superficie degli accadimenti e di noi stessi. È
di quella “follia creativa” che necessitiamo anche
noi, non necessariamente per vincere ma, come Louise Michel,
per vivere.
Silvia Papi
Libri per l'infanzia (ma non solo)/
Quando l'eternità diviene un sussurro di poesia
 L'eternità
è un'idea incontenibile e per questo, il più delle
volte, suscita timore e sgomento. Vi sono tuttavia delle occasioni
particolari di poterla sfiorare come fosse una brezza sottile
e leggera, che tocca la punta del nostro naso per essere annusata.
Questa opportunità l'ho avuta leggendo, recentemente,
due racconti che, per forma e contenuto, hanno in sé
lo straordinario. Il primo è di Beatrice Masini,
Se è una bambina (bestBUR Rizzoli, Milano 1998,
prefazione di Antonio Faeti, pp. 108, € 9,50); già
letto qualche hanno fa, ma ritrovato da poco. Il secondo è
di Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni (Salani
editore, Milano 2017, pp. 272, € 13,90) più recente
e di prima lettura. L'eternità
è un'idea incontenibile e per questo, il più delle
volte, suscita timore e sgomento. Vi sono tuttavia delle occasioni
particolari di poterla sfiorare come fosse una brezza sottile
e leggera, che tocca la punta del nostro naso per essere annusata.
Questa opportunità l'ho avuta leggendo, recentemente,
due racconti che, per forma e contenuto, hanno in sé
lo straordinario. Il primo è di Beatrice Masini,
Se è una bambina (bestBUR Rizzoli, Milano 1998,
prefazione di Antonio Faeti, pp. 108, € 9,50); già
letto qualche hanno fa, ma ritrovato da poco. Il secondo è
di Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni (Salani
editore, Milano 2017, pp. 272, € 13,90) più recente
e di prima lettura.
Beatrice Masini e Bruno Tognolini indicati nelle loro biografie
come “scrittore e scrittrice” per i bambini e le
bambine, amo pensarli più come “scrittore e scrittrice
con l'infanzia” poiché nelle loro tracce, lasciate
sulle pagine, concedono, a chi le legge, di far riprendere forza
e sensibilità a quella parte di ognuno e ognuna di noi
che ci accomuna nella nostra vita e ci rende così simili
e vicini; parte che va appunto sotto il nome di: infanzia, quell'essere
qualcosa d'altro da ciò che da adulti siamo, saremo o
abbiamo immaginato di essere.
Le loro pubblicazioni sono molteplici e invito chi ancora non
li abbia incontrati, di tentare questa conoscenza attraverso
queste due loro opere che ci portano per mano in uno dei paesaggi
più timorosi, misteriosi e dolorosi della vita: quello
dell'eternità. Masini lo fa attraverso lo sguardo e le
parole di una bambina e la sua mamma che scompare per sempre
in quel giorno della polvere, Tognolini ci porta nel
giardino dei musi eterni in cui gli Àniman,
senza capo né coda, trovano il loro luogo oltre la vita
sulla terra. Lo stile di entrambi è quello di sussurrarci
parole poetiche entro quel buio che potrebbe essere la
luce eterna e dentro quel giardino in cui: Tu sei tutti e
tu sei tu.
Ora, immagino, vi domanderete: a chi sono rivolti questi racconti
e per quale età?
Come dicevo, a mio avviso, sono pensati per l'infanzia
qualsiasi età abbia oggi o abbia avuto ieri, a cui siamo
appartenuti o alla quale ancora apparteniamo. Poiché,
per fortuna l'infanzia può essere anarchica e
si posiziona liberamente nell'età che meglio crede.
Qui di seguito troverete alcuni pensieri che hanno l'intenzione
di essere un invito per l'infanzia che è corpo grande
e per l'infanzia che è corpo piccolo, in questo modo
anche, chi ancora è giudicato piccolo o piccola per scegliere,
qui troverà alcuni elementi per essere libero o libera
di farlo con la propria testa.
L'eternità è un'idea incontenibile e per questo,
il più delle volte, suscita timore e sgomento. Vi sono
cegliere, qui troverà alcuni elementi per essere libero
o libera di farlo con la propria testa.
Se è una bambina
Per l'infanzia che è ancora in un corpo piccolo.
Se sceglierete di leggere questo libro dovrete avere un po'
di coraggio perché vi troverete una bambina che vive
la terribile e crudele esperienza della guerra e che un giorno
perde per sempre la sua mamma. Da quel giorno la sua vita cambia
e decide di parlare fra sé e sé come se la sua
mamma ancora ci fosse, e contemporaneamente, nel tempo eterno,
la sua mamma fa lo stesso e pensa a lei. A volte è molto
triste capire che qualcuno è andato via per sempre, è
morto o morta, ma in queste pagine troverete molto di più
della sola tristezza e potrete anche sorridere ed essere contenti
per le cose belle che questa bimba continuerà a fare
anche se le manca moltissimo la sua mamma.
Qui troverete i racconti della sua vita che risalgono ad un
periodo storico molto diverso da quello che viviamo noi oggi,
ma che proprio per questo ci aiutano a comprendere cosa significa
vivere dopo una guerra. È molto bello leggere anche i
pensieri della sua mamma che, anche se volata nell'eternità
si ricorda, pensa e vuole per sempre bene alla sua bimba che
è ancora sulla terra, infatti lei stessa dice che non
saremo mai lontani perché siamo fatti di desideri
più che di carne, impastati in un materiale più
delicato che quella di solita lega di ciccia e sangue. Dunque
provate a vedere se avete voglia di ascoltare e stare vicino
a questa bambina che vive questa esperienza un po' difficile,
ma che tuttavia non si scoraggia mai.
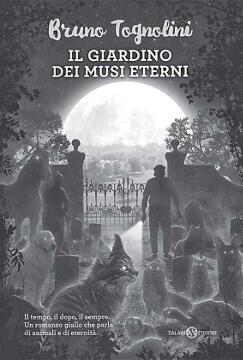
Per l'infanzia che è in un corpo già grande
consiglio, per questo libro, di trovare un posto caldo, solitario,
che sappia guardare verso l'infinito, poi consiglio due generi
di lettura quella tutta d'un fiato che ci porta via con essa
e non sappiamo più dov'è il posto dove siamo,
oppure la lettura a dialogo collettivo (a due voci magari) per
mettervi in scena e vivere sino in fondo questi attimi di altro
tempo. Vi ritroverete accovacciati in voi stessi, troverete
un silenzio mai trovato, che forse in realtà rintraccia
l'urlo che si fa anche quando si nasce, che sorprende, spaventa
e meraviglia. Masini vi prende per mano, non vi lascia comunque
soli, ma con i pensieri vi farà scoprire angoli mai visti,
traiettorie mai tracciate. Comparirà il timore della
dimenticanza nel famoso eterno presente che ci farà
preferire di insistere nel continuare a ricordare, vedere, sentire
perché i ricordi preziosi non si spengono e noi possiamo
sempre avere una lampadina. La prefazione di Roberto Faeti
ne amplifica e sostiene la straordinaria profondità esistenziale
e filosofica. Beatrice Masini sembra essere molto vicina a dare
senso a ciò che spesso senso sembra non trovarne. Se
avete un po' di coraggio infantile tentate e leggete.
Il giardino dei musi eterni
Per l'infanzia che è ancora in un corpo piccolo
Il giardino dei musi eterni è un giardino speciale,
abitato dagli Àniman, senza capo né coda,
che lasciata la terra, e con lei i loro amici e amiche umani,
per sempre si ritrovano in questo luogo indefinito e di tempo
infinito. Si tratta di un cimitero per animali in cui Ginger,
gatta maine coon a pelo semilungo, Orson, cane pastore
maremmano abruzzese, Mama Kurma, vecchissima tartaruga europea
di terra, Ted pastore tedesco poliziotto, Trilly porcellina
d'india peruviana, Sophie cagnetta bastarda, e molti e molte
altri e altre ci portano a vivere un'avventura nella vita ultraterrena
fatta di mistero e amicizia. Gli Àniman parlano,
pensano e ci faranno scoprire che a volte bisogna lasciare
andare qualcuno o qualcosa a cui vogliamo molto bene senza
paura, perché esiste, anche per gli animali, un luogo
fantastico in cui il tempo è divenuto infinito.
Per l'infanzia che è in un corpo già grande
gli Àniman sono l'Anima più grande
che possiamo incontrare nella vita, Tognolini con il suo sguardo
poetico e fantastico dona l'Àniman a quelle creature
che abitano con noi l'esistenza. Il giardino dei Musi eterni
è un insegnamento unico, quello di pensare che possiamo
essere tutti e che tutti possono essere noi, non solo nell'eternità.
Non fatevi prendere dunque dalla fatica dell'abbandono, ma sappiate
cogliere la forza della vicinanza, del legame anche con chi
ci sembra di essere così differenti da noi. Tognolini
ci mostra il potere di pensare che gli animali possano essere
Àniman.
Silvia Bevilacqua
Quasi una biografia/
Giuseppe Brunetti. Il culto del dubbio
 Il
Centro Internazionale della Grafica di Venezia, un anno e mezzo
fa, ha pubblicato Uno spirito libero, in un'edizione
limitata. Il medesimo testo è ora disponibile con una
veste rinnovata: Giorgio Brunetti, Educazione alla libertà
(edizioni Nuovadimensione, Portogruaro - Ve 2017, pp. 157, prezzo
non specificato). Il
Centro Internazionale della Grafica di Venezia, un anno e mezzo
fa, ha pubblicato Uno spirito libero, in un'edizione
limitata. Il medesimo testo è ora disponibile con una
veste rinnovata: Giorgio Brunetti, Educazione alla libertà
(edizioni Nuovadimensione, Portogruaro - Ve 2017, pp. 157, prezzo
non specificato).
L'autore, già docente di Economia aziendale alle facoltà
Ca' Foscari di Venezia e Bocconi di Milano, è professore
emerito e autore di diversi libri sulla sua materia di insegnamento,
ma qui dedica la sua attenzione al ricordo del padre Giuseppe,
nato nel 1907 e morto nel 1985. Sarebbe però improprio
catalogarlo fra le biografie: non mancano i dati essenziali,
ma lo scorrere del vissuto è cadenzato dalla crescita
della sensibilità intellettuale descritta parallelamente
ai principali avvenimenti storici italiani e al dibattito alimentato
dagli stessi.
Giuseppe Brunetti nasce da “famiglia modesta” a
Venezia dove trascorre tutta la sua esistenza; trova lavoro
come infermiere, studia e si diploma, trovando in questa professione
la coerenza etica che caratterizzerà tutto il suo percorso
di vita; si sposa, ha un figlio e due nipoti.
“Gli ammalati gli offrono uno spaccato di una umanità
dolente e disagiata che lo coinvolge profondamente: viene a
contatto con vagabondi, avvinazzati, questuanti e poveri di
ogni tipo. Ha un profondo senso di rispetto della persona ed
è generoso quando si tratta di aiutare i degenti, qualità
che lo aiutano a svolgere il lavoro di infermiere con professionalità
e con altrettanta umanità”. È questo affettuoso
ritratto di Bepi a delineare l'indole benevola che sempre lo
accompagnerà e che aiuta a comprendere l'instancabile
esigenza di un'incessante ricerca culturale maturata fino all'avvicinamento
al movimento e all'ideale anarchico, entro il quale trova una
personale dimensione di coerenza oltre ad ulteriori stimoli
di arricchimento del proprio pensiero.
L'incontro con Giulio Morandini diventa così fondamentale
che Giuseppe affiancherà, all'approfondimento dei suoi
interessi, uno sguardo critico prettamente libertario a “conferma
del suo sentire. Una filosofia etico politica nella quale scopre
cose che avverte da sempre quali la libertà dell'individuo,
la sua autodeterminazione e il totale e pieno diritto di scelta,
di consenso o di rifiuto.”
Frequenta la Libreria Internazionale di Venezia e le tante iniziative
lì organizzate, anche grazie alle instancabili attività
editoriali ed artistiche di Silvano Gosparini che in seguito
diverrà il fulcro creativo del Centro Internazionale
della Grafica.
Il figlio Giorgio, nel dettagliare autori e titoli di cui è
composta la biblio/emeroteca del padre – ora divenuta
un fondo a suo nome conservato nell'Archivio Famiglia Berneri-Chessa
- svela quanto, all'interno dei libri, abbia trovato appunti,
parti evidenziate, citazioni esemplificative, commenti o recensioni
a testimonianza di quanto le letture abbiano sempre nutrito
il suo bisogno di approfondire una gamma vastissima di temi:
“due insegnamenti di mio padre. Il primo, non sempre la
ragione è a fondamento del proprio pensiero e del proprio
agire, occorre anche tener conto del cuore. Il secondo è
il culto del dubbio”.
La scorrevole lettura di Educazione alla libertà
è di per sé una sorta di viaggio temporale, una
mappatura delle principali tappe del percorso intellettuale
del protagonista dalle quali emerge una poliedrica messa a confronto
di saperi ed espressioni, dall'economia alla politica, dall'attualità
alla letteratura, dalla pedagogia alla psicanalisi.
Chiara Gazzola
Migranti/
Quando la libertà dipende dal verso
“Tu racconti, io scrivo e firmiamo entrambi”. L'accordo
tra Bruno Le Dantec, giornalista e scrittore, e Mahmoud Traoré,
è stato da subito molto chiaro. L'idea di rubargli la
storia era categoricamente fuori discussione (Partire - Un'odissea
clandestina di Mahmoud Traoré e Bruno Le Dantec (traduzione
di Federico Brivio, Edizione Baldini & Castoldi, Milano
2018, pp. 288, € 18,00).
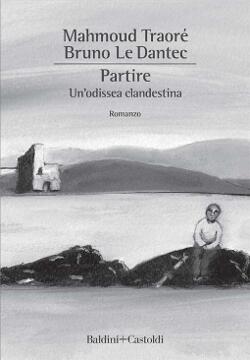 Già
per tutto il viaggio, sin dal treno Dakar–Bamako, il giovane,
come tutti i migranti, ha dovuto fare i conti con una serie
di appropriazioni indebite, richieste ricattatorie di denaro
e altri soprusi che caratterizzano tutto il bizness dell'immigrazione.
E poi secondo Bruno Le Dantec, troppo di rado i migranti hanno
occasione di raccontare in prima persona la propria storia e
i propri sentimenti. E quando anche lo fanno, troppo spesso
le loro storie vengono riferite in maniera parziale e manipolatoria
a seconda dell'obiettivo di chi, sia egli politico o giornalista,
le riferisce. Già
per tutto il viaggio, sin dal treno Dakar–Bamako, il giovane,
come tutti i migranti, ha dovuto fare i conti con una serie
di appropriazioni indebite, richieste ricattatorie di denaro
e altri soprusi che caratterizzano tutto il bizness dell'immigrazione.
E poi secondo Bruno Le Dantec, troppo di rado i migranti hanno
occasione di raccontare in prima persona la propria storia e
i propri sentimenti. E quando anche lo fanno, troppo spesso
le loro storie vengono riferite in maniera parziale e manipolatoria
a seconda dell'obiettivo di chi, sia egli politico o giornalista,
le riferisce.
La potenza del racconto del viaggio che Mahmoud Traoré
ha affrontato sta nello svelarci soprattutto le nostre contraddizioni.
Siamo ben disposti, non tutti ovviamente, ad accogliere migranti
che scappano da guerre, dittature e fame. A noi e alle nostre
coscienze fa comodo pensare che i flussi migratori avvengano
solo ed esclusivamente a causa di fattori che pongano la
fuga come unica alternativa ad una morte certa.
Non voglio negare che queste siano le motivazioni di una moltitudine
di migranti, ma il punto è che ci è più
facile far leva sul nostro pietismo piuttosto che sul nostro
intimo concetto di libertà. Non è detto infatti
che siamo disposti ad accogliere chi, come Mahoumud Traoré
decide di partire all'improvviso per “fare l'avventura”
all'africana semplicemente perché, come lui stesso racconta,
“sei lì, a mani vuote, stanco di soffrire e di
attendere qualcosa che, ne sei sicuro, non succederà
mai se non sei tu ad andartelo a cercare. Così un bel
giorno decidi di darti una mossa e vai a cercare fortuna, dicendoti
che se ti andrà male potrai sempre tornare indietro”.
E così si arriva alla motivazione più personale,
più intima che spinge Bruno Le Dantec a sbobinare più
di trenta ore di registrato in cui Mahmoud Traoré racconta
la sua odissea durata più di 3 anni (2002/2005). Scrive
il giornalista: “Partire all'improvviso, ho fatto la stessa
cosa, più o meno alla stessa età. L'unica differenza
è che mi trovavo dalla parte giusta del mondo. Nelle
situazioni difficili, un passaporto mi garantiva la possibilità
di tornare a casa.”
Ma Mahmoud Traorè, nonostante l'illusione iniziale, ci
racconta che non è più possibile tornare a casa.
E non solo per orgoglio, perché non si vuole essere considerati
dei falliti, dei rinunciatari mollaccioni. Non si può
più tornare indietro perché non si hanno i soldi,
non si hanno i documenti ma soprattutto non si riattraversa
il deserto dopo che si è riusciti una volta e si sa quanti
sono i morti che ci si è lasciati alle spalle. Perciò
ci si ammassa per cercare di arrivare in Europa che pare l'unica
meta possibile per sfuggire all'inferno libico o marocchino.
Partire - Un'odissea clandestina ci mostra molto chiaramente
anche le contraddizioni delle politiche migratorie. Ci sono
ampi settori della nostra economia che si basano esclusivamente
sullo sfruttamento dei migranti irregolari, checché strillino
ipocritamente e demagogicamente i politici.
Ma sempre di sfruttamento si tratta. La mano d'opera a bassissimo
costo consente alle nostre economie di poter competere con i
paesi emergenti in cui il lavoro viene sottopagato. E questo
meccanismo non viene applicato solo in campo agricolo, ma anche
in edilizia, nell'industria alberghiera, nella ristorazione
oltre che nei servizi alla persona. Il ricatto di espulsioni,
leggi discriminatorie e ritorsioni razziste, mettono il clandestino
in condizione di apparire come il lavoratore ideale desiderato
dal capitalismo. Come può infatti rivendicare alcunché
chi è ricattabile su tutto?
Senza filtri, Mahmoud Traoré ci racconta anche le contraddizioni
in seno alla stessa comunità dei migranti dove ovviamente
non tutti i migranti sono angeli così come non tutti
i passeur o i poliziotti sono mascalzoni, e del razzismo
diffusissimo soprattutto in Libia nei confronti dei subsahariani.
È amara la constatazione che i migranti, da quando partono
a quando arrivano, sono una merce che durante tutto il tragitto
fa guadagnare tutti tranne i migranti stessi, a meno che non
decidano di fermarsi per dedicarsi in prima persona al bizness
dell'immigrazione. E il bizness è a tutti i livelli.
Mahmoud Traoré non può infatti dimenticare il
“torna quando vuoi” dettogli da uno dei militari
marocchini che lo stava respingendo verso l'Algeria. Al momento
aveva giudicato tale invito incomprensibile. Solo in seguito
si renderà conto del senso di quelle parole: senza migranti
non vi sarebbero i soldi che l'unione Europea versa al Marocco
e alla Libia che nel 2005 era ancora sotto il dominio di Gheddafi
(adesso pare che la mercificazione e le condizioni siano peggiori
di allora).
Come scrive Bruno Le Dantec certo ora le rotte clandestine si
sono spostate e la guerra in Iraq, in Siria e Libia hanno provocato
ulteriori ingenti esodi cui si sono aggiunti a quelli dei curdi,
dei palestinesi, dei somali, degli eritrei, degli afghani, degli
iracheni e dei sudanesi oltre che dei pachistani, etc. Ma a
prescindere dalla provenienza e dalla motivazione per intraprendere
un esodo migratorio, la realtà è che qualsiasi
migrante è una merce che crea profitto, ma che contrariamente
a tutte le altre merci che circolano in questo mondo globalizzato,
non ha alcuna tutela, sebbene di esseri umani si tratti. E questo
è disumano. Come pure disumana è la geografia
dell'Africa che emerge dal racconto.
Un'Africa divisa dal Sahara e da una serie infinita di confini
fittizi, confini che delimitano zone di influenza di bande organizzate
per sfruttare il traffico dei migranti, il bizness appunto.
Certo ci sono anche i confini lasciati dalla spartizione coloniale,
ma ciò che stupisce è che i paesi africani agiscano
come se fossero ancora delle colonie. E la globalizzazione non
fa altro che estremizzare lo sfruttamento colonialistico a vantaggio
dei pochi che si spartiscono il potere e le mazzette a scapito
della propria gente.
Diamo per scontate le dinamiche tangentistiche legate allo sfruttamento
delle risorse petrolifere, e pare esemplare il caso del Senegal
che concede alle multinazionali della pesca di pescare con mastodontici
pescherecci di fronte alle proprie coste, a scapito della diffusissima
economia della pesca locale che ovviamente non regge la concorrenza
tecnologica e da anni è sprofondata in una devastante
crisi economica. Dunque, al di là delle nefandezze che
compiono i nostri governi nei confronti dei migranti, la domanda
che rimane sul piatto è: perché i governanti del
Senegal, del Niger, del della Nigeria eccetera non fanno nulla
per i diritti alla libera circolazione della propria gente?
Eppure Mahmoud Traoré ci racconta che la solidarietà
è l'unica semplice regola che governa l'agire della comunità
che costituisce il suo villaggio.
E noi cosa facciamo?
Eugenia Lentini
Detenuti politicizzati/
Una vita tra le sbarre
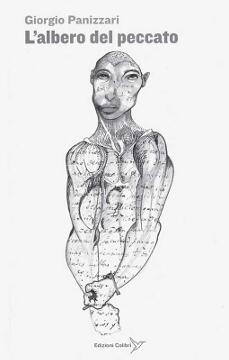 Una
storia articolata precede la pubblicazione di questo testo firmato
da Giorgio Panizzari (L'albero del peccato, Edizioni
Colibrì, Milano 2018, pp. 205, € 14,00) ma che va
ritenuto, almeno parzialmente, un'opera collettiva con il doppio
valore di testimonianza storica e di analisi da parte di un
profondo conoscitore del sistema carcerario. Il testo originario,
dallo stesso titolo, fu elaborato nell'1980-81 da un gruppo
di detenuti nel carcere di Palmi e pubblicato a Parigi a firma
“Collettivo Prigionieri Comunisti delle Brigate Rosse”
nel 1983, in un'edizione che conobbe, contrariamente a L'ape
e il comunista, scarsissima diffusione. L'autore, tra i
fondatori dei NAP e successivamente entrato nelle BR, compie
una radicale revisione della prima versione. Una
storia articolata precede la pubblicazione di questo testo firmato
da Giorgio Panizzari (L'albero del peccato, Edizioni
Colibrì, Milano 2018, pp. 205, € 14,00) ma che va
ritenuto, almeno parzialmente, un'opera collettiva con il doppio
valore di testimonianza storica e di analisi da parte di un
profondo conoscitore del sistema carcerario. Il testo originario,
dallo stesso titolo, fu elaborato nell'1980-81 da un gruppo
di detenuti nel carcere di Palmi e pubblicato a Parigi a firma
“Collettivo Prigionieri Comunisti delle Brigate Rosse”
nel 1983, in un'edizione che conobbe, contrariamente a L'ape
e il comunista, scarsissima diffusione. L'autore, tra i
fondatori dei NAP e successivamente entrato nelle BR, compie
una radicale revisione della prima versione.
Ad opera conclusa, nel 1989, non c'è più niente
del rustico vocabolario guerrigliero dei lottarmatisti, inutile
cercare esortazioni programmatiche quali: “Magistratura
penale dei tribunali che mitraglia raffiche di secoli di carcere
a decine di migliaia di proletari; giudici istruttori, procuratori,
giudici degli sfratti, tribunali dei minori; esperti tecnici
dell'amministrazione e avvocati di regime che ne integrano struttura
e funzioni, vanno battuti e dispersi se si arrendono. Massacrati
se resistono.” - che si trovano nell'edizione parigina,
espunte al pari di numerosi altri passi che oggi rappresentano
pura archeologia. Così dalla prima persona plurale si
passa a quella singolare, scelta opportuna visti anche i notevoli
ampliamenti e le cospicue parti autobiografiche. Una lunga gestazione
dunque per il libro dell'ex ragazzino torinese incappato, per
reati comuni, prima in quella scuola di violenza che erano i
riformatori degli anni '60 e successivamente in una condanna
all'ergastolo per un omicidio non commesso.
Il contatto con i detenuti politicizzati dà forma e contenuti
all'insofferenza verso le ingiustizie subite e trasforma Panizzari
in una singolare figura di proletario divenuto intellettuale
militante in un percorso consumatosi quasi interamente in istituti
carcerari. La biografia dell'autore permea l'intero saggio che
è in qualche modo il contrario di un trattato dell'osservatore
distaccato, ma non per questo ne mina le capacità di
valutazione, che restano integre e metodologicamente chiare.
L'obiettivo è quello di definire la storia, formazione
e struttura del proletariato extralegale, ovvero la parte
della classe rivoluzionaria che conduce un'esistenza contrassegnata
dall'infrazione delle leggi e conseguente detenzione. L'esigenza
di chiarimento viene dall'originaria sentenza sul lumpen
che ben conoscono il lettori di Marx & Engels - “putrefazione
passiva degli strati più bassi della vecchia società”
- e dalla necessità di tenere assieme la teoria rivoluzionaria
comunista e il ruolo del sottoproletariato. Come dire: salvare
la capra marxista e il cavolo carcerato. Tale problema è
del tutto estraneo alla tradizione anarchica che non si è
mai fatta alcun problema ad includere tra gli oppressi bisognosi
di rivolgimento globale gli strati marginali e socialmente irrecuperabili,
mentre è questione spinosa per chi si aspetta la rivoluzione
dal proletariato industriale disciplinatamente condotto da avanguardie
politiche.
Talmente scomoda che Panizzari nota: “Benché il
carcere stimoli indignazione in tutti i ceti sociali, c'è
infatti chi lo ritiene un «male», sì, ma
«necessario», e vorrebbe liberarsi della sua necessità;
oppure chi lo vorrebbe continuamente riformato in vario modo;
altri lo individuano come un simbolo da combattere e da abbattere:
«baluardo controrivoluzionario della società borghese»
ma non una sola rivoluzione politica in tutto il mondo ha saputo
disfarsene!”. L'osservazione non è scorretta, ma
lacunosa, e sarebbe stato bello se l'autore avesse ricordato
chi erano quelli che durante la Rivoluzione spagnola svuotavano
le carceri non per rinnovarne l'utenza ma per lasciarle
definitivamente prive di ospiti.
A tali evidenti mancanze, che non sono di Panizzari ma dell'intero
contesto marxista, corrispondono rigide formule derivate dal
bisogno di corrispondere a un ingessato modello ottocentesco,
racchiuso in sentenze del tipo: “Il percorso storico della
produzione, dello sviluppo delle forze produttive, è
racchiuso nel rapporto tra i mezzi di produzione-materie prime
e lavoro umano = mp/l” - visione ristretta e determinista
che, a modestissimo avviso del recensore, non tengono conto
della natura proteiforme del dominio e della sua complicata
relazione con il celeberrimo “sviluppo delle forze produttive”.
Il merito del libro si trova invece altrove, nelle brillanti
descrizioni delle dinamiche delinquenziali-carcerarie, nelle
testimonianze dirette e nell'inesausto desiderio di libertà
che prorompe dalle pagine migliori, e nel suo rappresentare
un importante documento su una parte dei movimenti degli anni
'70 che andrebbero compresi e non demonizzati, ma men che mai
mitizzati.
Giuseppe Aiello
Sulla Resistenza/
Vent'anni dopo Peli precisa
“...Non voglio con questo dire che grandi tentativi di
sintesi delle vicende resistenziali, come quello di Roberto
Battaglia, o di Giorgio Bocca, o di Gianni Oliva, non siano
meritorie, o prive di grande utilità. Per loro natura,
sono però comprensibilmente portate all'elaborazione
di una narrazione unificante, o quanto meno a sfumare le grandi
diversità di atteggiamenti, di partecipazione, di significati
che la guerra partigiana assume nei vari contesti dove si realizza...”
(p. 73).
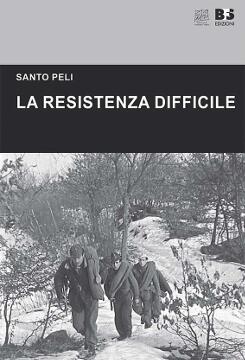 La
storiografia sulla Resistenza (come quella sull'anarchismo del
resto) ha sofferto – almeno fino agli anni Novanta del
secolo scorso, fatte ovviamente le dovute eccezioni –
di prevalenti impostazioni autoreferenziali e da epopea, di
narrazioni altisonanti talvolta più inficiate dagli stili
propagandistici che caratterizzate dall'uso dei ferri del mestiere
di storico. La
storiografia sulla Resistenza (come quella sull'anarchismo del
resto) ha sofferto – almeno fino agli anni Novanta del
secolo scorso, fatte ovviamente le dovute eccezioni –
di prevalenti impostazioni autoreferenziali e da epopea, di
narrazioni altisonanti talvolta più inficiate dagli stili
propagandistici che caratterizzate dall'uso dei ferri del mestiere
di storico.
Di questi ritardi e distorsioni, nel caso specifico riguardanti
le modalità della produzione scientifica sulle vicende
nazionali e sulla guerra civile del 1943-'45, portano la loro
parte di responsabilità quelle istituzioni ed enti che
si sono posti sullo scenario pubblico nazionale come, monopolistici
e poco inclusivi, imprenditori politici della memoria, come
vigili custodi delle ortodossie interpretative. E, a tal proposito,
il riferimento evidente è sia all'atavica e persistente
insipienza storiografica della rete degli Istituti storici della
resistenza, sia ai fautori della tradizionale retorica celebrativa
tipica dell'associazionismo combattentistico e reducistico.
Santo Peli è uno studioso di valore che, sulla scia della
lezione indimenticabile di un grande maestro come Claudio Pavone,
ha rotto da tempo quegli schemi e quegli approcci euristici
monumentali e ingessati, così obsoleti e inutili. Perché
solo con Pavone, e anche attraverso la sua innovativa categoria
guerra civile, la ricostruzione storica su quegli anni tragici
e tribolati è stata restituita a quell'universo emozionale
che è insieme plurale e soggettivo e che, fino a quel
momento, era stato appannaggio del racconto di testimoni d'eccezione
e dei classici della letteratura (Fenoglio, Viganò, Calvino,
Nuto Revelli...). Peli, già autore di testi fondamentali
sulla classe operaia durante le due guerre mondiali, oltre che
di studi specifici proprio sul movimento partigiano (si pensi
ad esempio al suo ultimo, avvincente, Storie di Gap uscito
nel 2014 con Einaudi), ripubblica oggi – a distanza di
vent'anni e con i dovuti aggiornamenti bibliografici –
questo prezioso saggio su La Resistenza difficile (Bfs
Edizioni – Pisa / Centro Studi Movimenti Parma, 2018,
pp. 140, € 16,00).
I temi tabù della violenza e della morte sono qui affrontati
attraverso casi-studio e con l'indagine introspettiva sui percorsi
esistenziali dei protagonisti, con la comparazione infine con
le fonti extra-saggistica, come ad esempio i romanzi storici,
le memorie e tutte quelle forme di scrittura che attengono l'arte
di inventare il possibile e di renderlo reale, di “rifondare”
insomma la stessa realtà. Su questo aspetto, non secondario,
Giovanni De Luna – l'autore de La Resistenza perfetta
– ha da tempo invitato i colleghi storici a superare il
vecchio complesso di inferiorità dello scrittore mancato.
Questo perché “spezzando i compartimenti stagni
ereditati dal positivismo, il lavoro sulle fonti non appartiene
solo alla fase erudita della sua ricerca, ma è parte
integrante della narrazione”. Ed è lo stile ampiamente
adottato da Peli: ossia una “relazione emotiva”
instaurata con le fonti, tale da rendere più intenso
il registro narrativo e da coinvolgere maggiormente il lettore,
tale da restituire una realtà plausibile dei fatti che
si vogliono far conoscere e delle correlate tesi interpretative.
La questione della violenza – dura necessità o
seduzione? – è ampiamente sviscerata dall'autore
e le sue opinioni paiono del tutto condivisibili (almeno da
parte del recensore).
“La mera deprecazione della violenza, facendo appello
a un ovvio e incontestabile senso comune, è in realtà
finalizzata all'annullamento della storia, alla banalizzazione
e svuotamento delle cause dei contendenti” (p. 37).
Il volume contiene una Prefazione alla seconda edizione,
una Introduzione (risalente al 1999) e sei saggi tematici così
articolati: 1) La morte profanata. Riflessioni sulla crudeltà
e sulla morte durante la Resistenza; 2) ”Rendere
il colpo”. Osservazioni su novità e difficoltà
della violenza partigiana; 3) Vecchie bande e “nuovo
esercito”; i contrasti tra partigiani nella “grande
estate” del '44; 4) Violenza e comunità
locali nella guerra partigiana; 5) Il caso Nicola Pankov;
6) Operai e Resistenza.
La ricerca si fa apprezzare anche perché, oltre a “valorizzare
i momenti alti” di un grande dramma collettivo, caratterizzato
da un inusitato protagonismo popolare, mette a nudo il “lungo
e travagliato lavorio di distillazione” del percorso resistenziale,
ma, allo stesso tempo però non ne cela ambiguità
e coni d'ombra.
Giorgio Sacchetti
 Alfonso
Failla (Siracusa 1906-Carrara 1986) è
stato una delle figure più prestigiose del movimento
anarchico di lingua italiana di questo secolo. Avvicinatosi
giovanissimo all'anarchismo si impegna nella lotta contro
il montante regime fascista. Più volte arrestato
e sottoposto a provvedimenti restrittivi, nel 1930 viene
spedito al confino ove rimane – salvo una breve
parentesi di libertà vigilata a Siracusa nel '39
– fino all'estate del '43. Alfonso
Failla (Siracusa 1906-Carrara 1986) è
stato una delle figure più prestigiose del movimento
anarchico di lingua italiana di questo secolo. Avvicinatosi
giovanissimo all'anarchismo si impegna nella lotta contro
il montante regime fascista. Più volte arrestato
e sottoposto a provvedimenti restrittivi, nel 1930 viene
spedito al confino ove rimane – salvo una breve
parentesi di libertà vigilata a Siracusa nel '39
– fino all'estate del '43.
Dopo l'evasione in massa dal campo di Renicci d'Anghiari
partecipa alla Resistenza principalmente in Toscana, Liguria
e Lombardia. Nel dopoguerra è tra gli organizzatori
della Federazione Anarchica Italiana redattore e direttore
responsabile del settimanale Umanità Nova attivo
nell'Unione Sindacale Italiana. Tiene centinaia di conferenze,
dibattiti e comizi, l'ultimo dei quali a Pisa dopo l'assassinio
di Franco Serantini.
Dal giugno del '72, per ragioni di salute è costretto
ad interrompere l'attività pubblica.
Questo volume (pagg. 366 + XXIV, euro 12,90) è
suddiviso in tre sezioni. Nella prima sono raccolte carte
di polizia e documenti relativi al periodo '22/'43 tratti
dal dossier Failla al Casellario Politico Centrale. Nella
seconda sono raccolti gran parte degli articoli da lui
scritti nel secondo dopoguerra. Nella terza sezione sono
raccolte testimonianze della sua attività.
Per informazioni e richieste: info@sicilialibertaria.it
|
|

