
Lettera all'autore/
Ma per la vittima la violenza è violenza (poliziesca o no che sia)
Ha passato gran parte della sua vita a girare in bici. Spesso tra Italia e Francia. E non solo per questo è una figura particolare di anarchico. Magari l'avete sorpassato in val Susa o sul Massiccio Centrale in Francia. Conosciamo Giordano Bruno Giglioli da decenni, ogni tanto abbiamo pubblicato qualcosa di suo. Scrive solo a macchina o a mano. Computer e mail non gli appartengono.

Nel febbraio 2016, un gruppo libertario di Avignone (Francia), nell'ambito di attività solidali con i detenuti, presentò al pubblico Georges Courtois, da poco uscito di prigione, dove aveva scontato 30 anni; una decina dei quali per il “processo alla magistratura” benché senza colpo ferire.
Il suddetto “Giudice dei Giudici” presentando il libro che narra la propria storia e quella del tribunale messo sotto “processo” fece il riassunto a viva voce, strappando gli applausi dei presenti prima ancora di aver letto il suo libro: Aux marches du palais. Mémoires d'un preneur d'otages (traduzione: Sulle scale del palazzo. Ricordi di un sequestratore d'ostaggi, Le Nouvel Attila, Parigi 2015, pp. 320, € 20,00)
Leggendolo mi son reso conto che non tutto meritava, a mio parere, gli applausi ai quali io stesso mi ero associato. Ho tenuto perciò a farlo presente all'autore e protagonista di questa storia esprimendogli apprezzamenti e “deprezzamenti” tramite una lettera inviatagli recentemente. Eccola, la mia lettera indirizzata all'autore del libro.
Dopo 30 anni di galera
 Signor
Georges Courtois, buongiorno. Signor
Georges Courtois, buongiorno.
Le scrivo a proposito del suo libro che presi il giorno della
presentazione nel febbraio dell'anno scorso ad Avignone.
Man mano che avanzavo nelle lettura segnavo i passaggi che ritenevano
particolarmente la mia attenzione: dei punti esclamativi quando
condividevo ciò che dicevate, e dei punti interrogativi
quando provavo incomprensione o rigetto.
I punti esclamativi hanno prevalso ampiamente sugli altri, là
dove è questione delle sue “requisitorie”
al momento del confronto con i detentori del potere legislativo,
o sotto forma indiretta attraverso le lettere da lei inviate
ai magistrati, ecc. È ciò che è apparso
anche nel corso della presentazione del libro, suscitando gli
applausi del pubblico di cui facevo parte e che stavano a dimostrare
la nostra simpatia e solidarietà, condividendo le critiche
e condanne senza appello di una maniera di applicare la giustizia
evidentemente ingiusta, e anche iniqua in vari momenti della
sua storia, che riflette dei procedimenti diffusi che colpiscono
ben altri condannati un po' ovunque, spingendo al crimine anche
coloro che sarebbero ben intenzionati di cambiare rotta rispetto
a quella che, in un modo o nell'altro, li ha condotti in prigione.
La denuncia delle leggi e di una pratica penitenziaria che,
anziché educare e contribuire ad un reinserimento edificante
del condannato, lo affonda ancor più nel giro vizioso
di una criminalità resa quasi ineluttabile attraverso
quei procedimenti avvilenti che fanno venir meno ogni speranza
di rinnovamento nell'esistenza per coloro che entrano in quest'ingranaggio
senza uscita che è agli antipodi di ciò che pretende
essere la giustizia.
Tutto ciò è quanto ho potuto rilevare dalla narrazione
riassuntiva che ha fatto del suo libro, e in varie pagine di
questo al momento della lettura. E il tutto espresso in modo
efficace e diretto dove appare evidente, tra l'altro, una padronanza
linguistica degna d'uno scrittore di professione. Tuttavia,
leggendo il suo libro, come l'ho accennato prima, dei punti
interrogativi sono apparsi, a dispetto dei tanti punti esclamativi
che marcano il pieno accordo con varie cose da lei sostenute.
La sua attitudine disinvolta colpendo sulle sue vittime, o mettendole
il coltello alla gola per derubarli (agli esordi della sua attività)
senza nemmeno scegliere la preda tra individui che, essendo
dei farabutti, avrebbero potuto “meritare” tal modo
di procedere; degli anonimi, presi a caso, senza saper niente
di loro... (Avrei potuto essere io, benché generalmente
al verde o quasi, vivendo o avendo vissuto finora con quel poco
guadagnato con i miei lavori di manovalanza; e inoltre non avrei
potuto soddisfare le vostre esigenze, le sue e dei complici,
in vista di sequestri d'auto, dato che non ne ho mai avute,
spostandomi soprattutto a piedi o in bicicletta). E la descrizione
che ne fa con cinico vanto, con quella divertita arroganza quando
colpivate sulla testa d'un autista recalcitrante che cercava
di reagire al vostro sequestro attuato con brutalità,
non fa che rinforzare la mia delusione rispetto alla simpatia
suscitata al momento della presentazione dei libro.
Altrettanto riguardo a quella donna morta in seguito all'incidente
che avete provocato; non una parola di rincrescimento. La vittima
dell'incidente essendo evidentemente per lei e soci “quantità
trascurabile”, che non vi riguardava affatto.
E il vostro o il suo caro amico, Karim, “morto
con lo stesso coraggio che aveva mostrato durante tutta la sua
vita”, come lei dice, era forse falsa la lista delle violenze
da lui perpetrate “con coraggio”, attaccando a coltellate
o con l'acqua bollente anche degli individui che non gli avevano
fatto niente o non tanto da giustificare delle azioni così
sproporzionate? (Ed ho qui abbreviato la lista in questione).
Lei ha risposto con ironia alla fin troppo lunga lista di violenze
evocate dal giudice, senza contestarne la veridicità,
limitandosi a definire charmant l'autore di queste prodezze;
charmant e coraggioso.
Se è questo a far prova di coraggio, questo vuol dire
che in nome dell'amicizia si può accettare e giustificare
tutto, qualsiasi crimine o criminale troverà allora
sempre la comprensione e giustificazione da parte dell'amico
di colui o coloro che li compiono.
Che differenza tra voi e la polizia?
Di fronte a tutto ciò - e ben altro ancora - senza entrare nei tanti dettagli esposti nel libro, delle questioni sono venute a galla man mano che ne prendevo conoscenza nel corso della lettura...
Riguardo alle vostre vittime occasionali, quale differenza c'è tra la vostra violenza e quella della polizia? La polizia, e tutto l'apparato che vi è connesso, si caratterizza con una violenza repressiva istituzionalizzata, mentre la vostra fa parte della “libera impresa”, “artigianale”, al vostro livello, e anche “selvaggia” in vari casi. Ma per le vittime cosa cambia? In un caso come nell'altro, ricevono, subiscono dei colpi, vittime della legge del più forte... Legge che lei e i suoi complici e simili imponete o avete imposto, alla stregua di quella istituzionalizzata, contro la quale vi siete rivoltati.
Strana e discutibile rivolta tuttavia, visto i colpi che avete assennato, a destra e a manca, attaccandovi a degli sconosciuti imponendogli, con la forza o la minaccia, la vostra volontà.
La volontà del più forte, appunto, e ci possiamo allora chiedere dove si situa l'aspetto “libertario” della vostra rivolta contro un sistema iniquo, quando, senza esitare, esercitate la vostra violenza su degli individui inermi, a voi sconosciuti, degli anonimi che, puo darsi, si trovano a prenderne da ambe le parti: da parte delle “forze dell'ordine”, dunque dell'ordine stabilito, statale, ecc. da un lato, e da parte di individui come voi che si presentano come vittime del sistema, insorti contro di esso, ma che non esitano a far vittime a loro volta, “grazie” alla vostra forza, alla vostra superiorità in certi momenti, di cui vi servite per attaccare chi è più debole di voi, imitando ciò di cui siete stati vittime, denunciandolo - anche con valide ragioni - come io “denuncio” entrambi, (l'istituzione e la sua violenza legalizzata, e voi che praticate la violenza “illegale”) quando infierite su gente inerme; gli uni obbedendo agli ordini - ed eccedendo anche in selvagge iniziative personali - e voi obbedendo al bisogno di realizzare, senza scrupoli, i vostri obbiettivi.
Mi si potrà ribattere che le due violenze non sono paragonabili, ma per coloro che la subiscono, la violenza, da ovunque essa venga, è pur sempre un attacco alla libertà, un'ingiustizia che gli è imposta col trionfo, momentaneo o permanente, della legge del più forte.
Quella legge non scritta, ma che prevale in tutte le società conosciute, compresa la nostra, sia per via istituzionale, sia attraverso quei “cani sciolti” che praticano la violenza in modo “artigianale”.
Mi sono esteso in tutto ciò che riguarda le sue denunce del sistema penitenziario e delle nostre società che procedono col classico “due pesi e due misure”, che ha così ben messo in evidenza nel suo libro, e che altri, soprattutto nel campo del movimento libertario non hanno mai cessato di denunciare.
Mi sono soffermato particolarmente sugli aspetti che, a mio parere, anziché servire, nuocciono all'iniziativa delle critiche e denunce di un sistema ipocrita che legifera sempre a senso unico, difendendo i privilegi iniqui dei detentori del potere. Degli aspetti che, a mia conoscenza, non sono mai presi in considerazione da coloro che, difendendo le vittime del sistema, omettono di parlare del come e quanto, tra le vittime, ci sono dei modi di agire assai simili - al loro livello - a quelli che esercitano la violenza al servizio dello Stato, e per questo impuniti, contrariamente agli altri.
Ma questa differenza di trattamento non giustifica quest'ultimi quando si trovano ad imitare i primi attaccando gente inerme di cui ignorano tutto, incoraggiandoli con tali atti ad aderire alle forze dell'Ordine, quale esso sia, comprese quelle che aspirano all'instaurazione di una nuova dittatura.
E alla fine mi presento...
Per terminare questa lettera, non mi sembra fuori luogo, anzi mi pare corretto, presentarmi, come lei stesso ha fatto raccontando la sua vita. Non sarà una cosa lunga, mi limiterò al minimo, altrimenti ci vorrebbe anche in questo caso un libro, benché sprovvisto delle prodezze come quelle spettacolari della presa di ostaggi nel tribunale di Nantes che lei ha così ben narrato nel libro...
Mi limiterò dunque a dirle che siamo nati nello stesso anno (1947), che la povertà era presente in casa mia come nella sua, ma che... a 14 anni ho accettato di andare in fabbrica, senza provare il bisogno di sfuggirli attraverso delle... audaci peripezie come le sue, coronate dalla spettacolare presa di ostaggi di “alto livello”.
Non ho quindi avuto l'occasione di conoscere la prigione, il mio rifiuto del sistema non ha raggiunto quel grado di rottura che avrebbe potuto valermi un così glorioso approdo. Molto più modestamente, o... mediocremente, ho limitato il mio tempo di lavoro al minimo, in rapporto ai miei bisogni, ed essendo questi ben limitati, elementari, se non addirittura alimentari e poco più, (a parte quelle cose piacevoli e benefiche non necessitanti denaro) il lavoro si è trovato ad essere altrettanto limitato, dunque non qualcosa di terribile da fuggire come la peste, come nel suo caso.
Un momento di “distrazione” se vogliamo, non “affliggente”, ma un'occasione per incontrare varia gente, senza frustrazioni nell'esser nullatenente... E, me voila, alla fine del percorso, con una “pensione” di 150 euro in Francia (in base ai contributi) e raggiungendo in Italia quel minimo vitale per chi non ha reddito o è troppo debole, la favolosa somma di circa 400 euro...
Faccio dunque parte di quegli individui che “non sono riusciti; non sono... arrivati”, raggiungendo quella massa di gente che hanno vissuto, più o meno, del loro lavoro; quella massa disprezzabile, probabilmente, agli occhi degli audaci come lei che ne son venuti fuori prendendo il cammino che è stato il vostro.
Tuttavia, per quanto mi riguarda, se fosse da rifare, a parte qualche variante en passant, rifarei la stessa cosa.
Augurandole un buon anno nuovo, migliore di quello appena concluso, la saluto, lei e famiglia,
Giordano Bruno Giglioli
Federalismo proudhoniano/
Un lungo e tortuoso percorso
 Ampio,
documentato, impegnativo e ricco di stimoli questo saggio di
Claudio De Boni (Liberi e uguali. Il pensiero anarchico in
Francia dal 1840 al 1914, Mimesis, Milano-Udine, 2016, pp.
464, € 30,00) dedicato alla nascita e allo sviluppo del
corpus teorico libertario nel cuore dell'Europa. Dopo l'opera
monumentale e ineguagliabile di Jean Maitron (1910-1987), non
sono mancate negli ultimi anni opere di sintesi oppure di analisi,
antologie e pubblicazioni di livello accademico o divulgative
dedicate da storici del pensiero politico all'anarchismo in
Francia. A dire il vero però il fenomeno editoriale ha
riguardato più che altro il paese d'oltralpe, dove ormai
da tempo il lungo filo narrativo che si dipana dalla Rivoluzione
del 1789 fino all'età contemporanea inquadra e include
tutte, ma proprio tutte, “les quatre gauches” (ossia:
la liberale, la giacobina, la collettivista e – appunto
– la libertaria). Ampio,
documentato, impegnativo e ricco di stimoli questo saggio di
Claudio De Boni (Liberi e uguali. Il pensiero anarchico in
Francia dal 1840 al 1914, Mimesis, Milano-Udine, 2016, pp.
464, € 30,00) dedicato alla nascita e allo sviluppo del
corpus teorico libertario nel cuore dell'Europa. Dopo l'opera
monumentale e ineguagliabile di Jean Maitron (1910-1987), non
sono mancate negli ultimi anni opere di sintesi oppure di analisi,
antologie e pubblicazioni di livello accademico o divulgative
dedicate da storici del pensiero politico all'anarchismo in
Francia. A dire il vero però il fenomeno editoriale ha
riguardato più che altro il paese d'oltralpe, dove ormai
da tempo il lungo filo narrativo che si dipana dalla Rivoluzione
del 1789 fino all'età contemporanea inquadra e include
tutte, ma proprio tutte, “les quatre gauches” (ossia:
la liberale, la giacobina, la collettivista e – appunto
– la libertaria).
A tale proposito, per chi legga il francese, ci permettiamo
di segnalare altri due titoli di lettura facile e avvincente,
magari utili anche ai lettori non specialisti per compendiare
il volume di De Boni sia con un inquadramento generale, “manualistico”,
sulla storia del pensiero politico in Francia, sia con un florilegio
di significativi testi anarchici scelti e commentati. Si tratta
nel primo caso di: Les Gauches françaises 1762-2012.
Histoire et politique di Jacques Julliard (Champs histoire,
2012); e nel secondo di: Révoltez-vous! Répertoire
non-exhaustif des idées, des pratiques et des revendications
anarchistes, autore “Un indigné” (Atelier
de création libertaire, 2014).
L'autore di Liberi e uguali, studioso del pensiero utopico,
allievo di Antonio Zanfarino e docente presso la prestigiosa
Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri” di
Firenze, affronta, per la prima volta in maniera organica e
strutturata, un argomento fino ad ora da lui trattato solo episodicamente.
È, per sua stessa ammissione, un tributo ed un riconoscimento
all'importanza che l'anarchismo riveste nell'ambito della storia
delle idee politiche nel mondo contemporaneo, e che lui stesso
ha da tempo potuto verificare sul campo della ricerca. Il punto
di partenza, molto interessante e che potrebbe sembrare per
certi versi paradossale, è proprio il ridimensionamento
dell'approccio “utopico” al tema: “...Si verificherà
– avverte De Boni – come un atteggiamento superficiale
come quello di identificare anarchia e utopia sia non di rado
rifiutato, e con qualche fondamento, dagli stessi anarchici”.
Il volume ricostruisce, si deve dire con grande efficacia narrativa,
tutto il lungo e tortuoso percorso che dal federalismo proudhoniano
conduce verso la terribile cesura del 1914. E ne coglie i vari
passaggi cruciali: dal 1848 alla Comune di Parigi, dall'affaire
Dreyfus alla transizione di secolo e ai prodromi della guerra
europea. Le correnti e le tendenze peculiari, diversificate
dell'anarchismo francese sono esaustivamente presentate e raccontate,
inserite in una sorta di mappa che le colloca e le contestualizza.
In una galleria davvero affollata, si susseguono i personaggi
che hanno in vario modo o influenzato o plasmato i fondamentali
del pensiero libertario in Francia e non solo.
Si parte da Proudhon, il primo filosofo ad usare il lemma “Anarchia”
in termini positivi, per poi proseguire con Bellagarrigue, Déjacque,
Coeurderoy, Louise Michel, André Léo, Malato,
Reclus, Grave, Ravachol, Henry, Zo d'Axa, Albert Libertad, Han
Ryner, Palante, Tailhade, Pelloutier, Pouget...
Il metodo sincronico utilizzato dall'autore, ossia l'attenzione
estrema rivolta alle contaminazioni politiche e culturali coeve,
ci permette inoltre di inquadrare due grosse tematiche tipicamente
“francesi” che sovrastano, per la loro importanza
e incisività, tutta la costruzione moderna dell'immaginario
anarchico. Si tratta da una parte del cosiddetto “ravacholismo”
(ossia la corrente individualista fautrice dell'illegalismo,
del banditismo sociale e dell'azione diretta violenta) e dall'altra
del sindacalismo rivoluzionario.
Sul primo si deve dire, onore al merito, che in genere la storiografia
sull'anarchismo d'oltralpe, e questo libro di De Boni non fa
eccezione, è molto più avanzata e meno condizionata
rispetto a quella omologa riferita al movimento italiano. Sul
secondo l'autore descrive e analizza “l'incontro tra sindacati
e anarchia”, inserendolo nell'intricato scenario primonovecentesco
dominato dalla sinistra soreliana.
La conflagrazione europea segna la fine di un mondo e, di conseguenza,
segna anche la fine di una feconda stagione di ideali internazionalisti
e solidali. L'idea di Nazione si giustappone oppure si sostituisce
a quella di Classe. Gli anarchici, al pari delle altre componenti
del movimento operaio e socialista, sono costretti a misurarsi
con il nuovo secolo delle masse, dove la violenza dispiegata
è la cifra ineluttabile di elementi costitutivi autoritari
e di dominio diffuso, quali Stato e lavoro industriale. Significativo
in tal senso l'Epilogo del libro, intitolato: Dalla guerra
sociale alla guerra mondiale.
“Ogni corrente culturale, dopo, sarà diversa, perché
dovrà fare i conti con la sfida dei nuovi totalitarismi
e con la minaccia costante e universale della distruzione armata:
il che comporterà nuove riflessioni, nuovi atteggiamenti,
e anche tante diaspore”.
Giorgio Sacchetti
Fascismo/
Speciali sentenze del Tribunale speciale
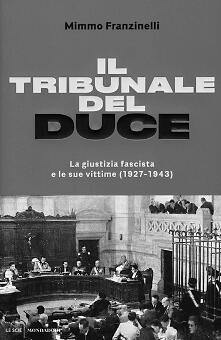 Le
ricerche d'archivio dello storico Mimmo Franzinelli (Il tribunale
del duce. La giustizia fascista e le sue vittime 1927-1943,
Mondadori, Milano, 2017, pp. 303, € 22,00) mettono in luce
pagine poco note del ventennio fascista. L'autore integra fonti
della memorialistica delle vittime antifasciste con le fonti
nuove di sentenze, istruttorie, interrogatori. Restituisce attraverso
documenti la realtà sconosciuta e indefinita del Tribunale
speciale per la difesa dello stato, il tribunale degli squadristi.
Neppure la vasta biografia mussoliniana di Renzo de Felice dedica
più di due pagine. Del resto, l'archivio del tribunale
da poco è aperto alla consultazione degli studiosi, e
molti documenti sono rimasti fuori consultazione per il riordino. Le
ricerche d'archivio dello storico Mimmo Franzinelli (Il tribunale
del duce. La giustizia fascista e le sue vittime 1927-1943,
Mondadori, Milano, 2017, pp. 303, € 22,00) mettono in luce
pagine poco note del ventennio fascista. L'autore integra fonti
della memorialistica delle vittime antifasciste con le fonti
nuove di sentenze, istruttorie, interrogatori. Restituisce attraverso
documenti la realtà sconosciuta e indefinita del Tribunale
speciale per la difesa dello stato, il tribunale degli squadristi.
Neppure la vasta biografia mussoliniana di Renzo de Felice dedica
più di due pagine. Del resto, l'archivio del tribunale
da poco è aperto alla consultazione degli studiosi, e
molti documenti sono rimasti fuori consultazione per il riordino.
Oltre alla macchina giudiziaria, l'attenzione è rivolta
alle vittime che affollano l'aula IV al piano terra del Palazzo
di giustizia di Roma. La ricerca si inoltra altresì nel
dopoguerra, per accertare la controversa eredità del
Tribunale del duce.
Il 1926 è l'anno degli attentati. Dopo quello inscenato
per mano del quindicenne Anteo Zamboni, freddato dagli squadristi,
e quello enigmatico dell'irlandese Violet Gibson, il regime
istituisce il Tribunale speciale, ripristina la pena di morte
- abolita con il codice Zanardelli del 1889 - e la figura giuridica
dell'attentato. Si combatte così il nemico interno e
si sopperisce alla sfiducia nella magistratura ordinaria. Un
commento politicamente scorretto costa l'arresto per vilipendio
delle istituzioni e del duce. Il regime fascista usa la polizia
per controllare l'opinione pubblica e apprenderne gli orientamenti.
D'altro canto, dai rapporti segreti emerge una magistratura
faziosa, anche corrotta e legata a privilegi di casta, sollecita
nel colpire spietatamente il dissenso.
Saranno 56 le condanne a morte eseguite. Prosciolti 7581 imputati,
ma sconteranno un anno di carcere preventivo prima di essere
assolti. L'effettivo diritto alla difesa è impedito dalla
segretezza dell'istruttoria. Quando gli imputati compaiono in
aula tutto è già deciso. Il giudice istruttore
Scerni ammetterà: “l'istruttoria si svolge essenzialmente
in base alle informazioni raccolte dalla polizia politica”.
Inoltre - ribadisce Mimmo Franzinelli - la storiografia ha ignorato,
oscurandolo, un aspetto del Tribunale speciale e delle sue funzioni:
la capacità di contrastare, manipolare, piegare molte
sue vittime dopo mesi di isolamento, insidie, lusinghe, violenze.
Nel 1928-33 le condanne sono circoscritte agli attentatori del
duce e agli irredentisti sloveni e croati. L'offensiva antislava
del Tribunale speciale è la manifestazione giudiziaria
del fascismo di frontiera. Scatenato dalle gravi aggressioni
squadristiche del luglio 1920, si traduce in vessazioni quotidiane
e nell'internamento di popolazioni ostili. E con la nascita
del regime, nell'italianizzazione forzata di nomi e toponimi.
Il rigore verso i dissidenti si alterna all'uso combinato di
amnistie e grazie. I graziati vivono in semilibertà.
Reclusione e confino gettano nello sconforto migliaia di famiglie,
peggiorando le condizioni economiche. Non sono isolati i casi
di prigionieri che antepongono l'ideale alla vita. Spesso gli
imputati rifiutano di essere graziati, come nel caso di Sandro
Pertini che rigetta la richiesta di grazia presentata dalla
madre.
Pregiudizi maschilisti (a volte favorevoli alle donne)
Nel capitolo “Donne alla sbarra”, Franzinelli definisce “giustizia maschilista” quella del Tribunale speciale. Oltre 430 le donne, di età poco superiore ai vent'anni, sottoposte a giudizio. I giudici ravvisano nella funzione ancillare la peculiarità del contributo femminile al sovversivismo: ruolo di supporto logistico, staffette nella consegna di messaggi e distribuzione di materiale propagandistico. Tuttavia, studi sul movimento femminile socialista dimostrerebbero un contributo delle donne all'opposizione al fascismo più elevato di quanto non risulti dalla raccolta dati delle sentenze. Ma essere mogli, figlie, sorelle, fidanzate di antifascisti comporta l'arresto anche senza riscontri oggettivi di reato.
Come successo alla casalinga ferrarese Maria Manfredini arrestata nel 1928 perché compagna di un sovversivo. Oppure a Ida Scarselli, schedata e sorvegliata nel 1927 dal comando dei carabinieri di Firenze, considerata “anarchica e delinquente, con fama pessima anche sulla moralità”. Non si registrano precedenti penali a suo carico. Colpevole di essere la sorella di Ferruccio, anarchico, ucciso perché appartenente alla Banda dello Zoppo dedita a “rapine politiche”. Pregiudizi maschilisti talvolta giovano alle imputate considerate “traviate”, quindi meritevoli di attenuazioni. Laura Cavallucci, pesarese, tipografa a Torino, condannata a un anno per aver stampato manifesti con incitamenti all'insurrezione e alla guerra civile, viene qualificata dai giudici “di equivoca condotta” perché avrebbe “avuto parecchi amanti”.
Condanne esemplari, invece, alle “rivoluzionarie professionali” come nel caso di Adele Bei, funzionaria comunista, intransigente, “per la quale nessun pietismo dev'essere invocato”. Nel '33 sarà condannata a 18 anni, rispetto ai 13 e ai 12 anni inflitti ai due coimputati. Nel '41 verrà trasferita dal carcere di Perugia al confino di Ventotene. In seguito, parteciperà alla resistenza nel Lazio.
Nel '42, il dissenso contagia gli studenti universitari e delle scuole superiori. Nel gabbione dell'aula IV si inscenerà il processo perfetto per sette studenti: pur appartenendo a gruppi universitari fascisti, distribuiscono a Milano materiale sovversivo che definisce Mussolini “impostore”. Invitati a chiedere perdono al duce e ad arruolarsi come combattenti per “cooperare alla vittoria comune e cancellare il passato”, otterranno condanne non superiori ai tre anni.
Non mancano esempi di resistenza individuale. Carmelo Salanitro di Catania, professore di latino e greco, riporta nel suo diario “solidarietà tacita a tutte le vittime della tirannia fascista”. Clandestinamente, dattiloscrive e distribuisce volantini a Catania. Tradito dal preside, verrà condannato a 18 anni e interdizione perpetua dai pubblici uffici: vilipendere il fascismo significa vilipendere la nazione.
Nel '43, dopo la caduta del regime, il tribunale è sciolto, con trasferimento delle competenze ai tribunali militari. Ma i nuovi equilibri politici e la dottrina della continuità dello stato rallentano o vanificano l'attuazione dei provvedimenti. Nel Secondo dopoguerra, si ribadiscono alcuni casi di condanna: per i pacifisti, la sentenza non riguardava l'opposizione politica, ma la posizione antinazionalista e contro la guerra.
Peggio i repubblicani dei repubblichini, a volte
Nell'estate del '46, l'amnistia Togliatti estingue ogni crimine dei giudici in camicia nera. Sarà la Cassazione ad indicare agli operatori della giustizia la strada dei proscioglimenti. La magistratura repubblicana inizia a incriminare esponenti del movimento partigiano: non godranno dell'amnistia in quanto appartenenti a formazioni militari irregolari. Addirittura, in alcuni casi, la magistratura repubblicana si dimostrerà più persecutoria di quella repubblichina, respingendo le istanze di familiari di antifascisti intenzionati a far cancellare post mortem la condanna dei loro cari. Altre volte si ritroveranno in carcere cittadini che non hanno espiato per intero le pene inflitte dai giudici del regime.
Solo verso la fine degli anni Sessanta, il magistrato Floro Rosselli accoglierà i ricorsi degli ex condannati, in applicazione del decreto del 27 luglio 1944 sull'abrogazione di “tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo”. L' attuazione della norma dopo un quarto di secolo pone fine a quel Tribunale speciale per la difesa dello stato, che fornì le basi al Tribunale per la difesa della razza.
Nei libri di storia, capitoli non menzionati che andrebbero conosciuti. Un saggio ben documentato e coinvolgente. Un approccio appassionato che suscita interesse ad approfondire la conoscenza delle fonti storiche attendibili, per una maggior consapevolezza e una presa di posizione critica contro le manipolazioni delle informazioni sul ventennio, che da tali fonti spesso attingono.
Claudia Piccinelli
La filosofia “in vita”/
Un viaggio con Ágnes Heller
Entrare in una libreria (in particolare in quelle piccole e
minuziose) porta con sé una disposizione all'attesa,
un fenomeno raro se ci si guarda intorno. Attesa, sorpresa e
ritrovamento e si è in gioco. Fra le mai si stringe
un oggetto ancora da desiderare sino in fondo ma di cui non
possiamo più fare a meno. Un insieme di pagine, segni,
lettere, immaginari, personaggi, che apriranno ulteriori desideri,
sorprese e orizzonti.
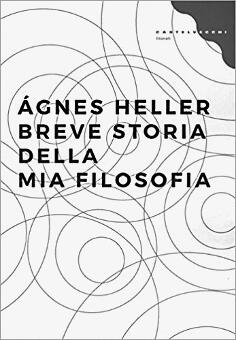 Bene,
trovare il nuovo libro di Ágnes Heller (Breve storia
della mia filosofia, Castelvecchi, Roma, 2016, pp. 187,
€ 17,50) fa parte di questo sentimento dell'inatteso, misto
ad una gioiosità d'infanzia. Tale gioiosità si
manifesta per diverse ragioni. Prima di tutto Heller è
ancora in vita, ha ottantotto anni, abita in Ungheria,
insegna negli Stati Uniti (e non solo) e dunque non è
ancora parte di quella tradizione postuma che sembra a volte
l'unica condizione per avere importanza. Inoltre si tratta di
una donna e non è sempre così facile farsi riconoscere
nel panorama storico e filosofico. Persiste, infatti, una certa
tendenza a ritenere la “storia della filosofia delle donne
e per le donne” come qualcosa a cui ci si dedica a margine. Bene,
trovare il nuovo libro di Ágnes Heller (Breve storia
della mia filosofia, Castelvecchi, Roma, 2016, pp. 187,
€ 17,50) fa parte di questo sentimento dell'inatteso, misto
ad una gioiosità d'infanzia. Tale gioiosità si
manifesta per diverse ragioni. Prima di tutto Heller è
ancora in vita, ha ottantotto anni, abita in Ungheria,
insegna negli Stati Uniti (e non solo) e dunque non è
ancora parte di quella tradizione postuma che sembra a volte
l'unica condizione per avere importanza. Inoltre si tratta di
una donna e non è sempre così facile farsi riconoscere
nel panorama storico e filosofico. Persiste, infatti, una certa
tendenza a ritenere la “storia della filosofia delle donne
e per le donne” come qualcosa a cui ci si dedica a margine.
Sorrido dunque di gioia e con leggero sentimento di “lotta”
perché la filosofa Ágnes Heller fa essere in
vita la possibilità di essere filosofa. Terzo aspetto,
non certo irrilevante, è dato dal fatto che Ágnes
Heller è un'ebrea, marxista, una delle massime esponenti
della Scuola di Budapest. Insieme di elementi che caratterizzano
una grande complessità esistenziale e politica. Oltre
a questi aspetti c'è un ulteriore elemento che prevale
su tutti nel far generare un sorriso esteriore e interiore;
si tratta del titolo: Breve storia della mia filosofia
edito da Castelvecchi, e penso: “decisivo... questo scritto...
sarà decisivo”. Leggo la quarta di copertina e
saltano fuori alcune parole: avventura intellettuale, vortice
di scandalosi enigmi, sfide storiche politiche” e mi ripeto:
“intimamente decisivo per il futuro della mia filosofia
e politicamente decisivo per il futuro della filosofia, un testo
che non può passare inosservato”, annuso le pagine
e vado alla cassa. Comincia così un viaggio nell'essenza
della storia della filosofia di Ágnes Heller.
Già in passato, leggendo Heller, ho raccolto alcuni aspetti
fondamentali oltre a riflessioni sul mondo, l'umanità,
la libertà e la politica; Heller, a mio avviso, ci ha
mostrato un come (stile, modo, movimento) della filosofia
particolarmente generativo. Una filosofia che si è
sempre posta domande infantili da continuare a frequentare.
Per me che dell'infanzia e della “frequentazione degli
altri/e”, ho costruito, non da sola, il senso di un insieme
di pratiche filosoficamente autonome è un invito
che si fa politico e vitale.
In questo libro si racconta e si riflette di come la filosofia,
in vita, fra storia e Storia, si formi in tutta un'esistenza,
proprio come fa la farfalla da un bruco o la rana da un girino.
Esistenza in cui non si è mai smesso nemmeno un secondo
di pensare filosoficamente, di scrivere di filosofia. La storia
di una filosofia dunque, come una delle storie della propria
vita. Una pratica di filosofia fatta da pensieri che necessitano
di essere pensati e da intuizioni improvvise che non possono
essere trascurate, ma vanno inseguite da sciami di domande.
Una pratica di pensiero che sceglie, nel caso di Heller, la
pratica della scrittura per mantenersi vitale e in rapporto
con il mondo, ma che restituisce un'attitudine umana più
generale, quella di poter pensare. Una storia, quella
della filosofa, ritmata dagli anni dell'apprendistato,
del dialogo, dell'intervento, infine della peregrinazione.
Gli anni dell'apprendistato o quelli del suo io filosofico
passato sono l'embrione. Anni in cui il suo personaggio
filosofico si inizia a intravedere e che vanno dal 1950 al tardo
1964, in cui acquisisce dimestichezza con la tradizione, pensandola
non come accumulo di sapere, ma combustibile per il pensiero.
Un esercizio costante di formulazione di domande, di ripensamenti.
Formulazione di domande, di ripensamenti
Sono gli anni in cui emerge una delle domande centrali della sua ricerca: «Cosa significa, almeno per me, formulare una teoria marxista della filosofia?» Caratterizzati da un'intenzione non risolutiva del pensiero, ma attiva, radicale, disposta permanentemente a mutare i propri interessi. Era il periodo in cui le accade la fortuna più grande che potesse accaderle, essere allieva di György Lukács: «se non ci fosse stato lui non sarei mai diventata una filosofa, ma avrei seguito il mio proposito iniziale di studiare chimica. Non posso nemmeno lontanamente immaginare questa possibilità, se solo ci penso, a posteriori, mi spaventa persino nominarla». Sono gli anni in cui dopo un periodo di insegnamento, la compagna Heller sarà licenziata, è il 1958 e da questo episodio le resta il continuo rimando fra politica, filosofia ed etica. Quella di Ágnes diviene un'occupazione costante, permanente, che a partire dalla ricerca filosofica genera una pratica politica (o forse anche viceversa) in cui la filosofia non è al servizio di nessuna causa se non quella della demolizioni delle verità assolute e delle maschere, riflessioni di cui abbiamo già traccia nella memorabile conferenza sulla libertà del 1956 a Berlino. Un impegno che lei stessa definisce da autodidatta, concetto decisivo per la sua filosofia e per la filosofia in generale a favore di un'idea di professionalità che si libera dal dominio del potere della sistematicità: «fare filosofia significa pensare, prima ancora di sapere a cosa i filosofi pensino in realtà. [...] Ad oggi disprezzo l'approccio cosiddetto “scientifico” alla filosofia, lo sprofondare in un puro e semplice professionalismo. [...] sono autodidatta, ecco perché il mio apprendistato è durato più di un decennio».
Risiede qui una libertà essenziale in questa disposizione di una filosofia in vita, che negli anni successivi da scrittura per sé tenderà ora al dialogo. Un dialogo che, a partire dalla Scuola di Budapest, una cerchia di amici battezzata così da Lukács, divengono alleati filosofi e politici. Un dibattito continuo, pratico, collettivo che la condurrà a scrivere ciò che lei stessa definisce il suo vero definitivo “io filosofico”: L'uomo del Rinascimento. Sono gli anni in cui si concentra su temi specifici, su un argomento, su di una domanda, arrivano così: Sociologia della vita quotidiana, La teoria dei bisogni in Marx, Confessioni alla filosofia (poi La filosofia radicale e Teoria dei sentimenti). Sono gli anni in cui radicalmente si chiede come la filosofia debba impegnarsi e quanto il filosofo o la filosofa siano disposti a vivere secondo le proprie idee, scontrandosi così con l'idea valida, per la maggior parte dei professori universitari, che l'unico compito sia solo quello di insegnare il meglio possibile. Sono gli anni in cui la Scuola di Budapest è denunciata come antimarxista nel cosiddetto processo ai filosofi. Matura in lei l'idea che alla base della filosofia ci debba essere impegno e nel suo percorso di ricerca tale prospettiva troverà forma proprio nella teoria dei sentimenti, e nell'elogio alla “persona buona”. Un impegno nella filosofia che diviene politico, una pratica politico-teoretica d'“intervento”. Intervento di opinioni, di critica, di polemica sostenuta da una “costruzione” una “tessitura” e mai da un sistema, in cui si sollevano domande rivolte al mondo e alla sua potenziale umanità: Come essere soddisfatti in una società insoddisfatta? Quali i bisogni?
Con sincerità e schiettezza
Siamo negli anni '80 la entusiasma il concetto di biopolitica
espresso da M. Foucault, ne intravede la forza di smontaggio
delle dinamiche di dominio fra soggetti, soprattutto quando
si affronta il tema della libertà, del corpo, e da questo
tema sviluppa l'idea di una costante, necessaria rivoluzione
nella vita quotidiana.
Heller ce la mette tutta a fare i conti con l'autorità
al di fuori, ma anche con la propria autorità di filosofa,
di donna, di persona, inaugurando, forse, una filosofia che
fa i conti con propri meccanismi di potere: Chi sono io?
Chi mi ha autorizzata a dire a uomini e donne cos'è giusto
o sbagliato? Nessuno mi ha autorizzata, non ho alcuna autorità.
Qui si gioca una questione importante per la filosofia e per
il potere del sapere e proprio qui mi fermo nell'invito ad avventurarsi
in questa storia scritta con sincerità e schiettezza,
con coraggio e senza vergogna. Uno scritto che ci fa essere
amiche e amici di una ricerca ancora in vita.
Sul finire del libro nella peregrinazione di questi suoi
anni emerge come la sua idea di filosofia sia un'avventura
sempre in divenire in grado di farsi trasportare dal viaggio,
dai luoghi e dalle persone “della vita”, perché
come dice lei stessa: «Una vita umana ha un ritmo, un
certo tipo di dinamismo che, a volte, deve cambiare. Bisogna
cambiare luogo, argomenti, amori, interessi. Gli esseri umani
seguono sempre i loro istinti. O, per lo meno, io sì.
Almeno così ho sempre fatto. Posso anche spiegare perché
ho fatto ciò che ho fatto. Ma la risposta non è
altro che un nuovo punto interrogativo».
Silvia Bevilacqua
Psichiatria e guerra/
Dalla faradizzazione alla Tec
Il Collettivo Antipsichiatrico Antonin Artaud di Pisa, dopo
una preziosa pubblicazione edita da “Sensibili alle foglie”
sulla storia dell'elettroshock – ora riammesso a pieno
titolo nei protocolli medici sotto le mentite spoglie di TEC
(terapia elettroconvulsivante) –, con questo opuscolo
autoprodotto aggiunge un altro tassello sulle implicazioni di
questo metodo di tortura. Il contesto analizzato è quello
bellico, con uno sguardo particolareggiato alla I guerra mondiale.
 La
ricerca è firmata da Marco Rossi che ribadisce “la
complice amicizia con il Collettivo pisano e il gruppo Kronstadt
di Volterra”: quest'ultima città ospitò
infatti, qualche mese fa, un dibattito pubblico su questo tema.
L'opuscolo, sintetico quanto estremamente documentato, ha per
titolo Correnti di guerra – Psichiatria militare e
faradizzazione durante la Prima guerra mondiale (Pisa, 2017,
pp. 38, scaricabile dal sito artaudpisa.noblogs.org) La
ricerca è firmata da Marco Rossi che ribadisce “la
complice amicizia con il Collettivo pisano e il gruppo Kronstadt
di Volterra”: quest'ultima città ospitò
infatti, qualche mese fa, un dibattito pubblico su questo tema.
L'opuscolo, sintetico quanto estremamente documentato, ha per
titolo Correnti di guerra – Psichiatria militare e
faradizzazione durante la Prima guerra mondiale (Pisa, 2017,
pp. 38, scaricabile dal sito artaudpisa.noblogs.org)
Le tecniche utilizzate per la faradizzazione (impiego a scopo
terapeutico di una corrente elettrica di bassa frequenza,
n.d.r.) servirono ad affinare gli strumenti, ideati più
tardi, per la TEC: la dolorosa scarica elettrica veniva applicata
in varie parti del corpo, scroto compreso: “già
sperimentata a scopo medico nel Settecento, durante il Primo
Conflitto divenne quindi una pratica – anche se poco conosciuta
– asservita alla logica militare e anticipò quanto
sarebbe avvenuto, sistematicamente, durante la Seconda guerra
mondiale” specifica l'autore, oltre a spiegare efficacemente
le motivazioni che soggiaciono al connubio fra l'apparato psichiatrico
e quello militare. Nel 1915, 170 psichiatri di comprovata esperienza
manicomiale furono inseriti nell'organico militare, sotto la
guida di A. Tamburini, presidente della Società italiana
di freniatria ed ex direttore del S. Lazzaro di Reggio Emilia,
uno fra i più grandi ed efficienti manicomi europei.
É risaputo quanto questa guerra sia stata particolarmente
cruenta; le conseguenze in termini di povertà, morte,
invalidità, traumi fisiologici e psicologici fecero maturare
– nell'esercito e nella società – forme di
riluttanza all'asservimento delle politiche statali: evidentemente
gli apparati di potere le giudicarono eccessive, sorse così
l'esigenza strategica di un rimedio pertinente agli obiettivi
bellici. I reparti manicomiali dedicati ai disertori (molto
noto quello del S. Maria di Pietà di Roma) furono giudicati
insufficienti; l'istituzione militare preferì occuparsi
direttamente degli “scemi di guerra”, potendo così
garantire agli ufficiali un trattamento privilegiato. Si mise
in atto una vera e propria “profilassi morale per
bonificare le truppe dagli elementi inaffidabili, secondo una
morale più patriottica che deontologica”; ciò
significa che “l'obiettivo primario divenne quello di
recuperare i soggetti critici per il fronte, come carne
da cannone, nonché scoprire e deferire i frodatori alla
giustizia militare” ben sottolinea Marco Rossi a pag.
12 e 13.
La guerra non avrebbe mai dovuto essere percepita come causa
di sofferenza psicologica o di insofferenza sociale: ecco perché
l'ideologia dominante trovò negli assunti positivisti
il miglior alleato. Cesare Lombroso dedicò studi e attività
professionale alla determinazione di presunte tare ereditarie
e congenite – rese palesi ad esempio dalla morfologia
del cranio – di soggetti potenzialmente criminali
poiché dimostravano forme di asocialità. Questi
insegnamenti fornirono l'eccellente opportunità per poter
affermare che soltanto la degenerazione mentale e morbosa potesse
indurre al rifiuto del servizio patriottico. Si enumerarono
sintomatologie e diagnosi fantasiose fra le quali ricorrono
la debolezza nervosa, la predisposizione organica, l'immoralità
costituzionale, la gracilità intellettuale, l'ectopia
testicolare, la simulazione, la scarsa volontà o il rifiuto
al sacrificio, ma anche infermità mentali rese
manifeste dalla pederastia o dalle scelte libertarie
e antimilitariste tradotte nei termini di pazzia ragionante.
Allo scopo di ostacolare queste aberrazioni, si individuò
nella somministrazione di scosse elettriche il metodo principe
di persuasione e punizione: scoprire i bugiardi, ma soprattutto
ricollocare nelle trincee un'abbondante carne da macello indispensabile
alla guerra.
I militari italiani sottoposti a trattamenti psichiatrici furono
circa 40.000, “secondo le cifre ufficiali ma probabilmente
sottostimate”, afferma l'autore che poi aggiunge: “resta
invece da accertare il numero, non meno rilevante, delle donne
internate in manicomio a causa di disturbi psichici determinati,
più o meno direttamente, dal contesto bellico”.
Nonostante vi siano documenti che riconducano alle condizioni
di vita in trincea la causa di malesseri psichici, la propaganda
ideologica scelse di ribadire il concetto non dipendente
da cause di guerra: fecero eccezione soltanto i traumi cerebrali
provocati direttamente dalle esplosioni. Anche in questo caso
le diagnosi psichiatriche si avvalsero di un ribaltamento fra
causa ed effetto nel tentativo, ancor oggi non dimostrato, di
individuare la causa organica delle cosiddette malattie mentali.
Il determinismo scientifico di derivazione lombrosiana, dalla
guerra in Vietnam a oggi, certifica con la diagnosi di PTSD
(Post Traumatic Stress Disturb) molte delle sofferenze dovute
agli scenari bellici o alle calamità naturali, così
da poter curare testimoni e vittime sottoponendole a
TEC o a sedazione chimica.
In perfetta continuità con l'analisi storica di M. Rossi,
completata dal confronto delle tecniche di faradizzazione utilizzate
in altri Paesi europei e da dati territoriali specifici come
quelli individuati presso il frenocomio di San Girolamo di Volterra,
risulta evidente quanto la maggior parte delle diagnosi psichiatriche
– soprattutto quelle inserite nel DSM, il manuale delle
malattie mentali redatto negli USA – svelino la corruzione
del linguaggio scientifico, ogni volta che offre la propria
complicità alla pianificazione del controllo sociale.
Chiara Gazzola
Metalmeccanici anni '60 e oggi/
La parola collettiva, la lotta, la fabbrica
Nel 1964, il periodico della Fiom di Milano bandì un
concorso letterario per raccontare le lotte appena trascorse
– le grandi rivendicazioni sindacali che avrebbero smosso
l'Italia dal torpore degli anni '50. In giuria c'erano scrittori
del calibro di Luciano Bianciardi, Franco Fortini, Giovanni
Arpino e Umberto Eco.
 Nel
2013, Ivan Brentari – un ricercatore alle prese con la
biografia del segretario Fiom Giuseppe Sacchi – scopre
quei racconti inediti, e propone allo scrittore Wu Ming 2 di
ripubblicarli; magari con altri testi di autori contemporanei.
Wu Ming 2 accetta e rilancia: perché invece non mettere
in piedi un laboratorio di scrittura collettiva di lavoratori,
proprio tramite la Fiom? Passa qualche anno, il collettivo nasce
e cresce – con il nome di MetalMente – ed ecco infine
il risultato: Meccanoscritto, appena pubblicato da edizioni
Alegre (Collettivo MetalMente con Wu Ming 2 e Ivan Brentani,
Roma, 2017, pp. 350, € 16,00, con un racconto di Luciano
Bianciardi). Nel
2013, Ivan Brentari – un ricercatore alle prese con la
biografia del segretario Fiom Giuseppe Sacchi – scopre
quei racconti inediti, e propone allo scrittore Wu Ming 2 di
ripubblicarli; magari con altri testi di autori contemporanei.
Wu Ming 2 accetta e rilancia: perché invece non mettere
in piedi un laboratorio di scrittura collettiva di lavoratori,
proprio tramite la Fiom? Passa qualche anno, il collettivo nasce
e cresce – con il nome di MetalMente – ed ecco infine
il risultato: Meccanoscritto, appena pubblicato da edizioni
Alegre (Collettivo MetalMente con Wu Ming 2 e Ivan Brentani,
Roma, 2017, pp. 350, € 16,00, con un racconto di Luciano
Bianciardi).
Il volume alterna i racconti degli anni Sessanta a quelli del
2015, con una terza voce di utilissime infrastorie che
raccontano l'evoluzione e l'involuzione delle lotte nei periodi
narrati. Vediamo così scorrere in filigrana gli eventi
chiave delle due epoche: da un lato i grandi scioperi del 1960-1963,
la Milano dei metalmeccanici e delle prime sollevazioni popolari,
gli interventi brutali della celere; e dall'altro Genova 2001,
le proteste contro l'Expo, il lavoro precarizzato e digitale,
le fabbriche autogestite.
“Tieni presente che eravamo trattati peggio delle bestie”,
spiega Giuseppe Sacchi rievocando il suo lavoro da sindacalista
negli anni '50. E Ivan Brentari sottolinea: “la lotta
degli elettromeccanici dell'autunno-inverno '60-'61 è
importante per un motivo molto semplice. È la prima lotta
che gli operai vincono dopo la Liberazione. In sostanza: quindici
anni di licenziamenti discriminatori, repressione nelle fabbriche,
umiliazioni, crollo del tesseramento sindacale... e poi gli
elettromeccanici. Una mobilitazione vittoriosa e unitaria, o
meglio: vittoriosa perché unitaria.” Non
solo: è generata dal basso e autogestita; una lezione
che il movimento ricorderà anche negli anni a seguire.
Lo slogan è semplice e potente: “Resteremo un minuto
in più dei padroni”. Le prime vertenze nascono
nel 1958. Nel 1959 viene occupata la Pracchi. Nel 1960 la lotta
si estende, cavalcando anche le mobilitazioni contro il governo
Tambroni: gli operai passano anche un Natale di protesta sul
sagrato del Duomo. Le rivendicazioni proseguono con scioperi
di ogni sorta: “scioperi di più giorni, scioperi
quotidiani di mezza giornata, scioperi di due ore, scioperi
di mezz'ora, scioperi a scacchiera. Scioperi à la
carte”. I metalmeccanici si battono per il nuovo contratto
nazionale e trascinano nella lotta altri operai.
Questa la grande Storia; ma per gustarla nei dettagli è
bene rivolgersi ai testi del concorso indetto nel 1963. Sono
pagine che odorano di corpi, sigarette, zama, spazi chiusi,
sale d'assemblea, e soprattutto di fabbriche milanesi. Sì,
questo è una grande racconto milanese: una storia delle
periferie del capoluogo lombardo, della sua classe operaia e
dei suoi umori cangianti.
I pezzi migliori sono forse Cinegiornale – che
ci spiega come funziona il ricatto del cottimo – e La
prova di Gastone Iotti, vincitore del premio; dove fra l'altro
si trova una brillante intuizione libertaria. Il protagonista
deve scegliere se costringere con la forza alcuni impiegati
che non vogliono scioperare a fianco degli operai. Ma preferisce
convincerli a parole: obbligarli “neppure sarebbe stato
democratico, perché se è vero, come io credo,
che la democrazia è prima di tutto libertà, libertà
anche di sbagliare, non sarebbe stato democratico costringerli
a scioperare. Era una cosa da fargliela capire, insomma, che
poi, una volta capita, gli sarebbe rimasta in testa tutta la
vita, e questa sarebbe stata veramente democrazia. Se uno lo
obblighi a fare qualcosa con la violenza, anche se è
una cosa giusta e sacrosanta, quello mica capisce che la cosa
è giusta, e anche se lo capisce, è la violenza
che egli ha presente innanzitutto [...].”
I racconti del laboratorio contemporaneo – scritti collettivamente
sotto la guida e i consigli di Wu Ming 2 – parlano invece
la lingua attuale degli impieghi liquidi, dei diritti erosi
nel tempo, della lotta contro l'abolizione dell'articolo 18.
Ma anche del giornalismo sensazionalista e della “coltre
di arrendevolezza” che il vecchio operaio Giovanni, nel
racconto Profumo, può ben riconoscere.
In ogni caso, c'è molto che accomuna i testi del 1963
a quelli del 2015: non solo l'impatto emotivo, ma anche la permanenza
di alcune figure del capitalismo. I padroni si comportano sempre
da padroni; e i lavoratori da lavoratori. La finzione ci fornisce
un'immagine nitida della vita in fabbrica e delle lotte, cento
volte più efficace di un trattato sociologico. E soprattutto,
scevro di luoghi comuni: non serve leggere L'operaiolatria
di Berneri per accorgersi della realtà complessa, sfaccettata,
che trasmettono questi racconti.
Gli operai messi in scena non sono perfetti. Non sono mitizzati.
Sono uomini e donne con ossessioni, difetti, dipendenze: a volte
sono spacconi, a volte volgari, di certo non rientrano in alcuno
stereotipo. Ma nessuno di essi è vile e meschino. Tutti
hanno coscienza di classe, o la sviluppano strada facendo.
Basta leggere la testimonianza di Infrastoria #9 per
farsi un'idea: è l'educazione alla lotta di uno scettico
che di base pensa per lo più “alla figa”
e poco altro, e finisce per sostituire alla parola “colleghi”
la parola “compagni”. Difficile trovare qualcosa
di più realistico e completo, che dica con chiarezza
anche la paura, l'ansia e i rischi che la lotta sindacale comporta.
Scioperare non è una gita; i padroni sono tutt'altro
che propensi a mollare, e in ballo c'è la vita delle
persone coinvolte.
Oltre a essere letterariamente interessante – pur con
alcune, ovvie ingenuità stilistiche – Meccanoscritto
ha anche un valore aggiunto. Dice a gran voce, in un panorama
dove “il racconto del lavoro non fa notizia, anzi non
è notizia”, che le fabbriche esistono ancora. Che
la produzione esiste ancora, contro ogni ideologia di immaterialismo,
ed esiste il dolore che la produzione genera: il tempo perso,
i movimenti ripetitivi, lo sfruttamento; le intimidazioni, i
ricatti padronali, le delusioni del crumiraggio. Non sono relitti
del XX secolo, ma realtà che ci accompagnano quotidianamente:
se molti non le vedono è perché hanno minore dignità
e centralità nel discorso pubblico, e perché sono
in parte dislocate. Inutile aggiungere che rispetto agli anni
Sessanta il movimento operaio ha una forza assai minore, e che
molti dei sogni di quell'epoca sono andati incontro a una brutale
sconfitta. Anche il paragone tra l'Unità di allora
e quella di oggi fa male al cuore.
Eppure il pregio di questo libro è quello di non abbandonarsi
affatto a una sterile nostalgia. Anzi. Attraversando gli anni
del grande riflusso con rinnovata energia – e veicolandoli
attraverso le storie, uno degli ultimi argini di resistenza
rimasta – ricorda al lettore il valore della lotta.
Giorgio Fontana
Roma 1906-1926 (e oltre)/
La Casa del Popolo al Celio
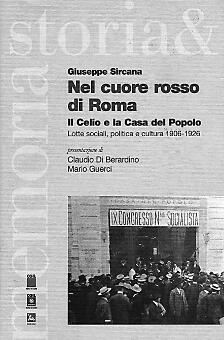 Dalla
quarta di copertina leggiamo: “Per circa vent'anni la
Casa del Popolo è la casa comune di socialisti rivoluzionari
e riformisti, anarchici, repubblicani, comunisti, il quartier
generale di grandi agitazioni operaie e della prima resistenza
al fascismo”. Dalla
quarta di copertina leggiamo: “Per circa vent'anni la
Casa del Popolo è la casa comune di socialisti rivoluzionari
e riformisti, anarchici, repubblicani, comunisti, il quartier
generale di grandi agitazioni operaie e della prima resistenza
al fascismo”.
Già questo periodo può dare l'idea di quanto Giuseppe
Sircana sia stato obiettivo e rigoroso nel narrare la storia
della Casa del Popolo di Via Capo D'Africa (Nel cuore rosso
di Roma. il Celio e la Casa del Popolo, Lotte sociali, politica
e cultura 1906-1926, Ediesse, Roma, 2016, pp. 180, €
13,00). Con l'occasione si ricorda che Sircana ha anche scritto
la pregevole voce biografica di Pietro Gori, sul Dizionario
Biografico degli Italiani, pubblicata su Internet nel 2002.
Nei primi del '900 in Europa ed in tutta Italia vennero costruite
dagli operai le Case del Popolo. Le Case del Popolo che fiorirono
dovunque, rispondevano alla necessità dei lavoratori
di un luogo fisico e simbolico, ove potersi riunire, invece
che sulla strada e nelle osterie, che all'inizio della sua lunga
storia il movimento operaio, nella seconda metà dell'800,
era costretto a praticare, in mancanza di strutture diverse.
Nelle osterie, che rappresentavano i primi luoghi di riunione
e di socializzazione, prendeva piede anche la piaga dell'alcolismo,
al quale la Casa del Popolo, nella concezione dei partiti socialisti
che acquisivano sempre più consenso popolare, doveva
porre una argine, strappando i lavoratori sia dalle ingenti
spese per il vino, che ai medesimi falcidiava il magro ed assai
faticato salario, che dalle malattie che l'alcolismo comportava.
Negli anni recenti sono stati prodotti molti studi su queste
forme autogestite del movimento operaio e popolare. Alberto
Ciampi e Sergio Mechi hanno curato nel 2011 un ottimo libro
dal titolo “Case del Popolo - Case di tutti?”, dedicato
al compagno Gigi di Lembo, che getta una luce di insieme sulla
nascita e fioritura delle Case del Popolo e su come siano state
distrutte tra il '21 ed il '22 dalla devastazione fascista.
Anche a Roma venne inaugurata al Celio il 6 ottobre 1906 la
Casa del Popolo, costruita di sana pianta dai lavoratori dell'edilizia.
Essa divenne il centro della vita sociale e politica del popolo
lavoratore fino a qualche anno dopo l'avvento del fascismo.
La capacità costruttiva del popolo lavoratore, che non
attendeva aiuti dallo Stato, innanzitutto formulò l'idea
di un centro dove riunirsi, discutere e formarsi e successivamente
e molto rapidamemte edificò dalle fondamenta lo stabile,
che è ancora presente al Celio, provvedendo ad arredarlo
con il contributo degli artisti dell'epoca.
Questa istituzione operaia venne intesa dai socialisti anche
come luogo sia di formazione dei quadri per la gestione amministrativa
dei Comuni in via di conquista dall'elettoralismo socialista,
che di formazione della personalità completa socialista,
antitetica a quella borghese. Poco lontano venne costruito l'Educatorio
Andrea Costa, al medesimo dedicato, a pochi anni dalla sua morte,
dove, fino a quando la struttura in legno non venne distrutta
dallo squadrismo, si tennero corsi scientifici, professionali,
scolastici ed artistici rivolti alla popolazione adulta ed infantile.
Giuseppe Sircana nel suo libro narra la storia di questa istituzione,
il suo ruolo nelle agitazioni popolari e nelle lotte sindacali,
i conflitti che tra le sue mura e nella città si ebbero
tra i socialisti, gli anarchici ed i repubblicani e, dopo la
scissione di Livorno, i comunisti; le principali forze popolari
a Roma nel primo ventennio del '900.
Dalle pagine del libro emergono non solo le voci dei socialisti
e dei sindacalisti, ma anche le voci degli anarchici. Specialmente
gli interventi di Aristide Ceccarelli, di Spartaco Stagnetti,
di Forbicini, di Varagnoli cioè delle figure carismatiche
di quell'epoca, che a Roma spesero la propria attività
frenetica, con spirito di grande sacrificio, tra il dopo Bresci
e il primo dopoguerra. Sono altresì elencate le varie
organizzazioni libertarie.
È assente dal libro, perché ovviamente non è
nato con tale finalità, l'analisi del movimento anarchico
romano, che svolse, nel primo ventennio del novecento, un ruolo
assai importante per la ripresa organizzativa del movimento
anarchico di lingua italiana, dopo la dissoluzione della I Internazionale
e la messa fuori legge degli anarchici durante il periodo crispino.
Nel libro non si parla del Congresso di Roma del 1907 che sancì
la svolta libertaria promossa da Luigi Fabbri e dell'evoluzione
del movimento, su sollecitazione di Malatesta, da uno stato
di estrema protesta ad uno stato di progressivo consenso tra
le masse popolari ed i lavoratori, così da annoverare,
a livello nazionale, come segretari delle Camere del lavoro,
numerosi anarchici. Con la svolta libertaria il movimento anarchico
italiano esce dalla clandestinità, nella quale era stato
costretto precedentemente. Questo periodo, di circa vent'anni,
si chiuderà dopo il biennio rosso, tra il '21 e il '22,
a conclusione dell'attacco ad oltranza delle truppe fasciste
e della conquista del potere da parte di Mussolini.
Nello specifico del lavoro organizzativo gli anarchici si ispirano
a Pietro Gori e a Luigi Fabbri. Pietro Gori, a Roma, inizia
a rappresentare l'esigenza della formulazione del diritto operaio,
ossia del diritto del lavoro e della legislazione sociale, che
invece qualche anno prima, nel 1892, insieme a Malatesta, respingeva,
durante le sedute del Congresso di Genova, quando considerava
la legislazione sociale del lavoro un'esigenza di Turati, per
soffocare la rivoluzione sociale ed impantanarla nel legalitarismo.
In “Aspettando il sole!” Conferenza tenuta a Roma
il 1 maggio 1902 da Pietro Gori (Editrice F. Serantoni 1908
Firenze Roma), leggiamo: “Così ebbero la loro legislazione
quasi tutti gli istituti, dalla proprietà al matrimonio
- che potevano in qualche modo interessare i dirigenti delle
pubbliche aziende e le classi ricche e potenti. Ma è
stato dimenticato il diritto operaio e quando se ne ricordarono
fu per mutilarlo oscenamente.”
Gli anarchici svolgono prevalentemente i mestieri e le professioni
di barbieri, camerieri, stagnini, edili e contadini. Ma non
è automaticamente desumibile che l'impegno sia più
o meno moderato, in misura direttamente causata dalla collocazione
di classe. Anzi spesso gli anarchici mostrano di essere più
moderati nella conduzione delle lotte e nell'avanzamento delle
istanze rivendicative, di quanto siano i repubblicani, ai quali
lanciano frequentemente accuse di estremismo. Alfredo Fabbretti,
anarchico, nel 1912, avanzando critiche alla Camera del lavoro
che viene accusata di mandare allo sbaraglio i muratori, “come
avvenne nel 1910, dopo 45 giorni di sciopero per le 9 ore”;
non incita allo sciopero insurrezionale, ma invece ammonisce
gli operai a non imbarcarsi in scioperi senza sbocco, come si
legge nel “Libertario” del 25 febbraio 1912.
Il libro non tratta del minuto lavoro organizzativo che gli
anarchici svolgevano, né del fatto che Malatesta, nei
suoi passaggi clandestini a Roma negli anni dieci del Novecento,
prima di poter operare alla luce del sole in Italia al suo rientro
nel primo dopoguerra, intratteneva rapporti con il movimento
romano, in vista dello auspicato strappo rivoluzionario.
Ma il saggio tratta dei momenti pubblici e drammatici dell'attività
politica e sindacale dei diversi partiti e movimenti, fra i
quali gli anarchici; come conflitti con la forza pubblica, scioperi
e manifestazioni, che hanno coinvolto in vari modi la Casa del
Popolo e che hanno interessato la città.
Dalla trattazione gli anarchici emergono come i più radicali.
Ma se non si avesse conoscenza dell'intenso lavoro organizzativo,
propagandistico e culturale che è legato alla svolta
libertaria, ispirata dalla ricerca del consenso tra le masse
popolari ed i lavoratori, svolta della quale Luigi Fabbri nel
suo periodo romano è l'anima, nonché della redazione
e vasta diffusione di periodici come “Il Pensiero”
e “L'Agitazione” sia come edizione anconetana che
come edizione romana; si avrebbe l'impressione di un atteggiamento
degli anarchici estremista fine a se stesso. Tuttavia, a parte
queste osservazioni, il saggio di Sircana è un assai
importante contributo, sul piano delle storia del lavoro e dei
movimenti popolari, nel gettare ulteriore luce sulla storia
degli anarchici durante il periodo giolittiano.
Periodo che benchè esaminato da numerosi libri, come
quelli di Roberto Carocci “Roma sovversiva. Anarchismo
e conflittualità sociale dall'età giolittiana
al fascismo (1900-1926)” e di Valerio Gentili “Dal
nulla sorgemmo”, dei quali Sircana riporta diverse citazioni,
resta ancora da approfondire, oltre che nel dettaglio della
concreta vita organizzativa del movimento, anche nei suoi aspetti
politici e sindacali.
Alla conclusione della I Guerra Mondiale cambia il tono del
conflitto sociale e politico, che si fa più aspro e decisivo
per le sorti del popolo lavoratore. La smobilitazione di migliaia
di soldati, la disoccupazione crescente e la fame, la qualità
delle proteste e delle manifestazioni operaie e popolari tese
a “fare come in Russia”, la nascita della guardia
bianca composta da ufficiali e studenti che infierisce nel '19
inizialmente sui deputati socialisti e il dilagare delle squadre
fasciste, coinvolgono ancor di più la Casa del Popolo.
Con il primo dopoguerra la Casa del Popolo che accoglie Errico
Malatesta al rientro in Italia e si mobilita contro il suo arresto
insieme ai redattori di “Umanità Nova” il
17 ottobre 1920, che accoglie gli Arditi del Popolo e la riunione
del Comitato dell'Alleanza del Lavoro in vista dell'ultimo sciopero
contro il fascismo, vede, contestualmente ai frequenti eccidi
dei manifestanti che fanno riferimento alla Casa del Popolo,
il progressivo venir meno delle speranze rivoluzionarie.
Con l'esproprio, nel 1924, da parte del fascismo della struttura,
edificata da un'Associazone del popolo lavoratore nel lontano
1906, non si conclude la storia della Casa del Popolo che prosegue
fino ai giorno nostri, come chi leggerà il libro avrà
modo di vedere.
Enrico Calandri
Sulla condizione umana/
Salpare le ancore
Quant'è bella libertà/
che cos'è nessun lo sa
In una celebre disputa, ormai quasi mezzo secolo fa, due star
della scena intellettuale internazionale si confrontarono sulla
questione della natura umana1:
da una parte Noam Chomsky, grande linguista oltre che intellettuale
critico americano vicino all'anarchismo e dall'altra Michel
Foucault, maitre-à-penser francese, filosofo,
storico delle idee e dei sistemi di pensiero e critico delle
istituzioni.
Se si ha la pazienza di seguire il dibattito, ci si accorge
presto almeno di due cose: che adottano stili di pensiero così
distanti che solo tangenzialmente riescono a incontrarsi su
alcuni concetti e alcune questioni, peraltro con un modo di
intenderle assai diverso; e che nessuno dei due si azzarda a
dire di sapere bene che cos'è la natura umana. Chomsky,
più pragmatico, sembra più propenso a definire
un set di regole che permettono creatività e libertà
all'individuo, mentre Foucault, attraverso continui riferimenti
alla storia del sapere e della cultura, sembra rifiutare un'astratta
idea di natura umana, fuori dal contesto sociale, politico,
culturale. Il risultato è francamente deludente, tanto
più se si pensa ai personaggi coinvolti.
Ma forse aldilà dell'occasione specifica è proprio
il tema stesso che è come un contenitore vuoto in cui
ciascuno mette altre questioni che considera decisive: nel caso
di Chomsky e Foucault la contrapposizione tra giustizia politica
e potere. Ma potrebbero essere anche altre questioni come l'annoso
dibattito sulla natura/cultura (o nurture), oppure l'identità
personale, tra permanenza e cambiamento.
Pensate a quante volte vi siete detti, magari davanti allo specchio:
forse non avrei dovuto, ma sono fatto così e non posso
cambiare. Quante volte, magari in preda all'ira imprecando,
avete detto: devi cambiare; e vi siete sentiti rispondere: non
posso, son fatto così. Avete voi e l'altro rivendicato
l'esistenza di un nucleo duro che resiste al cambiamento dall'interno
o dall'esterno. Forse non avete scomodato la parola “natura”,
ma vi siete molto avvicinati al modo in cui per secoli, e ancor
oggi, si è pensata la “natura” nella sua
permanenza.
L'accostamento di due concetti così polisemici e ricchi
di sfumature moltiplica all'infinito le varianti possibili.
La parola “natura” è stata usata per indicare
tra le altre cose: la totalità (l'insieme degli enti
reali nell'unità del cosmo), il principio generativo,
per indicare tutto ciò che non è fatto dall'uomo
(in opposizione ad artificiale), il primordiale (in opposizione
al mondo civilizzato), la spontaneità (in opposizione
a ciò che è posto dall'uomo), il mondo del vivente,
il creato (per chi crede in dio), lo stato prepolitico (il mitico
«stato di natura»), l'oggetto in contrapposizione
al soggetto (umano), l'essenza, la sostanza ossia la vera natura
di qualcosa, la norma (nel senso di ciò che è
comune e in questo senso costituisce il fondamento dell'etica).
 Quanto
all'“umano” anche qui il catalogo delle interpretazioni
è assai voluminoso: dall'animale politico di Aristotele
a tutte le varianti di homo sapiens che la paleoantropologia
va studiando. Senza mai dimenticare, come si fa ancora troppo
spesso, che nel “meccanismo antropogenetico” c'è
in gioco la differenza da e la rimozione dell'animale2.
Non è dunque affatto sorprendente che quando ci si siede
intorno a un tavolo a discutere di “natura umana”
ci si trovi davanti a qualche difficoltà. Ma quando mai
le difficoltà hanno spaventato gli anarchici? Quanto
all'“umano” anche qui il catalogo delle interpretazioni
è assai voluminoso: dall'animale politico di Aristotele
a tutte le varianti di homo sapiens che la paleoantropologia
va studiando. Senza mai dimenticare, come si fa ancora troppo
spesso, che nel “meccanismo antropogenetico” c'è
in gioco la differenza da e la rimozione dell'animale2.
Non è dunque affatto sorprendente che quando ci si siede
intorno a un tavolo a discutere di “natura umana”
ci si trovi davanti a qualche difficoltà. Ma quando mai
le difficoltà hanno spaventato gli anarchici?
Quant'è ricco il catalogo delle idee libertarie
Francesco Codello nel suo ultimo denso saggio, La condizione
umana nel pensiero libertario, (Elèuthera, Milano,
2017, pp. 344, € 16,00), ripercorre coraggiosamente i molteplici
incontri/scontri intorno alla vexata quaestio.
Il libro si può leggere come una rivisitazione della
storia dell'anarchismo attraverso il filo conduttore della questione
della natura umana. È bello imbattersi in pensieri già
pensati, a volta solo intuiti, a volta del tutto impensati.
È bello intrattenersi a lungo con il Principe, incontrare
conoscenti e amici che non si vedevano da tempo e imbattersi
in quasi sconosciuti che si avrebbe voglia di conoscere meglio.
Tutto questo ci richiama alla mente, se mai ce lo fossimo scordati,
quanto è ricco il catalogo delle idee libertarie, di
cui non c'è traccia quasi nel mainstream culturale.
È in questa rivisitazione che Codello ci presenta le
varie sfaccettature da cui è stata affrontata la questione
della natura umana, in rapporto con la società, con l'ambiente,
con le strutture del dominio. In effetti per prendere la cosa
con prudenza, basterebbe l'ammonimento di Emma la rossa: “Povera
natura umana, che crimini orrendi sono stati commessi in tuo
nome! Ogni idiota, dal re al poliziotto, dal parroco ottuso
fino al dilettante di scienza privo di immaginazione, pretende
di parlare con autorevolezza di natura umana. Quanto più
qualcuno è un ciarlatano, tanto più categorica
è la sua insistenza sui mali e le debolezze della natura
umana” (149).
E tuttavia questo non basta perché è abbastanza
chiaro che la questione non è fine a se stessa, dibattito
accademico o causerie. Sono le conseguenze politiche
di una determinata visione dell'uomo e della natura umana ad
essere importanti. Come scrive Codello: “l'idea da cui
muove questa riflessione è innanzitutto capire se da
una specifica concezione su quale possa essere l'essenza più
autentica dell'uomo si siano poi declinate filosofie politiche
conseguenti” (9). Per tacere delll'educazione di cui Codello
si occupa da sempre.
Ed ecco allora il secondo livello di lettura di questo libro,
per così dire la sua cornice teorica. L'introduzione
e la chiusa che incorniciano la grande panoramica delle idee
di cui abbiamo detto, accentuano giustamente un aspetto particolare:
quello della critica anarchica al determinismo, nelle sue varie
forme filosofiche e scientifiche, e in particolare queste ultime
da quando le scienze hanno occupato more teorico/pratico campi
che per millenni erano stati di pertinenza della filosofia.
Un riferimento al pensiero orientale
La questione è decisiva non solo perché a partire
dalla scienza del XVII secolo e dall'assunzione del paradigma
meccanicistico e deterministico, il gioco della libertà
si riduce progressivamente, ma anche perché nella realtà
del controllo contemporaneo la scienza e le tecniche hanno un
ruolo sempre maggiore. Qui appunto l'autore fa bene a mostrare
i punti di contatto e l'apporto critico di autori come Kropotkin
a questioni scientifiche. Oggi, a mio parere la questione è
molto più complicata: mentre ai tempi di Darwin una persona
colta e uno scienziato anche non specialista poteva leggere
un'opera scientifica di grande livello, oggi non è più
nemmeno lontanamente possibile, dato il livello di specializzazione
e i tecnicismi di cui si nutre la scienza contemporanea. D'altra
parte già ai tempi della relatività di Einstein,
un secolo fa, le sue equazioni erano comprensibili a un numero
di scienziati che si potevano contare sulle dita di due mani.
Tornando alla ricostruzione di Codello, in questa cornice di
secondo livello, è ben chiara la sua mossa di indebolire
l'idea di una “natura” umana immutabile scegliendo
invece di parlare di condizione umana: “non c'è
un'essenza umana, ma una condizione umana, la prima è
fissa e immutabile, la seconda malleabile e adattabile, la prima
è il regno del dominio, la seconda della libertà
possibile” (317).
Ma ancora oltre, a un ulteriore livello, c'è la questione
della “libertà”, di cui gli anarchici sono
innamorati folli da sempre. Una volta che si sia rinunciato
a un'idea libertà senza limiti, che si siano però
rifiutati i limiti della libertà liberale, anche qualora
non ci si rifacesse più a un'idea vetusta di natura umana,
a che cosa dovremmo rifarci? Codello, citando Ambrosoli, riprende
l'idea dell'indeterminazione (335) che deriva dalla tradizione
umanistica (Pico della Mirandola: l'uomo è stato creato
come mancante di una natura determinata, e proprio in ciò
sta la sua dignità, ossia la sua libertà). Non
è il centro del saggio di Codello, ma il suo punto conclusivo
è in realtà l'inizio di una ricerca intorno alla
libertà che è sì cara. Quanto in alcune
immagini di libertà della tradizione dell'anarchismo
ci sia un retaggio romantico, o idealistico, quanto è
possibile invece guadagnare da un corpo a corpo con la questione
del determinismo scientifico3.
O ancora, quali altre suggestioni possono derivare dalla scienza,
se si abbandona un paradigma deterministico?
E per finire, dato che lo stesso autore, sempre al livello della
cornice (secondo piano) fa più volte riferimento al pensiero
orientale, quanto verrebbe dal confronto possibile con altre
immagini del pensiero come quello cinese, come nel percorso
che da anni François Jullien ci va proponendo.
Concludo con una citazione appunto dal suo ultimo libro riguardo
alla contrapposizione tra disponibilità e libertà:
“L'Europa ha misconosciuto la risorsa della disponibilità
proprio perché ha sviluppato un pensiero della libertà;
per la Cina vale l'inverso. (...) la libertà è
il prodotto di un'invenzione (più che una scoperta, come
si è sempre creduto, un'invenzione che tutto sommato
è assai singolare, ma che in Europa è stata assimilata
a tal punto da averne dimenticato la parzialità”4.
Filippo Trasatti
- Noam Chomsky- Michel Foucault, La natura umana, Castelvecchi
2013; si può vedere il video al seguente indirizzo:
https://it.video.search.yahoo.com/search/video?fr=chr-greentree_sf&p=foucault+chomsky+debate#id=3&vid=0d991185bff2d6ba8601a11fb35a3d6b&action=view
- Sulla questione dell'animale la bibliografia è ormai
per fortuna ricca. Mi limito a segnalare due testi: Jacques
Derrida, L'animale che dunque sono, Jaca Book Milano
2006 e il libro di Massimo Filippi, L'invenzione della specie,
Ombre corte 2016.
- cfr. ad esempio Daniel Dennett, L'evoluzione della libertà,
tr.it., Cortina Milano 2004.
- François Jullien, Essere o vivere, tr.it. Feltrinelli,
Milano 2016, p. 35 e 36.
|

