
Per un'emancipazione
integrale e completa
 Le
edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano di Henri
Roorda Il maestro non ama i bambini (Lugano
2014, pp. 80, FrS. 12,50, € 10,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).
Ne riproduciamo l'introduzione di Francesco Codello. Le
edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano di Henri
Roorda Il maestro non ama i bambini (Lugano
2014, pp. 80, FrS. 12,50, € 10,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).
Ne riproduciamo l'introduzione di Francesco Codello.
Nato a Bruxelles nel 1870, a causa delle posizioni politiche
anticolonialiste del padre olandese, costretto a fuggire dal
suo paese nativo in seguito alla pubblicazione di un pamphlet
anticolonialista, vive la sua vita prevalentemente nella Svizzera
Romanda e a Losanna.
Henri Roorda inizia nel 1892 a insegnare matematica e ad affinare
la sua sensibilità pedagogica in senso libertario. Pubblica
negli anni che si succedono diversi articoli sulla scuola, l'insegnamento,
l'educazione, in numerose testate anarchiche e libertarie. Nel
1917 pubblica a Losanna il testo Le pédagogue n'aime
pas les enfants che viene qui editato. Nel 1925 decide di
porre fine alla sua vita rivendicando il diritto per ciascuno
di decidere quando e come morire.
Se la vita di Roorda si inserisce a pieno titolo nella tradizione
del pensiero antiautoritario (emblematica la sua fine volontaria),
il suo pensiero, in particolar modo quello educativo, pur appartenendo
a un periodo storico preciso e pur collocandosi nell'alveo della
memoria anarchica, presenta numerosi spunti di attualità.
Il professore svizzero (di fatto), nelle sue pubblicazioni,
nel solco delle riflessioni libertarie tese alla promozione
di una emancipazione integrale e completa di ogni essere umano,
non manca di offrirci argomenti e valutazioni quanto mai utili
per una attuale critica del sistema sociale autoritario, con
in più un gusto tutto suo di umorismo dissacrante e intuitivo.
Già nel titolo di questa sua riflessione, “Le pédagogue
n'aime pas les enfants” (Il maestro o l'insegnante non
ama i bambini), provoca immediatamente una sorta di fastidio
concettuale se non se ne colgono le implicazioni e le meditazioni
conseguenti. Quale educatore autenticamente degno di fregiarsi
di questo titolo, infatti, non inorridirebbe di fronte alla
condizione strutturale nella quale le società hanno organizzato
le loro scuole e pianificato l'intero sistema educativo? Questa
la domanda di fondo da cui muove il ragionamento di Roorda e,
conseguentemente, la convinzione che ci rappresenta in questo
testo, secondo la quale appunto solo pochi maestri sanno cogliere
l'assurdità di un sistema scolastico fortemente impregnato
di autoritarismo. Ecco perché chi non rifiuta tutto questo,
pur sentendosi un educatore, di fatto perpetuando queste ritualità,
non può affermare di amare i bambini.
Attenzione però, il discorso dell'educatore svizzero,
non è mai condito da affermazioni perentoriamente dogmatiche
(ideologizzate), né il linguaggio scivola in roboanti
asserzioni di maniera (apparentemente rivoluzionaria). Il suo
pacato incedere è proprio di chi fonda le proprie osservazioni
dall'interno di una prospettiva e di una professione, avvertendo
il lettore di essere prudente nell'accogliere le critiche ma,
al contempo, anche di continuare a mettere alla prova dei fatti,
empiricamente e pragmaticamente, tutto quello che gli viene
proposto. Si tratta di un atteggiamento proprio di chi sviluppa
le proprie convinzioni facendo sempre attenzione a metterle
in discussione perché talvolta si può divenire
prigionieri anche delle proprie verità, quando queste
non sono animate da autentico spirito libertario.
Fatte queste premesse però la sua critica al sistema
scolastico è decisa e radicale, se vogliamo in qualche
modo anticipatrice delle più moderne teorie descolarizzatrici
di illiciana ascendenza, senza però rinunciare a coniugare
una prospettiva di radicale cambiamento con la paziente e faticosa
azione quotidiana anche all'interno di una società sicuramente
non libertaria. La scuola come istituzione totale, che sottomette
le menti e addomestica i corpi, è il bersaglio della
sua critica, non solo una certa scuola (quella religiosa) ma
anche quella che si presenta come diversa, comunque statale.
Si tratta per Roorda di smascherare l'insieme delle pratiche
e delle teorie che le rappresentano, di cui il sistema-scuola,
le sue ritualità, i suoi presupposti fondativi e le sue
articolazioni organizzative, si nutrono e ne costituiscono l'essenza
trasversale alle diverse politiche governative. Non è
un caso che la sua azione si sia concretizzata anche nel sostegno
all'esperienza della scuola Ferrer di Losanna e al sostegno
attivo a tutto quel movimento, non solo ferreriano, di sperimentazioni
scolastiche che hanno caratterizzato questi anni del secolo
ventesimo fino all'avvento dei totalitarismi. Per Roorda la
Scuola è innanzitutto una scuola di sottomissione che
ha comunque come scopo l'addestramento funzionale degli individui.
Qui il suo riflettere si accompagna a quello della più
classica tradizione anarchica e libertaria che da William Godwin
arriverà fino ad Alexander Neill per poi proseguire nelle
contemporanee esperienze di educazione antiautoritaria e incidentale.
Le scuole sono una sorta di caserme dello spirito e disciplina
dei corpi, che si sostengono attraverso una sistematica azione
ripetitiva e suadente di ritualità e prassi quotidiane,
che potremmo dire riecheggiano le descrizioni del Foucault di
Sorvegliare e punire.
Non si tratta dunque di contestare (solo) la caducità
dei contenuti che vengono impartiti, le metodologie che non
lasciano spazio all'apprendimento autentico e originale, la
perpetuazione di rapporti gerarchici e autoritari, la selezione
classista, ecc., tutto sicuramente vero e ben presente nelle
sue osservazioni critiche, ma occorre andare oltre.
Bisogna cogliere, ci dice il pedagogista svizzero, la natura
appunto totalizzante del sistema, denunciare con forza una pedagogia
adulto-centrica, un insieme di pratiche che mettendo al centro
l'insegnamento (quindi il presunto possessore della conoscenza),
sviliscono l'apprendimento (l'incidentalità e l'autonomia
del presunto discente). Se lo scopo è la normalizzazione
delle vite a favore di una precoce assimilazione a un sistema
autoritario, bisogna ribellarsi, costruire vere alternative
antiautoritarie, spazi di autonomia e di libertà, per
interrompere il circolo vizioso del sistema e modificare l'immaginario
sociale in senso libertario. La Scuola è simile a una
prigione, dotata di un proprio tribunale interno che si preoccupa
di valutare le “giuste” risposte a domande poste
in modo standardizzato e schematizzato, a misurare quella quantità
di conoscenze (nozioni o informazioni in realtà) ritenuta,
dall'insieme dell'organizzazione, quella sufficiente per essere
considerata degna di un apprendimento pre-stabilito.
Roorda, dimostrando in questo un forte senso di anticipazione
e un'intuizione veramente eccezionale, afferma con convinzione
che la scuola esige troppo dai bambini. L'ingresso dei piccoli
nel sistema scolastico è troppo precoce, sempre più
ne occupa e organizza lo spazio e il tempo, imponendosi in maniera
soffocante e alienante. L'infanzia viene mutilata della sua
natura e dimensione, l'adultizzazione è precoce e invasiva.
L'alternativa che egli propone è quella classica della
tradizione anarchica (attenzione non confessionale), dove, sostanzialmente,
l'autonomia (del pensare e dell'agire) costituisce il vero fondamento
di un'educazione autenticamente alternativa. Uno spazio e un
tempo nel quale ogni specificità, ogni sensibilità,
ogni essere, trovi modo di esprimere la propria personalità
in armonia con quelle degli altri, senza sopraffazioni e violenze
più o meno evidenti o mascherate. Insomma dove ciascuno
diviene liberamente ciò che è e che desidera e
non ciò che qualunque altra autorità ha deciso
per lui. Ricerca, spazio prioritario agli interessi e alle curiosità,
creatività, individualizzazione, incidentalità,
diversità naturale coniugata con uguaglianza sociale,
ecc: questi gli assi portanti di una nuova educazione veramente
antiautoritaria posti da Roorda a fondamento di una nuova scuola.
Non può mancare, nella sua visione, un diverso significato
del ruolo dell'educatore, qui inteso come facilitatore, accompagnatore,
che fonda sul rispetto effettivo del bambino/a, sull'empatia
e su di una sensibilità tutta delicata e autentica, il
proprio agire. Roorda delinea una postura diversa dell'insegnante
e dell'educatore, una vera rivoluzione del ruolo tradizionale
e autoritario, a favore di una condivisione di un percorso di
ricerca e di mutuo scambio di esperienze e conoscenze, senza
calpestare e neanche quasi sfiorare le proprie originalità,
consapevoli che, comunque, ogni educazione è un'esperienza
sociale e condivisa.
La lettura attenta e profonda di questo testo offre a ciascuno
di noi, educatori di professione o no, spunti e pensieri che
fanno riflettere e che possono essere “usati” nella
nostra quotidianità, senza che possano farci sfuggire
da un impegno che veramente testimoni un amore autentico per
i bambini e le bambine.
Francesco Codello
 Movimenti
dal basso
e democrazia partecipataCon il suo ultimo libro Virtù che cambiano il mondo.
Partecipazione e conflitto per i Beni Comuni (Feltrinelli,
Milano 2013, pp. 160, € 12,00) Guido Viale indica e analizza
le qualità che garantiscono a tutti un'apertura verso
un mondo diverso, un veicolo finalizzato a raggiungere una giustizia
per il sociale e per l'ambiente. Un tale auspicabile obiettivo
sarebbe raggiungibile, secondo l'autore, sia tramite la risoluzione
delle conflittualità intrinseche nelle lotte contro il
sistema di potere, sia attraverso l'adesione e l'interessamento
passionale alle rivendicazioni decisionali per cambiare la politica
e la sua agenda. Decisivo è il nostro modo di concepire
la società e il mondo, con comportamenti e buone pratiche
quotidiane, basate sulla partecipazione e la condivisione continua
delle decisioni.
Le “virtù” sono bistrattate da un sistema
di potere basato sulla meritocrazia e il servilismo, dominante
il contesto sociale diviso tra “vincenti” e “perdenti”.
La competizione universale ad oltranza di tutti contro tutti
è imposta dall'avanzata di un neoliberismo postfordista
e reazionario che aliena gli esseri umani deprivandoli di dignità,
travalicando ormai l'antiautoritarismo in fabbrica e il ritorno
dell'indignazione nelle piazze.
Le virtù della dignità, dell'empatia, della conoscenza,
della sobrietà sono necessarie ad avviare un percorso
futuro di trasformazione del mondo in una “conversione
ecologica” che parta dalle rivendicazioni dal basso contro
lo strapotere della formula TINA (“There is no alternative”),
che impone la legge dell'industria tramite la dittatura dell'ignoranza
e del liberismo capitalista sintetizzato dai suoi principali
esponenti: Thatcher, Reagan, Wojtyla.
Per una democrazia dal basso e per la trasformazione ecosostenibile
del pianeta, secondo Viale, è necessario coniugare lotte
e saperi, nell'aggregazione di soggetti dissenzienti e di movimenti
diversi, in un'educazione permanente fondata sulle buone pratiche
dei saperi diffusi e delle scuole di vita, di cui il mondo della
disoccupazione, della precarietà e del lavoro è
straordinariamente ricco.
L'orizzonte da raggiungere è la conversione ecologica
di cui parlava Alex Langer, quale percorso necessario per ricondurre
l'attività e la convivenza umane entro i limiti della
sostenibilità sociale e ambientale, tramite le virtù
dell'immaginazione e della creatività; il fine è
quello di produrre meglio e consumare meno, cambiando lo stile
di vita, per combattere la crisi non solo congiunturale, ma
soprattutto ambientale. La conversione ecologica è una
scelta etica, un'abiura all'individualismo che domina l'attuale
cultura, nella mendace prospettiva di perseguire la propria
affermazione personale nella competizione senza regole e remore
verso il nostro prossimo.
Viale è convinto che si possa cambiare: la riconversione
produttiva, la riterritorializzazione, la priorità del
ruolo dei servizi pubblici locali sono l'antidoto alla privatizzazione
che sta consegnando i beni comuni e la ricchezza collettiva
al mondo della finanza internazionale. Per riappropriarci di
tali beni è necessario fare comunità e coordinarsi
in reti sociali convergenti, per superare la logica dell'individualismo
competitivo, come avviene con le varie forme di resistenza al
“pensiero unico”: un grande esempio è la
lotta No-Tav in Val di Susa.
La democrazia partecipata dal basso, lo spazio pubblico e le
nuove forme di convergenza, cooperazione, deliberazione consensuale
non sono dissociabili dal bene comune della conoscenza, del
legame sociale e della creatività. La lotta contro l'appropriazione
e la privatizzazione, per la conversione ecologica, è
necessariamente fondata sulle cosiddette “virtù
che cambiano il mondo”, ossia scelte, orientamenti, saperi,
che si sviluppano nella condivisione, nella reciprocità,
nell'accoglienza.
Viale, nella sua opera, individua percorsi di formazione capaci
dell'organizzazione necessaria per esautorare gli attuali poteri
politici, imprenditoriali, amministrativi e culturali, che sono,
all'opposto, incapaci di assicurare prospettive di futuro, non
solo al nostro Paese, ma all'intero pianeta. Le “virtù”,
nutrenti le lotte di base e le pratiche alternative, che garantiscono
a tutti un'apertura verso un mondo diverso, costituiscono la
possibilità di sottrarsi all'attesa impotente della catastrofe
economica e ambientale che incombe: possiamo insieme “sgonfiare”
questa “bolla” fondata sul nulla degli ego dominati
dall'ambizione e dalla paura.
Laura Tussi
 Contro
il fanatismo,
spunti di autocriticaÈ risaputo quanto sia più facile vedere pagliuzze
negli occhi altrui piuttosto che le travi nei propri. Per questo
– e perché chi scrive conosce in prima persona
l'illusione di collocare se stessi sempre sul lato migliore
della strada – consiglio la lettura di questo piccolo
libro uscito alcuni anni fa (Amos Oz, Contro il fanatismo,
Feltrinelli, Milano 2004, pp. 78, € 4,50) e più
volte ristampato. Mi pare un buon suggerimento per tutti coloro
che abbiano nel cuore il sogno di una società libera
composta da diversi conviventi in pace.
Il libretto è suddiviso in tre capitoli, tre lezioni
che riflettono in maniera profonda, ma con leggerezza e molta
ironia, sulla natura del fanatismo, per arrivare a vedere il
compromesso non come arresa ma bensì come qualcosa che
nasce dal desiderio profondo di accettarsi l'uno con l'altro.
Interessante, ai miei occhi, è il fatto che Oz abbia
compiuto il suo tragitto di riflessioni partendo da se stesso
– la sua infanzia, la sua storia personale (con la migliore
ebraica ironia) – per prendere poi in considerazione il
fanatismo come impronta del carattere (dove non è difficile
riconoscersi) e arrivare, con la terza lezione, al tema più
ampio e cruciale quale è quello della difficile situazione
tra Israele e Palestina. È questo movimento – dal
personale al collettivo, al sociale/politico, e viceversa –
che trovo importante, una modalità, oserei dire, dalla
quale non si può prescindere se si vuole innanzitutto
fare esperienza autentica dell'esistenza, ma, soprattutto, non
parlare a vanvera.
“Il fanatismo, credo, prende le mosse in casa”
e bisognerebbe non dimenticarselo mai, e fare del proprio piccolo
territorio, composto da parenti e amici, la prima palestra di
educazione alla civiltà, per poi uscire di casa e vedere
cosa si è in grado di gestire fuori Infatti: “Ritengo
che l'essenza del fanatismo stia nel desiderio di costringere
gli altri a cambiare. Quell'inclinazione comune a rendere migliore
il tuo vicino, educare il tuo coniuge, programmare tuo figlio,
raddrizzare tuo fratello, piuttosto che lasciarli vivere. Il
fanatico è la creatura più disinteressata che
ci sia. Il fanatico è un grande altruista. [...] Vuole
salvarti l'anima, vuole redimerti, vuole affrancarti dal peccato,
dall'errore, dal fumo.”
E ancora: “solo colui che ama può diventare
un traditore. Il tradimento non è il contrario dell'amore,
è una delle sue tante opzioni. Traditore è colui
che cambia agli occhi di coloro che non possono cambiare e non
cambierebbero mai e odiano cambiare e non lo concepiscono, a
parte il fatto che vogliono continuamente cambiare te: così
la penso io. In altre parole agli occhi del fanatico il traditore
è chiunque cambi. Triste alternativa quella fra il diventare
un fanatico o un traditore. [...] Penso che il seme del fanatismo
si annidi immancabilmente nella rettitudine inflessibile, piaga
di molti secoli.”
Come vedete, spunti interessanti di riflessione, anche se ovviamente
soluzioni facili per il fanatismo non ce ne sono. Amos Oz suggerisce
due escamotage, buoni trucchi per confondere se stessi e le
proprie certezze. Uno è l'immaginazione, la possibilità
che abbiamo sempre di immaginarci nei panni di un altro: “immaginarci
nel preciso momento in cui sentiamo di avere ragione al cento
per cento. Anche quando si ha ragione al cento per cento, e
l'altro ha torto al cento per cento, anche in quel momento è
utile immaginare l'altro”. Domandiamoci: se fossi
lei, e se fossi lui? La capacità letteraria di immaginare
come la stessa situazione può essere vissuta da un altro,
sposta senz'altro l'attenzione dalla centralità assolutista
del nostro “giusto” modo di vedere.
L'altro escamotage è l'umorismo, che rende tutto più
relativo e quando si può ridere, soprattutto di sé
stessi, è una gran cosa.
Nella terza lezione, Israele e Palestina: fra diritto e diritto,
si entra nel vivo di una situazione difficile e dolorosa, dall'autore
conosciuta in prima persona, e della quale parla non cercando
di portare la ragione da una delle due parti, ma sottolineando
il profondo dolore di entrambe. Sicuramente un modo diverso
di guardare a quella realtà rispetto ai soliti schieramenti
pro o contro.
Amos Oz usa una bella immagine per parlare di noi esseri umani
ed è quella di paragonarci a una penisola. “Siamo
tutti penisole,” dice, “per metà attaccati
alla terraferma delle nostre tradizioni, della cultura che ci
ha formati, della lingua di appartenenza, la famiglia, gli amici
[...], per l'altra metà di fronte all'oceano dove abbiamo
bisogno di essere lasciati, soli ad ascoltare il vento.”
È un'immagine congeniale a descrivere il genere umano
nel suo vivere in mezzo tra bisogno di certezze e anelito verso
lo sconosciuto, tranquillità e avventura, nella costante
ricerca del vero significato di una parola difficile quale libertà.
Silvia Papi
 Gatti
non foste
a viver come brutiGatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e
canoscenza! Si può dire sia questo il centro tematico
del prezioso lavoro di Lucilio Santoni (Fusa e parole tra
umanità e gatti, Infinito edizioni, Modena 2014,
pp. 100, € 12,00): la virtù anarchica, ovvero la
nuda passione che libera dai soprusi del potere. A dispetto
del titolo, non si pensi che il volume sia destinato alla ristretta
cerchia degli etologi o dei soli animalisti. Perché è
straordinariamente oltre il limite del gattesco.
È un libro sui gatti, certo, ma al contempo è
una riflessione poetica, letteraria, politica, culturale, sociale,
e quindi più in generale filosofica sulla contemporaneità,
sui tic dell'uomo, sulle sue miserie, piccinerie, debolezze.
La scelta dei gatti come protagonisti delle tredici narrazioni
è stata dettata all'autore – oltre dall'amore per
questi animali – anche dalla caratteristica principale
del felino, che vive libero dai condizionamenti della modernità
e dalle pressioni antropiche. «Io sono anarchico, sì
– è l'affermazione di Henri Cartier-Bresson riportata
in esergo – Perché sono vivo. La vita è
una provocazione... Io sono contro chi detiene il potere, con
tutto ciò che il potere comporta. Un gatto sa cos'è
l'anarchia. Chiedetelo a un gatto. Lui lo sa. Lui è contro
la disciplina e l'autorità. Un cane è addestrato
a obbedire. Il gatto no. Il gatto è portatore di caos».
Il volume si compone di racconti, lettere e poesie attraverso
cui Santoni, con una maestria davvero singolare, riesce a parlare
degli ultimi senza cedere a sentimentalismi pietosi. Questo
libro punta a «gettare un sasso non puramente teorico
nello stagno dei diritti dei più deboli» (p. 12).
E fra i più deboli troviamo i matti,
i bambini, la natura
violentata in nome del profitto, i disoccupati che vengono costantemente
oltraggiati dalla cultura dominante. Proprio su quest'ultimo
tema si sofferma Santoni nel momento in cui immagina un dialogo
fra due gatte anziane che parlano del «biondo»,
un gattino giovane e bello, che tuttavia a loro dire «vive
fra le nuvole e non pensa a guadagnarsi la vita in modo dignitoso,
come tutti. Non lavora. Non s'impegna. È buono solo a
filosofeggiare a vuoto» (p. 49). La riflessione, il pensiero,
l'arte, l'otium vengono banditi dall'orizzonte economico
contemporaneo, pronto solo a riconoscere l'importanza del lavoro
produttivo. E a ciò Santoni si ribella, inventa un codice
valoriale alternativo, rivoluzionario, e risponde infine al
dominio dell'economia modulando a piacere la metafora biblica
della creazione. «Il Gran Gatto Eterno dice: Nascete tutti
nell'erba e ognuno di voi ha i propri difetti. Nel mio regno
valgono di più quelli che giocano, vivono e si divertono,
degli altri che passano la vita a lavorare. Dovete essere il
sale e il lievito del mondo. I fiori del prato e la corteccia
degli alberi» (p. 49).
Santoni pensa in grande. Esprime una raffinata maestria nel
dipingere con un linguaggio asciutto l'utopia, il sogno, la
rivoluzione. Sin dalle primissime pagine del suo lavoro, emerge
con forza l'intento di prendere le distanze dalla cultura violenta
della contemporaneità tecnologico-capitalista. Oggi l'élite
al potere organizza, dispone, parla una lingua aspra e orienta
la quotidianità in un senso del tutto opposto alle parole
del Gran Gatto Eterno. E quel parlare dispotico che emerge dal
pensiero masticato dagli obesi del nostro mondo, dal mainstream
del tempo contemporaneo, è vuoto di sentimenti e carico
d'odio, d'indifferenza, di dolore. E Lucilio Santoni lo mette
molto bene in luce nel momento in cui scrive: «tutto l'Occidente
parla, e anche l'Oriente. Prima dell'orrore finale tutti parlano.
Si parla per prolungare all'infinito l'indifferenza letale.
Si parla per dar sfogo alle nevrosi, perché solo quelle
aprono minimi spiragli di comunicazione con l'altro. Si parla
per giustificare i crimini quotidiani e, soprattutto, per esorcizzare
il suicidio collettivo» (p. 61).
I gatti, invece, non parlano, non esercitano la violenza volontaria
e deliberata sugli altri, ma scintillano emissioni sonore talvolta
lievi, talaltra intense che chiamiamo fusa. E le fusa, spiega
Santoni con una tensione poetica che avvolge la prosa, «non
dicono nulla, ma permettono a chi le produce di prendersi cura
del sole che nasce e che muore, dei gattini che crescono, del
silenzio, della fragilità, della dolcezza. Di accettare
la pioggia quando cade. Di accompagnare il sonno quando viene.
Vibrano nella sofferenza e nella gioia. Forse favoriscono la
capacità di ammirare la bellezza e forse di ringraziare
per tutto questo» (p. 63).
Per cogliere a fondo il senso di questo libro è necessario
staccarsi dal pensiero comune e lasciarsi cullare dalla sonorità
poetica che emerge dalla lettura solitaria. Sì, solitaria
come solitari sono i gatti. D'altronde non c'è altra
via d'uscita alla barbarie che cercare di incarnare in se stessi
la rivoluzione che si vuol concretizzare nel mondo. Il singolo
salva se stesso: Santoni è qui come il miglior Michelstaedter
de La persuasone e la Rettorica: «Non c'è
cosa fatta – scrive Michelstaedter – non c'è
via preparata, non c'è modo o lavoro finito pel quale
tu possa giungere alla vita, non ci sono parole che ti possano
dare la vita: perché la vita è proprio nel crear
tutto da sé, nel non adattarsi a nessuna via: la lingua
non c'è ma devi crearla, devi crear il modo, devi crear
ogni cosa: per aver tua la tua vita. – I primi Cristiani
facevano il segno del pesce e si credevano salvi; avessero fatto
più pesci e sarebbero stati salvi davvero, ché
in ciò avrebbero riconosciuto che Cristo ha salvato se
stesso poiché dalla sua vita mortale ha saputo creare
il dio: l'individuo; ma che nessuno è salvato da lui
che non segua la sua vita: ma seguire non è imitare,
mettersi col proprio qualunque valore nei modi nelle parole
della via della persuasione, colla speranza d'aver in quello
la verità. Si duo idem faciunt non est idem»
(C. Michelstaedter, La persuasione e la rettorica, Adelphi,
Milano 2011, pp. 103-104). E sulla stessa scia si attesta la
riflessione di Siddharta: «Questo è il motivo per
cui continuo la mia peregrinazione: non per cercare un'altra
e migliore dottrina, poiché lo so, che non ve n'è
alcuna, ma per abbandonare tutte le dottrine e tutti i maestri
e raggiungere da solo la mia meta o morire. [...]. Se io diventassi
ora uno dei tuoi discepoli, [...], mi avverrebbe – temo
– che solo in apparenza, solo illusoriamente il mio Io
giungerebbe alla quiete e si estinguerebbe, ma, in realtà,
esso continuerebbe a vivere e a ingigantirsi, poiché
lo materierei della dottrina, della mia devozione e del mio
amore per te, della comunità con i monaci!» (H.
Hesse, Siddharta, in Id., Romanzi, Mondadori,
Milano 1994, p. 689).
Il gatto salva se stesso quando coglie istintivamente la sua
singolarità e al contempo la poliedricità della
vita. E nel far ciò, il gatto Camillo «capì
allora che in fondo all'ululato del gattone nero, così
come in quello di tutti i gatti del mondo, c'è sì
il richiamo d'amore, ma c'è anche il lamento per ciò
che è perduto per sempre. C'è la voce dell'accoppiamento
e anche quella della separazione. C'è la vita e c'è
la morte» (p. 55). Ecco all'improvviso emergere un altro
concetto bandito dalla cultura contemporanea: la morte. Morte
descritta con sapiente maestria durante l'incontro fra il bipede
e il gatto-angelico con le ali. La morte è naturale,
il gatto lo sa: sono invece gli uomini spesso a dimenticarlo.
Così come dimenticano il limite in cui sono immersi –
è appunto questa la ragione del nascondimento della morte,
l'unico limite che non si lascia respingere – confondono
il fare bene col fare comunque, e all'orizzonte non resta che
la desolazione alla quale solo i gatti sanno sottrarsi. «La
marea durò per tutta la notte – scrive Santoni
– al mattino, le acque si calmarono e si ritirarono, lentamente
e in silenzio. Il mare salato aveva lasciato spazio a un mare
di desolazione. / Sulla cima dell'edificio più alto erano
radunati i gatti della città. Contemplavano, con un nodo
alla gola, l'immensa opera di distruzione operata dall'uomo»
(p. 69).
Tutta l'opera è sorretta da un tono politico e spirituale
che si concentra appieno nella poesia Preghiera del randagio
crocifisso fra i grattacieli (pp. 91-94). È quello
lo spazio in cui l'autore oltre a ribadire la sua critica alla
razionalità urbanistica contemporanea («Non sanno.
[...] perché distruggono paesaggi») e alla tragica
indifferenza dell'uomo nei confronti della natura («Se
si avvicinano a un albero è solo per pisciare. / Sono
capaci di tutti / pur di non ascoltarsi, / pur di non rimanere
da soli»), chiude le sue riflessioni con un invito che
si staglia all'incrocio fra l'approccio politico anarchico e
il cristianesimo: «Hanno distrutto ciò che incontravano,
/ hanno fatto piazza pulita della poesia. / Sono ferocemente
crudeli, / sono crudelmente stupidi, / ma sono innocenti. /
Bisogna perdonarli» (p. 94). Poi una breve pausa che spalanca
l'orizzonte alla tensione evangelica: «Stasera sarai con
me in un luogo infinitamente dolce» (p. 94), sibila il
gatto randagio crocifisso fra i grattacieli.
Alessandro Pertosa
 Persecuzioni
contro i rom durante il fascismo
(ma anche oggi...)La recente pubblicazione del libro Il Porrajmos in Italia.
La persecuzione di rom e sinti durante il fascismo (Ed.
Emil, Bologna 2013, pp. 110, prezzo non specificato, http://www.ilibridiemil.it/images/Image/Copertine_Emil/2013/2013_26_8Porrajmos.pdf),
a cura di Luca Bravi e Matteo Bassoli, uscito contestualmente
alla creazione del primo museo virtuale dedicato al Porrajmos
in Italia (www.porrajmos.it),
offre la possibilità di tornare su uno degli aspetti
più scomodi della storia italiana, ossia quello della
responsabilità non solo del regime fascista, ma di gran
parte della comunità nazionale, nella persecuzione, nell'internamento
concentrazionario e nello sterminio di rom e sinti durante gli
anni del regime mussoliniano, compresa l'appendice collaborazionista
di Salò (così come documentato nel sito: www.campifascisti.it).
Un capitolo che, dopo essere stato per decenni eluso ed escluso
dalla memoria collettiva “ufficiale”, ora si cerca
di relegare in un passato lontano e irripetibile, quando invece
riaffiora con inquietante frequenza della quotidiana cronaca
istituzionale, segnata da misure razziste e liberticide come
quelle emanate ultimamente in Veneto e a Firenze contro i mendicanti,
con insistito riferimento a rom e sinti, su iniziativa di sindaci
democratici e “di sinistra” che sembrano voler fare
concorrenza ai colleghi “sceriffi” leghisti o di
destra.
Paradossalmente, sovente si tratta delle stesse amministrazioni
che ogni anno commemorano il Giorno della Memoria e inaugurano
lapidi in ricordo delle vittime del nazismo, magari patrocinando
convegni sull'argomento, ma che poi in nome della cosiddetta
legalità mandano le ruspe a demolire i miseri insediamenti
dei “nomadi” oppure incaricano le forze dell'ordine
di dare la caccia agli “zingari”.
Eppure, come viene opportunamente precisato nel libro, «Il
Porrajmos è stato infatti una storia anche italiana,
durante il periodo della dittatura fascista, ma gli eventi che
lo hanno caratterizzato sono rimasti misconosciuti. In Italia
non sorsero campi di sterminio e non ci fu un Auschwitz-Birkenau
a simboleggiare il progetto di distruzione fisica attuato rispetto
a popolazioni europee definite come razzialmente inferiori,
ma Auschwitz non può svolgere una funzione autoassolutoria
per quanto l'Italia fascista mise in atto in ambito di legislazione
dichiaratamente razzista o legata al progetto di eliminazione
di posizioni o voci o presenze dissonanti rispetto a quanto
previsto dal regime. Se Auschwitz ha avuto in Italia una funzione
autoassolutoria rispetto alla Shoah attuata nel nostro Paese,
nei confronti del Porrajmos la riflessione non è in pratica
neppure avviata».
Evidentemente, troppe sono le analogie e le assonanze –
anche semantiche – tra le persecuzioni di ieri e di oggi:
meglio quindi glissare e liberarsi da eventuali sensi di colpa,
nascondendosi dietro presunte emergenze e senza assumersi la
responsabilità delle vessazioni legali di cui sono oggetto
persone, per lo più di cittadinanza italiana, “colpevoli”
di appartenere ad una minoranza linguistica non-riconosciuta,
quale quella dei rom e dei sinti, anche se presente in Italia
appena dal... Quattrocento!
Questo paradosso era stato ben evidenziato nel 1999 dal compianto
Antonio Tabucchi (Gli Zingari e il Rinascimento) e continua
a riproporsi proprio a Firenze dove, ultimamente, sono state
attuate misure di polizia che somigliano a veri e propri bandi
quattrocenteschi ma ricordano pure le leggi emanate tra gli
anni Venti e Trenta in Germania «per la protezione della
popolazione dalle nocività di zingari, vagabondi e oziosi»,
oggi contro la presenza in stazione – e in particolare
presso le piattaforme dell'Alta Velocità – di quanti
chiedono l'elemosina, specie se «di etnia rom»,
sostenute dal pro-sindaco renziano con gli abusati richiami
alla sicurezza e alla legalità.
Le stesse dichiarazioni alla stampa del prefetto di Firenze,
Varratta, sembrano ricalcare, anche nel lessico, certe circolari
ministeriali fasciste del 1928 contro “zingari”
per prevenire «il vagabondaggio e l'oziosità. Che
fomentano ed agevolano l'accattonaggio e la perpetrazione di
vari reati».
Infatti la persecuzione di rom e sinti da parte del fascismo,
inizialmente, non venne formalmente motivata da ragioni razziali,
tanto che Renato Semizzi (professore di Medicina sociale a Trieste
e firmatario dell'antiscientifico Manifesto della Razza)
ipotizzò semmai un inquinamento della razza italica «dal
punto di vista psichico-morale» in quanto lo stesso popolo
“zingaro” era andato soggetto a indefinite «mutazioni
di psicologia razziale». D'altronde, anche allora, il
razzismo di Stato poteva contare su «il disprezzo e la
diffidenza del popolo» che rappresentavano già
«un ottimo elemento di difesa» e «una ben
definita barriera di repulsione matrimoniale» nei confronti
di rom e sinti.
Tale indirizzo iniziò comunque a scivolare sul piano
biologico ben prima delle Leggi razziali del 1938, grazie al
contributo che in tal senso fornì Guido Landra, autentico
seguace filonazista e, con queste premesse, come viene puntualmente
riportato nel libro, le progressive misure persecutorie realizzarono
una vera e propria escalation, peraltro nell'indifferenza pressoché
totale: «tra 1922 e 1938 i respingimenti e l'allontanamento
forzato di rom e sinti stranieri (o presunti tali) dal territorio
italiano; dal 1938 al 1940 gli ordini di pulizia etnica ai danni
di tutti i sinti e rom presenti nelle regioni di confine ed
il loro confino in Sardegna; dal 1940 al 1943 l'ordine di arresto
di tutti i rom e sinti (di cittadinanza straniera o italiana)
e la creazione di specifici campi di concentramento fascisti
a loro riservati sul territorio italiano; dal 1943 al 1945 l'arresto
di sinti e rom (di cittadinanza straniera o italiana) da parte
della Repubblica Sociale Italiana e la deportazione verso i
campi di concentramento nazisti».
Un doveroso pro-memoria, contro le facili autoassoluzioni per
il passato, ma soprattutto per il presente.
Osservatorio anti-discriminazioni
 Per
capire
la flessibilità“La credenza che una maggior flessibilità del
lavoro, attuata a mezzo di contratti sempre più brevi
e insicuri, faccia aumentare o abbia mai fatto aumentare l'occupazione,
equivale quanto a fondamenta empiriche alla credenza che la
terra è piatta”. In queste righe è racchiuso
l'intento del libro di Luciano Gallino Vite rinviate. Lo
scandalo del lavoro precario (Edizioni Laterza, Roma, 2014,
pp. 136, € 5,90) che si propone di analizzare le conseguenze
della flessibilità all'interno del mercato del lavoro,
sfatando il mito della sua incondizionata positività.
Non fermandosi alla semplice confutazione della tesi che indica
le misure di flexibility come responsabili dell'aumento
dell'occupazione, Gallino prende in esame e spiega i concetti
di “società flessibile” e “lavoro flessibile”
e pone l'accento sullo scollamento tra teoria e pratica, tra
l'idealtipo e la prassi; la conquista di indipendenza e autonomia
in campo lavorativo, la “mobilità incessante da
un processo [produttivo] all'altro” e la possibilità
di essere inseriti in un flusso benefico caratterizzato da “formazione
permanente” sono aspetti positivi che sembrano in realtà
passare in secondo piano, oscurati dalle conseguenze socio-economiche
della precarietà.
L'autore sottolinea come la creazione di una collettività
di lavoratori “che tende a diventare omogenea verso l'alto
in termini di reddito”, cardine delle motivazioni di una
richiesta di maggior flessibilità all'interno del mercato
del lavoro, sia di fatto una chimera. La realtà è
infatti molto diversa e gli esiti che si hanno, lungi dall'aver
contribuito al miglioramento della qualità di vita dei
lavoratori, hanno di fatto generato un aumento delle diseguaglianze
socio-economiche e una polarizzazione dei redditi.
Gallino esplora le conseguenze, per i singoli lavoratori e per
la società, di una vita all'insegna della flessibilità:
insicurezza, incapacità di progettare un futuro, mancanza
di stabilità, ripercussioni psicologiche per l'individuo,
ma anche gravi implicazioni sociali sono le principali conseguenze.
A causa della sempre maggiore instabilità in ambito lavorativo,
il tempo per la socializzazione, come quello per la ritualità,
sono andati perduti; il grado di coesione sociale risulta, per
questi motivi, irreparabilmente compromesso. Per l'autore, l'aver
inciso negativamente sul grado di integrazione sociale, base
della “convivenza pacifica” e della “ragionevole
armonia tra differenti settori e livelli della società”
potrebbe da solo considerarsi un valido motivo per rivalutare
i costi della ricerca di una maggior flessibilità. A
tal proposito, Gallino afferma che “dobbiamo saper distinguere
i costi umani [...] dai loro eventuali benefici, ed esigere
che i primi non vengano – come invece accade – ignorati
o sottovalutati in nome dei secondi”.
L'autore prende in esame le istanze di alcuni studiosi e politici
che propongono percorsi ispirati a paesi europei, in grado di
favorire l'aumento della flessibilità all'interno mercato
del lavoro italiano, e sottolinea come al netto dei costi che
l'Italia dovrebbe sostenere per inserire al proprio interno
tutte le caratteristiche di un paese preso a “modello”,
gli aspetti sociali negativi superano quelli positivi.
Diverse sono state in Italia le disposizioni legislative che
hanno tentato di influenzare positivamente il mercato del lavoro,
ma che non sono riuscite nell'intento. Gallino è convinto
che il vero male da estirpare sia il presente modello produttivo,
unico colpevole della non rosea condizione del mercato del lavoro.
La soluzione da lui auspicata è quella di una completa
revisione dell'intero sistema; non è infatti attraverso
una maggior flessibilità che si può arrivare a
curare i mali causati da un modello economico “scosso
ormai da una gravissima crisi globale”. È invece
necessaria una presa di coscienza circa la vera causa del problema
della precarietà che affligge milioni di lavoratori nel
mondo e che sembra destinato a non arrestarsi. È il momento
di mettere fine alla prassi di arginare il problema tramite
“artefatti legislativi” e di volgere la nostra analisi
verso il modello economico produttivo, caratterizzato dalla
finanziarizzazione, causa prima dei mali che da molti anni si
tenta invano di estirpare.
Per l'autore è bene comprendere che la richiesta di una
sempre maggior flessibilità è data dall'importanza
acquisita dalla finanza a scapito dell'economia reale: “il
lavoro non ha più, o non può più pretendere,
di avere un luogo: è perennemente in transito. Come il
capitale. La flessibilità del lavoro, in altre parole
è una filiazione diretta della finanziarizzazione dell'intera
economia”.
Quello scritto da Gallino è un libro pensato per accompagnare
il lettore verso la comprensione del tema della flessibilità.
Molto utile ai fini dell'intendimento è la parte dedicata
a “Il lavoro in cifre”, entro la quale vengono forniti
dati Istat circa “la disoccupazione in Europa”,
“tassi di occupazione in Italia”, “tasso di
disoccupazione giovanile” e molte altre variabili riguardanti
il mercato del lavoro italiano ed europeo. Altrettanto utile
si rivela la “Cronologia dei diritti perduti” a
cura di Roberto Mania che fornisce una breve sintesi dell'evoluzione
dei diritti inerenti al lavoro dal 1970, anno dell'approvazione
dello Statuto dei diritti dei lavoratori, fino ad arrivare al
2014. Si noti anche la presenza di un capitolo dedicato alla
spiegazione di alcune delle parole chiave fondamentali, quali
“ammortizzatori sociali”, “articolo 18”,
“cassa integrazione”, necessari per comprendere
pienamente e fino in fondo l'argomento.
Carlotta Pedrazzini
 Massimo
Varengo, Andrea Papi
Due conferenze, due opuscoliSono disponibili, a cura delle Edizioni Bruno Alpini, due
nuovi opuscoli: Massimo Varengo, Utopia e controrivoluzione
nel decennio 1968-1977, trascrizione della conversazione
tenuta a Imola all' Archivio Storico della FAI sabato 26 ottobre
2013, pp. 31 e Andrea Papi, Il pensiero anarchico
contemporaneo, trascrizione della conversazione tenuta
a Imola all' Archivio Storico della FAI sabato 9 novembre 2013,
pp. 26. Per richieste bruno.alpini@libero.it,
offerta libera e responsabile, spese di spedizione euro 2,00.
Ne pubblichiamo qui di seguito le due rispettive introduzioni
di Massimo Ortalli, nostro collaboratore nonchè militante
dei Gruppi Anarchici Imolesi che hanno promosso le due coversazioni.
Ma quali “anni di piombo”?
Non è un decennio soltanto quello che viene così
ampiamente riportato alla memoria in queste pagine, perché
quando si parla di Sessantotto bisogna necessariamente riandare
agli anni precedenti che ne hanno permesso l'esplosione, così
come non si può ritenere concluso con il Settantasette
un ciclo “davvero rivoluzionario” che invece continuerà,
con drammatica intensità, per altri cinque, sei anni
ancora. Ecco perché i fatti, le storie, le vicende di
cui Varengo racconta con la partecipazione e la sicurezza di
chi quegli anni li ha conosciuti e interpretati, riguardano
non un decennio, ma piuttosto tutti gli anni Sessanta e Settanta.
Un ventennio, dunque, ma quanto differente, quanto ricco e a
tratti entusiasmante, a differenza dei ben altri “ventenni”
che hanno offeso e ancora offendono questo paese!
La storia non procede a sbalzi, e le apparenti cesure tra un'epoca
e l'altra non sono altro che le dirette conseguenze di premesse
ineludibili. Le tensioni sociali, i moti esistenziali, le fratture
generazionali, non sono fenomeni tra loro indipendenti e a compartimenti
stagni, ma diventano un miscuglio vitale. Un miscuglio che esprime
questa sua vitalità producendo profonde e irreversibili
trasformazioni necessitate dalla radicalità delle contraddizioni
da cui ha preso origine. Tutto è concatenato, tutto può
trasformarsi e procedere, purché ci sia una nuova generazione
di soggetti sociali in grado di comprendere, di fare proprie
e modellare queste contraddizioni, creando un inarrestabile
processo dialettico di mutamento.
E così è stato in quegli anni. E così in
queste pagine ricche di riflessioni, di considerazioni, di spunti
per una comprensione più ampia delle dinamiche che li
hanno contraddistinti, riaffiorano alla memoria, e a una nuova
consapevolezza, gli avvenimenti che hanno segnato un'epoca.
Alla memoria per chi quegli anni ha avuto la fortuna di viverli,
alla consapevolezza per chi, di quegli anni, ha sempre solo
sentito parlare come di un buio periodo di violenza ed estremismo.
La criminalizzazione degli anni Settanta, così stupidamente
definiti “anni di piombo”, è una delle offese
più grosse che si possano fare alla comune intelligenza
e alla verità. Un'offesa che il Potere, allora minacciato
e messo alla berlina dalla creatività e dall'impegno
di un'intera generazione, oggi lancia come meschina ritorsione
per la sostanziale delegittimazione di cui fu “vittima”.
Voler ridurre la ricchezza di un'epoca, la gioia esistenziale
di milioni di giovani, la loro capacità di comprendere
e la loro volontà di modificare la realtà, a un
semplice fatto di lotta armata non è altro che la spia
della paura che i piani alti della società patirono di
fronte all'attacco che fu loro mosso da quelli che piani bassi
non volevano più essere. Da quelli che pensavano che
i “piani” dovessero essere tutti allo stesso livello.
Non essendo riuscito a fermare sul nascere, con la strage di
Piazza Fontana, la combattività di studenti e operai
finalmente decisi a riappropriarsi di tutto quello che era stato
loro sottratto, il Potere, il Sistema come allora veniva chiamato,
utilizzò strumentalmente le inevitabili contraddizioni
e debolezze che albergavano all'interno dei movimenti. E le
fughe in avanti dei settori meno disposti a una riflessione
non condizionata da un'ideologia a compartimenti stagni, divennero
il cavallo di troia con il quale fu possibile scardinare e scompaginare
un intero movimento. Un movimento all'interno del quale la componente
anarchica e libertaria, la più sensibile alle esigenze
esistenziali, e la più attenta alle insidie dello Stato,
non riuscì, nonostante il suo impegno lucido e coerente,
ad arginare le derive autoritarie e sostanzialmente autodistruttive,
che, lentamente ma inesorabilmente, avrebbero portato alla fine
ingloriosa di questo “ventennio”.
Si diceva che la storia fosse maestra di vita, e io ne sono
ancora convinto. Ben vengano, dunque, riflessioni e testimonianze
come quelle raccolte in queste belle pagine, perché sono
queste gli strumenti più idonei per capire il presente
e prefigurare il futuro.

Ottimismo della volontà e della ragione
Tensione etica, passione esistenziale, pensiero eterodosso,
e ferma convinzione nei propri postulati teorici, ecco ciò
che emerge da queste pagine che raccolgono le conversazioni
pubbliche recentemente tenute da Andrea Papi. Stimoli incalzanti
per cercare di comprendere meglio il presente in una prospettiva
di trasformazione.
Abituati a considerare le categorie del secolo passato come
immutabili e intoccabili, è un suggerimento forte quello
che ci danno queste pagine, un suggerimento coerente con lo
spirito sperimentatore dell'anarchismo: abbandonarle, una volta
per tutte, per iniziare lucidamente,con nuove griglie interpretative,
un'analisi più attinente alle nuove realtà della
società del duemila. Classe operaia, proletariato, capitalismo
industriale, lotta di classe, sfruttamento materiale, sembrano
essere, ormai, termini non più idonei per affrontare
una realtà, in radicale trasformazione, che sta stravolgendo
con l'impeto di un rullo compressore, le certezze sedimentate
di un pensiero critico incapace di evoluzione.
L'emergere dei nuovi strumenti con i quali il capitale, ormai
soprattutto capitale finanziario, sta esasperando il divario
fra chi ha e chi non ha o ha troppo poco, l'affermarsi di una
logica speculativa talmente concentrata sulla propria abilità
nel creare nuovi profitti da essere insensibile alle conseguenze
devastanti del suo operare, tutto questo richiede, da parte
nostra, l'abbandono definitivo di una visione “ottocentesca”
tanto del conflitto sociale, quanto dei mezzi tradizionalmente
impiegati per risolvere in una prospettiva libertaria questo
stesso conflitto. L'insurrezione, la violenza di piazza, il
confronto a muso duro contro una realtà che da questo
tipo di confronto uscirà sempre vincente, sembrerebbero,
ormai, strumenti inefficaci se non addirittura controproducenti,
strumenti inidonei e “datati” che proprio per questa
loro presunta inadeguatezza, rendono ancora più forte
e sedimentata quella realtà che si vorrebbe, se non rivoluzionare,
almeno trasformare. E allora che fare? Come agire per non abbandonare
definitivamente il campo? Come continuare la necessaria e sacrosanta
lotta contro un capitalismo che, nelle sue trasformazioni, è
diventato ancora più feroce e oppressivo?
Parlavamo in precedenza di tensione etica e di passione esistenziale,
ed è proprio grazie a queste “altre” categorie
che vengono prospettate nuovi percorsi per il cambiamento. Percorsi
che partono da una mutata consapevolezza sul ruolo e la funzione
del “pensiero anarchico contemporaneo”, un pensiero
meno legato al movimento militante ma al tempo stesso sempre
più pervasivo nel corpo sociale. Un pensiero che, sfruttando
a fondo tutte le potenzialità che nascono dal bisogno
di libertà e dal desiderio di uguaglianza, si propone
come lo strumento più efficace per scardinare i pilastri
sui quali poggia il sistema dello sfruttamento e della disuguaglianza.
Ed è nella vasta e plurale letteratura teorica che anarchismo
e libertarismo hanno prodotto nel tempo, che Papi individua
le proposte più convincenti, e soprattutto più
attuali per continuare quella lotta che, nella varietà
degli strumenti, nella diversità delle condizioni storiche,
non ha mai cessato di essere un impegno morale e un bisogno
vitale degli anarchici. Riprendendo la felice metafora di Colin
Ward, di un anarchismo simile ai semi sotto la neve, pronti
a germogliare in seguito al disgelo, Papi sembra indicarci che
accanto all'ottimismo della volontà debba esserci anche
l'ottimismo della ragione.
Massimo Ortalli
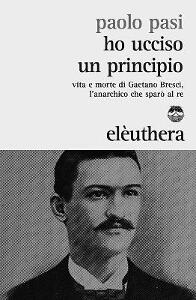 Un
re, un anarchico,
le ginestreMolto si è scritto e parlato della vicenda di Gaetano
Bresci, ma la prospettiva del libro di Paolo Pasi (Ho ucciso
un principio, vita e morte di Gaetano Bresci, l'anarchico che
sparò al re, elèuthera, Milano 2014, pp. 175,
€ 14,00) è nuova. Conduce nei luoghi dell'anima
estituendoci gli ultimi frammenti di vita dell'“anarchico
pericoloso”, l'uccisore del “Re Buono”.
Le fini illustrazioni in bianco e nero, dal tratto chiaro e
deciso di Fabio Santin supportano una narrazione viva, che ha
il pregio di riuscire a insinuarsi nelle pieghe dell'esistenza
sofferta, tormentata, controversa, ma soprattutto umana del
bravo tessitore di Prato.
Lo scrittore dà voce a dubbi, domande, colora di sfumature
e fa vivere il paesaggio interiore del damerino venuto dall'America
con una rivoltella nella valigia, calibro 38, a cinque colpi.
Popolato da grovigli di pensieri e ricordi, le condizioni dell'animo
sembrano riflettersi in modo speculare nel paesaggio fisico
che lo circonda.
Così veniamo condotti in una Milano arrancante nell'afa
umida dell'estate del 1900 e nel viaggio lento in treno verso
Monza. Seduto in compagnia di Luigi Granotti, il Biondino, Bresci
ripercorrere la propria vita stampata in un album di fotografie.
Attraversiamo la campagna costellata da opifici alla quale si
sovrappone l'immagine del Fabbricone nella campagna di Caiano,
tra i frutteti, con Gaetano bambino. Un'infanzia negata, la
sua, uguale a quella di molti altri bambini, scandita troppo
presto dal frastuono di telai, orari insostenibili, rigida disciplina,
e la domenica passata a scuola di “Arti e mestieri”.
Alla negazione della possibilità di sognare si impone
il ricordo della traversata oltreoceano per guadagnarsi il diritto
all'esistenza, mentre una donna resta sola, a casa, in attesa
di un figlio da lui.
Giungiamo alla pensioncina monzese di via Cairoli, al civico
4. Sdraiato sul letto in una camera umida, nella sua mente si
affastellano convulsi il petto del “Re Mitraglia”
costellato da onorificenze, le coreografie dei suoi ingressi
trionfali. Non riesce più a reggere sulla sua pelle il
peso dei seimila soldati morti sotto il sole di Adua. E poi,
come è possibile rimuovere l' indelebile umiliazione
da lui subita durante il domicilio coatto? Un anno su un'isola
lontana, Pantelleria, per aver preso le difese di un garzone
di macelleria colpevole di non aver rispettato l'orario di chiusura
del negozio. Una resistenza fatta di lavoro ai telai dei prigionieri
e di letture. La grazia ottenuta perché si voleva attenuare
l'atrocità della sconfitta del 1896.
Come materializzate, vediamo nella sua mente le mani protese
delle vittime anonime prese a cannonate perché chiedevano
pane, e le medaglie al generale Bava Beccaris per aver saputo
fronteggiare la folla. Sentiamo l'aria di Milano impastata ancora
di polvere da sparo e di sangue.
Riviviamo l'ultimo giorno di vita da re di Umberto, gli ultimi
dispacci da leggere, forse l'eccitazione per un appuntamento
con una donna, dopo le incombenze che si concluderanno a tarda
sera con la manifestazione sportiva. Partecipiamo alle ultime
ore spasmodiche del regicida prima dell'attentato, seduto solo,
al tavolo di una latteria a ingoiare gelati.
Ascoltiamo i pensieri che lo avranno assillato mentre s'incamminava
in una sorta di sospensione del tempo verso il campo sportivo,
vicino a Villa Reale. Riuscirà il popolo a riprendersi
la propria libertà? E il diritto all'esistenza?
Pasi ci riporta sulla scena, fa rivivere in diretta l'attentato,
la mano che non trema, i colpi. Tre andati a segno, il quarto
è come se il regicida lo avesse rivolto contro se stesso.
Sono le ore 22.30 del 29 luglio 1900. La carrozza ferza lasciandosi
dietro l'odore degli spari. Brandelli della camicia bianca di
Bresci strappata vola via, insieme ai polsini, all'orologio
d'oro comprato con duro lavoro.
Sulla notte del giorno più lungo dell'estate monzese
il temporale scuote l'aria e fa fuggire tutti, e noi sentiamo
i tuoni che percuotono i vetri della caserma e i muri della
Villa Reale. Per Bresci si invoca la tortura, mentre il suo
nome rimbalza fino in America, a Paterson dove ha lavorato,
a West Hoboken, dove ha una moglie, Sophie, una figlia, e un'altra
in arrivo, ma lui non lo sa. Il vissuto tormentato della coscienza
che accompagna le azioni restituisce umanità al dissacratore
della “poesia di Casa Savoia” così oltraggiato,
vilipeso, linciato, torturato, controllato e poi cancellato
dallo Stato. Niente più pena di morte, per il codice
penale introdotto da Zanardelli. Assistiamo così a una
morte che arriva lentamente, pregustata dall'agonia del tempo
che conduce alla follia autodistruttiva.
Troviamo Bresci nella caserma di Monza, con il torace fasciato,
un occhio tumefatto, la stanza spoglia, i segni delle percosse.
Alla trappola dell'isolamento nel buio della cella, egli può
rispondere solo con un esteriore distacco. Impone ai ricordi
di Sophie, della piccola Madeleine, del fratello Lorenzo, della
sorella Teresa – quelli più dolorosi e sanguinanti
– di farsi da parte. Si lascia permeare solo da immagini
trasfigurate dal sogno: Parigi, e una donna, Emma, nei suoi
occhi il conforto che può dare, per un istante, la sospensione
del tempo.
Un mese dopo l'attentato, siamo introdotti nell'aula del processo,
al palazzo di giustizia a piazza Beccaria . Dopo il rifiuto
alla difesa da parte del socialista Filippo Turati, l'accettazione
dell'avvocato napoletano Francesco Saverio Merlino. Infiammato
da ideali libertari durante gli anni giovanili, stimato dagli
anarchici, spesso ha difeso ribelli dalle tasche vuote senza
pretendere denaro. Ma un altro difensore, imposto d'ufficio,
cercherà i complici. Non può aver agito da solo:
“anziché un prodotto individuale, è un fatto
dell'anarchia”.
Bresci si presenta in manette con il volto scarno e stordito
dalla stanchezza per essere stato prelevato dalla cella alle
quattro del mattino. Ma la sua è un' elegante dignità,
la bella cravatta rossa, la camicia con i quattro bottoni e
il fazzoletto bianco. Si preannuncia una giornata piovosa, cupa,
afosa da togliere il respiro e nell'aula sentiamo l'odore della
gente che si accalca per scagliarsi contro “l'incisore
di proiettili”. E poi è la volta dei testimoni,
le loro facce, le voci. Teresa Brugnoli di Bologna, i compagni
di scuola, l'affittacamere di Milano, il datore di lavoro e
i compagni operai. “Ho agito da solo” ripeterà
al processo. “L'ho fatto per vendicare le vittime pallide
e sanguinanti di Milano”. E la sentenza della corte: “[...]
ergastolo e i primi sette anni di segregazione cellulare”.
È il quarto colpo andato a segno. Bresci rifiuterà
qualsiasi ricorso in cassazione. Fine pena: mai!
Nella cella del carcere milanese di San Vittore, l'annientamento
morale, il gelo dell'isolamento, sarà sempre dalla sua
parte. Solo, in compagnia dei pensieri che ingorgano la mente.
Silenzio. Buio. Sentiamo risuonare ora lo sferragliare dei chiavistelli
ora la voce sferzante delle guardie.
Poi il trasferimento nel penitenziario borbonico sull'isola
di Santo Stefano, vicino a Ventotene, la “tomba dei vivi”,
come ebbe a definirla Luigi Settembrini. Gli riservano una cella
speciale, separata. Matricola n. 515. Come resisterà
? Il corpo tenuto in vita con esercizi fisici e la mente allenata
con la lingua francese, per sentirne la musicalità e
riaccendere i ricordi dei compagni francesi, di Parigi. E il
gioco in cella. La palla fatta con il tovagliolo rimbalza dal
muro tra sogni d'infanzia e d'America, con Sophie, la bambina,
le recite teatrali, la musica, i balli.
Sulle circostanze della morte dichiarata il 22 maggio 1901,
fatte di troppi omissis ci ritornerà Sandro Pertini trent'anni
dopo, da presidente della Repubblica, sentita la confessione
di una guardia del carcere: una morte programmata da ordini
provenienti dall'alto.
L'anarchico che uccise il principio è sepolto nel piccolo
cimitero del carcere. Una croce di legno riporta il suo nome.
E le ginestre ogni primavera rinascono, testimoni dello spirito
mai sopito degli ideali di libertà.
Davvero un bel libro. Rispettoso, profondo, delicato.
Claudia Piccinelli
 Andarmene?
No,
in fondo qui sto beneLe edizioni anarchiche ticinesi La Baronata pubblicano “Le
fate del focolare” (Lugano 2014, pp. 48, FrS.. 6,00, €
4,00, http://www.anarca-bolo.ch/baronata).
Ne riproduciamo l'introduzione (per la precisione: “a
mo' di prefazione”) di Michela Zucca.
Finché sei bambina quasi non te ne accorgi: sei concentrata
a scoprire il mondo. Sì, è vero che a casa, tua
madre fa la serva a tuo padre: ma a te nessuno chiede niente,
se non in occasioni eccezionali. Tu devi rifarti il letto e
tenere in ordine la tua stanza, tuo fratello no perché
si sa che i maschi sono disordinati. Certe volte ti fa lavare
i piatti e a lui no, e sai lui aiuta papà a rimettere
a posto il garage, vuoi mettere?! e tu pensi ma il garage lo
mette a posto una volta l'anno e i piatti si lavano tutti i
giorni ma beh dai, in fin dei conti, è poca cosa.
Poi tuo padre comincia ad insegnare a tuo fratello a tirare
qualche pugno: non sia mai detto che mio figlio le prende e
non sa neanche ridarle indietro. A te no, ma ti immagini, ti
regalano un vestito nuovo, guarda quanto sei carina cerca di
non sporcarti, fare a botte è roba da maschi, devi essere
gentile con la gente, se un altro bambino ti tocca devi dirlo
alla maestra. Tu gliel'hai detto, e lei ti ha risposto che devi
essere comprensiva, sai è un maschio, non farci caso,
crescerà e imparerà come deve comportarsi.
Quando sei a scuola, sembra che ogni cosa vada bene: anzi le
femmine sono più brave, studiano di più, hanno
maggiore proprietà di linguaggio, non fanno casino...
Le insegnanti sono quasi tutte donne, anche se il preside è
un uomo. E quando ci sono le riunioni, le assemblee, le elezioni
dei rappresentanti di classe, sono i ragazzi che parlano. I
ragazzi che si candidano. I ragazzi che vengono eletti. Ma mica
lo proibiscono, a te, di parlare. È che sei tu che preferisci
così.
Chissà perché tua madre si vanta molto delle conquiste
di tuo fratello: di te preferisce dire che sei una brava ragazza,
e che per certe cose c'è ancora tempo. Tuo fratello può
uscire quando vuole, e tu no: ma basta attrezzarsi con un po'
di furbizia, d'altra parte i tempi sono cambiati e un po' di
libertà in più adesso si deve ben concederla...
Poi ti diplomi: e al primo colloquio di lavoro ti chiedono se
sei fidanzata. Ma non sono cazzi miei?, pensi. Il ragazzo non
ce l'hai, non c'è niente di male, glielo dico, poi quando
avrò qualcuno non sono obbligata ad andarglielo a dire...
Tanto qui ci resto solo pochi mesi, è un contratto a
termine... Però trovi solo posti a tempo determinato.
Molti dei tuoi compagni di scuola hanno già un lavoro
fisso. Anche i deficienti.
In ufficio ti chiedono di fare il caffè e di portarlo
al capo. Ai maschi non lo chiedono. Ma sì, in fin dei
conti cosa sarà mai un caffè... In ufficio bisogna
andarci vestite bene. Quello che guadagni non basta per fare
bella figura. Non ti rimane niente per te. Per un uomo è
diverso, quando è pulito è presentabile.
A un certo punto trovi quello giusto, che puoi presentare in
casa: lavoro in regola, buone prospettive, ottima famiglia.
Tua madre è al settimo cielo. I suoi di lui la pensano
diversamente da te: ma non farci caso, fa' finta di niente quando
tuo suocero dice che li rimanderebbe tutti a casa loro e che
adesso non c'è più nessuno che ha voglia di lavorare
– da te continuano a farsi il mazzo – in fin dei
conti ti sposi il figlio non il suocero, e dopo sarà
diverso.
Sul lavoro storcono il naso quando porti i confetti, e ti dicono
vero per adesso non se ne parla, di che cosa? Chiedi tu, ma
di fare un figlio, figuratevi voglio ben godermi un po' la vita
c'è tempo.
Vai a vivere sotto di loro che hanno già preparato l'appartamento,
è una gran bella comodità e così non devi
pagare l'affitto, e se arriva un bimbo ti possono dare una mano...
Così quando arriva, molli l'ufficio nel tripudio generale,
lui riceve un avanzamento e deve sempre stare fuori fino a tardi
e poi sai le cene coi clienti, tu stiri le sue camicie che devono
essere sempre in ordine, cucini mattina mezzogiorno e sera e
nel frattempo ne arriva un altro, tu ingrassi e sei sempre stanca,
la festa devi spadellare per riunire la famiglia e far andare
tutti d'accordo.
Dopo un po' di anni ti accorgi che adesso è lui che non
ti cerca più. Prima lo cacciavi via – avevi altro
a cui pensare, non avevi la testa per questo – poi meno
male che ti lasciava in pace, ma adesso sono mesi che non lo
facciamo proprio. Non è che magari c'è qualcosa
che non va...?! Ha qualcuna...?! Eh già che ce l'ha.
Vent'anni meno di te, lo scopri controllando il suo telefonino,
ma non si vergogna questo porco... Disperata, telefoni a tua
madre. Voglio il divorzio.
Oh cara quanto mi dispiace ma sai pensaci bene... Sono cose
che capitano... Sai che gli uomini non ragionano... Quella là
è proprio una poco di buono... Pensaci bene sai qui la
porta è sempre aperta anche se per il papà sarebbe
un colpo... È anziano ormai e questa sarebbe l'ultima
dopo una vita di sacrifici... Alla fine che cosa te ne frega
anzi meglio... Lui fa la sua parte, tu la tua, pensa a crescere
i tuoi figli... hai la tua casa e le tue cose... Per quanto
ti possa dare di alimenti te lo sogni il tenore di vita che
hai adesso...
E così rimani a casa. D'altra parte dove potresti andare?
Basta sapersi adattare, non è che stai peggio di tante
altre, hai il tuo tran tran e lui non ti fa mancare niente e
quando deve esserci c'è.
Intanto gli anni passano, i suoi diventano vecchi e li devi
guardare tu: non è un lavoro che può fare un uomo,
loro non hanno la sensibilità, e poi c'è anche
un patrimonio da salvaguardare non per dire ma la roba serve
sempre, con due figli e allora certe attenzioni bisogna darle...
no, lui deve pensare al lavoro, con questi tempi di crisi non
può mancare... Assolutamente no...
Finalmente sono sepolti i suoceri. Posso avere un minimo di
respiro. I ragazzi sono all'università e lui è
partito per un viaggio: deve ben avere un po' di relax dopo
tutto quello stress. No, io no, sto bene qui, ho le mie cose,
non ho voglia di partire... E questa cos'è?!
Lettera di divorzio
Cara, ti ringrazio per tutti questi anni meravigliosi passati
insieme, e per la tua pazienza... Ho aspettato che i miei non
ci fossero più per non dargli un dispiacere troppo grande,
e che i ragazzi crescessero perché potessero capirmi...
Sai la situazione andava avanti da anni, e non trovavo il coraggio
di dirtelo... ma adesso lei sta aspettando un bambino... D'altronde
tu hai sempre la casa dei tuoi e stai sicura che per i soldi
ci aggiusteremo.
Michela Zucca
 Società
arabe,
la presenza delle donneLa lettura dei sommovimenti arabi da parte di Ivana Trevisani
e Leila Ben Salah in Ferite di parole (Poiesis editrice,
Alberobello 2013, pp. 187, € 16,00) scompagina molti luoghi
comuni e interpretazioni scontate che risultano inadeguati a
cogliere la filigrana simbolica di quegli eventi.
Con linearità di ricerca e spostamento di sguardo, le
autrici restituiscono una testimonianza lucida e determinata
“per entrare nel mondo delle società arabe, dalla
parte delle donne”, come scrive Giuseppe Goffredo in margine
editoriale al libro.
La scelta di campo di Ivana e Leila è quella di stare
agli ambiti dove le donne agiscono e si muovono senza estromettere
l'esistente. La loro massiccia presenza, non solo in senso numerico
ma ampiamente diversificata per età, estrazione sociale,
cultura e religione, nei luoghi della protesta e della lotta
contro le dittature – da Piazza Tahrir ad Avenue Bourghuiba,
dalle strade del Bahrein agli angoli di Misurata, fino ai villaggi
dell'entroterra in cui si è accesa la fiamma della rivolta
– connota la prima ma non la sola novità del panorama
rivoluzionario arabo. Imprevisti contesti di libertà,
orizzonti altri segnati da istanze e intendimenti che il sistema
mediatico occidentale non sa, o non ha voluto, leggere sono
attestati ipso facto in quanto dicono le molte donne
intervistate dalle autrici. Per esempio, dall'entusiasmo gioioso,
né ingenuo né privo di concretezza, di Jalila
che precisa: “Voglio mantenere la mia libertà
d'azione e di critica, per questo non appartengo a nessun partito
né associazione, ma continuo incessantemente nella mia
battaglia per la libertà; o dalla fedeltà
a se stessa e dalla determinazione irriverente a difenderla
di Ibthal che, incorniciata dal suo hijab, regala un sorriso
e dice: “Sono musulmana, credente e praticante, ma
anche profondamente convinta che lo stato e le leggi devono
assolutamente restare laici, la scelta religiosa deve essere
protetta dalla propria intima fede, non dalle leggi dello stato!”.
Le donne arabe in rivoluzione, mille fuochi di voci, di gesti
e di storie di vita, recita il sottotitolo. Articolato sulle
tre scansioni dell'unità di tempo secondo un prima,
durante, dopo, il libro racconta di una rivoluzione,
agita, partecipata, promossa dalle donne in prima persona e
non viceversa.
La tanto sbandierata rivoluzione-vessillo della lotta di classe...
che libererà le donne tutelandole... le guerre umanitarie,
intraprese, si è detto, in nome di una questione femminile
circoscritta all'obbligo patriarcale di indossare o non indossare
il velo, vengono chiaramente smascherate e, per certo, consapevolmente
ridicolizzate dalle semplici parole di un partire da sé
di Naziha Rejiba, scrittrice tunisina e giornalista indipendente:
“Devo immediatamente dire che non è stata la
rivoluzione che mi ha liberata, ero libera ben prima del 14
gennaio”.
Già, perché prima e prima di prima, le donne sono
sempre esistite e quel che hanno fatto è altrettanto
prezioso di quel che non hanno fatto. L'anno zero della rivoluzione
che apre le porte alla libertà femminile oltre ad essere
mistificazione storica è tentativo, da parte patriarcale
e da parte di un certo femminismo di stato, di espropriare le
donne – e per di più le arabe – del loro
potere sociale, politico e simbolico.
Ferite di parole riporta al presente un passato di sollevazione
e proteste di cui le donne “erano state protagoniste essenziali
in più angoli dei Paesi, dagli scioperi di Gafsa, il
bacino minerario tunisino, agli scioperi per l'aumento del prezzo
del pane e per la libertà di informazione in Egitto”.
Nella sezione durante è attestata la continuità
simbolica dell'agire delle donne. In tutta evidenza –
letteralmente in corpore – dal “tradizionale”
ambito domestico, dalle mura delle case e dei cortili, il materno
e la cura sono (state) tradotte – senza tradimento –
nel cuore della lotta, nelle piazze e nelle strade per affrontare
le dittature con la forza di legare libertà e vita facendo,
lì e subito, mondo. La rivoluzione è un processo
continuo. Di difesa delle libertà conquistate, ma soprattutto
di determinazione ad andare avanti, perché una concezione
della libertà non è una concezione libera. Se
qualcuno pensa che non possiamo andare più lontano di
così [...] che finiremo di rientrare nei ranghi
[...] queste menti malate si sbagliano, non cederemo un millimetro
della libertà che abbiamo raggiunto, andremo verso la
sua crescita e niente ci fermerà.
C'è un senso molto più sottile dell'idea di conquista
del Palazzo riguardo a ciò che si intende per rivoluzione:
le cose cambiano se si cambia il rapporto con esse.
“L'occidente politico ed economico potrà aiutare
il mondo arabo in trasformazione se riuscirà a non imporre
i propri progetti politici e finanziari alle popolazioni dell'area
e rinuncerà a paventare sistematicamente l'avvento del
terribile pericolo islamico”, scrivono le autrici
all'inizio del capitolo L'insidia islamista”. Le
testimonianze e le riflessioni registrate sul campo,
di fatto si sottraggono tenacemente al “giogo dicotomico”
della visione occidentale che ancora una volta fissa le donne
a scenari di oppressione e che “non contempla neppure
la possibilità di scelta spirituale in una società
laica nel mondo musulmano”.
La storica Laila el-Houssi pacatamente e lucidamente osserva:
Il tentativo di limitazione della libertà femminile
non attiene alla contrapposizione laicità islamismo,
quanto al patriarcato, alla cultura patriarcale tipica dell'area
mediterranea – e aggiunge con l'ironia senza disprezzo
di un sorriso – e anche di tutto l'Occidente.
L'ordine materno non si arresta al momentaneo. Il dopo
in Ferite di parole riconosce l'acquisito senza abbandonarsi
al conclusivo. Nel preambolo finale a Considerazioni non
conclusive, appunto, si riportano alcuni versi di Mariam
H. – donna comune avvezza alla poesia e-o donna che rende
in poesia le interlinee del prosaico?
Così avverte: Ogni giorno è nuovo/e ogni giorno
incontro/qualcosa che non conoscevo/e il mondo/mi si apre un
po' di più.
Monica Giorgi
|

