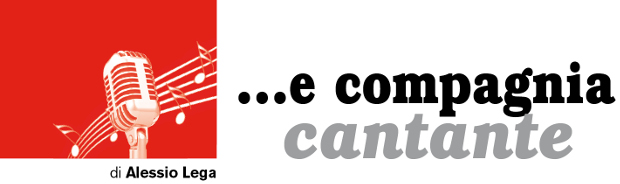
Germinale a Ribolla.
Bianciardi e la memoria della miniera
«Ma cosa doveva diventare, secondo lui, la miniera di
lignite, un salotto?
Per fortuna adesso al distretto minerario non c'era più
lui a dettar legge, e con l'ispettore nuovo ci si poteva mettere
d'accordo.(...) Quando l'avanzamento ha esaurito un filone,
che bisogno c'è di fare la ripiena? È tutto tempo
perso, tutta gente che mangia a ufo. Si disarma, si recupera
il legname, e poi il tetto frani pure. E non c'è nemmeno
bisogno di tracciare gli avanzamenti a giro d'aria. Si può
anche scavare a fondo cieco, basta un ventilatore che ci forzi
l'aria dentro, no? Certo, la temperatura così aumenta,
a volte supera quaranta gradi, ma si può rimediare, con
una tubatura che goccioli acqua davanti alla ventola. Sì,
obbiettava il medico di fabbrica, la temperatura in questo modo
scema, ma aumenta l'umidità, e aumentano i casi di malattia
a sfondo reumatico.(...) Qui bisognava far meno storie e aumentare
il tonnellaggio... E per favore, con le radiografie ci andasse
piano, il dottorino. Non erano tempi, non era aria da mettere
in mutua per una sospetta silicosi o per una diminuita capacità
respiratoria del diciotto per cento.(...) Allora, con l'ispettore
consenziente, misero ventiquattro cantieri su venticinque coltivati
ad avanzamento cieco e a franamento del tetto, realizzando in
tal modo, diceva la relazione, una normale concentrazione del
personale. Rispetto al quarantasei, produzione pressoché
identica con un terzo degli operai di allora. Certo, restava
il grosso guaio della ventilazione imperfetta.
Non occorreva che glielo dicesse la commissione interna –
questi altri lavativi – lo sapeva da sé il direttore
che il flusso d'aria non aveva andamento ascendente continuo,
che due rimonte, la venti e la ventidue, facevano scalino, erano
almeno venti metri più alte della galleria di livello,
e lì l'aria stagnava. Sapeva anche (ma la commissione
interna questo, per fortuna, lo ignorava) che a un certo punto
della 265 l'aria di afflusso si mescolava con quella di riflusso,
e il regolamento di polizia diceva, chiaro chiaro, che le vie
destinate all'entrata e all'uscita dell'aria debbono essere
divise da sufficiente spessezza di roccia tale da resistere
all'esplosione. Altro che spessezza di roccia! Lì non
c'era nemmeno un foglio di carta.
Fortuna che quelli non l'avevano capito. Certo, si poteva rimediare:
da anni erano sospesi i lavori per l'apertura di una galleria
nuova che garantisse la ventilazione di tutto il settore. Ma
con quelli che dalla sede centrale premevano, circolari su circolari,
a chiedere che non si sprecasse un uomo, una tonnellata, un
giorno lavorativo, cos'altro poteva fare lui direttore, che
mettere tutti alla frusta, a tirar su lignite?(...) L'aspiratore
nuovo, da sessanta cavalli, non l'aveva forse fatto piazzare
la mattina del primo maggio, che era un sabato, approfittando
delle due giornate di festa consecutive?(...) Ma la mattina
del tre la festa era finita, e allora sotto a levare lignite.
Si erano riposati abbastanza o no, questi pelandroni? Eppure
il caposquadra aveva fatto storie: diceva che dopo due giorni
senza ventilazione, giù sotto era pericoloso scendere,
bisognava aspettare altre ventiquattr'ore, far tirare l'aspiratore
a vuoto, perché si scaricassero i gas di accumulo. Insomma,
pur di non lavorare qualunque pretesto era buono.(...) Stavolta
era stufo: meno storie, disse ai capisquadra, mandate cinque
uomini della squadra antincendi a spegnere i fuochi, ma intanto
sotto anche la prima gita.
La mattina del giorno dopo, alle sette, la miniera esplose.»

«Rimasi quattro giorni nella piana sotto Montemassi,
dallo scoppio fino ai funerali, e li vidi tirare su quarantatré
morti, tanti fagotti dentro una coperta militare. Li portavano
all'autorimessa per ricomporli e incassarli (...). Alla sala
del cinema, ora per ora, cresceva la fila delle bare sotto il
palcoscenico, ciascuna con sopra l'elmetto di materia plastica,
e in fondo le bandiere rosse. Venivano a vederli da tutte le
parti d'Italia, giornalisti con la camicia a scacchi, il berrettino
e la pipetta, critici d'arte, sindacalisti, monsignor vescovo,
un paio di ministri che però furono buttati fuori in
malo modo.(...) Questa volta non venne la celere e anche i carabinieri
del servizio d'ordine si tennero accosto al cancello della direzione.
Ai funerali ci saranno state cinquantamila persone, tutte in
fila con le bandiere, le corone dei fiori, il vescovo con la
mitra e il pastorale. E quando le bare furono sotto terra, alla
spicciolata se ne andarono via tutti, col caldo e col polverone
di tante macchine sugli sterrati. Io mi ritrovai solo sugli
scalini dello spaccio, che aveva chiuso, e mi sembrò
impossibile che fosse finita, che non ci fosse più niente
da fare.
Nella bacheca al cancello stava scritto che alle famiglie delle
vittime il ministero offriva contribuzioni straordinarie e immediate
varianti dalle 60 alle 100 mila lire, oltre il normale trattamento
previdenziale previsto dall'Inail. La direzione offriva assegni
assistenziali di 500 mila lire e di un milione, secondo i relativi
carichi familiari. A conti fatti ci scapitava una ventina di
milioni. Ma in compenso poteva chiudere subito la miniera.»
Tutte queste parole vengono da un unico libro, “La vita
agra” di Luciano Bianciardi. Si consideri questo un lungo
omaggio a quei quarantatré minatori – subito diventati
quarantaquattro, un sopravvissuto morì qualche giorno
appresso delle conseguenze dell'esplosione – a quegli
angeli lavoratori restati nel fondo del pozzo. Quanta potenza
sta in queste parole, alle quali pare un delitto tagliare ogni
sillaba, accorciare, “citare” dei frammenti per
far rientrare nell'articolo giornalistico ciò che è
stato scritto col respiro del tragico affresco. Si tratta del
secondo capitolo de “La vita agra” di Bianciardi,
scrittore di Grosseto, maremmano e anarchico.
Nel 1954 il giovane Bianciardi, insieme a un'altra giovane promessa
della prosa italiana Carlo Cassola, si muove spesso dalla natia
Grosseto per condurre un'inchiesta sulle condizioni di vita
dei minatori delle sue zone. Parla con loro, scrive la vita
che vivono, ne diviene amico. Quando esplode uno dei pozzi di
Ribolla, ne rimane sconvolto, annichilito, morto nell'anima.
Il libro “I minatori della maremma” uscirà
due anni dopo. Ma Grosseto ora più che mai gli è
diventata pesante, non crede più in quel “lavoro
culturale”, periferico e dal basso, che darà il
titolo al suo primo romanzo vero e proprio.
Presto accoglierà l'invito del giovane editore Feltrinelli
e monterà a Milano, centro concentrico, prigione e fonte
di molta sua letteratura e in particolare di questo suo capolavoro
“La vita agra”. Nella rabbiosa prosa di questo romanzo
il protagonista è proprio uno scrittore – alter
ego fatto e finito dell'autore – che vive di traduzioni
e lavoretti editoriali, ma che ha l'idea fissa di “vendicare”
i suoi amici minatori “assassinati” dalla Montecatini,
la società proprietaria della miniera che ha sede nel
“torracchione” di Milano, che il nostro vuole fare
esplodere. Ma la vita faticata, “agra”, cui costringe
la città, farà a pezzi la rabbia vendicativa e
lascerà un sordo autodistruttivo rancore nel protagonista.
L'autore invece – dopo qualche anno di stenti –
farà la propria fortuna proprio con quel romanzo, fra
i più rappresentativi del Boom Economico e del suo connesso
malessere. “La vita agra” diverrà un modo
di dire popolare a quei tempi, quasi subito Carlo Lizzani ne
trarrà un bel film con Tognazzi protagonista. Bianciardi
per qualche anno diventa una celebrità mediatica, spesso
intervistato dalla televisione e conteso dai giornali, presenza
fissa della Milano della sinistra pre-contestazione. Molti ancora
lo ricordano, avvinnazzato e berciante, ai tavoli del Bar Jamaica
di Brera. Ma sarà una breve pausa in una vita che declina
per lento suicidio attraverso l'alcool. Una dilazione della
tragica sfiducia, di quell'amaro in bocca che lasciano in eredità
le meravigliose ultime pagine del suo romanzo.
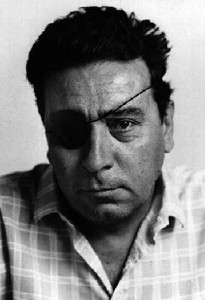 |
| Lo scrittore Luciano Bianciardi
(Grosseto, 1922 - Milano, 1971) |
«Faranno insorgere bisogni mai sentiti prima. Chi non
ha l'automobile l'avrà, e poi ne daremo due per famiglia,
e poi una a testa, daremo anche un televisore a ciascuno, due
televisori, due frigoriferi, due lavatrici automatiche, tre
apparecchi radio, il rasoio elettrico, la bilancina da bagno,
l'asciugacapelli, il bidet e l'acqua calda.
A tutti. Purché tutti lavorino, purché siano pronti
a scarpinare, a fare polvere, a pestarsi i piedi, a tafanarsi
l'un con l'altro dalla mattina alla sera.
lo mi oppongo.
Quassu io ero venuto non per far crescere le medie e i bisogni,
ma per distruggere il torracchione di vetro e cemento, con tutte
le umane relazioni che ci stanno dentro.
Mi ci aveva mandato Tacconi Otello, oggi stradino per conto
della provincia, con una missione ben precisa, tanto precisa
che non occorse nemmeno dirmela.
E se ora ritorno al mio paese, e ci incontro Tacconi Otello,
che cosa gli dico? Sono certo che nemmeno stavolta lui dirà
niente, ma quel che gli leggerò negli occhi lo so fin
da ora. E io che cosa posso rispondergli? Posso dirgli, guarda,
Tacconi, lassù mi hanno ridotto che a fatica mi difendo,
lassù se caschi per terra nessuno ti raccatta, e la forza
che ho mi basta appena per non farmi mangiare dalle formiche,
e se riesco a campare, credi pure che la vita è agra,
lassù.
Almeno avessi trovato gente come te. Ma la gente come te non
me la fanno vedere, non gli danno il modo di dormire a sazietà,
la tengono distante, staccata, la fanno venire tutte le mattine
presto col treno, e io ho appena fatto in tempo a intravederli,
senza capirci nulla, senza nemmeno potergli dire una parola.
(...) No, Tacconi, ora so che non basta sganasciare la dirigenza
politico-economico-social-divertentistica italiana. La rivoluzione
deve cominciare da ben più lontano, deve cominciare in
interiore homine.
Occorre che la gente impari a non muoversi, a non collaborare,
a non produrre, a non farsi nascere bisogni nuovi, e anzi rinunciare
a quelli che ha.
La rinunzia sarà graduale, iniziando coi meccanismi,
che saranno aboliti tutti, dai più complicati ai più
semplici, dal calcolatore elettronico allo schiaccianoci.
Tutto ciò che ruota, articola, scivola, incastra, ingrana
e sollecita sarà abbandonato.
Poi eviteremo tutte le materie sintetiche, iniziando dalla cosiddetta
plastica.»
Da Ribolla al mondo. L'indignazione per quel massacro voluto
– o quanto meno volutamente non evitato – aveva
acceso un furore profetico nello scrittore di Grosseto, una
profezia attualissima. Bianciardi morì di tristezza e
di ubriachezza il 14 novembre del 1971, a quarantotto anni.
Il 4 di maggio del 2014 sono passati sessanta anni tondi dalla
sciagura di Ribolla. Cosa abbiamo serbato noi di quella rabbia?
Cosa ci resta nella memoria di tutto quel dolore? Uno splendido
romanzo, lo abbiamo detto. Un libro inchiesta dello stesso autore
(e di Carlo Cassola). E poi – e qui entro in ballo io
– delle canzoni, perché la vita dalle nostre parti
si è sempre sposata con la musica, e tanto più
era vita – anche tremenda – tanto più si
cantava per alleviare la fatica.
Meno male che c'è sempre qualcuno che canta
e la tristezza ce la fa passare,
se no la nostra vita sarebbe una barchetta in mezzo al mare,
dove tra la ragazza e la miniera apparentemente non c'è
confine,
dove la vita è un lavoro a cottimo e il cuore un cespuglio
di spine.
Così fa un meraviglioso brano di Francesco de Gregori
che si chiama proprio “La ragazza e la miniera”.
Chissà se l'ispirazione per questa moderna ballata di
lavoro, di solitudine e dolore esistenziale, è arrivata
a de Gregori dal suo lontano sodalizio con Caterina Bueno –
per la quale all'inizio della sua carriera lavorò come
chitarrista – dal suo repertorio ritrovato e salvato di
canzoni popolari toscane sul duro, povero e insano faticare
dei carbonai o degli stagionali che percorrevano l'agra estensione
del centro Italia, per qualche spicciolo mal guadagnato e già
speso.
So stato a lavorà a Montesicuro
se tu sapessi quanto ho guadagnato,
ci manca quattro pavele a uno scudo.
Non posso dì però quanto ho sudato,
so mezzo morto me se schianta il core
e l'anema me va pè conto suo.
Mannaggia all'ora quanno ci ho pensato
d'annatte a lavorà a quel diserto,
che p'arricchì 'n brigante so crepato.
Caterina Bueno, questa grandissima ricercatrice e cantante di
Firenze aveva reso celebre il repertorio maremmano, la dura
maremma lontana dalle sdolcinate rievocazioni letterarie, enologiche
e nostalgiche, dura di lavoro e verità: “una Maremma
amara” come dice una delle più note canzoni popolari.
Tutti mi dicon Maremma, Maremma...
Ma a me mi pare una Maremma amara.
L'uccello che ci va perde la penna
Io c'ho perduto una persona cara.
Sia maledetta Maremma Maremma
sia maledetta Maremma e chi l'ama.
Sempre mi trema 'l cor quando ci vai
Perché ho paura che non torni mai.
La ventura di questa improbabile vita di musicista itinerante
mi ha fatto incontrare, su un palco a un angolo della vita,
Eleonora Bagnani, giovane cantante residente a Siena, ma originaria
di Roccastrada, il comune di cui Ribolla è frazione.
La sua tradizione familiare – il nonno fu minatore e scampò
alla strage solo perché il giorno prima si era infortunato
a un piede – insieme al mio bisogno di cantare la memoria
ci ha fatto concepire uno spettacolo su quel pozzo sprofondato
nel nostro passato: la miniera. Siamo partiti alla ricerca delle
canzoni: arrivare al cuore delle cose, per noi equivale a cantarle.
Abbiamo scavato in questo giacimento sparso, vi abbiamo trovato
delle perle, sempre macchiate di fango, qualche volta anche
di sangue e sputo. Nasce così lo spettacolo “Germinale
a Ribolla, memoria cantata del 4 maggio 54”, il titolo
omaggia il capolavoro di Zola, il testo è un impasto
di canti e citazioni di Bianciardi.
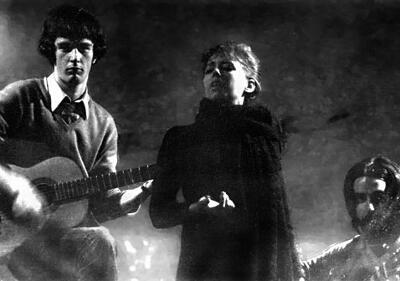 |
| Francesco De Gregori, Caterina Bueno e Antonio
De Rose durante
un concerto nel 1971 |
Nella ricerca sono stato folgorato da questo brano che mi hanno
fatto conoscere i compagni del Canzoniere Bresciano: un cupo
capolavoro, proveniente dal repertorio della famiglia Bregoli,
minatori in Val Trompia. Ascoltare dalle loro voci forti e consumate
dalla silicosi, tirate e violente, queste parole mette un brivido
nella schiena. E con queste parole vi lascio, con l'augurio
e la voglia di aria pulita nei polmoni e sole, in memoria dei
quarantaquattro di Ribolla.
E anche il mio padre
sempre me lo diceva
di star lontano
dalla miniera
Ed io testardo
ci sono sempre andato
finché di una mina
mi ha rovinato
Finché di una mina
in quella galleria
mi ha rovinato
la vita mia
Non c'è più medici
nemmeno medicine
che fan guarire
le mie rovine
Non c'è più medici
nemmeno i professori
che fan guarire
i miei polmoni
O Santa Barbera
o santa Barberina
dei minatori
sei la regina.
Alessio Lega
alessiolegaconcerti@gmail.com
|

