|
Thailandia
I garofani d'aria
reportage di Moreno Paulon
Una storia di profughi, rivoluzioni e monaci buddhisti nella città di Mae Sot, meta di molti rifugiati birmani,
e nell'eterotopia di Mae La, uno dei più grandi campi profughi della Thailandia.

Mae Sot / intervista al monaco Ashin Issariya
La città di Mae Sot
è una culla di garofani dell'aria. Malgrado l'appartenenza
al territorio nazionale thailandese, gli abitanti della città
sono piante senza radici. Non affondano i piedi nella terra
patria, vivono di movimenti storici e scambi quotidiani, si
radicano nel vento della diaspora, mettono casa nelle persone
come fanno gli stranieri, non nel suolo o nei monumenti alla
maniera dei nativi.
Ad appena 7 km dal confine birmano, Mae Sot è terra di
esuli per scelta o per forza, è un porto in cui le barche
ormeggiano legate a corda, lasche, senza ancora. Non del tutto
Thailandia e niente affatto Birmania, la sua popolazione ufficialmente
si aggira intorno ai 45 mila abitanti, ma stimarla con esattezza
è molto più difficile di quanto le statistiche
lascino supporre. Le cifre dei censimenti inevitabilmente mentono:
moltissimi abitanti, soprattutto di origine birmana, non vi
sono registrati, attraversano ogni giorno clandestinamente il
confine via terra o sul fiume, si fermano per giorni o per anni,
mettono su famiglia, lavorano, a volte passano tutta una vita
inosservati sotto il naso delle autorità nazionali, invisibili
come le ombre nel buio. Per quelli meno fortunati invece, per
chi viene scoperto nelle strade senza documenti validi, c'è
la gabbia.
“Che cos'è quella?” domando ad un
passante thai.
“Quella è la gabbia”
“Per che cosa?”
“Per i birmani”.
 |
| “La gabbia” è una sorta di sbrigativo
centro di indentificazione ed espulsione
nel mezzo della città di Mae Sot |
La gabbia è una cella nel bel mezzo della città,
ben visibile dalla strada, proprio accanto alla stazione di
polizia e a due passi da un piccolo terminale secondario di
autolinee. È uno sbrigativo centro di identificazione
ed espulsione, dove ogni giorno birmani irregolari colti sul
territorio finiscono collettivamente sotto chiave per alcune
notti, in attesa dell'espulsione o di altre risoluzioni.
Mae Sot, miscellanea città di confine, è soggetta
a flussi complessi e molteplici: conoscere in maniera approfondita
anche uno solo dei suoi volti richiederebbe anni di permanenza
e ricerche serrate. Sotto la superficie tranquilla della vita
quotidiana si agitano acque in continuo movimento. Alcuni karen
vanno e vengono per Mae Sot muovendosi di nascosto dai vicini
campi profughi, moltissimi birmani entrano in Thailandia come
vittime di traffico di esseri umani, altri sono stati privati
dei documenti dal loro governo per aver preso parte alle varie
lotte contro il regime militare. In città alloggiano
circa trenta bordelli, una miriade di artigiani, gruppi karen
e hmong, pagode buddhiste e chiese cristiane, fotografi
a caccia di un Pulitzer nella miseria, cittadini thai, operatori
internazionali delle centinaia di Ong presenti sul territorio,
cinesi commercianti di pietre preziose, ufficiali, piccoli mercanti.
Nelle strade, accanto alla lingua thai, si sentono spesso parlare
quella karen e quella birmana, mentre fuori dal centro
viaggiano indisturbati pick-up stracarichi con oltre venti persone
a bordo. Piccoli e grandi trafficanti fregano il confine ogni
giorno per contrabbandare dosi di yaba, la droga dei
poveri, una tremenda metanfetamina prodotta in Birmania e rivenduta
sul mercato di Bangkok e di Chiang Mai, da dove entra in circolo
e divora rapidamente il cuore della Thailandia.
Il festoso mercato di Mae Sot è fitto di scritte tondeggianti
in caratteri birmani, alfabeto thai e ideogrammi cinesi. Gli
uomini e le donne indossano spesso il passou e la longyi
come si usa in Myanmar e i volti dei bambini birmani e delle
loro madri sono spesso truccati di tanaka, un legno color
ocra che strofinato sulla pietra e impastato con acqua diventa
una crema usata come belletto.
Come in Birmania, molte persone indossano il pigiama anche di
giorno per uscire in città, con fantasie di cuori e fiori,
cuccioli di gatto, cartoni animati. A cadenza regolare la cantilena
nasale del muezzin risuona dai minareti della moschea
e richiama al tempo della preghiera i musulmani, che accorrono
dalle vie del centro come marinai stregati da un canto di sirena
divulgato sull'oceano, mentre i monaci buddhisti raccolgono
l'elemosina di porta in porta, pregando sull'uscio con voce
baritonale e capo chino, sollevando a due mani il debey,
il vaso delle offerte, pendente dalle accese tonache color zafferano.
All'ultimo piano di una biblioteca nei pressi del mercato centrale,
ho trascorso qualche ora con il monaco buddhista Ashin Issariya,
attivista politico della prima ora, esule birmano e fra i più
rilevanti promotori della grande rivolta del settembre 2007,
poi battezzata Rivoluzione Zafferano. Perseguitato dalla caccia
alle streghe del regime, costretto per anni nel silenzio e nella
penombra della clandestinità, Issariya, come altri protagonisti
della rivolta contro la junta militare, ad anni di distanza
si sente libero di raccontare gli eventi del settembre 2007,
di un movimento che nel giro di due mesi ha coinvolto 227 proteste
in 66 città, interessando tutti i 14 Stati e divisioni
dell'odierna Birmania, o Myanmar.
 |
| Ashin Issariya |
Perché sei a Mae Sot, Issariya?
«Mi cercavano. Dopo i fatti del 2007 il regime perseguitava
tutti, e in particolare chi come me scriveva articoli e poesie
contro di loro, chi organizzava il movimento di dissidenza dall'interno.
Eravamo i peggiori nemici, quelli che influenzavano le coscienze.
Nel 2008 sono arrivati fino alla mia famiglia, ero in pericolo.
Prima hanno catturato otto membri di Generation Wave e li hanno
torturati per sapere dove fossero i miei familiari, poi sono
arrivati fino al mio villaggio. “Dov'è il vostro
monaco?” chiedevano. La mia famiglia non ha rivelato niente,
ma mi ha chiesto di mettermi in salvo, di andarmene dal Paese.
Così ho deciso di venire qui, appena oltre il confine.
Dal mio villaggio sono partito per Rangoon, passato per Pegu,
poi attraerso il Kayin State fino a Myawaddy e infine sono arrivato
a Mae Sot nell'ottobre 2008. Molti dei miei amici e compagni
monaci, compresi U Gambira e U Kemind, erano già finiti
in galera, erano caduti nelle mani dei militari, io rischiavo
di fare la stessa fine.»
Come sei riuscito a sfuggire agli arresti e alle persecuzioni
fino al 2008?
«La sera del 28 settembre, durante le violenze e i massacri,
mio fratello è venuto segretamente in visita al mio monastero.
“Per ora non puoi fare più di così”
mi disse, “molti monaci sono già finiti in prigione,
altri sono stati picchiati a morte nelle strade. Lo hai visto.
Devi nasconderti, devi muoverti, se ti prendono non potrai lottare
dalla prigione”. Così ho iniziato a muovermi di
nascosto di villaggio in villaggio senza fermarmi mai. Portavo
con me il mio computer, facevo editing, montavo i filmati
delle manifestazioni e li mostravo agli abitanti. Il regime
aveva fatto il lavaggio del cervello alla popolazione. Dicevano
che quelli nei filmati non erano veri monaci, che i veri monaci
erano nei monasteri, non a manifestare. Così cercavo
di mostrare loro la verità. Molti monaci e molti miei
amici e studenti erano in prigione. Io mi nascondevo sotto falso
nome, il regime cercava King Zero, non Ashin Issariya.
King Zero era il nome con cui mi firmavo negli articoli contro
il regime.»
Quando è nato il tuo attivismo politico?
«Devo la mia coscienza politica al mio maestro, Thu Mana.
Ben prima dell'università, i miei genitori volevano che
ricevessi un'istruzione e mio padre mi mandò al monastero
quando la mia scuola statale venne chiusa, così fui affidato
alla guida di Thu Mana. Lui, invece di dirmi cosa pensare,
mi ha insegnato come pensare. Nel 1972 i militari avevano
distrutto la sua biblioteca, ma era riuscito a salvare alcuni
libri, a tenerli nascosti, e me li fece leggere. Più
tardi mi fece ascoltare anche i discorsi di Aung San Suu Kyi.
Mi istruì politicamente, non era una fortuna che avevano
tutti i monaci. Io ho cercato di seguire il suo esempio. Aprivo
biblioteche, ovunque, in qualsiasi città e villaggio,
ne ho aperte 13 finora. Le aprivo così che tutti potessero
iniziare un percorso simile al mio, istruirsi politicamente,
socialmente. Ne ho aperta una anche nella mia stanza a Rangoon,
ho cercato di fare quello che il mio maestro ha fatto con me.
Durante l'università io e gli altri monaci cercavamo
di proporre iniziative creative per informare gli studenti e
la popolazione, scrivevamo articoli e poesie per stimolare le
persone a riflettere, perché sotto il regime l'istruzione
della popolazione era bassissima, li crescevano nell'ignoranza,
facevano solo propaganda e nessuno capiva veramente o si preoccupava
della situazione politica, che era gravissima. Nel 2000 mi hanno
fatto chiudere una biblioteca che avevo aperto nell'università,
perché l'università era statale e statale significava
del regime.»
[ ... ]
 |
| Mae Sot, Thailandia occidentale, in prossimità
del
confine con il Myanmar (Birmania) |
Che cosa ti ricordi dei giorni di settembre?
«È stato un massacro. Il 5 settembre oltre 500
monaci scesero in strada a Pakokku, Magwe Division, ed altri
200 erano già intervenuti ad Arakan, Rakhine State. Furono
picchiati e arrestati dalle forze dell'ordine. Poco tempo dopo
con U Gambira e U Kemind ci siamo incontrati per stendere un
documento, era il 9 settembre. Uke l'ha trasmesso attraverso
la Bbc e tutti i monaci del Paese l'hanno sentito. La All Burma
Monks Alliance chiese delle scuse ufficiali, scuse pubbliche
da parte del regime e delle forze dell'ordine per le violenze
perpetrate contro i monaci che avevano manifestato pacificamente.
Chiedevamo anche la liberazione dei prigionieri politici, di
ridurre immediatamente le tasse, la fine della dittatura e l'inizio
di un dialogo fra le parti sociali. Durante la raccolta dell'elemosina
distribuivamo di nascosto volantini ai cittadini. Abbiamo dato
un ultimatum ai militari: avrebbero dovuto scusarsi entro
il 17 settembre. Ma le scuse non arrivarono.
Il giorno dopo abbiamo sfilato di fronte ai militari con i debey
“ma”, le urne dell'elemosina capovolte, a indicare
che non c'era nessuna associazione fra noi e loro, che noi dipendevamo
solo dall'elemosina del popolo e intendevamo estrometterli dall'ordine
sociale. L'abbiamo fatto in tutti i monasteri, poi in corteo,
in moltissime città, in tutte le città.
La mattina del 26 settembre è iniziata un'altra manifestazione
non violenta, con le stesse richieste. Il giorno prima mi ero
collegato a internet e un monaco anziano mi aveva avvisato che
la situazione sarebbe diventata ancora più violenta,
che il regime non aveva intenzione di tollerare il nostro dissenso.
C'erano blocchi enormi di polizia a serrare le strade e alcune
zone della città, non ci lasciavano manifestare liberamente.
Noi avevamo diffuso video e fotografie delle violenze, la gente
era arrabbiata, chiedeva “Perché avete picchiato
i nostri monaci?” 5.000 monaci andarono verso la Sule
Pagoda. I soldati ci picchiavano a morte, non riuscivamo a parlargli
da uomini, obbedivano agli ordini come robot. Allora ci siamo
divisi nei monasteri. I soldati ci fermavano, chiudevano le
strade, non avevamo dove andare. Non potendo più muoverci,
abbiamo deciso di sederci tutti a terra e pregare. Allora ci
hanno gridato che non ci accordavano il permesso di pregare
per strada, che ce lo proibivano. Gridavano “Vi diamo
10 minuti per smettere”, poi hanno sparato colpi in aria.
Molti monaci erano terrorizzati dagli spari, quindi abbiamo
detto “Torneremo ai monasteri, apriteci la via”,
e ci siamo divisi.
Nella notte sono entrati nei monasteri. Ci hanno picchiati,
ci hanno uccisi, portati in galera. Il 26, 27, 28 e 29 settembre
sono venuti ogni notte, poi sporadicamente nei primi di ottobre.
Molti sono scappati nei villaggi cercando riparo e non hanno
più potuto partecipare alla lotta. Se studenti e popolazione
riempivano le strade, i militari gli sparavano, c'era il coprifuoco.
Poi una notte è arrivato mio fratello, in segreto, come
ti ho detto, chiedendomi di scappare, dicendomi che U Gambira
e U Kemind erano in galera, sotto tortura. Allora ho iniziato
a muovermi per i villaggi. È cominciata la caccia al
monaco.»
Che ne è stato del movimento?
«Tornato a Rangoon ho potuto usare internet e organizzare
ancora il movimento. Volevamo soprattutto la liberazione dei
prigionieri politici, inclusa Aung San Suu Kyi, non ci volevamo
fermare. Ma poi i militari sono arrivati alla mia famiglia,
erano troppo vicini, e sono venuto a Mae Sot. Da qui cerco ancora
di diffondere istruzione, materiale politico, libri, cultura.
U Gambira si è sposato, si è tolto l'abito. Ma
le torture dei militari l'hanno cambiato, non è più
lo stesso, la sua mente non è più la stessa, non
è più lui. U Kemind è ancora monaco e milita,
si trova a Mandalay. L'hanno imprigionato due volte: nel 1990
e poi nel 2007, è un osso duro. Il mese scorso ci siamo
incontrati a Yangon.»
 |
| La città di Mae Sot |
Una domanda di rito: cosa pensi di Aung Sang Suu Kyi e
del Ndl (Lega nazionale per la democrazia)? Gli stati birmani
non hanno mai dimenticato l'indipendenza sottratta, il federalismo
perso prima con il colonialismo inglese e poi con la morte di
Aung San. Molti di loro non parlano la lingua nazionale e non
accettano lo stato unitario. Credi che una possibile elezione
di Suu Kyi potrebbe migliorare la situazione birmana?
«Aung San Suu Kyi ha un buon programma, conosce la storia
e le necessità del suo popolo, ma c'è qualcosa
di più urgente della sua elezione. Prima occorre cambiare
il sistema politico, scrivere una nuova Costituzione. Qualsiasi
variazione ora richiede una maggioranza parlamentare superiore
al 75% dei voti, e i militari hanno sempre tenuto per loro il
25% dei seggi. Senza la loro approvazione niente si muove, quindi
siamo ancora in loro balia, malgrado la farsa democratica. Occorre
cambiare il sistema prima che Aung San Suu Kyi e il suo partito,
Ndl, possano intervenire concretamente. Lo stiamo facendo, ma
non c'è molto tempo.»
E se non riusciste a intervenire in tempo? Se i militari
non lasciassero il campo?
«Chissà, potrebbe anche scoppiare una rivoluzione.»
Lo speri?
«In un certo senso lo speriamo tutti.»
Ringrazio Issariya per le parole scambiate e sorseggiamo un
tè caldo nella tiepida stanza dei libri. A guardarlo
così, vis-à-vis, si resta stregati dalla
forza latente che riposa nei suoi occhi bui ma visionari, dalle
mani ben ferme ai polsi durante i gesti nel discorso, dal vigore
aggraziato di quel corpo, un corpo sacro, mai toccato da mano
di donna. Si avvicina l'ora del pranzo e sul pavimento è
stato allestito un tavolino rotondo alto appena una spanna da
terra, come si usa nelle case e nei templi birmani. Il riso
al vapore vi fuma controluce. Scattiamo alcune fotografie, poi
prima del congedo domando ad Issariya informazioni su un suo
amico, un altro monaco che vorrei intervistare, un altro garofano
d'aria esiliato dal giardino birmano e finito a Mae Sot dopo
la tempesta politica. Issariya siede nuovamente. Con un brivido,
sospeso fra entusiasmo e timore, apprendo dalle sue parole la
delicata posizione del mio monaco: “È qui, ma non
lo troverai a Mae Sot. Vive da anni nel campo di Mae La”.
Mae Sot / intervista al monaco U Tilawca
La nazione birmana è
composta da 14 stati e divisioni minori. Nonostante l'istituzione
dello Stato unitario, oltre 130 gruppi di minoranze (qualcuno
direbbe “etnie”) fin dalla conquista britannica
non hanno fatto che lottare contro un governo centralizzato
più o meno dittatoriale, più o meno colonialista,
più o meno democratico. Dopo la morte dell'eroe dell'indipendenza
Aung San (padre di Suu Kyi), il quale aveva assicurato alle
minoranze una certa autonomia nel 1947, la chimera del federalismo
è scomparsa e di fronte alle reiterate richieste di indipendenza
da parte delle minoranze, la strategia dei generali e dello
stato è stata grosso modo sempre la stessa: lasciare
l'eco come sola risposta alle domande e passare alla repressione,
al massacro, alla “pacificazione” via esercito per
imporre l'annessione e l'unità. Alcuni gruppi hanno deciso
di impugnare le armi, ed è il caso dei Kachin,
altri di negoziare, altri ancora risolsero di fuggire via dalla
loro terra.
Malgrado le recenti aperture al turismo da parte del governo
e il sorriso caricato a molla degli ufficiali, molte aree sono
tuttora coinvolte in una guerra sanguinaria e i loro territori
restano chiusi ermeticamente agli stranieri. Scoraggiare gli
occhi dei curiosi non è lavoro da poco: le reti infrastrutturali
del Paese sono pattugliate intensamente, le strade sono disseminate
di barriere e checkpoint militari, le visite in alcune
destinazioni richiedono permessi governativi e raggiungerne
altre da straniero comporta un biglietto di treno con prezzo
gonfiato fino a dieci volte. Viaggiando nei pressi delle zone
di confine capita di essere fermati e registrati anche sette
o otto volte in uno spostamento via terra di un paio d'ore.
Molti karen lottano per l'indipendenza fin dagli anni
'40 opponendo la karen National Union all'esercito del Myanmar,
mentre la zona del Kachin State, a Nord del Paese, è
attualmente coinvolta in una violentissima guerra armata sotto
il più serafico silenzio mediatico internazionale. La
Birmania non “pacificata”, la Birmania delle trincee
e delle mine anti-uomo, grondante di sangue e sparsa di brandelli
di corpi, resta ampiamente un segreto, mentre le rivolte e le
repressioni continuano avvolte nella complice intimità
di una coltre di fumo statale.
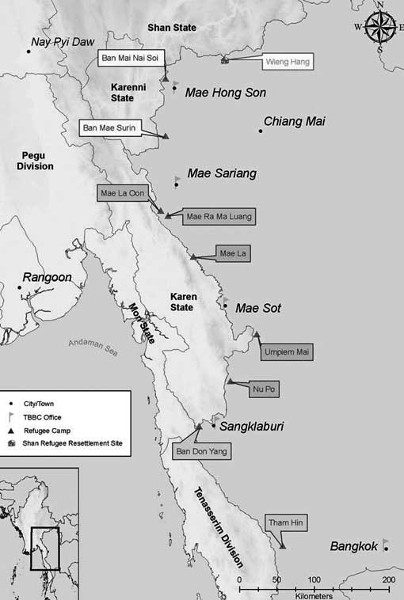 |
| Principali campi profughi birmani sul territorio thailandese |
Ad oggi la violenza e la morte delle guerre civili e le ripetute
violazioni dei diritti umani hanno costretto oltre 140.000 birmani
in cerca di pace alla fuga oltreconfine. Il governo thailandese
li ha accolti, temporaneamente, in una decina di campi profughi
lungo la linea di demarcazione nazionale, ma la temporaneità
di queste aree d'eccezione, vere e proprie eterotopie istituite
a cavallo degli stati nazionali, dura ancora dagli anni '80.
Nuove generazioni di non-cittadini ogni anno nascono all'interno
dei campi, nuove umanità in bilico, senza nazione o documenti,
mentre quella birmana passa alla storia come una delle più
durature condizioni di dislocazione del mondo intero. Nel giugno
2013 la Tbc ha censito una popolazione di 128.480 persone all'interno
di queste aree speciali, ma appena la metà di questa
è stata riconosciuta e registrata dalle Nazioni Unite.
Il più grande di questi campi per i profughi birmani
è proprio quello di Mae La. Situato nel bel mezzo della
giungla, a 8 km dal confine birmano e a circa 60 km dalla città
di Mae Sot, il campo contiene attualmente una popolazione di
circa 60.000 persone, di cui un buon l'85% è di origine
karen. Mae La fu istituito nel 1984, ha l'estensione
di una città di provincia ed è suddiviso in tre
aree (A, B, C) a loro volta ripartite in cinque sezioni ciascuna
(1, 2, 3, 4, 5). Alle 6 del mattino sono salito sul primo songthaew
in servizio ed ho lasciato il centro di Mae Sot diretto verso
il campo. L'area di Mae La è posta sotto la tutela del
Ministero degli Interni e l'accesso è strettamente riservato
ai rifugiati e ai pochi operatori abilitati e dotati di carte
governative. Tutto il perimetro adiacente alla strada è
recintato di filo spinato e pattugliato dall'esercito. Fallito
il dialogo con le Ong, sempre timorose di bruciarsi i finanziamenti
con mosse sbagliate, il mio monaco avrebbe dovuto convincere
(o corrompere) una delle guardie per farmi entrare, e mi aspettava
al cancello di ingresso alle 7.30. Avvicinandomi al campo, tuttavia,
mi sono reso conto che non esisteva un cancello di ingresso,
ma una decina di cancelli, ben snocciolati lungo tutta la lunghezza
del confine. La sorveglianza era piuttosto elevata e il perimetro
era troppo esteso per pensare di percorrerlo a piedi cercando
il mio contatto al cancello giusto. Dopo un maldestro tentativo
di ingresso dal cancello principale, e dopo il prevedibile muso
duro dei soldati thai a gambe divaricate, sono tornato sui miei
passi, ho cercato con calma un punto debole nella camicia di
forza del recinto e sono entrato di nascosto, con il cuore leggero
e gagliardo di chi tralascia di pensare alle conseguenze delle
proprie azioni. Da dentro, con prudenza, ho iniziato la ricerca
del mio monaco.
I primi passi fra le capanne sono stati con i piedi di piombo.
Ogni rumore è sinistro, ogni piccola ombra sulle palizzate
sembra venire per portare disgrazie. Il campo al primo sguardo
è un labirinto di vicoli sterrati che si districano senza
logica né disegno, sentieri nodosi figli di un inurbamento
spontaneo, casuale, non pianificato. Senza il conforto possibile
di una mappa, al principio non c'era strada che potessi essere
certo di non aver già percorso un attimo prima, e sul
villaggio riposava il silenzio grave e imponente di un tempio.
Le capanne avevano pareti e recinti in bambù, un pian
terreno e uno sopraelevato, spesso un piccolo giardino in cui
razzolavano polli e a volte anche una casetta per i porci. L'umidità
mattutina della giungla ovattava il campo in una nebbia fitta
e granulosa che abbracciava tutta la valle e la vegetazione
trasudante tutto intorno, e solo alcuni buchi passeggeri nel
vapore permettevano a tratti di intravedere i crinali delle
alture circostanti e i campi coltivati a fondo valle. I pochi
strumenti linguistici acquisiti in un mese trascorso in Birmania
si sono rivelati inutili: i karen di Mae La non parlano
birmano, parlano karen. Fortunatamente ho incontrato
Gedeon, un giovane karen che ha studiato inglese nel
campo, il quale mi ha raccontato la sua storia e si è
offerto di farmi da guida nel campo. I genitori di Gedeon sono
stati uccisi sei anni fa dall'esercito birmano. Fucilati a freddo
e senza colpa sulla nuda terra. Non erano soldati e non facevano
parte dei gruppi armati, erano semplici contadini karen,
con il solo torto di trovarsi nel posto sbagliato al momento
sbagliato all'arrivo dell'esercito pacificatore. L'unico parente
in vita di Gedeon, uno zio, si trovava nel campo di Mae La da
anni e gli ha proposto di raggiungerlo. Senza più le
impronte di una famiglia davanti ai suoi passi, in una casa
vuota, su una terra di assassini e campi minati, Gedeon ha camminato
per due settimane, dormendo nella giungla, fino a raggiungere
il campo, dove vive da sei anni. Gli ho domandato di condurmi
al monastero più vicino, specificando che non voglio
incontrare militari né operatori di Ong lungo la via.
Gedeon non aveva certo più simpatia di me per le forze
armate, comprende la situazione e mi mostra la via.
Senza conoscere a fondo il campo, di primo acchito è
facile abbandonarsi a impressioni romantiche e fantasie ad occhi
aperti. Si apre davanti allo sguardo una società senza
stato, senza polizia, senza documenti; una società costruita
su relazioni spontanee da conoscere e indagare, una comunità
pre-sociale da salvare, accudire, educare, da convertire per
alcuni. Si apprende poi che dentro il campo si verifica la stessa
criminalità vigente nel mondo esterno, che la corruzione
è alle stelle e che un chief commander incassa
fra i 10 e i 20 mila euro al mese di mazzette per vedere certe
cose e non vederne altre, con pieno controllo su tutta l'area;
si scopre che famiglie di ricchi musulmani sono arrivate da
fuori esclusivamente per fare affari, con il benestare delle
autorità corrotte. Si viene a sapere che ogni notte alle
21 c'è il coprifuoco, che esiste un servizio d'ordine
gestito da rifugiati e che i cattolici, culto predatore, fanno
spudorata opera di conversione nel campo in cambio di servizi
al non-cittadino, ai danni della comunità buddhista meno
provvista di capitali occidentali erogati via Ong. La presenza
di Ong nel campo, cristiane o meno, è massiccia e provvede
alla fornitura di servizi basilari come acqua, elettricità,
istruzione di primo e secondo livello. Vedo che tutte le abitazioni
sono numerate e Gedeon mi spiega che anche gli abitanti sono
suddivisi in due categorie: vecchi e nuovi. Mi dice che ai primi
è stata rilasciata una sorta di carta di registrazione,
che consente loro di interfacciarsi con Ong e autorità
thai, di svolgere alcuni lavori retribuiti e di partecipare
ai programmi di integrazione all'estero. I secondi, fra cui
lui stesso, non esistono.
Dopo una lunga camminata attraverso l'Area C del campo, giungiamo
in cima ad una collina sfavillante di panni arancioni sbattuti
dal vento contro il cielo turchino del primo pomeriggio, collina
su cui sorge uno dei tre templi buddhisti che si trovano all'interno
di Mae La. Faccio subito il nome del mio monaco fra i novizi,
solo per scoprire che sfortunatamente non fa parte di questo
monastero, mentre nessun monaco maturo sa dirmi dove si trovi.
Mostro allora il suo numero di telefono al monaco superiore,
il quale, estratto il suo iPhone dalla tonaca zafferano, inoltra
la telefonata per me. I novizi fuori dal monastero giocano a
chillou, sorta di tennis palleggiato con le gambe, facendo
volare una leggera palla di vimini intrecciati delle dimensioni
di una noce di cocco oltre una rete tesa fra le due metà
di un campo. Circa mezz'ora dopo, vedo arrivare il mio monaco,
che si arrampica sulla collina con un'agile motocicletta 125.
Ci sediamo a terra, sulle assi scure e lucide di una terrazza
ombrosa, sotto il sorriso bonario e dorato di una statua del
Buddha. U Tilawca è nato nel 1982 e non è sempre
stato un monaco; prima di indossare l'abito faceva parte del
Ndl, il partito di Aung San Suu Kyi, e in queste vesti ha partecipato
agli eventi della Rivoluzione Zafferano.
 |
| U Tilawca |
U Tilawca, come sei arrivato al campo di Mae La?
«Dopo i fatti del settembre 2007 sono scappato dalla Birmania.
Sono stato in Malesia fino al 2008. Ho attraversato il fiume
di notte, poi ho viaggiato attraverso la Thailandia con bus,
barche, macchine, contrabbandieri, mazzette. Un amico musulmano
mi ha organizzato il viaggio, e sono partito. C'era troppo sangue
per le strade. Quando le acque si sono calmate ho deciso di
rientrare in Birmania, ma nel gennaio 2008, quando sono arrivato
alla frontiera di Mae Sot, gli ufficiali allo sportello mi hanno
portato via la carta di identità. Mi hanno guardato,
hanno controllato una qualche lista, si sono presi il mio documento
e mi hanno detto di andarmene, che non ero il benvenuto, di
tornare da dove venivo e che il mio documento sarebbe stato
mandato direttamente al governo. Mi sono trovato improvvisamente
in bilico, senza terra sotto i piedi: da un lato del fiume c'era
la frontiera thailandese, dall'altro quella birmana, ero fra
i due ingressi, entrambi chiusi, e non potevo andare né
da una parte né dall'altra, ero bloccato nella terra
di nessuno. Non sapevo dove andare, così ho preso la
via del fiume, sono passato nella foresta e sono arrivato fino
al campo. Vivo qui da cinque anni.»
Cosa pensi dell'intervento dei monaci nella Rivoluzione
Zafferano, tu che non eri ancora monaco in quel periodo?
«No infatti, la mia situazione era diversa, non indossavo
gli abiti del monaco quando iniziarono le sommosse, facevo parte
del Ndl. Le proteste erano già in corso quando i monaci
hanno deciso di darci il loro supporto, a fine agosto. Il Ndl
Generation Wave, 88 Generation, gli studenti, eravamo tutti
in fermento, ma l'intervento dei monaci buddhisti ha dato un
supporto e una legittimazione enorme al movimento di protesta.
I musulmani hanno fatto lo stesso più avanti, il 24 settembre,
quando sono scesi in strada fianco a fianco con i monaci buddhisti,
ma ovviamente erano meno. Il messaggio dei monaci era talmente
forte che la junta si è spaventata. Prima ha cercato
di screditare il fenomeno dicendo che quelli in protesta non
erano veri monaci, poi, quando la popolazione di Rangoon ha
preso parte e fu chiaro che la propaganda non bastava, sono
passati alle mani. Il 26 settembre hanno ammazzato tre monaci,
due a forza di botte e uno sparandogli a bruciapelo. Si appellavano
ai diktat: l'ordinamento 7/90 proibiva ai monaci di partecipare
a iniziative non religiose, di pronunciare sermoni di contenuto
politico e di iscriversi ai partiti. Capivano bene l'importanza
dell'intervento dei monaci. Dopo le violenze molti ufficiali
hanno aumentato le loro offerte ai monasteri, e a Pakokku hanno
offerto 30.000 kyat ai monaci come rimborso per le botte, cercando
di insabbiare i fatti, di accattivarsi simpatie, di rimediare.
L'intervento dei monaci nelle nostre file è stato inestimabile,
è diventato il centro della Rivoluzione Zafferano. Non
era la prima volta che i monaci intervenivano politicamente.
Già nel 1990 quelli di Mandalay avevano boicottato le
elemosine dei militari, che è il più grande schiaffo
possibile da parte loro, significa che il legame sociale di
interdipendenza, con tutto ciò che rappresenta per la
comunità religiosa, è infranto.»
 |
| Un profugo karen, vittima
di una mina anti-uomo |
Chi ha la responsabilità delle violenze di settembre?
«I generali naturalmente, con i loro nomi e cognomi, e
tutti i loro soldati senza nome. Il generale Than Shwe, il generale
Maung Aye, il generale Thura Shwe Man. Da tempo soffocavano
il paese di tasse, usavano le armi contro la popolazione, contro
le minoranze che chiedevano l'indipendenza, contro i Kachin,
i karen, i Lissu, i Pa-o, i Chin,
i Kayan e tutti gli altri gruppi. Eravamo tutti uniti
contro di loro: il partito Ndl, gli studenti, la All Burma Monks
Alliance, Generation Wave, tutti. I monaci chiedevano una democrazia,
scuse ufficiali per le violenze subite, la fine della guerra
alle minoranze e la liberazione dei prigionieri politici: Suu
Kyi, Min Ko Naing, Ko Ko Gyi, Ko Htay Kywe, Ma Su, Su Nway.
Tutte richieste legittime. Il 28 e 29 settembre i militari hanno
sparato ancora, hanno raso al suolo i monasteri con i carri
armati per ordine dei generali, hanno sparato a un reporter
giapponese, si chiamava Kenji Nagai, e hanno distrutto il monastero
di Ngway Kyas Yan a Rangoon. Hanno iniziato la caccia al monaco
e messo in galera tutti i nemici politici, chi voleva cambiare
le cose. In prigione, oltre alle torture, alle umiliazioni,
alla malnutrizione, nell'acqua c'erano residui di piombo e la
facevano bere ai prigionieri, avvelenandoli. U Gambira è
uscito malato, aveva tutta la pelle macchiata, poi ha perso
la testa. I generali e i loro soldati hanno la piena responsabilità
di tutto questo, tanto delle cause e quanto delle conseguenze.»
Mantieni i rapporti con il Ndl di Suu Kyi dal campo di
Mae La?
«No, ho lasciato il partito quando sono tornato dalla
Malesia, nel 2008. Ho cambiato vita. Arrivato a Mae La ho indossato
gli abiti del monaco, ora qui insegno la lingua birmana, quella
inglese e matematica. Cerco di diffondere istruzione dal basso,
la politica di partito non mi interessa più. Le mie idee
sono cambiate, credo che Suu Kyi non possa salvare la nazione,
la popolazione non ha istruzione, i buddhisti sono in lotta
con i musulmani che arrivano dal Bangladesh, i cristiani cercano
di convertire i buddhisti, di stravolgere la nostra società.
Non sono problemi che può risolvere lei, lei fa la sua
vita politica, cerca di mediare, troppo, non prende parte e
parla vagamente di pace, non si capisce da che parte stia. Ha
un'etica diplomatica che non fa i conti con i conflitti più
urgenti nella nostra società; ci servono soluzioni, non
discorsi diplomatici. Non basta condannare il fervore religioso
con un bel discorso pubblico, è giusto ma non basta.
Bisogna preservare la religione buddhista dalle conversioni,
e dalle lotte. Noi non siamo una religione di conversione, ci
possono estinguere. I cristiani hanno supporti enormi che noi
non abbiamo. L'Europa e l'Occidente in generale li hanno, noi
siamo allo sbando, frammentati. Mi hanno chiamato anche tra
le file dell'esercito karen. Ho rifiutato. Non voglio
saperne di eserciti e armi, sono violenti, ignoranti, io cerco
di diffondere sapere, la via del Buddha, la non violenza. Dato
che non posso tornare in Birmania, cerco di fare quello che
posso qui, nel campo, senza partiti né stati.»
Come è organizzato socialmente il campo? E cosa
fanno qui le Ong?
«L'area più estesa è la C, dove ci troviamo
ora. Qui ci sono gruppi karen, Kachin, Lissu,
Pa-o, Chin, Kayan, musulmani. Nell'area
B non ci sono musulmani invece, perché è piena
di cristiani. Nell'area A ci sono ancora cristiani, buddhisti,
soldati karen, Shan. Ma i gruppi sono molto ramificati
dentro Mae La, non ci sono veri confini. Qui non si parla birmano,
non si parla thai, si parla karen. In cima alla piramide
ci sono le autorità thai, poi una commissione rifugiati,
poi coordinatori, Ong e Un. Le Ong sono ovunque nel campo, forniscono
servizi sanitari, istruzione, costruiscono toilettes, depurano
le acque, distribuiscono razioni. Fanno tante cose, ma non ci
aiutano con le questioni più importanti, non ci aiutano
con i documenti, non vanno alla radice, qui ci servono passaporti
per andarcene, per acquisire diritti, non solo assistenzialismo.»
 |
| Il campo profughi di Mae La |
Saluto il monaco U Thilawca e lo ringrazio per le sue parole.
Il sole dalla cima della collina mostra i colori del declino,
si prepara a scomparire tutto in una volta come accade a queste
latitudini, tirandosi subito dietro la notte come un lenzuolo
a strascico, senza concedere l'intervallo della sera. Alle sei
sarà già notte fonda, non ho molto tempo per ritrovare
il punto da quale sono entrato e riattraversarlo di nascosto.
Poco prima delle sei, inoltre, passerà l'ultimo songthaew
pubblico, che mi conviene prendere al volo. Seguo Gedeon, che
ricalca i nostri passi fino alla sua abitazione per vie secondarie,
e prima di salutarmi, avendo ascoltato attententamente la mia
conversazione con il suo monaco, mi regala un dossier sulla
Rivoluzione Zafferano: Bullets in the Alms Bowl, proveniente
da una ex biblioteca del campo profughi.
Con la breve distanza dei primi passi fra me e l'eterotopia
di Mae La, inizio a sentirmi più calmo, e ripensando
alle interviste a quei garofani dell'aria, alle violenze di
stato contro le minoranze birmane, al sacro attivismo dei monaci
buddhisti e alla vita quotidiana dei 60.000 non-cittadini del
campo profughi, mi appresto a raccontare una storia di campi,
rivoluzioni e monaci birmani.
Moreno Paulon
|

