
 Fantascienza
e pedagogia/
Fobie, magie, resistenze e utopieQuando c'era il futuro (Franco Angeli, 2013) di Daniele
Barbieri e Raffaele Mantegazza esplora i confini e i punti di
contatto fra pedagogia e fantascienza. Ma ha senso parlare di
science fiction nel 2013? Esistono chiavi di lettura
valide anche per l'impegno politico-sociale dell'oggi? Ne ho
parlato con Daniele Barbieri.
Perché avete scritto un libro all'incrocio fra
pedagogia e fantascienza?
«È la prima volta che io e Raffaele Mantegazza
ci incrociamo, anche se abbiamo passioni e interessi comuni.
Lui usa la fantascienza nelle sue lezioni all'università
e immagino che constati spesso il fenomeno che io osservo lavorando
nelle scuole o altrove.
Immaginiamo di affrontare un nodo drammatico: può essere
la violenza sessuale, l'apatia politica, le molte facce del
razzismo e la stessa definizione di umanità, le catastrofi
ecologiche in corso e il tentativo di uscirne, e così
via. Se si prende il problema di petto, cercando stimoli nella
situazione data (cioè la scuola che, salvo rarissime
eccezioni, versa in condizioni di agonia) quasi mai si suscita
una passione autentica. Al massimo si registra un apprendimento
di tipo passivo. Persino i drammi vicini a noi in un contesto
scolastico sembrano ancora più lontani di Leopardi o
Boccaccio.
Sarebbe complesso spiegare il perché in due parole ma
la narrazione fantascientifica, il laboratorio che gioca a immaginare
futuri, la provocazione di ragionare a partire da qualcosa assolutamente
estraneo alla nostra attuale esperienza, possono invece spalancare
più facilmente porte che di solito sono chiuse.»
Cos'è oggi la fantascienza?
«La migliore fantascienza secondo me è un grimaldello
per uscire da un presente pigro e politicamente ingabbiato,
soprattutto oggi. Credo che per Raffaele Mantegazza la pedagogia
(e dentro di essa la fantascienza) sia uno degli strumenti per
contrastare l'oppressione. È chiaro che alcuni autori
e alcune autrici hanno una formazione scientifica e questo influenza
tutto ciò che scrivono ma è altrettanto palese
che la maggioranza dei libri di fantascienza nasce da persone
che non hanno la minima infarinatura scientifica. Ma tutti e
tutte – chi scrive come chi legge – devono fare
i conti con due questioni che non mi stanco di ripetere. La
prima è che da un secolo circa la scienza e la sua cuginetta
tecnologia hanno invaso le vite delle persone prima di una parte
del mondo e poi dappertutto. Impensabile dunque che ciò
non influenzi anche il nostro immaginario.
Seconda questione: noi viviamo in una società scientifico-tecnologica
senza avere la minima formazione, senza le conoscenze di base
per capirne leggi e regole. Quindi in una sorta di tecno-magia
che rende impossibile il controllo, persino la comprensione
di come i poteri usano la conoscenza scientifica e le sue applicazioni.»
C'è qualcosa di nuovo nella fantascienza contemporanea?
«Si vorrebbe morta la science fiction ma è
viva (pur se con gli inevitabili acciacchi di chi vive in una
fase storica depressiva). Da poco Urania ha portato in edicola
una trilogia di Robert Saywer. La storia inizia quando nella
rete internet nasce Webmind, entità intelligente e incorporea.
Il canadese Saywer ne esplora soprattutto il versante positivo
e ottimista. Non è un ingenuo, ha ben presente rischi
e contraddizioni ma questa trilogia comunica che la parte migliore
dell'umanità potrebbe trovare un alleato non previsto.
Se il “meticciato” fra una rete intelligente altamente
evoluta e il genere umano ci porta su una strada di liberazione
ne ricaveremo non solo meno guai e più giustizia ma anche
felicità, se si può usare questa parola così
difficile. Resto assai sorpreso che molte persone considerino
pericoloso seguire Sawyer su questa strada. A parte che io non
considero il novecento portatore solamente di catastrofi, per
me questa visione cupa è un freno all'azione, una “museruola”
al pensare. Di fronte a una crisi mondiale inventata, come quella
che viviamo, è molto difficile portare le persone a constatare
che non esiste soltanto una ricchezza economica enorme da redistribuire
secondo giustizia, che non esiste soltanto la possibilità
di risolvere la maggior parte delle tragedie mondiali fermando
il meccanismo che produce e alimenta le guerre: c'è anche
una ricchezza sociale diffusa in tutto il mondo, intelligenze
ed esperienze che il capitalismo dilapida, anzi perseguita.
Se non prendiamo atto di questa enorme potenzialità non
troveremo ragioni di opporci davvero a chi vuole lasciare tutto
com'è.»
Andrea Mameli
linguaggiomacchina.it
 Desiderare
la libertàÈ uscito recentemente per elèuthera Fantasie
rivoluzionarie e zone autonome di Saul Newman (Milano 2013,
pp.84, € 8,00). Ne pubblichiamo la prefazione all'edizione
italiana.
Due anni fa elèuthera diede alle stampe uno dei miei
saggi, raccolto insieme a contributi di Simon Critchley, Miguel
Abensour, Todd May e altri, in un volume sull'anarchismo e la
filosofia radicale. Esprimo la mia gratitudine nei confronti
dei curatori che hanno promosso la pubblicazione di un altro
dei miei scritti, e sono onorato che il mio lavoro sia stato
reso accessibile ancora una volta al pubblico italiano. Elèuthera
è un editore che ammiro da tempo per il suo impegno sperimentale
e d'avanguardia rivolto alla filosofia europea, alla teoria
politica radicale e in particolar modo all'anarchismo. L'anarchismo,
sia come tradizione eretica di pensiero, movimenti e lotte,
sia come etica e politica di ispirazione anti-autoritaria, è
stato per lungo tempo l'asse portante del mio lavoro; il suo
impulso critico e il desiderio di estendere le possibilità
della libertà umana sono stati le mie linee guida e hanno
costituito l'orizzonte del mio pensiero. Anzi, mi è impossibile
pensare criticamente alla sfera del politico senza confrontarmi
con le domande e le sfide fondamentali poste dall'anarchismo.
La pratica politica, e in particolare quella radicale, deve
continuamente misurarsi con le forme dell'anti-politica, un
ambito decostruttivo con derive anarchiche in cui le identità
fisse, le istituzioni, le relazioni sociali sono radicalmente
destabilizzate. In effetti, questa visione dell'anarchia ha
sempre ossessionato, in un modo o nell'altro, la teoria politica;
per alcuni si incarna in una concezione distopica dello stato
di natura, per altri (gli stessi anarchici, ad esempio) esprime
le possibilità di un'organizzazione sociale cooperativa
senza la necessità di uno Stato sovrano. In entrambi
i casi, l'orizzonte anarchico pone una sfida cruciale a tutte
le forme politiche basate sulla sovranità. Sono in molti
oggi a parlare di una “fase anarchica” quando si
tratta di descrivere le forme contemporanee di attivismo politico
radicale. Dalla nascita del movimento globale anti-capitalista
alla fine degli anni novanta, fino ai recenti movimenti di occupazione
apparsi tutto il mondo (nei quali includerei l'occupazione di
piazza Tahrir al Cairo, poiché tale è stata la
sua ispirazione), abbiamo visto nuove forme di azione orizzontale
o “a rete” che sembrano, se non ispirate direttamente
dai principi anarchici, almeno un loro chiaro riflesso. Inoltre,
si è verificato un netto passaggio dai modelli politici
avanguardisti di tipo marxista a più diffuse forme di
partecipazione e di soggettività post-identitarie, eterogenee,
il cui obiettivo non è più quello di appropriarsi
delle redini del potere statale, quanto piuttosto di dissolvere
questo stesso potere e di creare politiche, pratiche e spazi
autonomi che lo oltrepassino. Il mio lavoro sulla teoria politica
radicale risponde, e cerca di attribuire un senso, proprio a
questi sviluppi. Che ci chiedono in modo forte una riconsiderazione
dell'anarchismo, anzi un ritorno all'anarchismo.
Ma quale tipo di ritorno è possibile nella condizione
attuale? Questa è una domanda complessa. Da un lato,
vi è sempre stato un impulso insurrezionale, una volontà
di resistere (che Michel Foucault avrebbe definito una “qualità
plebea”, un'energia capace di arginare il potere resistendo
alla produzione di corpi docili, e che Michail Bakunin avrebbe
invece definito “istinto di rivolta”), ovvero un
desiderio libertario che ovviamente trascende l'anarchismo,
ma di cui la tradizione anarchica è diventata l'espressione
più schietta e coerente. Quella che ha trasformato l'istinto
di rivolta in una teoria, in una filosofia, in un'etica, in
una scienza sociale e soprattutto in una politica. Qualsiasi
tipo di rinnovamento dell'anarchismo deve prendere come punto
di partenza fondamentale il suo principio etico: la resistenza
al potere. Dall'altro lato, prendere l'anarchismo sul serio
significa valutarlo onestamente in quanto tradizione di pensiero
e di pratiche forgiata da precise coordinate filosofiche e fondata
su alcuni assiomi riguardanti il comportamento umano, la conoscenza,
la morale e le relazioni sociali. Se dobbiamo riflettere oggi
sull'importanza dell'anarchismo, non possiamo permetterci di
essere ciechi verso le sue tensioni, le sue aporie, i suoi limiti,
i suoi passaggi contraddittori, i suoi filoni di pensiero eterogenei
e talora contrastanti.
Dobbiamo ricostruire una genealogia dell'anarchismo nel senso
di Friedrich Nietzsche e di Foucault. Questo comporta qualcosa
di più che passare il nostro tempo a spluciare gli archivi;
piuttosto, si tratta di riconoscere che la nostra eredità
comune è anche “un insieme di faglie, di crepe,
di strati eterogenei che la rendono instabile e, dall'interno
o dal basso, minacciano il fragile erede”. Pertanto, ho
sostenuto che l'anarchismo dovrebbe prendere in considerazione
alcuni sviluppi teorici che inizialmente gli pongono alcuni
problemi, tanto da sembrare addirittura in contrasto con esso,
ma che allo stesso tempo lo costringono a pensare entro certe
condizioni, sia teoriche sia politiche (ad esempio i limiti
del potere, del discorso, i regimi di verità e di conoscenza,
l'inconscio e così via).
Mi riferisco qui alle importanti implicazioni della teoria psicoanalitica
e post-strutturalista per la riflessione politica, ed è
proprio nel tentativo di fare una sintesi tra questi elementi
e l'anarchismo (cercando di condurli a sostenersi l'un l'altro,
a pensarsi l'uno attraverso l'altro) che è possibile
parlare di un post-anarchismo. Questo è una definizione
che ha causato molti fraintendimenti (e forse, con il senno
di poi, la scelta del termine non è stata così
felice), ma con essa non si è mai voluto suggerire che
l'anarchismo si sia estinto oppure sia stato superato. Il prefisso
«post» non vuole significare un essere dopo, ma
al contrario invita a una rinegoziazione dell'anarchismo, a
un tentativo di rivitalizzare ed esplorare la sua rilevanza
per le lotte contemporanee, per i movimenti e per la sperimentazione
politica. Come il post-modernismo non è il seguito della
modernità ma piuttosto una riflessione critica sui suoi
limiti, e allo stesso modo (come ha suggerito Foucault) la critica
dell'Illuminismo fa proprio lo spirito critico dell'Illuminismo
stesso, così il post-anarchismo può essere considerato
come una sorta di apparato che propone una riflessione sui limiti
dell'anarchismo, ma collocandosi al suo interno. Il post-anarchismo
è quindi un tentativo di rinnovare teoria e pratica anarchiche.
Si tratta di un modo di intendere la politica radicale in termini
di contingenza e divenire, attraverso attività autonome
e forme di azione diretta. I temi analizzati nel presente saggio,
originariamente scritto per una rivista dedicata alla teoria
della pianificazione2, rappresentano il tentativo di pensare
ai vari modi in cui il post-anarchismo potrebbe riformulare
la nostra concezione dello spazio politico. La questione dello
spazio (spazi fisici, spazi sociali, ma anche spazi psicologici
e paesaggi) è presa raramente in considerazione nella
teoria politica radicale, ma è sempre lì presente
e ha un impatto incommensurabile sulla nostra percezione, in
ogni lotta politica, di ciò che è possibile. Se,
come ha mostrato Foucault, la disposizione degli spazi fisici
è sempre una questione politica, parimenti si potrebbe
sostenere che la politica è sempre una questione spaziale.
La politica radicale presuppone certi immaginari dimensionali,
una certa mappatura di territori passati, presenti, futuri.
La stessa rivoluzione avviene in un luogo particolare: il pensiero
rivoluzionario concepisce un settore strategico, una disposizione
di forze e di relazioni di potere, un obiettivo centrale da
sequestrare o distruggere. Non si può fare a meno di
pensare a simboli e punti di riferimento fisici come la Bastiglia
o il Palazzo d'Inverno. In questo saggio, il mio obiettivo è
non solo quello di indagare se sia possibile una concezione
alternativa dello spazio politico radicale, ma anche quello
di esplorare (con il supporto della teoria psicoanalitica lacaniana
e del pensiero di Cornelius Castoriadis) alcune delle fantasie
fondamentali che sono alla base delle pratiche politiche radicali.
È attraverso l'anarchismo – o meglio il post-anarchismo
– che possiamo ottenere una diversa comprensione dello
spazio politico, una concezione in cui pratiche, stili di vita
e forme di resistenza autonome, anziché disperdersi nella
grande narrazione della Rivoluzione, concorrono a costituire
una pluralità di luoghi. Se guardiamo agli squat, ai
centri sociali, alle cooperative di ogni genere, ai media alternativi,
alle comuni, sono tutte realtà che possono essere viste
come sperimentazioni spaziali autonome, situate sia all'interno
sia all'esterno del “sistema”. Questo aspetto è
importante anche per il nostro modo di pensare alla progettazione
degli spazi urbani e alle modalità con cui vengono prese
le decisioni di pianificazione: se come attività intrapresa
da un'élite tecnocratica di specialisti, o come forma
di attivismo autonomo e democratico intrapreso dalla gente comune
in contesti locali. Ora che tanti spazi pubblici e servizi sono
stati privatizzati (passando dal controllo dello Stato al controllo
aziendale), è il momento di ripensare gli spazi comuni,
in opposizione a questo processo, come luoghi radicalmente aperti
e non controllati. Riformulata così, la pianificazione
può diventare un'attività insurrezionale. Di conseguenza,
diventa qui fondamentale l'idea di insurrezione piuttosto che
quella di Rivoluzione. Questo passaggio può essere inteso
in molti modi, ed è irrinunciabile per il pensiero anarchico
e la sua politica. Seguendo Max Stirner (e in qualche misura
anche Gustav Landauer), con insurrezione intendo un tipo di
trasformazione micropolitica in cui i nostri soggettivi legami
psicologici con il potere vengono effettivamente sciolti. Non
ci può essere alcuna trasformazione sociale radicale
se essa non avviene innanzi tutto al livello del desiderio individuale
e collettivo, il che comporta di imparare a desiderare in modo
diverso: ossia a desiderare la nostra libertà, piuttosto
che la nostra attuale servitù.
Saul Newman
Un prete, i gay,
l'Arcigay, l'Aids
“Don Marco mi è stato padre, fratello maggiore...
Penso a don Marco quando leggo l'Ecclesiaste. Persino la sua
celebrazione dell'eros era quanto di più lontano da un'idea
consumistica, strumentale della sessualità ci potesse
essere, anche quando si è allontanato dal sacerdozio,
persino quando sembrava rinnegare il sacerdozio, non sapeva
far altro che celebrare la vita. Lui aveva il carisma di questo
speciale sacerdozio. Il suo è stato il dio che danza
la vita...”. Così Nichi Vendola ricorda don Marco
Bisceglia chiamato il “don Enzo Mazzi del Sud”,
in quanto animatore di una di quelle comunità di base
che si svilupparono spontaneamente pure all'interno della chiesa
italiana fra gli anni sessanta-settanta. Ma il nome di don Marco
oggi è legato anche a importanti e difficili battaglie
civili: da fondatore dell'Arcigay nazionale fu colui che, più
di altri, si profuse per legittimare i diritti degli omosessuali
e per strutturare uno spazio di lotta che – come ammette
lo stesso Nichi Vendola (che lavorò a Roma gomito a gomito
con il sacerdote) – potesse obbligare i partiti al confronto
su determinate tematiche.
A don Bisceglia, che non nascose la sua omosessualità
e dedicò tutta la vita e il sacerdozio ai poveri fino
a essere sospeso a divinis da una chiesa molto pre-concilio,
il giornalista Rocco Pezzano ha dedicato Troppo amore ti
ucciderà (Edigrafema Edizioni, 2013, pp. 320, €
16,00). Il libro è una appassionante biografia, che ripercorre
le tappe dell'impegno politico e civile del prete.
Don Marco nasce nel 1925 a Lavello, in provincia di Potenza,
studia dai gesuiti e diventa discepolo in Spagna di padre Díez-Alegría,
uno dei più grandi teologi del novecento, sostenitore
della teologia della liberazione e voce in netto stridore con
quei vertici della chiesa cattolica che, secondo lui, avevano
tradito Gesù. Ordinato sacerdote nel 1963, don Marco
l'anno successivo viene nominato parroco del Sacro Cuore di
Lavello. Qui inizia a portare avanti una pastorale da curato
di strada, cercando di rendere vivo nella vita di tutti i giorni
il verbo delle Scritture. Promossa da don Bisceglia, nasce a
Lavello una Comunità di base che si farà portavoce
di un certo dissenso e malcontento che era andato maturando
anche tra i cattolici. Sempre in prima fila a combattere per
i diritti della sua gente, don Marco si fa portavoce di un Cristo
umile, che si incontra da una parte come “brezza leggera”
e dall'altra in tutti gli uomini che soffrono.
Per questo suo sentire a portare la croce più sulle spalle
che sul petto e stare a fianco delle rivendicazioni e delle
proteste della sua gente, verrà rinviato in giudizio
nel 1972. Troppo scomodo, don Bisceglia è soggetto a
continui richiami dalla Curia, mentre a Lavello c'è chi
vede dannoso il legame che ha stretto coi i fedeli che frequentano
il Sacro Cuore. Tanto dannoso che pure i giornali nazionali
cominceranno a tendere a interessarsi a lui, fino al definitivo
allontanamento da parte del vescovo. La sua uscita di scena
però non sarà facile: il 25 ottobre del 1978 dovrà
arrivare a Lavello un consistente drappello di poliziotti e
carabinieri per porre fine alla protesta in chiesa dei fedeli,
che non vogliono che il loro parroco venga messo alla porta.
Don Bisceglia andrà via da Lavello con il cuore affranto
per il distacco dalla famiglia (in particolare dall'amata sorella
Anita), dalla sua umile gente, dai quei giovani che avevano
visto in lui un punto di riferimento. Si trasferirà a
Roma, dove troverà accoglienza e lavoro e, con l'Arci,
inizierà le sue lotte per i diritti dei gay. Trascinatore
di folle e intelligenza vivacissima, don Marco nella capitale
frequenterà i radicali di Marco Pannella (che lo volle
candidato alle legislative nel 1979, ma i 6000 consensi non
furono sufficienti per farlo eleggere) e i movimenti vicini
alla sinistra radicale, dediti a portare avanti le sue stesse
battaglie per i diritti civili. Finché, a metà
degli anni ottanta, si perdono le sue tracce.
Don Bisceglia ritornerà alla sua chiesa negli ultimi
anni di vita (morirà di Aids nel 2002), tant'è
che il Vaticano gli riconsegnerà la facoltà di
poter dir messa, ma il sacerdote ritrovato non sarà più
quello della parrocchia del Sacro Cuore, scomodo e scandaloso.
Sarà, per don Marco un momento di riflessione profondo,
in cui fare i conti con le proprie controversie e complessità.
Sarà il tempo della preghiera e della meditazione su
una vita apparsa, in tutti i suoi risvolti, intensissima e appassionante.
Come sono appassionanti le pagine che Rocco Pezzano passa in
dono ai lettori sulle “tre vite di don Marco Bisceglia”.
Mimmo Mastrangelo
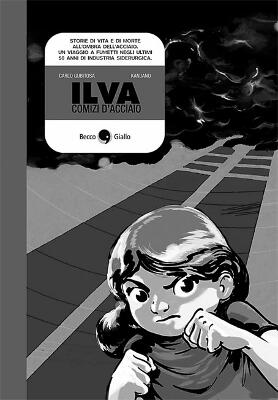 A
fumetti,
contro l'inquinamentoCarlo Gubitosa e Giuliano Cangiano (Kanjano), autori del libro
dal titolo ILVA. Comizi d'acciaio (Edizioni BeccoGiallo,
2013, pp. 192, € 12,00) narrano, tramite l'arte del fumetto,
un viaggio inedito negli ultimi cinquant'anni di industria siderurgica,
in cui si racconta il “male oscuro dell'inquinamento”,
attraverso storie di vita e di morte all'ombra dell'acciaio;
storie di scontri tra “Davide e Golia”: cittadini
e lavoratori si trovano a lottare contro politica, malaffare,
industria e grandi sindacati; storie di sfruttamento del clima,
dell'ambiente, del territorio, in nome di un'illogica, sfrenata
ed egoistica speculazione produttiva.
Il caso Taranto, come molte altre realtà lavorative e
operaie, vede i diritti alla salute e alla vita soppiantati
e violati dalla ricerca del massimo profitto dei padroni, votati
al sistema capitalistico, all'ordine militare sovranazionale
e mondiale, per il becero ricatto neoliberista tra lavoro o
salute, imposto dagli ingranaggi di potere, dai poteri forti,
da una politica locale connivente, corrotta. I cittadini e gli
ecopacifisti attivisti di Taranto, tramite l'associazionismo
ambientalista, da anni lottano contro il mostro dell'acciaio,
contro il siderurgico infernale che emette sostanze tossiche
(e non solo nel quartiere Tamburi) e nel frattempo cittadini,
lavoratori e operai continuano a morire di inquinamento industriale,
perché a Taranto è elevatissimo il tasso epidemiologico
di incidenza tumorale. L'associazione pacifista e ambientalista
PeaceLink, in primis, a Taranto, ha sollevato un autentico
terremoto politico-giudiziario, una contrapposizione netta tra
partiti (politica partitica) e magistratura. Il gip di Taranto,
Patrizia Todisco, con il provvedimento di sequestro, nella sentenza
del luglio 2012, dichiara esplicitamente: “con la salute
la vita non si può mercanteggiare”. I poteri forti
(partiti, sindacati, chiesa) troppo spesso sono rimasti in silenzio.
Con l'omertà si è nascosta la verità, già
nota da tempo, fatta di inquinamento, malattia, morte.
Come attivista Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d'Italia)
mi sento in dovere di constatare che i veri partigiani contemporanei
sono tutti gli ecopacifisti attivisti contro le cosiddette Goi,
le grandi opere inutili e dannose, presenti, non solo in Italia,
ma anche in Europa e nel mondo (come il Tav, il Muos ecc.);
i magistrati che lottano contro la mafia e i poteri forti e
tutti coloro che portano avanti cause giuste e oneste, dove
vengono negati e calpestati i diritti umani, la verità
e la giustizia, dove la magistratura si fa garante della legalità
e della tutela dei principi cardine della Costituzione (come
il diritto alla salute), dove le altre istituzioni sono invece
spesso omertose e corrotte.
“Ma il mondo ha proprio bisogno di tutto questo acciaio?”.
Tale quesito pone, nella conclusione del libro, Alessandro Marescotti,
presidente di PeaceLink. “Sembra che senza la produzione
di acciaio dell'Ilva debbano crollare l'Italia, l'Europa e il
mondo intero. (...)Ma è davvero così?”.
In realtà la Commissione Europea parla di una produzione
eccessiva. Le grandi opere vengono finanziate dai poteri forti,
al fine di alimentare un mercato dell'acciaio ormai al tracollo.
Ma è giunta l'ora che il sistema economico del grande
capitale si renda conto del proprio collasso e della necessità
di investire, al contrario, sui beni comuni, come la pace e
l'ambiente, quali risorse principali della nostra comune umanità,
da cui derivano altre priorità consequenziali, come la
salute, la cultura, l'istruzione: la vita nella sua autentica
essenza!
È proprio questo il messaggio del libro di Gubitosa e
Kanjano: un grido forte di disperazione di tutti gli oppressi,
di tutti gli abitanti dei Sud del mondo schiacciati dalle bieche
logiche di mercato, dallo sfruttamento delle risorse energetiche.
Un inno alla vita, un urlo di protesta per rivendicare gli inalienabili
diritti a un'esistenza serena e felice, contro tutte le manovre
impositive dettate dai poteri forti, dallo strapotere economico
dei mercati dell'alta finanza, dai padroni dell'acciaio, dai
signori della guerra.
Laura Tussi
 Biologia,
etica hacker
e informazioneAlessandro Delfanti, sociologo dei nuovi media all'Università
degli studi di Milano, ricercatore presso la McGill University
di Montreal, ha da poco pubblicato per Elèuthera Biohacker.
Scienza aperta e società dell'informazione (pp.120,
€ 10,00).
Il tuo libro è stato pubblicato prima in inglese,
questa versione italiana sembra un po' diversa, ci vuoi spiegare
quali sono le differenze e come nasce?
«Il libro nasce dalla tesi di dottorato che ho fatto in
Scienza e società all'Università Statale di Milano.
Essendo stato anche all'estero l'ho scritta in inglese, pubblicare
il libro in inglese mi consente di raggiungere lettori non solo
italiani. Per quel che riguarda l'edizione italiana, l'idea
di fare una versione ridotta, ma anche un po' trasformata, è
nata per capire se questo tema poteva raggiungere un pubblico
più ampio, composto non solo da chi si occupa di queste
cose come ricercatore ma anche da chi è interessato alla
cultura libera, all'open source e al rapporto tra scienza e
società, senza essere per forza un addetto ai lavori.
È un'edizione più accessibile, il pubblico accademico
può leggere quella in inglese.»
Il titolo a cosa fa riferimento? Cosa vuol dire biohacker?
«La definizione biohacker è utilizzata come termine
per far capire che l'argomento del libro ruota intorno all'idea,
che ho cercato di descrivere, che le culture hacker e quelle
legate all'open source e al software libero stanno contaminando
la ricerca scientifica. Temi, pratiche e alcune caratteristiche
del movimento hacker si stanno diffondendo tra chi fa ricerca
scientifica, in particolare biologia. Il libro presenta casi
molto diversi, tra cui quello di alcune comunità che
usano questo termine per descriversi “Siamo hacker della
biologia”.
Questi gruppi sono composti da persone che non lavorano all'interno
delle mura della scienza, non lavorano nelle università
o in qualche casa farmaceutica ma cercano di fare ricerca biologica
in modo autonomo, autodidatta e indipendente dalle istituzioni.
È la cosiddetta biologia “fai da te”. Poi
ci sono i casi di ricercatori più tradizionali, che lavorano
nel settore pubblico, come Ilaria Capua, una ricercatrice italiana,
e di coloro che lavorano invece nel settore privato ma che condividono
la stessa spinta a condividere le informazioni.»
Nel caso della cosiddetta biologia “fai da te”
o D.I.Y. (do it yourself) o da garage, nel libro accenni al
fatto che in realtà si tratta di un fenomeno che non
sta producendo molte scoperte innovative o molti risultati scientificamente
rilevanti. Negli anni '70 e '80, nei garage avvenivano delle
cose importanti, mi riferisco a ciò che è stato
lo sviluppo dei personal computer e alla nascita del movimento
open source. Secondo te stiamo assistendo a qualcosa di simile?
«Una risposta sul futuro non sono sicuro di averla. In
questo momento le persone e i gruppi che hanno aperto laboratori
indipendenti, in cui si può andare e sperimentare con
la biologia, non stanno producendo sapere di livello paragonabile
a quello di chi fa ricerca nelle istituzioni scientifiche. Le
attrezzature sono costosissime, non è facile aprire un
laboratorio che possa competere con quelli delle università.
Nel libro cito una frase di Bill Gates che dice “Se avessi
diciott'anni oggi, farei hacking della biologia”, prospettando
un futuro di ragazzi che nel loro garage cambiano un'industria
e cambiano un settore economico, come è successo con
i computer negli anni '70.
Io non so cosa succederà, quello che è interessante
è che chi fa biologia in questo modo, con delle piccole
comunità di hacker della biologia, può non avere
delle competenze tecniche molto elevate ma contribuisce a creare
una cultura scientifica nuova, diffusa, fatta di partecipazione
e di una volontà di comprendere i meccanismi della scienza.
Come si fa un esperimento? Come funzionano le istituzioni? Come
si mette in piedi un laboratorio? Questioni tecniche e sociali.
Da questo punto di vista è interessante e divertente.
Per ora manca la possibilità tecnica di competere con
altri laboratori e manca una cultura critica che renda questo
settore paragonabile a quello dell'informatica, dove gli hacker
presentano anche una volontà di cambiare l'industria
del software e del computer. In molti casi, soprattutto negli
Stati Uniti, più che opporsi e cercare di cambiare le
dinamiche di potere su cui si reggono le industrie informatiche
o della ricerca, c'è l'idea che si possa contribuire
a una nuova industria.»
La privatizzazione della vita
Una parte del libro è dedicata proprio a questo
tema: come l'impresa scientifica sia cambiata negli ultimi vent'anni
rispetto a ciò che è stata nel '900. Sono tre
le figure che profili: quella del ricercatore universitario,
libero e indipendente, quella del ricercatore che lavora per
le imprese private, e si destreggia tra i brevetti, e quella
più recente del ricercatore che ha fatto propria l'etica
hacker. Metti bene in luce l'ambivalenza di queste figure e
quanto siano sfumati i loro contorni.
«Questa è uno dei punti principali che cerco di
sviluppare nel libro. Da una parte la questione della privatizzazione
della vita: imprese private che fanno ricerca per brevettare
i risultati, chiuderli, renderli inaccessibili e usarli solo
per il profitto dell'impresa invece di condividerli; questa
dinamica è in un certo senso cambiata, il brevetto non
è più l'unico strumento che le imprese possono
adoperare.
La cosa interessante della scienza aperta di oggi è che
presenta questa ambivalenza che nell'informatica è un
dato di fatto da tanto tempo. L'open source può essere
un modello di rottura capace di cambiare i modelli del capitalismo,
come nel caso del free software, ma può essere anche
una forma di innovazione sfruttata dalle imprese.»
Su questo argomento proprio Elèuthera aveva pubblicato,
ormai qualche anno fa, Open non è free del collettivo
Ippolita che spiegava queste dinamiche. Etica hacker, vuol dire
tante cose e al suo interno si possono rinvenire aspetti diversi
come il perseguimento di istanze libertarie e la ricerca del
profitto e del successo privato.
«Sì. Questi modelli possono tranquillamente diventare
modelli di accumulazione di profitti. E così sta succedendo
anche nella ricerca scientifica. Questo non vuol dire che non
esistono più i brevetti, a volte è conveniente
privatizzare, altre invece condividere ma essere poi in grado
di raccogliere più velocemente, e meglio degli altri,
i frutti della condivisione: per esempio fornendo servizi invece
che vendendo informazioni.
L'altro tema è il ruolo del singolo scienziato all'interno
di questa dinamica nuova. La cosa interessante è che
gli scienziati che decidono di condividere le informazioni possono
avere fini molto diversi; possono avere scopi liberali: permettere
l'accesso all'informazione anche ai paesi poveri (un tema classico
della scienza aperta), oppure possono agire per scopi di profitto,
quindi farlo perché questo permette di raccogliere finanziamenti
da diverse istituzioni o permette di raccogliere innovazioni
che vengono dalla rete e non solo dall'interno dell'azienda.»
Queste due dimensioni coesistono perfettamente, anzi sono
quasi complementari: più diffondi dati che possono essere
liberamente elaborati e più è possibile realizzare
un profitto economico se hai una struttura che te lo permette.
Spesso si pensa all'open access e a tutte le battaglie sull'informazione
libera come battaglie di frontiera di pratiche libertarie.
Questo è sicuramente vero ma d'altra parte ci sono
grossi gruppi economico-finanziari che non hanno nessuna difficoltà
a sfruttare il lavoro volontario di una comunità per
poi confezionare il prodotto e venderlo a suo nome ricavandoci
un profitto privato.
«Quello che fanno i movimenti per l'accesso aperto o per
la libertà d'informazione, secondo me è sacrosanto.
Fa parte di un ideale libertario, ma in alcuni casi semplicemente
liberale, di una democrazia basata sull'accesso all'informazione.
Quindi niente di quello che scrivo toglie che tutto questo sia
vero. Anzi lo ribadisco più volte. Io stesso sono un
attivista dei movimenti per la scienza aperta e la cultura libera,
quindi sono assolutamente a favore di tutto ciò e penso
sia importante. Questo non toglie che nei momenti in cui questi
fenomeni aumentano di importanza, le imprese sono in grado di
trovare il modo di sfruttare anche la condivisione e non solo
la privatizzazione.»
Condivisione delle informazioni e sfida alle istituzioni
Nel libro citi tre casi esemplari. Uno è quello
di John Craig Venter, uno quello di Ilaria Capua e per finire
quello di Salvatore Iaconesi. Tre casi molto differenti che
permettono di capire molte cose. La storia di Venter è
emblematica del legame tra ricerca libera e profitto economico.
«Sì, prendo in considerazione questi tre casi perché
sono esemplari per mostrare, tra le differenze che li caratterizzano,
alcuni tratti comuni: la volontà di condividere le informazioni
e il rifiuto delle burocrazie delle istituzioni; per scopi e
con metodi molto diversi, però. Nel caso di Capua abbiamo
una visione liberale della ricerca, per cui l'accesso delle
informazioni deve essere garantito a più ricercatori
possibili in più paesi possibili, perché permette
di sviluppare in modo più efficiente la ricerca con ricadute
sociali importanti (un tema classico dell'open access). Nel
caso di Venter, il tipo di informazioni raccolte non sono più
semplicemente privatizzabili e poi vendibili. È più
interessante capire quali servizi fornire su quei dati, quindi
condividerli permette di raccogliere capitali di provenienza
diversa e di sviluppare un modello differente, assolutamente
votato al profitto.»
Crea servizi per leggere i dati.
«Sì. Questo non significa che Venter non abbia
modelli di privatizzazione, mantiene un equilibrio tra momenti
o tipi di ricerca nei quali l'importante è brevettare
e altri casi in cui è meglio condividere e poi cercare
di raccogliere le innovazioni che vengono da tutta la comunità
di ricercatori.
Il caso di Iaconesi è molto diverso perché non
fa ricerca scientifica. Anche in questo caso però c'è
la volontà di aprire e condividere le informazioni, nel
suo caso la sua cartella medica, facendo qualcosa che le istituzioni
della medicina non permettono o non favoriscono. Un caso molto
diverso, vi si può leggere il sogno di una ricerca medica
open source capace di trovare cure alle malattie anche tramite
la condivisione delle informazioni. Quante più persone
possono accedere a quelle informazioni, tante più persone
possono partecipare interpretandole e magari riuscendo a risolvere
un problema medico. Il suo caso, per molti versi diverso dagli
altri citati, ha dei punti di convergenza: condivisione delle
informazioni e sfida alle istituzioni.
Ritengo che il potere sull'informazione sia una delle questioni
più importanti nella nostre società. Chi produce,
controlla e raccoglie i profitti che provengono dall'informazione?
È importante, anche per un attivista della cultura libera,
avere sempre un punto di vista critico: spingere per l'apertura
delle informazioni non è sempre un'attività sufficiente
per andare nella direzione auspicata, in realtà mette
in campo dinamiche complesse: non apre soltanto nuovi spazi
di autonomia ma anche nuove forme di sviluppo economico per
le imprese.»
Marco Liberatore
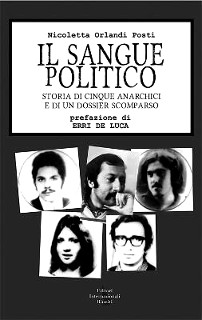 1970/
Cinque giovani anarchici calabresi. Morti.Quando nel 2001 usciva il libro di Fabio Cuzzola Cinque
anarchici del Sud. Una storia negata, la vicenda legata
alla morte di cinque compagni calabresi viveva solo nel dolore
dei familiari e nel ricordo dei compagni che avevano vissuto
l'irripetibile stagione del '68. Da quel momento in poi si è
aperto un cammino che, attraverso le più svariate forme
di comunicazione e arte, ha contribuito a fare conoscere anche
fuori dal movimento anarchico questa vicenda, che oggi è
patrimonio della storiografia ufficiale. Basti pensare che questa
storia ha ispirato vari spettacoli teatrali, un documentario,
canzoni, una puntata di Blu Notte di Lucarelli.
Un altro importante tassello si aggiunge oggi con la pubblicazione
del volume Il sangue politico (Editori Internazionali
Riuniti, 2013, pp. 253, € 16,00) di Nicoletta Orlandi Posti,
impreziosito dalla prefazione di Erri De Luca.
Ha ragione lo scrittore napoletano quando afferma che questo
è “un caso che li riassume tutti”, perché
in questa vicenda s'incrociano drammaticamente la strage di
piazza Fontana, la strategia della tensione, il golpe Borghese,
la rivolta di Reggio Calabria dei “Boia chi molla”
e la strage di Gioia Tauro, che con la recente sentenza, passata
in giudicato, si configura come la prima strage della storia
ad opera della 'ndrangheta. In questo gorgo di odio, lotta e
misteri trovarono la morte, in un attentato camuffato da incidente,
Angelo Casile, Gianni Aricò, Annalise Borth, Franco Scordo
e Luigi Lo Celso, poco più di cento anni in cinque, ma
con alle spalle una militanza già ricca di viaggi, manifestazioni,
arresti e processi.
Il libro poggia su due pilastri che fanno di questo lavoro un'opera
agile e indispensabile per capire e ricostruire un momento nevralgico
per la storia contemporanea. Orlandi Posti si è giovata
dell'immensa mole di documenti di tutti i processi di piazza
Fontana, oggi finalmente disponibile in formato digitale, e
sulle narrazioni dei militanti del gruppo 22 marzo, che hanno
consentito alla giornalista e scrittrice, orgogliosamente originaria
della Garbatella, di dare completezza storiografica a un quadro
di eventi complesso.
La storia dei giovani anarchici, al tempo militanti della Fagi
(Federazione anarchica giovanile italiana), s'incrocia con la
macro storia, nella quale finiscono per imbattersi in “cose
che faranno tremare l'Italia”. Trame oscure, più
grandi della loro gioventù e che ancora aleggiano nella
ricostruzione dell'incidente in quella maledetta notte fra il
26 e 27 settembre del 1970 lungo l'autostrada nei pressi di
Ferentino.
Due elementi raccolti successivamente alle indagini rivelano
la trama criminale ordita contro quei giovani mentre si dirigevano
a Roma per consegnare ai compagni della Fai il frutto delle
loro ricerche. In loco interviene la polizia stradale, quella
sera comandata da Crescenzio Mezzina, uomo dei servizi, quattro
anni dopo condannato per il tentato colpo di stato Fumagalli.
La sua mano sottrarrà i preziosi documenti.
Il secondo elemento è legato alla diffusione della notizia.
La prima informativa dei servizi segreti sull'incidente, telegrafata
alle tre del mattino del 27 settembre, arriva da Palermo, molto
strano per un normale incidente stradale, avvenuto a mille chilometri
di distanza.
Una riflessione a parte merita la sperimentazione del metodo
di scrittura utilizzato; la scrittrice dosa in maniera sapiente
un doppio registro linguistico e narrativo, alternando passi
romanzati, utili per fare capire a chi non ha vissuto quegli
anni il clima e l'ambiente politico-culturale, a capitoli di
vera e propria inchiesta “vecchio stile”, con documenti,
articoli, stralci di interrogatori, fonti orali.
Il sangue politico è diventato anche un monologo
teatrale e un blog, dove l'autrice raccoglie materiali delle
varie presentazioni a testimoniare che ancora quella storia
ha molto da raccontare ai vivi e a “quelli che passeranno”.
Fabio Cuzzola
cirano2@tiscali.it
Antologie/
Racconti anarchici dal mondo
“Dire che siamo piuttosto soddisfatti di questa raccolta
sarebbe minimizzare parecchio. In realtà siamo spudoratamente
orgogliosi del risultato, ci gira la testa, siamo in pieno delirio”.
L'introduzione in inglese racconta un po' della storia che ha
portato a Subversions, e l'altra introduzione, in francese,
aggiunge ulteriori informazioni. Il progetto nasce in una scena
libertaria, quella di Montréal, eccezionalmente ricca:
decine di collettivi, strade piuttosto agitate (“abbiamo
avuto l'onore di vedere l'amministrazione locale istituire una
speciale task-force di polizia anti-anarchica”), una grande
fiera del libro, un Festival internazionale del teatro anarchico...
Qui da noi la storia inizia poco dopo l'uscita del primo volume:
alla 5° Vetrina dell'editoria anarchica e libertaria di
Firenze, con i primi contatti fra l'Anarchist writers bloc (Awb,
Blocco degli scrittori anarchici) e i giovani autori, toscani
e non, raccolti attorno alla Vetrina e ad alcune nuove pubblicazioni
ivi presenti (rivista Collettivomensa, blog Cusa-Umanesimo anarchico).
Il risultato è una collezione anglo-franco-italofona:
Subversions vol II, a cura dell'Anarchist Writers Bloc
(Anarchist Writers Bloc, Montréal 2012, pp. 272 in carta
riciclata, prezzo non indicato, licenza Creative Commons 3.0,
anarchistwritersbloc.org, info@anarchistwritersbloc.org, distribuzione
AK Press); ventotto racconti di autori provenienti da diverse
zone del Canada, e da Italia, Isole Britanniche, Francia, Usa,
Nuova Zelanda, prodotti attraverso un processo di lavorazione
partecipata a cura della rete di autori e di lettori dell'Awb.
“La prima antologia multilingue di nuova narrativa anarchica”,
vanta il sito web del Blocco: il secondo volume di quella che,
uscita nel 2011 in versione anglo-francese, si presenta davvero
come una realizzazione inedita nella storia dell'anarchismo,
e nella storia della letteratura.
Cosa sia un “racconto anarchico” potrebbe essere
una questione problematica. I testi raccolti testimoniano di
una grande varietà di declinazioni di questo concetto,
e al tempo stesso di una visibile coesione del prodotto finale:
in molti possibili modi, autori diversi (alcuni attivi da tempo
come scrittori, altri ai loro inizi, ma non meno brillanti)
raccontano storie diversamente connesse agli ideali anarchici
e libertari. Ciascun racconto meriterebbe un commento specifico;
mi limito qui a segnalare quello di Peter Gelderloos, “Gathering
the Dolphins”*: una storia di capitalismo
avanzato e di rapporto con le altre specie, ambientata in Italia,
che ha la forza di una leggenda moderna, e che come una leggenda
potrebbe circolare a lungo attraverso le lingue e i paesi.
L'annoso dibattito sul rapporto fra arte e politica è
ripreso nelle brevi prefazioni di Raoul Vaneigem e della scrittrice
statunitense Marge Piercy: un ritorno ricorrente, questo di
un tema trito e fondamentale, che è un altro indizio
del trovarci nella fase di inizio di qualcosa di nuovo.
Matteo Broduè
* Titolo italiano proposto: “Radunando i delfini”.
I fantasmi di Stajano,
per capire il Novecento
“Il non poter sapere dà una triste
impotenza.
I documenti sono soltanto scheletri che vanno nutriti di
carne.
Come possono delle carte far riascoltare voci, rivedere gesti,
captare sguardi, far capire lo spirito del tempo?”
La stanza personale e intima di Corrado Stajano (La stanza
dei fantasmi. Una storia del Novecento, Garzanti, Milano
2013, pp. 280, € 18,80) è un deposito di Storia.
Piccole cose, petites madeleines suscitatrici di memoria
occupano gli scaffali della libreria. Un punteruolo, un piccolissimo
liuto, bossoli vuoti, soldatini di piombo, cornicette con medaglie
al valore, fotografie saltate fuori da una scatola metallica
dei droghieri. Il tempo, come immobilizzato, viene ri-cercato,
lo spazio ri-costruito. Di immediato impatto emotivo la prospettiva
di ripresa dal basso, quella che fa parlare gli oggetti come
giocattoli dimenticati, cianfrusaglie sparse, testimoni inconsapevoli.
L'arte maieutica di Stajano li restituisce alla vita. E convince,
coinvolge, quel dare voce agli indizi, dettagli preziosi del
“Secolo breve”, e agli altri fantasmi che si fanno
testimoni concreti, in un dialogo – anche se a volte muto
– con la Storia.
 Con
la sua scrittura chiara, precisa, fluida, a tratti poetica l'autore
ci conduce, quasi prendendoci per mano, in un viaggio nella
Storia del Novecento. A partire dalla sua microstoria alla ricerca
delle proprie radici, incrociando altre storie. Un tempo ritrovato
in luoghi intimi, in spazi pubblici. Incursioni della memoria,
mai indolori. Con
la sua scrittura chiara, precisa, fluida, a tratti poetica l'autore
ci conduce, quasi prendendoci per mano, in un viaggio nella
Storia del Novecento. A partire dalla sua microstoria alla ricerca
delle proprie radici, incrociando altre storie. Un tempo ritrovato
in luoghi intimi, in spazi pubblici. Incursioni della memoria,
mai indolori.
Testimonianze rigorose, ben documentate, affidate ai taccuini.
Carlo Emilio Gadda, volontario interventista, comprende solo
sul campo e racconta cosa è stata la disfatta di Caporetto.
Di un'altra guerra ci vengono restituiti, con sereno e ironico
distacco, i bombardamenti su Londra dal gran diario di Churchill.
Mentre, nel suo rifugio segreto, in un sottoscala, si decide
il destino del mondo. E altri bombardamenti ricostruiti dal
narratore a partire da schegge di ferro rimaste sullo zerbino
e conservate con cura fino a diventare familiari. Confessa:
“ero un instancabile raccoglitore di bossoli vuoti”.
Trovano posto anche gli scritti dell'amico partigiano Nuto Revelli,
ritratto immobile in una fotografia, dietro lo spigolo di un
muro della grande stanza. “Ero amico di Nuto, passai lunghe
giornate a parlare con lui. La guerra era il suo pensiero dominante,
l'8 settembre un'ossessione”. Anche i diari depositati
in archivi storici della Resistenza vengono interrogati, ma
dei molti partigiani caduti si conoscerà solo il nome
di battaglia.
Note, appunti di un sinistro viaggio dell'autore in Grecia,
proprio nel 1967, durante il colpo di Stato dei colonnelli,
e fotografie di carri armati davanti al Parlamento che faranno
il giro del mondo, sono richiamati alla memoria dall'inquieto
Auriga di Delfi. È infilato nel vetro della libreria
della stanza da più di quarant'anni, e lo scrittore si
sente ammonito dalla fissità dolorosa del suo sguardo,
quasi volesse metterlo sempre in guardia a cogliere per tempo
gli insulti alla libertà. Quindi, Stajano interroga gli
indizi del passato per parlare di noi, del nostro presente.
In questo modo, siamo costretti a calarci nella quotidianità,
a esistere in modo vero, in un rapporto dialogante con la Storia.
Il merito sta proprio nel proporci una narrazione della storia
da una prospettiva inedita e svecchiata, non antiquaria. Una
Storia che ci riguarda. Lo scrittore come un archeologo scava
in profondità, si interroga sulle motivazioni che hanno
mosso le azioni, ma anche sullo stato d'animo, i pensieri intimi
e profondi, il dolore di chi ha preso parte davvero alle vicende
narrate, e di chi è rimasto.
In una cornicetta liberty, la fotografia ritrae il padre, capitano,
seduto con il moschetto sulle ginocchia. Dietro di lui, in piedi,
la gerarchia. Tre tenenti, e gli altri nella vecchia uniforme
dell'esercito regio. Forse la Grande Guerra è finita
da poco.
“Che cosa hanno visto in quegli anni di guerra, sul Montello,
sul Monte Grappa, sul Monte Nero, sull'Isonzo, sul Piave? Hanno
ucciso con quei moschetti simili ora a pezzi di legno inanimati?
Hanno visto da vicino i loro soldati maciullati, i corpo a corpo
cruenti, hanno avuto paura del fragore delle granate o sono
riusciti a mascherarla?”. Considerazioni sulla crudeltà
della guerra sono affidate anche alle pagine di scritti letterari.
Altre fonti visive restituiscono luoghi, piazze e scenari di
conflitti planetari.
Come le tele dei “war artist”, Graham Sutherland
e Henry Moore. Le immagini surreali dove la vita non conta,
insieme a descrizioni minuziose di fotografie di guerra, ci
rendono ancora più complici. Tra molte altre, si è
colpiti da una fotografia, quella della madre, di forse vent'anni
nella fotografia del matrimonio, con i capelli raccolti a crocchia
e una rosa appuntata sul petto. Il cuore di quella donna, la
madre, come tante altre donne, si sarebbe fatto sentire erigendo
una muraglia di fermezza e coraggio per difende i propri figli
la notte della perquisizione nella casa da parte della Wehrmacht.
Anello forte, autorevole “non le servirono le parole”.
La ricerca si snoda dei luoghi affettivi depositari di storie
stratificate. Il nonno contadino, ricco proprietario “con
il genio della terra”, la sua Terramata. Uno che “pensa
in grande”, ma poco interessato alla politica. Luoghi
sui quali si sovrappone la scrittura letteraria di autori che
ci conducono in un viaggio lungo la campagna virgiliana e la
valle del Po. Ma è la testimonianza diretta dell'autore
a guidarci verso la città natale, Cremona, con la sua
piazza delle fucilazioni e la Caserma del Diavolo, dove ora
c'è la scuola per l'artigianato liutario e del legno
che porta il nome di Antonio Stradivari.
Invece, dal groviglio della memoria, un pezzo di legno color
carminio, modellino di fabbrica, si dipana e riporta a galla
la vicenda tremenda di Walter Alasia, terrorista delle Brigate
rosse, assassino e vittima, rievocata dal fratello Oscar. Sono
gli anni dopo l'autunno caldo e la strage di piazza Fontana
che ha dilaniato Milano e l'Italia. Gli anni del golpe in Cile,
del referendum sul divorzio, delle stragi di piazza della Loggia
a Brescia, del treno Italicus, del periodico Il pane e le
rose. Decine di morti innocenti.
La riproduzione della carta a colori della Sicilia dove compare
ancora capovolta “l'appendice dello stivale di cavaliere”,
secondo le spiegazioni della maestra di Como, è occasione
per un prossimo arcaico viaggio della memoria. Aspre tappe insidiose
ripercorrono la terra che è stata nutrita dalla presenza
di popoli diversi e che è la terra d'origine del padre,
fin da ragazzo sottotenente del 65° Reggimento fanteria,
ma poi prigioniero in un lager perché “ha prestato
giuramento al re, non al fascismo”. Poi la Sicilia dei
Gattopardi superstiti, tra pasticcerie e caffè, locali
preferiti decenni dopo da uno dei capimafia. E l'incontro con
Lucio Piccolo, incoronato d'alloro da Montale, così appartato
e schivo, e diverso dal cugino Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
Infine, la Sicilia della Conca d'oro, tanto densa di fascino,
e di morti ammazzati.
Così, a mano a mano, attraverso questi viaggi inquieti
della memoria, scaturiti dalla penna di un grande scrittore,
“i fantasmi che aleggiano in una stanza possono diventare
davvero entità di carne, ossa, sangue, fonti battesimali
di un tempo perduto e ritrovato”.
L'immagine conclusiva è rappresentata dalla famosa stanza
traballante di Van Gogh, fissata nel colore del celebre dipinto,
emblema di una vita non pacificata. Allo stesso modo, il groviglio
nella stanza dei fantasmi non si è del tutto dipanato.
Molti interlocutori della Storia che hanno lottato per un'Italia
migliore, “i superstiti della libertà”, offrono
il loro passato tribolato alle generazioni che verranno. Tuttavia,
per Stajano, oggi è venuta a mancare anche la speranza.
Allora, all'autore non resta che affidare alle parole poetiche
di Eugenio Montale, suggellate in Riviere, quell'esile
filo di speranza da infondere nelle nuove generazioni. Ma già
quest'ultimo bel lavoro, sofferto e generoso, credo possa rappresentare
un'apertura, un varco, poiché offre chiavi inedite di
una Storia del Novecento, lontana dagli approcci accademici
oppure libreschi di tanti manuali in uso nelle scuole. Perché,
dentro i fatti, di fronte alla Storia ci siamo noi.
E la prospettiva che Stajano riesce a restituire con la sua
scrittura, scavando nell'anima di quanti hanno partecipato della
Storia passando negli interstizi di altre storie, andando oltre
i fatti, è già uno spiraglio di attesa fiduciosa.
Quindi, non romanzo di un'autobiografia, ma racconto di una
Storia del Novecento, umana e “partecipabile”. Condizione
per elaborare un pensiero riflessivo e critico, promessa di
libertà, individuale e collettiva.
Claudia Piccinelli
 La
Resistenza in Italia
e il contributo (misconosciuto) degli anarchiciIl nostro collaboratore Giorgio Sacchetti ha da poco pubblicato
un suo studio sul campo di concentramento (prima fascista, poi
badogliano) di Renicci d'Anghiari (Arezzo) – tra il 1942
e il 1943: Renicci 1943. Internati anarchici: storie
di vita dal campo 97 (Aracne editrice, Roma 2013, pp. 236,
€ 16,00).
Nella sua premessa (che qui ripubblichiamo) il direttore
generale dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento
di Liberazione in Italia, Claudio Silingardi, affronta anche
la questione della sostanziale rimozione del contributo degli
anarchici non solo alla Resistenza, ma anche – precedentemente
– alla ventennale (e ben più “difficile”)
militanza antifascista sotto e contro il regime fascista.
Ho trovato tra i miei libri un opuscoletto di Giorgio Sacchetti,
dal titolo Renicci: un campo di concentramento per slavi
e anarchici, pubblicato dalla Provincia di Arezzo nel 1987.
Mi era servito per una piccola ricerca che stavo facendo su
Emilio Canzi, anarchico divenuto – caso davvero eccezionale
nella storia della Resistenza italiana – comandante unico
della XIII zona partigiana nell'Appennino piacentino. Il fatto
è che questo primo lavoro (presumo evoluzione della comunicazione
presentata al convegno internazionale tenuto lo stesso anno
sempre ad Arezzo) conferma davvero quanto l'autore asserisce
nella sua introduzione, cioè l'impegno assunto a mantenere
viva la memoria del luogo e di chi suo malgrado l'ha attraversato:
io posso testimoniare che grazie alle sue ricerche ho potuto
conoscere in modo non superficiale l'esistenza del campo di
Renicci e il profilo di alcuni di coloro che vi furono trattenuti
nel breve periodo badogliano.
Ora arriva Renicci 1943. Internati anarchici: storie di vita
dal campo 97 che, ci dice sempre l'autore, è il punto
di arrivo di una trentennale attenzione al ruolo svolto dal
campo, nel contesto di una produzione storiograca costantemente
di alto livello, attenta alle correnti libertarie e sindacaliste
toscane, ad alcuni profili biografici di rilievo nazionale e
internazionale, alla nascita dello squadrismo fascista, alle
esperienze sindacali sia precedenti al fascismo sia nell'Italia
repubblicana. Ho avuto anche il piacere della sua collaborazione
in uno dei progetti che mi ha maggiormente impegnato, quello
del Dizionario storico dell'antifascismo modenese, per
il quale Giorgio Sacchetti ha curato alcune voci tematiche.
In realtà, ciò che preme l'autore è focalizzare
la funzione che Renicci ha avuto nell'impedire che alcuni tra
i più combattivi ed esperti militanti anarchici potessero
svolgere un ruolo attivo subito dopo la caduta del fascismo,
e fare emergere il profilo in molti casi esemplare di questi
combattenti antifascisti. Le 118 biografie di “antifascisti
non conformi” – come li definisce – sono il
cuore di questo lavoro, accanto al tributo dovuto a una figura
altrettanto non conforme, quella di Beppone Livi, ribelle anarchico
e tra i primi esponenti e protagonisti della Resistenza nell'Aretino.
Non è facile, oggi, far comprendere a chi è cresciuto
in una società che fa del presente l'unica prospettiva
praticabile, il senso di vite complesse come quelle raccontate
dall'autore, il loro legame con il passato e la loro fiducia
incrollabile in un futuro migliore. Eppure di questo si tratta.
Persone che hanno conosciuto la violenza delle autorità
e poi del fascismo, che sono state costrette a emigrare, a perdere
il lavoro, a subire persecuzioni, carcere e confino, che però
hanno continuato a rimanere il più possibile coerenti
con le proprie idee e a credere nella possibilità di
una società più giusta e migliore. Questo atteggiamento
in molti di loro permane nonostante le profonde delusioni e
i momenti di sbandamento. D'altra parte, poteva essere diversamente?
Oggi certe vulgate si sono profondamente radicate, al punto
di riuscire a rappresentare il fascismo come un regime tutto
sommato tollerante, che se non avesse incespicato nelle leggi
razziali e non avesse compiuto l'errore di entrare in guerra
a fianco della Germania, in fondo non avrebbe agito male, come
dimostrerebbe il consenso raccolto nella maggioranza della popolazione
italiana. Queste rappresentazioni sono risultate vincenti in
questi ultimi decenni di continuo attacco da parte delle forze
politiche moderate all'antifascismo e alla Resistenza, in particolare
a partire dal crollo dei regimi comunisti dell'Est e dalla crisi
del sistema politico uscito dalla guerra.
Lo sono state, però, anche per la difficoltà delle
forze politiche antifasciste a fare i conti davvero con la memoria
dell'antifascismo (e con la realtà effettiva del regime).
Intanto, in molti casi si è determinato un appiattimento
della storia dell'antifascismo entro quella della Resistenza,
espungendo dal primo gli elementi ritenuti contraddittori rispetto
alla rappresentazione della Resistenza come fenomeno unitario
e democratico. Non a caso, dell'esperienza storica dell'antifascismo
sono stati valorizzati o gli episodi unitari (come ad esempio
le Barricate dell'Oltretorrente a Parma) o figure emblematiche
(Gramsci per i comunisti, Matteotti per i socialisti, Rosselli
per gli azionisti, don Minzoni per i democratico-cristiani),
mentre sono stati rimossi gli errori, le scelte settarie, le
contraddizioni politiche, l'orientamento rivoluzionario di alcune
delle forze protagoniste dell'antifascismo, come il Partito
comunista d'Italia e il movimento anarchico.
Ma c'è dell'altro: l'antifascismo, oltre che diviso al
suo interno, rimane sempre minoranza, e non gioca alcun ruolo
nel far cadere il regime fascista. Mentre la Resistenza –
anche se oggi sappiamo aver avuto anch'essa tanti problemi e
contraddizioni – può essere rappresentata (e in
buona parte lo è stata) come un movimento capace di raccogliere
un forte consenso nella popolazione italiana, in grado di mettere
in difficoltà la Repubblica Sociale Italiana, protagonista
nella liberazione di città e paesi del Centro e del Nord
Italia.
Purtroppo il prevalere di queste rappresentazioni ci ha fatto
perdere di vista il fenomeno concreto dell'antifascismo, le
idee e le proposte elaborate ma anche la vita concreta, quotidiana
di chi ha deciso di non adeguarsi. Direi che sia utile partire
da un dato apparentemente banale: in una dittatura, in un regime,
la normalità non è opporsi, ma appunto adeguarsi.
Era difficile essere antifascisti, continuare ad esserlo con
il passare degli anni, senza che si vedesse a breve un possibile
cambiamento. Anche perché vi era una evidente sproporzione
tra l'espressione delle proprie opinioni o l'agire politico
e le conseguenze sul piano della repressione, che non riguardavano
– bisogna sottolinearlo – solo il diretto interessato,
ma la sua famiglia. Anni fa Silvio Berlusconi dichiarò
pubblicamente che il confino era una sorta di villeggiatura;
avrebbe dovuto chiedere alle mogli e ai figli dei confinati
in quali condizioni erano costretti a vivere, venendo meno la
presenza (per un periodo da due a cinque anni) del proprio congiunto
e dei redditi del suo lavoro.
 |
 |
| Gli anarchici Emilio Canzi (Piacenza 1897 - 1945) (a sin.)
e Alfonso Failla (Siracusa 1906 - Carrara 1986),
due delle figure
di spicco tra i militanti
anarchici impegnati contro il fascismo
dal suo sorgere alla sua sconfitta |
La realtà della repressione non stava solo negli arresti,
nel confino, nel carcere, nelle diffide e ammonizioni, nei continui
controlli di polizia, ma in una vigilanza quotidiana esercitata
dall'insieme delle organizzazioni sociali e assistenziali del
fascismo, in meccanismi di controllo e di vessazione che portavano
alla perdita del posto di lavoro, a costrizioni quotidiane,
a rotture di vincoli familiari e sociali che, spesso, lasciavano
come unico sbocco quello dell'emigrazione e dello sradicamento.
Il tutto in un contesto di costruzione del consenso al regime
che utilizzava tutti gli strumenti possibili, dalla scuola allo
sport, dai mezzi di comunicazione alla promozione di una religione
civile fascista.
Essere antifascisti non era facile, perché occorreva
una disponibilità al sacricio, per sé e per la
propria famiglia, non indifferente, e perché era necessario
resistere a una situazione che vedeva premiati i comportamenti
di asservimento e di obbedienza nei confronti di un regime che
conquistava sempre più consensi. All'estero, dove molti
antifascisti si trasferiscono per poter continuare a vivere
e ad agire, è difficile fare comprendere la pericolosità
del regime, e solo dopo l'affermazione del nazismo in Germania
a partire dal 1933, e ai primi flussi migratori di intellettuali
e artisti tedeschi, alcuni paesi democratici iniziano ad interrogarsi
davvero sul pericolo costituito dai fascismi europei.
Da questo momento inizia a delinearsi il profilo dell'antifascismo
come coalizione di forze e culture diverse, che contrastano
non un partito ma una visione del mondo e dei rapporti economici
e sociali, che prepara il personale politico che sarà
protagonista della ricostruzione dell'Italia dopo la fine della
seconda guerra mondiale, trasformando profondamente le culture
politiche di alcune forze di opposizione che si sposteranno
progressivamente su un terreno democratico.
Nel caso degli anarchici (non solo, ma soprattutto) il momento
di svolta è costituito dall'esperienza della guerra di
Spagna. Il sogno di realizzare finalmente una società
libertaria si infrange non solo contro la potenza militare messa
in campo dai generali golpisti appoggiati da Hitler e Mussolini,
ma dalle profonde ferite determinate dalle divisioni e dallo
scontro entro il campo antifascista, in particolare tra i comunisti
e gli altri partiti antifranchisti. Uno scoramento accentuato
dalla condizione di precarietà che molti vivono al ritorno
in Francia (tanti finiscono internati nei campi di prigionia
allestiti nei Pirenei), dalla notizia disorientante della firma
del patto di non aggressione tra Unione Sovietica e Germania
e, infine, dallo scoppio della seconda guerra mondiale, con
l'occupazione nazista della Francia e la nascita del regime
di Vichy.
Le biografie presentate in questo volume rendono bene questa
fase, tra chi cerca di spostarsi in altri paesi, chi rientra
in Italia, chi vive l'esperienza dell'internamento, dei campi
di concentramento e/o della cattura e consegna alle autorità
di polizia italiane, con conseguente invio al confino. Oltre
a coloro, ovviamente, che al confino c'erano già per
effetto delle condanne comminate in Italia negli anni precedenti.
Ciò che colpisce di questi uomini è la volontà
di continuare la lotta. Viene impedito loro, come accennavo
all'inizio, di essere da subito protagonisti della ripresa delle
agitazioni sociali (duramente represse dal governo militare
di Badoglio, con esercito e polizia che provocano 96 morti e
552 feriti, mentre 2.341 sono i lavoratori arrestati) e nella
riorganizzazione delle forze politiche antifasciste. Molti di
loro, però, non avranno dubbi nel compiere la scelta
della Resistenza dopo l'8 settembre.
Purtroppo, il contributo degli anarchici alla Resistenza italiana
non ha conosciuto il giusto riconoscimento da parte della storiografia.
Certo, l'assenza di una organizzazione formalmente aderente
al Comitato di Liberazione Nazionale, il fatto che questo contributo
si sia concretizzato in esperienze non collegate tra loro, spesso
tradotto in scelte individuali, non ha favorito un tentativo
di sintesi generale. Però, nonostante questo, è
troppo evidente una discriminazione che rimanda soprattutto
a letture della storia della Resistenza condizionate dall'orientamento
politico degli autori, o da una interpretazione superficiale
dell'apporto che le idee libertarie hanno dato alla lotta antifascista.
Alla fine, ciò che conosciamo della partecipazione anarchica
alla Resistenza è frutto di ricerche generose da parte
di storici o appassionati vicini al movimento, ma questa conoscenza
non è ancora penetrata nelle ricostruzioni di carattere
più complessivo.
Da questo punto di vista spero che, anche grazie a lavori come
questo, il settantesimo anniversario della Resistenza e della
lotta di liberazione sia l'occasione per un salto di qualità,
per dare finalmente il giusto rilievo alla partecipazione degli
anarchici alla lotta antifascista e alla Resistenza.
Claudio Silingardi
Direttore Generale dell'Istituto Nazionale per la Storia del
Movimento di Liberazione in Italia
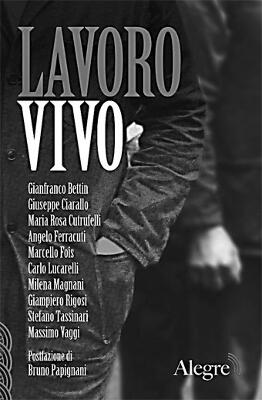 Il
mio babbo operaio,
morto di amiantoQuesto libro è un'antologia e l'ha pubblicata Alegre
nel 2012. Si intitola Lavoro vivo (aa.vv., pp. 187, €
14,00) e ci sono tanti contributi. C'è Stefano Tassinari,
che è scomparso di recente. Ci sono Carlo Lucarelli e
Milena Magnani. C'è Angelo Ferracuti che da anni sta
facendo un lavoro imponente per raccontare la storia delle vittime
del lavoro. Poi c'è Massimo Vaggi che gli operai li difende
come avvocato nelle cause pensionistiche per l'esposizione all'amianto
e la sua esperienza l'ha trasformata in un racconto molto bello.
E non si può tacere il contributo di Beppe Ciarallo,
che racconta in pagine toccanti la storia di suo padre, operaio
molisano emigrato tra le nebbie di Milano, quando a Milano la
nebbia c'era ancora.
Questo libro è sempre attuale, perché di lavoro
si muore ogni giorno. È così attuale che ho appena
incontrato una storia che poteva a ragione entrare nell'antologia
di Alegre. E pertanto questa recensione la intendo come un'estensione
di un testo che continua a scriversi tutti i giorni, sulla pelle
dei lavoratori. Degli operai, degli agricoltori, dei muratori,
dei corrieri, di tutti quelli a cui un Capitale che si riproduce
avvelenando il pianeta impone il dilemma mortale di scegliere
tra il pane e il lavoro, tra il lavoro e l'ambiente, tra il
lavoro e la salute e infine tra il lavoro e la vita. Di qui
il termine “lavoro vivo”, inteso con uno slittamento
semantico che sottrae spazio alla rappresentazione economica
e descrive il lavoro proprio nei termini di una nuda vita che
rasenta l'oscenità della morte quotidiana. Un lavoro
che non premia l'operosità umana, la manualità
suprema dei nostri vecchi operai e artigiani. Un lavoro che
è work, più che labor. Un lavoro
nocivo, avvilente, noioso, mortale. Un'oscenità sotto
gli occhi di tutti, che tutti fanno finta di non vedere.
Per questo non è assurdo recensire un libro intitolato
Lavoro vivo con la lettera di una ragazza (Barbara Bertucci)
a cui è appena morto il padre, operaio per tanti anni
alla Breda di Pistoia. Più che una recensione, quel che
ho fatto è stato provare a aggiungere un capitolo nuovo
al libro. E purtroppo non sarà neanche l'ultimo.
“Quando ero piccola, tutti gli anni in questo periodo,
il babbo prendeva me e Marco e ci portava alla Breda. In sala
mensa c'erano delle grandi scaffalature piene di giocattoli.
Ci diceva di sceglierne uno che poi Babbo Natale ci avrebbe
portato. Non ho mai creduto a nessun Babbo Natale, o meglio,
la scoperta della sua inesistenza mi fu lieve, non dolorosa,
perché sapevo che i regali me li portava il mio di babbo.
Ne ebbi proprio la conferma perché una vigilia lo vidi
portar su dalla cantina i pacchi. Ne gioii perché ebbi
la conferma di quello che pensavo”.
Non c'era nessun Babbo Natale, era il mio di babbo, Maurino.
Il mio babbo operaio, che lavorava nella grande fabbrica chiamata
Breda, quella dove andavamo a scegliere i regali. Ne ero così
orgogliosa, mi vantavo anche, quando mi chiedevano 'che lavoro
fa il babbo?' io fiera rispondevo 'È operaio alla Breda!'.
Probabilmente allora, anzi, probabilmente già quando
nacqui, le fibre d'amianto cadevano piano nei suoi polmoni.
Fermandosi lì, da lontano iniziavano a devastargli la
vita. Ma io non lo sapevo questo, lo avrei saputo solo molto
tempo più tardi. Io ero fiera di lui, di questo babbo
che sapeva fare e aggiustare tutto, le cui mani, per cinquant'anni,
non hanno mai smesso un attimo di lavorare. Io ho sempre provato
un'ammirazione stupefatta per questo suo riuscire a fare qualsiasi
cosa, diversamente da me che so fare ben poco e infatti il babbo
me lo diceva sempre 'Voialtri 'un sapete fa' nulla!'.
Aveva ragione, non so mica fare nulla io. Però babbo,
una cosa la voglio fare. Onorare la tua memoria e quella di
tutti gli altri compagni a cui le fibre d'amianto hanno eroso
la vita. Non smettere di lottare mai, per questa immensa ingiustizia
subita. Ne vedo tanti qui, i tuoi amici, i tuoi compagni, quelli
più giovani a cui hai insegnato tanto, quello più
vecchi che ti son stati vicini una vita, tutti quelli che hanno
beccato e sopportato le 'bande' che tu gli facevi, perché
tanto anche loro 'niente via, 'un sanno fa' nulla!'
Babbo ora son tutti qui a piangerti, con uno strazio che capisco.
Li vorrei abbracciare tutti, forte forte, perché son
loro che più mi stringono il cuore. Gli amici, compagni,
colleghi di lavoro e di una vita che son venuti qui oggi a darti
l'ultimo saluto e che mi rimandano un'immagine di te diversa,
che io conoscevo poco, ma vorrei che ancora mi parlassero di
te, mi raccontassero com'eri. Babbo.
Ciao grande Maurino, la tua Barbara.”
Alberto Prunetti
|

