| 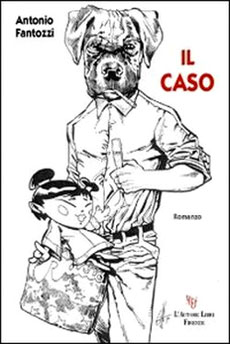 Uno sbirro Uno sbirro
troppo diverso
Fuma solo Nazionali. Si immagina paziente come Giobbe ma ogni tanto ha scatti di violenza. Veste male. Spesso gira in ciabatte. «Il bizzarro poliziotto di una commedia all’italiana» così si pensa. Ha una faccia da bulldog ma qualcuno direbbe che somiglia un po‘ ad Alberto Lupo o Amedeo Nazzari. Quando parla sputacchia. «Son fatto più per il lupanare che per la chiesa anche se non frequento nè l’uno nè l’altra». Il commissario Ernesto Donadei non piace ai suoi superiori e combina guai. Quando parla divaga. Ama il cinema e le parole difficili. E crede nella giustizia. Per questo solo lui si interessa a quegli stracci e «ossa spezzate» che una volta erano una bambina cinese.
Sullo sfondo di una Reggio Emilia incattivita e omertosa, a caccia di un serial killer che si diverte a torturare, Donadei è uno dei poliziotti («sbirri» direbbe lui) più insoliti che si siano visti in Italia. E meglio scritti. Eppure Il caso (256 pagine per 16 euri) di Antonio Fantozzi viene pubblicato da una piccola casa editrice (L’autore Libri Firenze). Faticherete a trovarlo … ma ne vale la pena.
Poco si può rivelare della trama – come per ogni poliziesco che si rispetti – ma chi legge si sente avvantaggiato rispetto a Donadei perchè, sin dalle prime pagine, sa che il serial killer esiste ed è una ragazza. Ma se invece non fosse così?
I capitoli «colore rosso» sono i pensieri di una bambina che cresce con la voglia di uccidere e straziare; quelli «colore nero» accompagnano le ricerche di Ernesto Donadei. Ogni tanto i colori si mescolano oppure si inserisce un misterioso Antonio con brevi racconti.
Scarne le notizie sull’autore: vive a Regggio e ha già pubblicato una raccolta di racconti (mescolati ad appunti di viaggio) sul Senegal. La sua scrittura è camaleontica: oscilla fra una crudeltà quasi insopportabile e lucidità “scientifica” se scava nella testa della (presunta?) assassina mentre si aggroviglia in saggezza-pazzia quando fa i conti con pensieri e azioni del commissario. Gioca con immagini e metafore efficaci e sempre fuori dal banale: il gambero rosso della Louisiana, il Bagatto, la pornografia degli alberi, la storia di Billie Holiday e di Abel Meeropol.
Tutto è «in circolo» come le infinite rotatorie stradali di una città che man mano si scopre essere Reggio. Tanti inizi e tanti finali. La prima mezza pagina insinua che Donadei sia pazzo oppure che a tutti faccia comodo crederlo. Il protagonista e l’autore ci ripetono (con il fim «Matrix») che «l’ignoranza è un bene». Forse proprio questo è il punto. Come per i reggiani che non vogliono sapere cosa è diventata la loro città: «solitudini e cattivera», cemento e lucciole, cooperative e camorra. Impietosi i pensieri di Donadei o i racconti di Antonio. «Ci hai mai pensato? Al focolare filippine, agli anziani badanti slave, alle coccole puttane africane... Ecco la globalizzazione dei sentimenti spiegata ai bambini».
Colpisce basso Fantozzi. Ed è forse anche per questo che faticherà a trovare editori o recensori. Ma chi leggerà questa indagine non dimenticherà questo sbirro troppo diverso per … non esser pazzo.
 Daniele Barbieri Daniele Barbieri
 Quelle eccezionali Quelle eccezionali
“donne libere”
È apparsa, a fine dicembre del 2010, la preziosa (Eulàlia Vega, Pioneras y revolucionarias. Mujeres libertarias durante la República, la Guerra Civil y el Franquismo, Barcelona, Icaria, 2010, pagg. 389) raccolta di testimonianze di militanti libertarie in Spagna prima, durante e dopo la guerra civile (1936-39), coniugando storia al femminile e storia orale. Fonti valorizzate metodologicamente in modo diverso dai ricercatori sulla Spagna contemporanea, che hanno dato buoni frutti in passato. Sul primo versante – quello della storia della donna nel conflitto – ricordiamo gli studi di Mary Nash e Martha Ackelsberg, mentre più in generale sulla guerra, ma centrate quasi unicamente sull’enorme potenziale della testimonianza orale, l’opera pionieristica a tutto campo di Ronald Fraser e quella, più approfondita e circoscritta su Albalate de Cinca (Huesca), della olandese Hanneke Willemse (1).
Il lavoro di Eulàlia Vega, ricercatrice e docente all’università di Lleida, dopo alcune considerazioni generali sul valore e l’impiego delle fonti orali, entra immediatamente nel merito, con una decina di storie di vita, organizzate attorno a cinque momenti.
Si parte con la formazione giovanile delle protagoniste, tra vita in famiglia e di quartiere.
La militanza prima dello scoppio del conflitto, in particolare durante la seconda Repubblica (1931-1936), costituisce il secondo momento. Le questioni di fondo a cui si cerca di trovare una risposta non sono di poco conto: perché e in che modo iniziò la loro partecipazione all’interno delle molteplici articolazioni del movimento? Nel sindacato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), nell’ambito della Federación Anarquista Ibérica (FAI) e delle Gioventù libertarie, negli atenei libertari e nelle scuole razionaliste, e più in generale nelle variegate forme di socializzazione promosse dagli anarchici spagnoli. Quali posizioni vi occuparono le donne? Furono veramente emarginate dagli uomini, come si è spesso sostenuto?
Il momento chiave è ovviamente rappresentato dalla calda estate del 1936: innanzitutto nelle strade per sventare il golpe franchista, poi al fronte come miliziane, ma soprattutto nelle collettività della retroguardia per supplire i volontari partiti per la guerra.
È in questo periodo che accanto alla moderata Agrupación de Mujeres Antifascistas di orientamento comunista, guidata da Dolores Ibárruri, sorge una nuova associazione anarchica, Mujeres Libres, che unisce chiaramente la questione dell’emancipazione dallo sfruttamento capitalista a quella dall’oppressione patriarcale. Solo una minoranza di donne però vi si affiliarono, circa 20.000. Come mai? Quali nuovi ruoli assunsero le militanti libertarie durante la rivoluzione forse più radicale dell’Europa contemporanea? In quali ambiti le loro rivendicazioni riuscirono a tradursi in pratica? Sono ulteriori interrogativi importanti affrontati dalla ricerca di E. Vega.
La quarta sezione approfondisce il momento della sconfitta militare, la disperata fuga verso la frontiera catalana e l’esilio, nel gennaio/febbraio del 1939, sotto i bombardamenti nemici; le pesanti condizioni che i fuggiaschi vissero nella clandestinità in Francia durante la Seconda guerra mondiale, minacciati di essere consegnati dall’occupante tedesco alla polizia franchista.
Solo dal 1945 le nostre rifugiate ottengono generalmente il riconoscimento dei loro diritti, e a questo momento si pone la scelta tra un possibile rientro clandestino in Spagna, per riprendere la lotta per la libertà che tarderà ancora moltissimo a venire, o ricostruirsi una vita “normale” nella loro patria d’adozione, attendendo (ma mai passivamente!) la fine della dittatura di Franco (1975).
Le gradevoli narrazioni delle nostre testimoni, perlopiù ultranovantenni al momento delle registrazioni (alcune di loro ci hanno nel frattempo lasciati), ricompongono un denso affresco, muovendosi continuamente dal privato al pubblico, dalla vita individuale a quella collettiva, con vivaci pennellate che lasciano una profonda emozione e ammirazione nel lettore.
 Renato Simoni Renato Simoni
- M. A. ACKELSBERG, Mujeres Libres. El anarquismo y la lucha por la emancipación de las mujeres, Barcelona, Virus, 1999 (traduzione italiana: edizioni Zero in condotta, Milano 2005). M. NASH, Rojas. Las mujeres republicanas en la Guerra Civil, Taurus, Madrid, 1999. R. FRASER, Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, Barcelona, Critica, 1979, 2 voll.; H. WILLEMSE, Pasado compartido. Memorias de anarcosindicalistas de Albalate de Cinca, 1928-1938, Zaragoza, PUZ, 200
 De André De André
tra i banchi
La quarta di copertina è categorica: «Fabrizio De Andrè si rivela ancora oggi, ad anni di distanza dalla sua morte, uno dei rari personaggi capaci di parlare ai giovani». Verissimo, a parte la vaghezza su una categoria “giovani”.
Da qui l’idea di Massimiliano Lepratti: organizzare fili logici e materiali per proporre «De Andrè in classe»; il libro è pubblicato dalla Emi (128 pagine, 9 euri) con prefazione di don Andrea Gallo.
La prima metà ricostruisce, con buona capacità di sintesi,«come nacquero le sue canzoni»: gli anni “francesi”, gli album a tema, il periodo “americano”, il ritiro in Sardegna. le opere “etniche”. Lepratti mostra poi come Faber può essere utilizzato a scuola in almeno 4 contesti diversi: storia, musica, “tra filosofia e intercultura” e ovviamente in letteratura (italiana ma anche francese e inglese). Volendo invece approfondire il discorso musicale si trovano molti legami-debiti di De Andrè con scuole o tradizioni, collocabili in almeno 6 caselle: il tardomedioevo, la canzone popolare inglese, le danze popolari, gli stili latinoamericani, un certo folk statunitense, la musica classica.
Non c’è dubbio che, in teoria, chi insegna – o chi a scuola si organizza e rivendica spazi – può trovare nelle sue canzoni eccellenti spunti per un lavoro in classe. Ma in pratica è possibile questo al tempo della skuola (tornata sempre più autoritaria) e della squola (l’ignoranza consigliata dall’alto) dove resistono ben pochi spazi di pensiero libero? C’è chi tenta, convinto – come suggerisce don Gallo – che Faber aiuti perché ha sempre viaggiato, con coerenza, su due binari: «l’ansia per la giustizia sociale e la speranza in un nuovo mondo».
Posso raccontare che mesi fa entrando al liceo Dante Alighieri di Ravenna in autogestione fra i 36 (!) laboratori previsti in una mattina spiccava un bel «De Andrè e i vangeli apocrifi». Evviva. Ma la scuola ipocrita e la cultura (i tanti che oggi fingono di osannare Faber dopo averlo censurato in vita) è capace di tutto. Mentre scrivo questa recensione leggo che alla scuola media «Fabrizio De Andrè» di Roma (quartiere Monteverde) i contributi “volontari” delle famiglie diventano obbligatori e dunque niente gite o altre attività extra per chi non paga. «Quello che non ho è il tuo conto in banca» vero?
 Daniele Barbieri Daniele Barbieri
 |
Una scritta sui muri di Roma
(foto Chiara Lalli) |
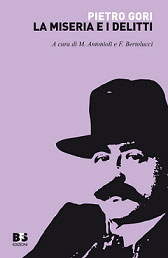 Il mito della Il mito della
società naturale
Nella storia dell’anarchismo italiano la figura di Pietro Gori occupa un posto significativo: è stato infatti, tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, di gran lunga l’esponente più popolare del movimento. Recentemente si è svolto a Pisa un convegno dedicato alla sua attività politica, sociale e culturale; nello stesso tempo la Biblioteca Serrantini ha pubblicato, a cura di Maurizio Antonioli e Franco Bertolucci, una antologia dei suoi scritti: Pietro Gori, La miseria e i delitti, BFS, Pisa 20011, euro 14,00; antologia che comprende temi riguardanti la sociologia penale e la sociologia criminale: un insieme di problemi che hanno avuto da parte del “poeta dell’anarchia” un’attenzione primaria. L’introduzione di Antonioli e Bertolucci dà conto tuttavia anche del più generale rapporto fra Gori e la storia del movimento operaio e socialista, affrontando alcune importanti questioni storiografiche e ideologiche.
Sotto il profilo strettamente scientifico, La miseria e i delitti non può essere considerato oggi un testo di attualità. La sua importanza risiede invece nel rappresentare un chiaro esempio della mentalità progressista dell’epoca, la quale, a sua volta, riflette, in questo caso, una fede politica e ideale non comune perché mette in luce il senso profondo che animava una parte dell’intellettualità anarchica e dunque, di riflesso, evidenzia il peso e il significato della sua militanza e dell’incidenza propagandistica che essa ha avuto presso le classi subalterne.
La cifra più importante dell’interpretazione goriana consiste nell’intrecciare la credenza deterministica, allora dominante, con il volontarismo etico. Si tratta dunque di leggere La miseria e i delitti alla luce di questo insieme problematico. Sintetizzando al massimo, possiamo dire che Gori non esce dall’ambito culturale del suo tempo, cioè dal positivismo. La sua concezione risente in modo quasi determinante di tale visione che assegna alla scienza il conseguimento della verità, sia essa sociale, politica, economica o filosofica. A suo giudizio la storia è depositaria di un tracciato destinato al miglioramento continuo del genere umano. La visione goriana è fondata su un sostanziale ottimismo antropologico, con un approccio enfaticamente illuministico, per cui tutto il passato è giudicato in modo negativo.
Nel positivismo di Gori non vi è soluzione di continuità tra il mondo fisico e il mondo morale, essendo tali determinazioni soltanto delle espressioni diverse di una medesima realtà. Infatti le stesse leggi che reggono le sorti del mondo naturale reggono anche quelle del mondo morale. Ne consegue che l’azione degli uomini è inserita organicamente senza soluzione di continuità in questo tutto; essa, in sostanza, è priva di una propria autonomia. E con ciò Gori riprende la polemica materialistica contro la concezione “idealistica” del libero arbitrio, che intende prescindere dalla forza cogente del contesto storico, geografico, economico e sociale. La volontà umana, malgrado l’illusione di essere libera e sovrana nella sua scelta, non fa che subire le forze esterne e interne, fisiche, sociali o morali tra loro amalgamate, per cui la scelta della volontà non è in ultima analisi che la pressione inavvertita, ma non meno esistente, dei motivi psichici coagenti sulla volontà stessa. E come non si può sfuggire al contesto fisico-naturale, così non si può sfuggire al contesto storico-sociale. Di qui l’evidente predominanza della società rispetto all’individuo, il quale si trova, in un certo senso, condizionato in modo determinante dall’ambiente che lo circonda.
Poste l’insieme di queste premesse, è legittimo allora chiedersi: cosa spinge gli esseri umani alla ribellione e alla ricerca della libertà? Se sono fisicamente e socialmente determinati, come riusciranno a diventare liberi? A queste ovvie domande Gori risponde, richiamandosi a Kant e Guyau; afferma infatti che se l’uomo è figlio dell’ambiente lo è «anche di se stesso», cioè del suo senso morale, il quale gli impone di riconoscere il diritto altrui spingendolo a rispettarlo. Di qui l’idea che il senso rivoluzionario è un sentimento morale, per cui la ribellione non è altro che il diritto di legittima difesa che rende necessaria la violenza nell’individuo e nella società; essa è il fondamento morale delle rivoluzioni contro qualsiasi forma di tirannia, anche se «la morale anarchica è la negazione completa della violenza».
Poiché l’uomo fa tutt’uno con la società, occorre che questa sia capace di rispondere alle necessità insopprimibili degli individui. Solo una società liberata dall’oppressione della proprietà privata può essere in grado di fronteggiare un simile compito. Pertanto la società anarchica non potrà che essere quel regime sociale dove la soluzione del problema della libertà presupporrà una soluzione socialista della proprietà, soluzione, a sua volta, che giungerà alla sua applicazione integrale soltanto attraverso il principio della giustizia comunista (“ognuno dà secondo le sue forze e riceve secondo i suoi bisogni”). Infatti l’anarchia non è che il coronamento necessario ed ineluttabile del socialismo perché se il socialismo vuol dire la fine d’ogni sfruttamento dell’uomo sull’uomo, l’anarchia significherà la soppressione d’ogni autorità dell’uomo sull’uomo. Ecco perché, più che proclamare astratti diritti, è molto meglio parlare di concreti bisogni, i quali sono il substrato positivo d’ogni diritto. Concepiti nella loro ultima essenza (cioè nella loro ragione naturale), essi si riducono al diritto di vivere e al diritto di amare. D’altra parte il soddisfacimento di queste primarie istanze naturali può avvenire attraverso il carattere tutto spontaneo e libero del loro funzionamento, che implica la necessità di assecondarne il flusso poiché esso coincide con l’intrinseco carattere “naturalistico” della società.
Affiora così, attraverso il determinismo positivistico, un topos classico dell’anarchismo, quello del mito della società naturale quale esistenza antecedente al “degenerato”, successivo sviluppo storico: l’anarchia è insomma il coronamento culturale della società naturale. Siamo, come si vede, alla vulgata di Rousseau, Godwin e Kropotkin. Gori, infatti, enfaticamente si domanda: «l’ordine ammirabile della natura ha egli bisogno di altre leggi, all’infuori di quelle rigide e inviolabili da cui dipende tutta l’esistenza delle cose, e lo sviluppo dei fatti e dei fenomeni? No! Perché questo è l’ordine vero; e le sue leggi sono ubbidite dappertutto senza bisogno di gendarmi, poiché se qualcuno si mette contro di loro trova nella sua disubbidienza il castigo meritato».
In conclusione, l’anarchia è finalmente la scoperta del vero ordine sociale, tanto da poter concludere che «gli odierni rivoluzionari sono i veri elementi d’ordine».
Naturalmente la realizzazione di questa utopia non porterà alla realizzazione della società perfetta, al conseguimento della felicità universale, perché il male «non scomparirà del tutto»; esso, però, «diminuirà grandemente la somma delle sofferenze umane».
 Nico Berti Nico Berti
|

