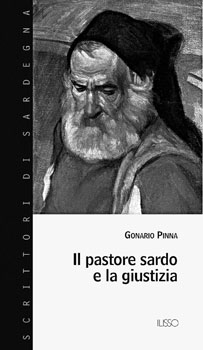
Si parla e si invoca spesso, soprattutto di questi tempi, la Giustizia, come se questa potesse arrivare candida ed eterea nelle sue vesti femminili per riequilibrare i torti e mantenere ben fermi i due piatti della bilancia. Eppure questa Giustizia, che appare così neutrale e di cui possiamo fidarci convinti della sua imparzialità ed equità, non sempre ha suscitato questi sentimenti, soprattutto quando questa veniva da lontano e si faceva chiamare
Giustizia di Stato. Accadde così che il popolo di un’isola da sempre terra di conquista, ma anche di tenace resistenza, venne a conoscere sulla propria pelle quella profonda differenza che divideva il suo concetto di giustizia con quello portato dagli invasori d’oltremare, soprattutto dal vicino Regno, e poi Stato, d’Italia.
I sardi, infatti, sin dall’antichità, avevano riservato a sa zustissia un posto importante nella propria concezione della comunità, imprimendo nella
propria lingua e nella coscienza collettiva l’idea di giustizia come riconoscimento di ciò che è conforme agli equilibri sociali: mezus manche(t) su pane che sa zustissia, abbiamo più bisogno di giustizia che di pane. Un elemento percepito come fondamentale, quindi, per l’esistenza stessa di una società organizzata, una giustizia però che si fa voce di un codice comunitario, frutto del tempo e della consuetudine che ha iscritto nei rapporti sociali il suo concetto di giustizia. Fu così che l’imposizione di un sistema normativo portato dall’esterno, e modellato sul concetto di giustizia dello stato italiano, portò inevitabilmente a una diffidenza, prima, e a uno scontro poi, verso quella “Giustizia che si fa strumento di un potere che non nasce dalla struttura della comunità ma le si sovrappone dall’esterno, potere di invasori, potere di dominatori, potere di uno Stato che non è espresso dalla società originaria ma ha connotati suoi propri… diverse esigenze e suoi propri strumenti di imperio” (1). Sono le parole di Gonario Pinna, avvocato sardo che conobbe a fondo la realtà barbaricina soprattutto degli anni ’50 e che raccolse i suoi lunghi anni di contatti col mondo agropastorale in un libro dall’evocativo titolo Il pastore sardo e la giustizia: il primo emblema della comunità sarda, la seconda strumento di un potere estraneo che si impose, non solo attraverso i noti sistemi repressivi, ma soprattutto e più furbescamente attraverso un completo svuotamento degli antichi codici, minando profondamente la concezione sarda del vivere in comunità e nel contatto con la natura.
 |
Orgosolo (Nu) |
 Il senso della latitanza
Il senso della latitanza
E così quella giustizia che vestiva i panni del carabiniere e del magistrato di turno, ma anche degli ufficiali giudiziari, si associò sempre più all’idea della fatalità, di qualcosa cioè che pesava sul destino di ognuno e che minacciava il valore più importante per il pastore sardo, nonché condizione ideale del vivere: la libertà. Nemos nete de cust’abba non bibo, nessuno dica di quest’acqua non berrò, poiché nessuno si può dire al sicuro dalla giustizia e, quindi, nessuno può avere la certezza di vivere in libertà. Colui che rimaneva intrecciato nelle sue maglie era considerato un disgrassiau, vittima di una disgrazia che poteva colpire tutti e che quindi meritava aiuto da parte della comunità. Una disgrazia, quindi, ma non solo, perché la legge non veniva concepita in astratto ma come espressione del potere, come strumento e canale di trasmissione di una determinata visione della società. E così quella giustizia di Stato iniziò ad essere considerata non realmente legittima poiché non era il frutto di uno sviluppo naturale della comunità che adeguava e sviluppava il sistema normativo in relazione ai suoi bisogni: si gettavano così le basi di una profonda diffidenza verso la giustizia e di riflesso verso lo Stato, sullo sfondo di uno scontro tra il codice comunitario percepito come naturale e quindi rispettato, e la legge dello Stato temuta prima, non riconosciuta poi e infine rifiutata. Due autorità sociali si scontravano, quella radicata nella tradizione e nella consuetudine, rispettata perché liberamente accettata agli occhi del pastore, e quella espressione di un potere dominante il cui rispetto era imposto dall’esterno.
Maturava così il passaggio dalla paura suscitata dalla terribilità della giustizia, che si portava via non solo la libertà ma anche i beni, allo scontro diretto attraverso la latitanza e le forme del banditismo che portarono “alla rottura aperta con la società, e alla dichiarazione di guerra allo Stato” (2). La latitanza, infatti, rappresenta la prima eclatante manifestazione della sfiducia del pastore sardo nella giustizia di Stato, poiché quest’ultima fa perno su tre elementi in profondo contrasto con la moralità propria del pastore. Il primo è il classismo della giustizia, ossia la convinzione che chie hat dinare cumparit innossente (chi ha denaro appare innocente) e che la bilancia, quindi, penda sempre dalla parte di chi socialmente è più forte; soprattutto un articolo del codice legislativo mostrava l’idea che lo Stato avesse della giustizia: era la norma che prevedeva il furto aggravato se si rubavano tre o più capi di bestiame raccolti in gregge, un aggravante che teoricamente mirava a tutelare il patrimonio zootecnico, colonna portante dell’economia isolana, ma che strideva con l’enorme sproporzione tra la pena solitamente inflitta a qualcuno che rubava del bestiame, spesso mosso dalla miseria, e quella inflitta per forme gravi di truffa o insolvenza fraudolenta; due “capacità criminali” ben diverse quelle messe in campo, per articolazione e conseguenze sociali, quella del poveraccio che rubava tre pecore e quella del truffatore. Il furto, infatti, rientrava in qualche modo nella normalità del vivere comunitario, tanto che attraverso la consolidata pratica de s’abbonamentu i furti venivano risolti attraverso accordi privati con la restituzione del bestiame o il risarcimento del danno. Il secondo elemento, che faceva attribuire l’appellativo di mala a sa zustissia e che provocava un profondo scetticismo fino a una totale opposizione, erano le norme preventive, poiché esse non rispondevano alla concezione retributiva, che a un danno faceva seguire una riparazione, ma costituivano un provvedimento preventivo non proporzionato a nessun reato ma inteso a colpire la supposta pericolosità dell’individuo. Arbitrii ed errori, quanto si profilava per il pastore nell’uso di queste norme e che alimentavano incertezza, a dispetto della sicurezza invocata dallo Stato. L’ultimo elemento, invece, si intreccia con un’altra istituzione che in Sardegna è stata e continua ad essere una presenza massiccia: il carcere.
 |
Orgosolo (Nu) |
 Disamistade verso lo Stato
Disamistade verso lo Stato
L’opposizione del pastore al sistema punitivo nasceva dal principio, a lui completamente estraneo, della conversione delle pene pecuniarie in pene detentive; questa pratica, infatti, non solo contraddiceva la concezione del pastore secondo cui la punizione inflitta doveva essere congrua rispetto al caso, ma soprattutto urtava la sensibilità morale del pastore poiché egli sapeva che una tale conversione colpiva in particolar modo “i disgraziati” che possono vedere annullato in pochi mesi il lavoro di anni. Era questa la ragione principale che spingeva molti verso la latitanza, unica possibilità non offerta dal “giusto” sistema legislativo statale di sorvegliare il proprio gregge e proteggerlo dai nemici. Il terrore che la carcerazione, soprattutto quella preventiva, ispirava al pastore l’idea che la bilancia della giustizia pendesse sempre a favore del potere, cioè di chi le leggi le scriveva e ne obbligava il rispetto, portò la comunità sarda a guardare ai carcerati come dei disgraziati, la cui famiglia andava sostenuta durante il periodo della detenzione. Non solo, il mondo pastorale diede vita a una bellissima pratica, sa ponidura, che consisteva nel ricostituire, attraverso la donazione di un capo di bestiame da parte di ogni pastore, un gregge nuovo da donare alla persona che usciva dal carcere e che, con molta probabilità, aveva perso tutto a seguito della detenzione. Un gregge che diventavo sacro agli occhi di tutta la comunità e il cui furto era considerato sacrilegio. Era il materializzarsi non solo dello spirito comunitario, ma soprattutto dell’opposizione di un codice morale e sociale che alla repressione e all’isolamento forzato dello Stato opponeva la solidarietà e la tutela dell’individuo.

È forse tutto questo solo racconto di un tempo lontano e di una realtà che ora non esiste più? In parte sì, perché quei vincoli comunitari sicuramente sono stati minati e sfilacciati, quei codici stravolti e depredati del loro filo diretto con il tessuto sociale di cui erano il frutto. Ma forse qualcosa rimane, seppur sotto traccia e spesso depoliticizzato, ed è il senso di estraneità rispetto a uno Stato percepito strumento di interessi opposti a quelli di una terra e del suo popolo. Ciò che quindi può mostrarci questo sguardo all’indietro sono le radici storiche di un’attitudine che porta ancora oggi la Sardegna a essere definita “una sorta di moderno laboratorio politico… una terra in cui si dibatte e si discute, un luogo in cui l’alto tasso di cultura politica fa sì che fenomeni, spesso considerati dai ‘continentali’ come semplici espressioni del malcontento popolare o fattispecie di reati perseguibili dalla legge, vengano valutati e analizzati in una prospettiva più ampia, che tiene conto anche delle radici storiche e culturali dell’isola. È una terra in cui l’estremismo tenta l’esperimento, sinora fallito ‘in continente’, di convogliare in un unico alveo le più diverse istanze ‘anti-sistema’, in nome di un obiettivo comune che, in questo caso, si identifica con ‘la liberazione dallo Stato colonizzatore italiano’ (3): sono le parole dell’intelligence italiana scritte sulla rivista di riferimento Gnosis in un articolo del 2005 e che mirano a tenere desta l’attenzione dello Stato affinché quell’alto tasso di cultura politica non esca dall’alveo dei partiti istituzionali conformi al sistema di rapina delle risorse dell’isola. Pena: la politicizzazione del malessere sociale e di quella tensione alla disamistade, all’inimicizia, verso uno Stato storicamente simbolo di potere e repressione.

