| Poeta, anarchico,
ebreo, assassinato
Anche quest’anno – in occasione dell’anniversario della sua morte, 10 luglio 1934 – ci sarà a Berlino una grande festa letterario-anarchica in ricordo del grande poeta Erich Mühsam, colui che diede voce alla protesta dei lavoratori bavaresi e che, assieme a Gustav Landauer, Ret Marut (il mitico scrittore/rivoluzionario B. Traven de Il tesoro della Sierra madre) e a tante/i compagne/i, partecipò all’organizzazione dei Consigli dei Lavoratori, Contadini e Soldati di Monaco all’indomani della caduta della monarchia guglielmina, il 7 novembre 1918. Un’esperienza breve, ma intensa (la Repubblica dei Consigli durò sino al 1° maggio dell’anno successivo, quando fu soffocata dall’esercito del governo socialdemocratico di Weimar) come quella del poeta anarchico berlinese, del quale l’editrice Zero in Condotta ha recentemente pubblicato, in un graziosissimo opuscoletto, un florilegio delle poesie, degli scritti politici e delle opere teatrali: Leonhard Schäfer (a cura di), Erich Mühsam, Il poeta anarchico, Zero in condotta, Milano 2007, pp. 60, € 5,00, www.zeroincondotta.org.
L’iniziativa editoriale vuole in un certo senso rispondere all’esortazione scritta in versi da Gustav Landauer – maestro, in quanto più anziano, del giovane Erich – che della primavera, della follia, della sbornia, della pazzia, dobbiamo sentire sempre il bisogno, la necessità, così come della rivoluzione, della poesia. E del poeta: un “soldato della libertà”, intento a “procacciarle nuovi combattenti”, come scrive Mühsam in una sua poesia autobiografia. L’opuscoletto di appena 60 pagine, riccamente adornato di foto, disegni e documenti dell’epoca, appare un tuffo nel passato remoto, quando le parole contribuivano a dare un significato ad una realtà che necessitava di un senso nuovo per affermare quanto l’arte e la rivoluzione abbiano il compito, l’una, di prefigurare la presenza di ciò che ancora è assente; l’altra, di realizzare – da ciò che ancora manca – la prefigurazione di un definitivo superamento delle condizioni organizzative sociali presenti. Quel richiamo all’imprevedibilità del nuovo che appare ogni qual volta la “rivoluzione significa non rovesciare le vecchie cose, ma vivere cose nuove” (p. 21).
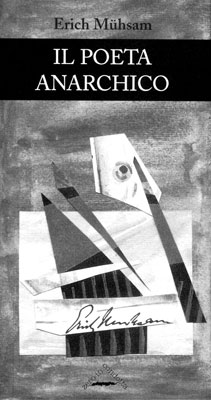
Con leggerezza e simpatia nei riguardi del “poeta anarchico”, Leonhard Schäfer si preoccupa di condurre il lettore a conoscere i diversi momenti che contraddistinsero la vita e le opere di Erich Mühsam, suggerendone i “temi” che con maggior forza emergono dall’esperienza vissuta dell’intellettuale berlinese: dalla fase romantica-ironica dei primi anni del secolo, quando l’amore e una carica introspettiva sono le lenti che aiutano il poeta ad osservare il mondo (limpido ed essenziale è il verso “sono una stella che illumina il suo dio” presente in Ich bin ein Pilger del 1904); ad una fase dove la poesia diviene un urlo di battaglia e di rivolta, come la ballata Der Revoluzzer del 1907, dedicata alla socialdemocrazia tedesca, in cui l’ironia graffiante dell’autore raffigura il rivoluzionario di professione nel suo compito di “lustra lampioni” da non accorgersi che la rivoluzione ha poco a che spartire con chi vuole preservare intatto il proprio mestiere di rivoluzionario…di professione “lustra lampioni”.
Ma sono in particolar modo gli anni che precedono il primo conflitto mondiale a far maturare definitivamente l’impegno anarchico, antimilitarista e rivoluzionario di Erich Mühsam. Al grido di “lasciateci esser caotici!” di Revolution (1913) si riassume in pieno l’ispirazione bakuniniana della volontà distruttrice come volontà creatrice tout-court (“non siamo drogati dal desiderio di distruggere, ma entusiasti a creare”), passando per la fucina della Repubblica dei Consigli di Monaco (novembre 1918-maggio 1919) dove l’uccisione dell’anarchico Landauer segnerà profondamente la vita del poeta berlinese, arrestato e condannato a 15 anni di duro carcere; anni in cui nello scrivere dalla fortezza-carcere Ansbach, (il 16 maggio 1920) “non perdonate né a servi né a padroni” e “l’uguaglianza abbellisce”, proclamerà a chiare lettere – è proprio il caso di dirlo – la sua volontà di continuare imperterrito la lotta.
Sono questi anche gli anni in cui aderirà, solo per tre mesi, al partito comunista tedesco (KPD) e in cui il pericolo fascista lo condurrà alla ricerca di un’alleanza con tutte le forze della sinistra rivoluzionaria al fine di vincere il nemico comune. A seguito di un’amnistia (grazie alla quale anche Hitler uscirà dalle prigioni, dopo aver trascorso appena un anno rispetto ai cinque comminati per aver organizzato nel ‘23 un putsch a Monaco) Mühsam, di nuovo in libertà, scriverà la poesia Lenin per la sopraggiunta morte, nella quale il ritmo panegirico è fortunatamente salvato dal verso: “Le catene che lui ha limato, strappatele” a conferma del suo credo nella libertà come conquista, non come concessione. Ma è soprattutto il suo impegno per la liberazione degli anarchici Sacco e Vanzetti che condurrà Erich Mühsam alla fine degli anni ’20 sino al suo arresto il giorno seguente all’incendio del Reichstag per opera dei nazisti (27 febbraio 1933), ad intraprendere una lotta politica ed una ricerca artistico-letteraria tesi ad esplorare nuovi registri linguistici (in primis la tragedia). Poi il buio, l’internamento, l’assassinio mascherato da suicidio, nonostante che poco prima avesse scritto alla moglie Zenzl: “non credere mai ad un mio suicidio!”.
In questo modo si chiude la vita di un “poeta anarchico” che con le sue numerose opere e liriche ha saputo coniugare l’arte e la rivoluzione nella sua concreta esperienza di vita, dove mai recedette alla sua massima: “piegarsi vuol dire mentire!”. E dove anche quest’anno a Berlino, dinnanzi alla sua tomba, saranno in molti a ricordarlo.
 Jules Èlysard
Jules Èlysard
Quando la sinistra
va alla guerra
La sinistra in guerra (Milano, Colibrì, pagg. 287, 12 euro), di Gaspare De Caro e Roberto De Caro, è un libro demolitore. Un libro ironico. Un libro che fa a pezzi l’ambizione della sinistra a governare, a sostenere il dominio e il controllo “con ogni mezzo necessario”. Una dissezione spietata del cadavere della sinistra di governo, portata fino all’osso con feroce verve parodistica, con capacità analitiche affinatissime, con tensione illuministica e uno sguardo sempre attento e documentato verso cifre e dati materiali.

Il saggio dei De Caro espone una sinistra che non ha altre pretese di quelle di un governo (cioè di un dominio) “ben temperato”. Che si regge – come ogni governo – sulla distanza tra governati e governanti, sulla separazione, sulla soggezione civica, sulla delega. Un governo che parla di solidarietà e reprime i migranti. Che lancia campagne intimidatorie sul tema fittizio della sicurezza. Che parla di pace e fa la guerra, ora con moderni eufemismi veltroniani, ora con la retorica militarista d’antan del ministro Parisi.
Proprio a quest’ultimo – in compagnia col borgomastro Cofferati – sono dedicate splendide pagine parodistiche. Ne esce – con stile esilarante – il ritratto impietoso di un militarismo da caricatura, di sceriffi di provincia che si alternano alla ribalta. E l’arte del “ritratto carico” non esige troppo artificio: la realtà è già oscenamente grottesca (si veda al riguardo l’episodio in cui Parisi stigmatizza gli studenti che copiano in classe, rei di una incipiente slealtà nei confronti delle istituzioni).
Ecco allora il ritratto di una sinistra pronta a rincorrere tutti i luoghi comuni del conformismo, un tempo dote della destra: guerra ai migranti, alle sostanze, ai comportamenti devianti. Più polizia, più legge, più magistrati, più legalità, più carcere.
Rimarrebbe la solidarietà, tra i cui panneggi a tratti si avvolgono alcuni leader più “movimentisti”. Ma bisognerebbe chiedere cosa ne pensano di certo umanitarismo solidale i profughi della Katër i Radës, la nave albanese speronata volontariamente dalla marina italiana nel marzo 1997 durante il precedente governo Prodi. Per quei cento morti, perlopiù donne e bambini, il governo Prodi non si è mai assunto la responsabilità morale. È a queste vittime dimenticate che è dedicato il libro dei De Caro.
 Alberto Prunetti Alberto Prunetti
Tra taverne
e balli vodoo
Il periodo che va dal XVI al XVIII secolo segna una nuova fase storica in cui
le borghesie mercantili e terriere europee aprirono nuove vie commerciali verso
l’Africa e le Americhe, fondarono nuove colonie, avviarono una nuova economia atlantica e soprattutto organizzarono da una parte all’altra di questo oceano la forza lavoro necessaria per far girare questa macchina. Estrarre l’oro, disboscare e dissodare le terre, coltivare il cotone, il tabacco, la canna da zucchero, trasportare le merci, lavorarle, edificare città, porti, costruire navi, tutto questo implicava strappare milioni di persone dai propri luoghi, dalle proprie economie tradizionali per immetterli, organizzarli e controllarli all’interno degli ingranaggi di questa nuova economia. Così lo schiavo africano, il servo irlandese, il marinaio multietnico, il proletario inglese, diventano le nuove figure necessarie a questa nuova economia lucrosa e sanguinosa. Se ci pensiamo un’impresa ciclopica, una prova di forza erculea da parte di questa nuova classe possidente.
Infatti i suoi esponenti prendono ad emblema proprio il personaggio mitologico greco che, come ogni Ercole che si rispetti, ha bisogno del suo mostruoso antagonista, l’idra dalle molte teste. Così apparivano alla borghesia del tempo le genti delle classi subalterne: una massa informe, pericolosa, colorata, multietnica, meticciata, rabbiosa, pronta alla rivolta per distruggere la civiltà che stavano edificando. Il libro di Peter Linebaugh e Marcus Rediker (1), due professori universitari statunitensi, intitolato I ribelli dell’Atlantico. La storia perduta di un’utopia libertaria (Feltrinelli, Milano 2004, pagg. 430, euro 30,00) tenta di ricostruire le vicende perdute di questo proletariato multietnico che lavorava sulle navi, nei porti e nelle piantagioni, una vera e propria classe internazionale ed intercontinentale che si snodava dal porto di Londra a quello di New York, passando per le coste dell’Africa occidentale fino ad arrivare alle isole caraibiche. Una classe che si incontra sui pontili delle navi o nelle taverne dei porti, accomunata dalle sofferenze e dalle violenze inflitte da una disciplina disumana.
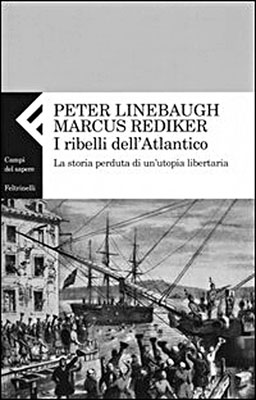 |
All’inizio la multietnicità è voluta dal padrone perché strumento di divisione e quindi di controllo, ma successivamente si trasforma in un elemento di forza per questi diseredati. I proletari, i servi e gli schiavi si parlano e si inventano nuove lingue, incrociando il loro inglese, il gaelico, l’akan africano e lo spagnolo. Così le motley crew, le squadre multientiche dove i marinai ed i proletari imparano a lavorare collettivamente, diventano il motore principale per le centinaia di rivolte, cospirazioni, rivoluzioni che esplodono nei porti atlantici, nelle piantagioni, sulle navi o nelle isole caraibiche. Le rivolte degli schiavi, gli ammutinamenti, le rivolte contro l’arruolamento obbligatorio, non erano tentativi ciechi senza progetto, al contrario puntavano a conquistare forti militari, a prendere città come New York, a fondare repubbliche comuniste all’interno del continente americano, con l’aiuto delle tribù dei nativi.
Ma il pregio di questo libro, non è tanto l’aver raccontato questa storia, ma il tentativo di far emergere il filo rosso che legava profondamente tutte queste esperienze che sorgevano da una parte all’altra dell’Atlantico. Spesso era la stessa borghesia che creava le premesse per questa unificazione delle esperienze rivoluzionarie, quando vendeva lontano gli schiavi ribelli pensando di liberarsi da un problema, così come accadde a New York che divenne il mercato in cui venivano venduti tutti gli schiavi più rivoltosi delle Antille. Spesso erano gli stessi proletari che, liberandosi dalla schiavitù ed abbracciando la pirateria, facevano circolare la loro esperienza per i mari.
Se è assolutamente vero che questa classe era composta anche da ladri, assassini, uomini senza scrupoli, sorgeva sempre più forte al suo interno e nelle sue rivolte la speranza nella realizzazione di un mondo di liberi ed eguali, dove non sarebbe più esistita la schiavitù o il servaggio. Era una speranza influenzata non da ideologie politiche ma dalle sette religiose evangeliste, segno del peso e della influenza che aveva avuto la rivoluzione inglese nella formazione di questo proletariato.
Quindi, un libro da non perdere, soprattutto per chi ama leggere la storia nelle sue pieghe nascoste, ma anche per chi desidera lasciarsi guidare in voli panoramici, capaci di cogliere le grandi correnti profonde che attraversano i secoli ed i continenti. Un libro da non perdere per chi ama tuffarsi nella storia concreta, per sentire gli odori ed i puzzi delle taverne portuali o per vedere i balli frenetici voodoo testimoniare un desiderio innato nell’essere umano alla libertà.
 Riccardo Bonelli Riccardo Bonelli
1. Ricordiamo di Marcus Rediker il libro Canaglie di tutto il mondo. L’epoca d’oro della pirateria, edito da Elèuthera nel 2005. N.d.R.
Cose da
museo
Alzi la mano chi, alla proposta “andiamo al museo?”, non pensi subito che ci sono un sacco di cose più belle da fare; giusto in vacanza sembra accettabile andare a un museo, tutto sommato fa parte del mestiere di turista, ma non nella vita quotidiana quando la sensazione che prevale è spesso di noia e polvere: anche nel linguaggio comune la parola “museo” è sinonimo di statico e vecchio. A questo si contrappone però un generico senso di colpa, perché nella nostra società la visita al museo è vista come il giusto completamento della vita culturale e sociale, è il luogo imprescindibile del bello e della cultura, un luogo che arricchisce il visitatore.
Stretti in questa contraddizione, ci si dimentica la cosa più importante: nell’immaginario comune il museo è un luogo di totale autorevolezza, dove le opere sono esposte senza mediazione e garantiscono una forma oggettiva di conoscenza che non soffre della manipolazione che diamo per scontata in ogni altro strumento di comunicazione: i mass-media per cominciare, ma anche i libri, il cinema, etc.
Nella realtà l’istituzione museo si presta a essere uno dei cardini della comunicazione delle produzione ideologica da parte delle élite che gestiscono il potere, e ogni forma di condizionamento è ovviamente strettamente correlata al grado di libertà sociale. Ogni stato, attraverso l’esposizione degli oggetti artistici e dei reperti archeologici, definisce l’identità della propria nazione. I musei etnografici hanno rappresentato per oltre un secolo la supposta arretratezza degli altri popoli rispetto all’uomo bianco per giustificare l’occupazione coloniale in tutto il mondo. I musei storici, attraverso la selezione e la rilettura degli avvenimenti, contribuiscono a scrivere il passato a uso e consumo dei bisogni politici del presente.
Di contro, è anche utilizzato per distinguersi rispetto al potere dominante: i musei gestiti dai popoli nativi in tutto il mondo consentono spesso di rivendicare una propria dignità culturale autonoma; i musei di comunità che stanno cominciando a sorgere nelle grandi metropoli multi etniche e permettono il dialogo tra le varie componenti sociali, costituendo un’occasione di orgoglio e di argine alla richiesta di omologazione imposta dalla cultura ospitante.
Il museo insomma non è una struttura asettica e innocente, al di sopra delle parti, ma un soggetto attivo della vita sociale.
 |
Cose da museo. Avvertenze per il visitatore curioso (di Andrea Perin, Elèuthera 2007, 136 pp., € 12,00) aiuta a scoprire i suoi meccanismi, a comprendere le motivazioni che guidano le scelte: intende offrire la possibilità di essere in grado non solo di non essere sprovveduto di fronte a questa istituzione, ma anche di potersi godere con maggiore consapevolezza tutte le meraviglie e le bellezze che espongono.
 Andrea Perin Andrea Perin
|

