|
 Canzoncina d’amore
Canzoncina d’amore
senza pretese
per Bulat Okudhava
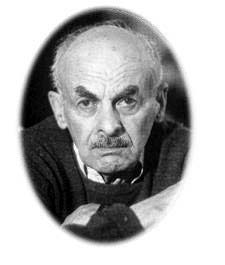
«Ahi guerra che hai fatto vigliacca!»
A quella mummia mostruosa di Leonid Breznev si
attribuisce la seguente frase «L’aria di Mosca sarà
più respirabile quando Okudhava e Vissotskji non la respireranno
più».
Questi due nomi – tutto sommato – in occidente ben
poco noti, contro cui si ergeva la censura sovietica, a chi
mai saranno appartenuti?
A pericolosi deviazionisti? A sionisti borghesi? A rinnegati
Titoisti? A torbidi borghesi decadenti? A spioni Trosko-Bucharinisti?...No
signori! Nulla di così innocuo!... Faceva bene il Politburo
a infierire e a mettere in guardia i sani virgulti della gioventù
socialista... perché i due appartenevano alla categoria
di persone più pericolosa per qualsiasi tirannia: Bulat
Okudhava e Vladimir Vissotskji erano due poeti.
Peggio! Due grandi poeti, popolarissimi e armati di chitarra.
Incoercibili alle ragioni dello stato, perfettamente allineati
a quelle dell’arte.
Del secondo ci occuperemo più avanti.
Bulat Sandovic Okudhava (1924-1996), poeta dei mezzi toni, dell’ironia,
della dolcezza, della comprensione, ha alle spalle la tragedia
della rivoluzione e della guerra! Suo padre, attivista importante
del Pcus, rivoluzionario della prima ora, cadrà vittima
di una delle tante purghe: fucilato negli anni ’30 («Ahi
guerra che hai fatto vigliacca!»). Sua madre, militante
anch’essa, appena più fortunata, berrà l’acqua
congelata del Gulag per 19 anni («Ahi guerra che hai fatto
vigliacca!»). Altri nove fra i suoi parenti furono fucilati,
e poi, tutti, riconosciuti innocenti. Bulat, appena diciassettenne,
allevato nel culto staliniano della personalità, correrà
ad arruolarsi volontario per difendere il suolo patrio dalla
minaccia nazista, e sarà immediatamente e più
volte ferito. «Ahi guerra che hai fatto vigliacca!».
Come una caduta sulla via di Damasco, la ferita apre a Bulat
gli occhi, degli occhi molto particolari... caustici e irridenti
col potere, con l’ingordigia, con la superbia... dolci,
comprensivi e sensibilissimi con un’umanità fraterna
e sofferente. Innanzi tutto proprio l’esperienza terribile
della guerra detterà alcuni dei più bei versi
mai cantati al nostro, che continuerà a inseguire questo
tema per tutta la vita: «Canzone degli scarponi militari»,
«Lenka Korolev», «Il soldatino di carta»,
«Il giovane ussaro»...e tanti, tanti altri canti,
compongono uno stupendo poema, non ideologicamente antimilitarista...nella
poesia di Okudhava non vi è mai alcun teorema da dimostrare,
così che il sacro orrore della guerra gli nasce dalla
profonda antiumanità di quest’ultima. L’esperienza
personale detta a Bulat immagini tanto semplici quanto strazianti:
«non credere alla guerra ragazzo|la guerra è stretta
come le scarpe». Potrebbero sembrare parole troppo familiari,
poco adeguate all’immensità della tragedia? Forse
non avete mai portato un paio di scarpe troppo strette.
L’ironia: Okudhava la maneggia come nessun altro, e la
sua ironia è solo sua, giacché spinge sempre a
una profonda pietas, che, anziché far ridere,
diventa due volte più commovente. Non è il cinico
sarcasmo del blasé che da una cima di disprezzo
sogguarda il mondo, è una forma d’amore, piuttosto,
d’un uomo tanto sensibile da confessarsi solo in questa
maniera.
A confermarsi in questa lettura basta ascoltare le melodie.
Il poeta confessa durante un concerto: «Quand’ho
iniziato conoscevo tre accordi di chitarra, ma ora, dopo trentacinque
anni di lavoro son migliorato...ne conosco cinque!». Può
anche darsi, la questione è un’altra, la pasta delle
sue melodie è la voce pura del miele! Sono melodie meravigliose,
placide e indimenticabili, iniziano in calma, come un discreto
tappeto su cui la scarna voce dell’autore srotola i suoi
versi, poi si agganciano all’anima dell’ascoltatore,
e gli strappano lacrime dalle oasi più profonde dell’inconscio...
Il talento del melodista è una strana bestia, può
essere conferito a un musicista preparato e colto come Léo
Ferré, Gershwin, ma anche a un orecchiante sbilenco;
attiene probabilmente più all’universo emotivo che
a quello culturale, e che sia elaborata su un piano armonico
complesso e inafferrabile (alla maniera dei grandi compositori
di canzoni Brasiliani ad esempio) o che si appoggi su un banale
“do/sol7” ripetuto alla nausea, la melodia, quand’è
bella, emerge come un regalo della natura, come un sospiro di
brezza nell’afa estiva; questo era il talento di melodista
dell’incolto Okudhava, tutt’altro paio di maniche
l’apparente semplicità delle sue liriche... lì
vi è sì, come dicevamo, il tormento dell’uomo
che conosce per nome le separazioni («qualcuno conosce
a memoria il nome delle specie dei pesci, io delle separazioni»
diceva Nazim Hikmet), ma tale tormento è stratificato
da una fittissima presenza di riferimenti letterari. La totale
consapevolezza dell’Okudhava letterato, che non può
sfuggire allo slavofilo, giunge al lettore persino in traduzione,
ed è il risultato di una cultura assimilata nei pori
della pelle, non certo fuga ma altra realtà, verità,
spesso profondissima, da cui attingere motivi di un’intima
resistenza. La capacità di rendere trasparente tale stratificazione,
di modo che la cultura in questo poeta è come quelle
20 o 30 passate di vernice neutra che Amedeo Modigliani era
uso dare sui suoi ritratti, rendendoli al contempo lucidissimi
eppur imprecisi, è una delle più alte caratteristiche
di quest’opera, densa ma chiarissima. Quanta povertà
c’è invece in certi contemporanei poeti laureati
che coprono dietro l’oscurità di un ermetismo indigesto
una deprimente vuotezza di sentimenti!
Quando le opere di Okudhava si cominciarono a diffondere in
Russia, nell’aria si respirava la corrente fresca del disgelo,
era il ’56 e il mondo sperava in quella primavera annunciata
dal XX congresso; lì Bulat ha l’occasione di poter
pubblicare il primo smilzo librettino di liriche. Intanto queste
liriche lui le ha già adattate al canto, e già
le esegue per un ristretto cerchio di amici... i primi magnetofoni...
le duplicazioni clandestine... la sete di libera comunicazione,
permettono a queste canzoni di raggiungere la più sperduta
periferia dell’immensa nazione sovietica, è il primo
passo di una notorietà senza diritti d’autore, ma
perciò tanto più eroica e indispensabile. È
l’epoca gloriosa del Samizdat. A Okudhava comincia a capitare
di esibirsi in pubblico, limitatamente al proprio carattere
molto schivo e agli impegni di scrittore tout-court: egli, oltre
alle pubblicazioni poetiche, pubblica diverse opere narrative,
novelle e romanzi, di cui alcuni esistenti persino in traduzione
Italiana: «Il povero Avrosimov», «In prima
linea», «Appuntamento con Bonaparte».
Le esibizioni pubbliche del Bulat cantautore sono però
spesso limitate oltre che dalle scelte personali dai mancati
permessi, dall’ostilità aperta, dalla censura sempre
all’erta. Sempre imbecille e inutile.
A Bulat capita persino di poter incidere un disco, uno vero,
ma a Parigi, e ovviamente per la sinistrosissima etichetta «Chant
du Mond», ben lieta di annoverarlo nel suo pregevole parco
di artisti (Athaualpa Yupanqui, Lluis Llach,...); evidentemente
per i comunisti francesi vale la regola biblica del «non
sappia la destra quello che fa la sinistra» e così
ciò che è apertamente osteggiato in patria diventa
motivo di sovietico orgoglio all’estero... beninteso, purché
non si tenti di importare quei pericolosi dischi in Russia!
Ma non voglio neanche io compiere l’errore, troppo spesso
rimarcato, di interpretare la sublime arte di Bulat all’unica
luce della infame ostilità in cui si dovette esprimere,
ben più grande, generosa e magnifica resta la sua opera.
«La preghiera di François Villon», «La
canzone dell’Arbat», «Canzone Georgiana»,
per non fare che pochi titoli, sono diamanti inestimabili, in
cui la nostalgia e un dolore diffuso, un senso di perdita senza
remissione si sposa a una fraterna appartenenza alla dolorosa
umanità dei protagonisti di questo canzoniere.
Una delle ultime incisioni che hanno circolato (beh, insomma,
diciamo che io me la son disseppellita in un magazzino francese)
di Bulat è la postuma pubblicazione dei nastri del suo
ultimo concerto dato nel ’95 a Parigi... cosa si può
dire se non che ogni minuto di quei circa 100 è un’emozione
indescrivibile; l’anziano bardo vieta di spegnere le luci
in sala perché vuole dialogare col pubblico fra una canzone
e l’altra, si fa portare sul palco dei foglietti con le
domande dei presenti, si serve di un traduttore simultaneo (assolutamente
incapace), leggiucchia stentatamente alcune liriche senza nessuna
prosopopea, come rivolto a se stesso... ma nonostante tutta
quest’informalità, quando sul tappeto dei suoi cinque
accordi, fa il suo augurio agli amici o parla del soldato ussaro,
che nel turbine di polvere che il tempo ha deposto su ogni eroismo,
su ogni vanteria, su ogni medaglia, è ancora inginocchiato
a brillare d’amore per la sua Marina... allora la voce,
il respiro e il fiato portano a bruciare le lacrime in ogni
petto umano che abbia o non abbia mai conosciuto quella Mosca
straziante e commossa, la cui aria, come diceva Breznev, sarebbe
stata più respirabile dopo la morte dei suoi massimi
cantori. Bulat lì respira e aggancia a ogni respiro chi
lo ascolta.
Chi è morto due volte è solo Breznev. E ben gli
sta.
 Alessio Lega
Alessio Lega
amoreanarchia@tiscalinet.it
|
Canzoni
della fanteria
Perdonate
la fanteria, spesso è così stupida:
partiamo sempre quando sulla terra esplode la primavera.
E con passo incerto, sulla scala che vacilla non c’è
salvezza.
Ci sono solo salici bianchi, come bianche sorelle che
ti guardano andare.
Non
credete al tempo quando riversa a lungo la pioggia.
Non credete alla fanteria quando canta canzoni gagliarde.
Non credete, non credete, quando nei giardini cantano
gli usignoli.
La vita e la morte non hanno ancora chiuso i loro conti.
A
noi il tempo ci ha insegnato a vivere all’addiaccio,
con la porta aperta.
Compagno uomo, la tua sorte è ingannevole: sei
sempre in marcia,
però c’è una domanda che ti fa perdere
il sonno.
Perché partiamo quando sulla terra esplode la
primavera?
|

|
Canzone
dei ragazzi dell’Arbat
(l’Arbat,
una delle vie centrali della vecchia Mosca, è
per Okudhava la “patria mitica”, l’infanzia
e il luogo di ogni separazione e ritorno, moltissime
canzoni le sono state dedicate dal grande poeta)
Che
hai fatto in tempo a pensare, padre mio fucilato,
quando io son partito con la chitarra, sconcertato ma
vivo?
Come se dalla scena fossi sceso nell’intima mezzanotte
di Mosca,
dove ai vecchi ragazzi dell’Arbat si dona gratis
il destino?
Secondo
me tutto è stupendo e non c’è motivo
per tristezze
e quei tristi commissari camminano per Mosca come un
sol uomo;
e non ci sono, non ci sono caduti fra i vecchi ragazzi
dell’Arbat.
Solo: chi doveva s’è addormentato, ma chi
non doveva, non dorme.
Sì,
la memoria è una mesta sorte, ma Mosca ha visto
di tutto
e i vecchi ragazzi dell’Arbat ridono delle parole
di consolazione.
|

|
Lenka
Korolev
(in
russo il cognome Korolev, peraltro diffusissimo, richiama
la parola “re”, di qui il gioco di parole
su cui nasce la canzone)
Nel
cortile in cui ogni sera il giradischi suonava,
dove le coppie ballando alzavano la polvere,
i ragazzi erano devoti a Lenka Korolev
e gli avevano conferito il titolo di RE.
Era
un re come tutti i re, e dunque onnipotente
e se un amico era nei guai o in qualche brutta storia
Lenka Korolev gli porgeva la sua mano regale
e con la mano fedele, lo salvava.
Ma
quando i Messerschmitt come corvi
lacerarono il silenzio dell’alba
il nostro re, come tutti i re, mise l’elmetto sulle
ventitré,
come una corona, e partì in guerra.
Ora
suonano di nuovo i dischi, il sole è alto,
ma nessuno piange sulla sua vita...
il nostro re era solo, scusatemi,
non aveva fatto in tempo a procurarsi una regina.
Però
io dovunque vada e qualsiasi cosa pensi,
se lavoro o anche se passeggio,
ho sempre l’impressione che al primo angolo
incontrerò Korolev il re.
Perché
se pure è vero che in guerra si muore,
la terra umida non può fare per Lenka,
e poi, scusatemi, ma Mosca non può esistere
senza un re come lui.
|
|

