|
Conflitti in miniera
Siamo nella seconda metà dell'Ottocento. In un'Europa
profondamente trasformata dalla rivoluzione industriale, si
aggira, come è noto, uno spettro. Il quale, tanto temuto dagli
uni quanto auspicato dagli altri, assume le sembianze di una
nuova organizzazione, l'Associazione Internazionale dei Lavoratori.
Ramificata in molti paesi del vecchio continente e negli Stati
Uniti, l'Internazionale, la proletaria Prima Internazionale,
raccoglie sotto le sue bandiere i ceti e le classi sociali che,
fino a quel momento, non hanno mai goduto di una rappresentanza
specifica. È la prima volta che accade. Non è più un'organizzazione
politica che raggruppa una borghesia illuminata e progressista,
non è più la fratellanza di tipo massonico che auspica il libero
pensiero o combatte il dogma, non è più la paciosa società di
mutuo soccorso; niente di tutto questo, è un'organizzazione
sociale composta da proletari che lottano contro il padronato,
per migliorare le proprie tremende condizioni di vita. E per
cambiare il mondo. E sono queste sue caratteristiche, così nuove
e "rivoluzionarie", che la rendono temuta, osteggiata e calunniata
da un capitalismo profondamente offeso dalla sua audacia. E
ancora impreparato al duro scontro sociale che si prospetta.
Naturalmente anche la letteratura diventa uno strumento utile
per affrontare la questione, e come sempre, per suo tramite,
si cerca di proporre un originale contributo interpretativo.
Fra le opere coeve che parlano di Internazionale e di internazionalisti,
ho scelto uno sconosciuto "romanzone" popolare, tanto significativo,
quanto, ormai, dimenticato: I Minatori ovvero Internazionale
e Comune, romanzo sociale di Emilio Tanfani, pubblicato
ad Asiago nel 1879 dall'editore Rigoni Graber.
Riporto per grandi linee la trama, avvincente nello svolgimento
e illuminante nei contenuti. In una miniera francese gli internazionalisti
non cessano di sobillare ed eccitare i lavoratori. Nonostante
la paternalistica offerta di aumento di salario, riduzione d'orario
e compartecipazione agli utili avanzata dal padrone, la situazione
precipita, la folla si ribella e distrugge col fuoco miniera
e opifici. Enrico, bravo operaio pur se internazionalista, dopo
aver inutilmente cercato una mediazione riformistica ed essere
sfuggito per un pelo alla vendetta degli antichi compagni, salva
i proprietari, mentre un loro intransigente impiegato si redime
morendo eroicamente nel disperato sforzo di avvertire i gendarmi.
A Parigi, durante la Comune, si ritrovano tutti. In un susseguirsi
di drammatiche avventure, trionfano i buoni sentimenti e la
giustizia. Mentre la Comune viene sconfitta nel sangue dalle
truppe versagliesi (ma questa è un'altra storia), il minatore
mauvais, dopo mille tradimenti trova la fine che merita,
il padrone benedice le nozze fra l'eroico operaio e la figlia,
il capo degli Internazionali, l'alter ego cattivo dell'internazionalista
buono, si uccide per non soccombere ai suoi nemici, esprimendo,
al tempo stesso, irriducibile malvagità e dignitoso coraggio.
E i minatori, buoni buoni, tornano alla miniera rimessa in funzione,
godendo di migliori condizioni di vita. Schiavi come sempre
ma un po' meno poveri.
Nel libro, di gradevole lettura, non compaiono, ovviamente,
solo queste tematiche sociali, ma anche tutti gli elementi canonici
del feuilleton ottocentesco: le passioni forti, la traviata
e la figlia della colpa, la squallida megera, gli assassinii,
il fuoco divoratore, il vecchio genitore povero ma onesto, l'amore
fra l'operaio e la padroncina, il buon dottore, la folla invasata,
la bimba rapita in fasce... Tutto serve a rendere attraente
il racconto, e a indurre a parteggiare, mai come stavolta, per
i buoni padroni e gli onesti operai, uniti nella lotta contro
i cattivi internazionalisti. L'aspetto più interessante di questo
romanzo, tuttavia, è che non si tratta affatto del prevedibile
testo reazionario scritto dal pennivendolo di turno, ma della
"lungimirante" opera di un riformatore sociale avveduto e intelligente,
il quale, nonostante cadute obbligate quale la descrizione dell'Internazionale
come una setta tenebrosa e assetata di sangue, prospetta una
soluzione riformistica e compromissoria del conflitto sociale,
in grado di garantire il permanere dei privilegi a fronte di
un miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, e
di tarpare le ali alle insopprimibili rivendicazioni proletarie.
Questo conflitto fra capitale e lavoro, fra proposte riformistiche
e istanze rivoluzionarie, si coglie, soprattutto, nella caratterizzazione
dei due antagonisti. Da una parte il buon operaio Enrico Vergani,
antesignano del gradualismo e della via parlamentare, solidale
coi compagni di lavoro e con l'Internazionale ma non tanto da
accettarne i metodi "sanguinari", dall'altra il cattivo, malvagio
e cinico Guglielmo Darwing, alias Rodolfo Musson alias
Arturo Chariots, l'irriducibile emissario dell'oscura setta,
intransigente nel suo cieco furore antipadronale e rivoluzionario.
Ossia, il nostro "ritratto in piedi" di questo mese. Perché,
e non credo di sbagliarmi, sotto le sue sembianze, si possono
intravvedere quelle, ben più famose e nobili, di Michele Bakunin.
Il suo attivismo, la sua capacità di convincere, il suo disprezzo
per ogni interesse personale, la sua coerente intransigenza,
il suo anteporre il trionfo della rivoluzione alle regole morali,
sembrano infatti descrivere, con la vividezza del contemporaneo
(la prima stesura del romanzo è del 1873) se non i tratti biografici,
sicuramente quelli caratteriali e politici del grande russo.
Bakunin è troppo famoso, perché mi soffermi a tracciarne una
biografia, per cui qui mi limito a riportare una sua bella istantanea
tratta da G.D.H. Cole, (Il Pensiero socialista. Marxismo
e anarchismo, vol. II, Bari, Laterza, 1967), nella quale
l'autore riesce a ritrarne, con vivaci colori, l'estroverso
comportamento. Scegliendo poi fra una pubblicistica imponente,
affianco, a queste, le pagine di Renato Zangheri, (Storia
del Socialismo italiano. Dalla Rivoluzione francese a Andrea
Costa, Torino, Einaudi, 1993), nelle quali il grande storico
marxista presenta l'altro vero protagonista de i Minatori,
vale a dire lo Sciopero. Seguono quelle di Pier Carlo Masini,
(Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta,
Milano, Rizzoli, 1969), nelle quali il caposcuola degli studi
sull'anarchismo illustra le aspirazioni alla rivoluzione sociale
dei primi internazionalisti italiani. Del libro di Tanfani,
del quale non posso raccomandare la lettura perché essendo introvabile,
dovrei imprestarlo (e non lo farei volentieri) avrei voluto
riportare interi capitoli. Nella evidente impossibilità, ho
scelto alcuni brani particolarmente "importanti" nell'economia
del racconto, sperando di poter così trasmettere, a chi mi legge,
almeno una parte del piacere che mi ha dato la sua lettura.
 Massimo Ortalli
Massimo Ortalli
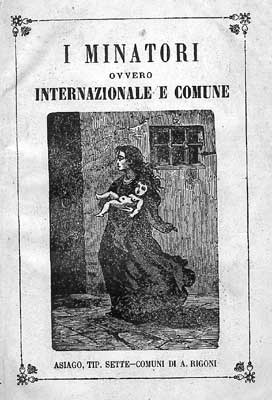
Il buono
e il cattivo
di Emilio Tanfani
(...). A queste parole Guglielmo divenne pensieroso e corrugò
la fronte. Poi, dopo alcuni istanti di silenzio, che gli avevano
forse servito a riconcentrare 1e proprie idee, con accento sommesso
ma concitato, disse:
"La lega dei mestieri e l'Associazione Internazionale degli
operai sono due benefiche istituzioni che nei tempi moderni
propugnano in favore degli operai la rivendicazione dei diritti
del salariato.
Per mezzo di esse abbiamo già potuto stabilire la solidarietà
rivoluzionaria fra quattro milioni circa di individui. Ebbene,
voi che siete gl'instancabili agenti della moderna rigenerazione,
a coloro che non capiscono o non vogliono capire che soltanto
un' altra terribile rivoluzione sociale può porre un argine
alla prepotenza dei capitalisti alle miserie degli operai, direte
che il tempo delle dissertazioni è finito e che quello dell'azione
sta per cominciare.
Direte che ogni loro più caro sogno, ogni più gradita loro speranza
addiverrà un fatto compiuto, se sapranno mostrarsi uomini all'ora
della terribile rivendicazione dei loro sacrosanti diritti.
Direte che fra breve avverrà tra la Francia e la Germania una
delle più sanguinose e più accanite guerre. E allora sarà giunto
il momento propizio a noi, qualunque sia la parte vincitrice!
Noi non apparteniamo ad alcun partito, a nessun paese, noi siamo
l'Internazionale, abbiamo quattro milioni di soldati... e guai
al vinto!
Ecco, amici miei, l'avvenire; ecco la meta, ecco la ricompensa
promessa ai nostri sforzi!"
(...). Finalmente Enrico, dopo aver vissuto in Inghilterra ed
in America, d'onde ebbero origine le nuove idee socialiste che
attualmente minacciano la pace del mondo, e d' onde si diramò
in Europa l'Associazione Internazionale degli operai, ebbe modo,
di acquistare esperienza, di convincersi che non è tutto oro
quel che riluce e che le rivoluzioni sociali non si possono
effettuare coi mezzi illeciti e violenti, ma colla progressiva
educazione delle masse alle nuove teorie dell'economia sociale;
moderò I'impeto giovanile delle proprie convinzioni e s'indusse
a pregare lo zio di porre una pietra sulle passate discordie,
assicurandolo, che non avrebbe mai preso parte all'opera dissolutrice
già iniziata; specialmente in Francia, dai segreti agenti dell'Internazionale.
(...). Né si tacque all'arrivo di Enrico, sicchè questi potè
udire le ultime parole del suo discorso e convincersi che non
s'era ingannato nel credere che il Darwing da lui conosciuto
a New York come uno dei più fanatici capi dell'Internazionale,
e il Soprintendente della miniera del signor Dubois, fossero
una stessa ed unica persona.
"Pare impossibile che dopo tre rivoluzioni politiche –
diceva Guglielmo – tanto radicali come quelle del 1789,
del 1831 e del 1848, la classe operaia si trovi ancora miserabile
e oppressa come prima! È dunque necessario combattere
con armi nuove e nuove idee!
V'ingannano coloro che vi parlano di repubblica: essi sono affezionati
alle viete formule del passato, e invece noi dobbiamo proclamare
quelle dell'avvenire! Sono tre i flagelli dell'attuale società:
il prete, il soldato, il possidente; e per sottrarci alla dannosa
influenza di queste tre caste, fa d'uopo combattere senza pietà
finchè non sieno per sempre annientate.
Siate pronti ad ogni mio cenno; cercate costantemente di porre
a profitto dell'Internazionale l'influenza che avete sui vostri
compagni di sventura, per accrescere così le file dei combattenti...
e la vittoria sarà nostra".
Un fragoroso applauso accolse queste ultime parole di Guglielmo,
sul di cui volto passò un lampo di indefinibile soddisfazione.
E siccome i capisquadra si disponevano a separarsi per tornare
chi a casa e chi al lavoro, ei li fermò col gesto e additando
loro Enrico, che muto e pensieroso aspettava di conoscere per
qual ragione avesse dovuto recarsi in quel luogo, disse: "Amici,
vi presento il cittadino Enrico Vergani da molti di voi già
conosciuto e stimato. Egli proviene da New York ove ha ricevuto
il primo battesimo dell'Associazione Internazionale. Nella sua
qualità di Sottodirettore dell'Opificio meccanico, egli avrà
modo di far nuovi proseliti fra gli operai che non si trovano
alla mia dipendenza e che finora rimasero sordi alle vostre
istigazioni. Rispettatelo come superiore, amatelo come compagno
di cospirazione! Al pari di noi egli vuole il trionfo della
nostra causa, al pari di noi farà di tutto per conseguirlo".
(...). "Ignoro se poc'anzi avete promesso ai rivoltosi di prendere
in considerazione i loro reclami, colla ferma idea di concedere
davvero almeno una parte di ciò che vi è stato chiesto. Comunque
sia, mentre ammiro l'avvedutezza da voi dimostrata in sì difficile
situazione, avvedutezza che vi ha risparmiato certamente qualche
scena di sangue, mi trovo in obbligo di avvisarvi che la vostra
salvezza presente e avvenire dipende appunto dall'evitar qualunque
altra causa di lamento.
Per giungere a questo, occorre dunque che agli occhi dei vostri
operai possiate sembrare un principale modello, informato ai
princìpi della moderna questione sociale, e per conseguenza
penetrato dalla giustezza dei reclami che vi sono stati fatti".
"Tu dunque intenderesti che io concedessi tutto ciò che mi è
stato chiesto?" domandò il signor Dubois, alquanto agitato dall'
idea di dover sottostare ad un atto di brutale prepotenza per
parte di coloro che gli dovevano l'esistenza.
"Questa, a mio parere, sarebbe l'unica via per iscongiurare
qualunque altro doloroso avvenimento, per assicurarvi al presente
e in futuro la più perfetta tranquillità, per garantire alla
signorina Anaide il possesso avvenire della vostra proprietà.
Al punto cui siamo oggigiorno con la questione sociale, e stante
l'eccitamento in cui si trovano le masse operaie, è necessario,
indispensabile ovviare qualunque causa di malcontento, non solo,
ma evitare anche ogni sospetto di preconcetta malafede.
Così diverrete l'idolo dei vostri operai, così sarete da loro
mille volte benedetto, così disarmerete i malintenzionati, così
annienterete l'azione dell'Internazionale! Invece, eludendo
le speranze che dianzi avete avvalorate colle vostre stesse
parole, o ricorrendo all'intervento della truppa per punire
i colpevoli e ristabilire l'ordine colla forza e col terrore,
sareste esecrato, e non garantirei a lungo né la vostra vita,
né le vostre sostanze".
(...). Ma Guglielmo intendeva le cose in ben altro modo; ei
non istigava le masse alla lotta per amore ad un principio di
giustizia, di diritto e di umanità; ma bensì per un diabolico
trasporto a tutto ciò che genera discordia e distruzione. Ei
non aveva per fine, nella sua incessante azione sovversiva,
gl'interessi della classe operaia, ma voleva valersene come
mezzo per giungere ad appagare una smodata cupidigia di ricchezza
e una irresistibile bramosia di potere.
Perciò, con quel fare misterioso e quell'accento profetico che
tanto gli giovava sempre ad acquistarsi gli animi dei suoi uditori,
disse: "che un fatto parziale a profitto di poche diecine d'operai
non poteva ritenersi come un trionfo per tutta l'Associazione
Internazionale; che il sig. Dubois aveva probabilmente ceduto
più per timore di qualche serio disordine, che per desiderio
di avvantaggiare le sorti dei suoi dipendenti; che prima o poi
avrebbe certamente cercato di rendere illusorie le fatte concessioni;
che, per conseguenza, nell'interesse della solidarietà indispensabile
fra tutti i membri della gran famiglia operaia, era d'uopo stare
all'erta e diffidare, per non avere poi da rimpiangere di aver
troppo presto deposto le armi e troppo presto rinunciato alla
sanguinosa lotta che in ogni parte del mondo si stava preparando
fra la mano d'opera e il capitale."
A queste parole gli occhi di Tigrotto lanciarono uno sguardo
feroce e selvaggio.
Anch'esso anelava sangue, stragi, carneficine, e gioiva nel
sentir confermato dal Darwing il proprio convincimento, cioè:
che le concessioni del Dubois non dovessero avere per conseguenza
una pace duratura, ma una semplice tregua. L'improvvisa sparizione
di Michele Perrier l'aveva già spinto a ritenere per fermo che
il sig. Dubois intendesse giocare una commedia che prima o poi
doveva tramutarsi in ispaventevole dramma.
Tratto da: Emilio Tanfani, I Minatori ovvero Internazionale
e Comune, Asiago, 1879.
Forza vulcanica
di G.D.H. Cole
Fisicamente, Bakunin era un gigante, dotato d'una forza erculea.
Gli anni trascorsi in carcere dopo il '49 gli costarono la perdita
di tutti i denti e contribuirono molto a minare la sua fibra;
ma rimase sempre capace di un'attività immensa, anche se spasmodica.
Dovunque andasse era una forza vulcanica ed esercitava spesso
un fascino veramente notevole su coloro ai quali si associava:
dirgli di no era quasi impossibile, anche quando non era agevole
accogliere le sue richieste. Per altri aspetti, invece, non
era uomo con cui fosse semplice intendersi. Sempre a corto di
denaro – anzi, non possedendo mai un soldo che non venisse
dai suoi amici era uno scroccone impenitente e insaziabile,
non tanto perché facesse per sé spese pazzesche, quanto perché
non aveva il senso dell'economia, era molto generoso col denaro
che si faceva prestare e si trovava di solito in difficoltà
familiari che mettevano a dura prova la sua borsa. Appena qualcuno
gli dava un po' di soldi, subito li spendeva o li dava via e
si metteva alla ricerca di altri amici dai quali farsi fare
altri prestiti, di rado o mai sdebitandosi, ma senza mai cessare
di trovare nuovi fornitori. Visse molto in casa d'altri, per
lo più con gran disagio di chi l'ospitava, giacché non sapeva
che cosa fossero né gli orari né l'ordine: riduceva ogni appartamento
da lui abitato ad un caos, e tendeva a stare a letto tutto il
giorno e in piedi tutta la notte, scrivendo indefessamente e
consumando enormi quantità di caffè e tabacco. La sua corrispondenza
era di una mole prodigiosa, e continuamente metteva mano a opere
che, iniziate come opuscoli, acquistavano via via le dimensioni
di grossi libri ed erano poi di solito abbandonate per qualcos'altro,
molto prima che fossero finite. Quasi tutte le opere di Bakunin
sono incompiute; e in verità non c'era ragione che venissero
finite, dato che più egli scriveva più affrontava nuovi argomenti,
sicché alla fine si stancava e cominciava a scrivere qualche
altra cosa, per lo più con le stesse idee essenziali, ma sistemate
in modo alquanto diverso. Lo stesso accadeva con le serie di
articoli che egli accettava di scrivere per vari giornali: di
solito restavano interrotti a metà, o perché si stancava o perché
la sua attenzione veniva attratta da altre cose. È indubbio
che Bakunin fu fedele ai suoi princìpi anarchici anche nel suo
modo di vivere: quel paio di tentativi che fece negli ultimi
anni per adattarsi a una vita più regolare fallirono in partenza.
Il grande principio del vivere è la libertà, egli proclamò sempre;
e certamente nessuno mai visse più libero con così poco denaro
proprio.
Tuttavia quest'uomo tanto importuno era evidentemente una persona
amabile, e ispirava un affetto profondo, se i suoi amici sopportavano
per lui una mostruosa quantità di fastidi. Aveva quel tipo di
temperamento aristocratico che rende chi lo possiede totalmente
inconscio delle barriere di classe e pronto ad accontentarsi
di una cipolla come a gradire il lusso, quando il lusso gli
càpiti dinanzi. Era geniale in grado eminente, quasi incapace
di offendersi e irresponsabile all'estremo. Era inoltre un amico
lealissimo, pronto a fare qualunque cosa per i suoi compagni
tranne che restituire il denaro che gli avevan prestato, e molto
generoso nell'apprezzare i suoi avversari se riteneva che fossero
fondamentalmente "dalla parte " della rivoluzione, la quale
era la sua passione.
Tratto da: G.D.H. Cole, Il pensiero socialista. Marxismo
e anarchismo, vol.2, Bari, 1967.
Un delitto
morale
di Renato Zangheri
L'anno 1872 segnò nel paese una presa di coscienza
degli scioperi. Uscìi in quell'anno il IV volume del
Dizionario della lingua italiana del Tommaseo in cui
la parola "sciopero" veniva definita nel suo significato attuale,
sconosciuto ai vocabolari tradizionali: "Voce pur troppo viva,
di lavoranti che smettono le opere consuete, per forzare chi
paga la mercede a aumentarla" (1). Due fascicoli furono pubblicati
sugli scioperi negli Annali del ministero di agricoltura,
industria e commercio per il 1872, il secondo dei quali
conteneva notizie sui conflitti del lavoro a Torino e a Milano,
Parma, Venezia, Verona, Cremona. Poco perspicui erano i commenti
dei prefetti ivi contenuti: gli scioperi erano stati determinati
da cause politiche, dal desiderio di imitare quello che si era
fatto altrove o da altre cause "innaturali". L'Internazionale
veniva indicata come principale promotrice. L'anno prima Cesare
Cantù nel suo Portafoglio dell'operaio, romanzo edificante
commissionato dall'industriale Alessandro Rossi, aveva indicato
lo sciopero come "un delitto morale", responsabile di "una perdita
sociale ". Era ormai in corso non solo una percezione ma una
reazione delle classi dominanti. Agli arresti degli "eccitatori"
si accompagnava se cosi possiamo chiamarla una offensiva di
persuasione (2).
Venne pubblicato dai fratelli Treves nella collana "La scienza
del popolo" un volumetto di Leone Paladini, Gli scioperi
e la questione sociale in Italia. Parole ai poveri ed ai ricchi
(3), in cui erano profusi tutti i possibili argomenti per distogliere
gli operai dalle "inutili agitazioni" e dai "sordi rancori ",
dalle "azioni sconsigliate e colpevoli ". Gli scioperi non servivano
a fronteggiare il caro degli affitti, perché se avessero provocato
un aumento delle paghe, altri lavoratori sarebbero affluiti
nelle città e gli alloggi sarebbero diventati più costosi. Cosi
ogni accrescimento dei salari porrebbe in difficoltà i fabbricanti
di fronte alla concorrenza straniera, farebbe lievitare i prezzi,
si tradurrebbe in disoccupazione, renderebbe la vita più difficile.
In realtà, i lavoratori non riconoscerebbero necessari gli scioperi,
se dei sobillatori non li eccitassero. È vero che essi patiscono
" dure sofferenze"; ma ciò che conturba le loro menti non è
tanto il caro vita quanto "altre aspirazioni, altre tendenze,
altre suggestioni ", nella " seducente ma pur menzognera speranza
di un' immaginaria trasformazione sociale".
(...).
Il Paladini sapeva qualcosa dei recenti contrasti in seno all'Internazionale.
I suoi membri, affermava, sono poco stimabili: "dai medesimi
rendiconti dei loro congressi risulta che sono essi i primi
a disprezzarsi, a coprirsi d'insulti, a nutrire la massima diffidenza
verso coloro che si danno per loro capi, ed accusarli brutalmente
di seduzione, di ambizione e di intrigo", com'è avvenuto all'Aia.
Essi non hanno programmi, il loro vero piano "è la dissoluzione
sociale ed il caos, lusingandosi che possa poi da sé costituirsi
una società meglio organizzata". Non é comunque da parte di
questi comunisti che si debba temere il peggio, e non c'è motivo
di grave allarme né necessità di "applicare quelle misure violente
di repressione, che alcuni troppo pessimisti e paurosi vanno
invocando con troppa sollecitudine". È vero che il malumore
che cova fra le classi povere "è purtroppo appoggiato anche
sul fatto che i proletari hanno imparato a ragionare sui propri
diritti, sulle loro condizioni, sull'eguaglianza umana, e sono
irresistibilmente allettati dalla speranza di poter modificare
il loro stato di povertà, di privazioni e di sacrifici". Ma
solo i pochi seguono "le perniciose teorie dell'Internazionale".
La stessa Comune fu il risultato di circostanze eccezionali,
un concorso di nobili sentimenti e di subdole imprese, che non
si potranno mai riprodurre né a Parigi né in altre città. Il
vero rimedio sarà l'istruzione impartita dai dotti agli ignoranti,
una morale "più filosofica ed evangelica", un impegno educativo
delle "classi agiate ed elevate".
1. G.C. Jocteau, L'armonia perturbata. Classi dirigenti e
percezioni degli scioperi nell'Italia liberale, Roma - Bari
1988, p.3.
2. Ibid., pp.10-16, 19-20. E sul "Portafoglio" di Cantù si veda
il commento di C. Ginzburg, Folklore, magia, religione,
in Storia d'Italia Einaudi, I. I caratteri originali,
pp. 660-70.
3. L'edizione da me consultata è la terza, del 1874.
Tratto da: Renato Zangheri , Storia del socialismo italiano.
Dalla rivoluzione francese a Andrea Costa, Torino, 1993.
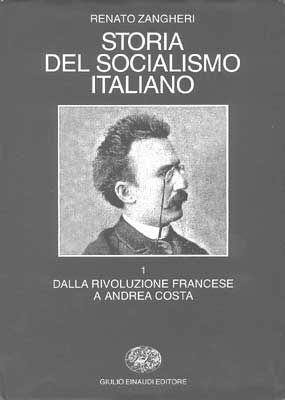
La Rivoluzione
Sociale
di Pier Carlo Masini
"VIVA LA RIVOLUZIONE SOCIALE ", con questo grido
erano finiti i lavori della Conferenza di Rimini. E il Cafiero,
presidente di quella conferenza, aveva poco dopo concluso il
suo articolo sul congresso dell'Aia con parole altrettanto impegnative
e solenni: "A provare le nostre forze attendiamo la Rivoluzione:
che essa giudichi autoritari ed anarchici" (1).
Ma che cosa intendevano gli internazionalisti italiani
per rivoluzione sociale? Essi anzitutto, mettendo piuttosto
l'accento sull'aggettivo che sul sostantivo, intendevano il
contrario della rivoluzione politica, di cui il Risorgimento
con il suo epilogo unitario-monarchico, rappresentava l'esempio
negativo e deludente. In secondo luogo, per la stessa impostazione
anarchica del problema, non potevano concepire la rivoluzione
nei termini delle esperienze quarantottesche: come conquista
del potere politico a mezzo di colpi di mano sui centri di questo
potere. Infatti gli internazionalisti non volevano in
alcun modo – né violento, né pacifico, né legale, né illegale
– la conquista del potere politico, ma si proponevano piuttosto
di distruggerlo. Le due questioni erano legate perché la conquista
del potere politico ricadeva ancora negli schemi della rivoluzione
politica che appunto gli internazionalisti rifiutavano
in nome della rivoluzione sociale.
D'altra parte la rivoluzione politica richiedeva anche per il
suo successo una organizzazione fortemente centralizzata, un
efficiente apparato militare, una rigida disciplina ideologica
e tattica che gli internazionalisti, per ragioni di principio,
rifiutavano.
Detto ciò che gli internazionalisti non volevano, resta più
facile capire che cosa in effetti volessero.
Di positivo volevano, come dicono i loro programmi, "l'emancipazione
del proletario" e "l'organamento del lavoro": due obiettivi
che a loro giudizio stavano completamente fuori della politica
corrente, in una nuova dimensione storica. Per "emancipazione
del proletario" essi intendevano la liberazione dei lavoratori
dalla condizione del salariato e dalla soggezione al capitale;
per "organamento del lavoro" una organizzazione economica collettivistica
a base federativa fra i comuni e le associazioni produttive:
questa era la parte socialista del loro programma.
Quanto alla rivoluzione sociale – o come si diceva talvolta
più fantasiosamente liquidazione sociale (2) – essa
si presentava agli occhi degli internazionalisti come una prospettiva
catastrofica e palingenetica, una specie di sisma politico più
o meno imminente. Si trattava di un mito di potente effetto
nell'agitazione e nella propaganda, mancante peraltro di quella
concretezza e praticabilità che invece si ritrovava nei piani
rivoluzionari di tipo tradizionale, giacobino o blanquista,
mazziniano o garibaldino.
Un nuovo millenarismo animava questa idea di rivoluzione sociale
non più concentrata in un punto dato e prevista per un momento
convenuto, ma concepita come un moto diffuso e ininterrotto,
una guerra senza quartiere, senza rigidi fronti di combattimento,
senza possibilità di armistizi e di soluzioni provvisorie: cospirazioni,
dimostrazioni barricate guerriglia per bande, sortite, moti
di piazza, proteste, agitazioni, scioperi, attentati, rivolte
in campagne e in città, atti individuali e movimentI collettivi,
fino alla totale distruzione del nemico: tutto questo era la
rivoluzione sociale.
1. L'articolo, intitolato Il Congresso dell'Aia e apparso
suI giornale "La Rivoluzione Sociale" del settembre 1872, non
è firmato ma lo si può attribuire con certezza a Cafiero, unico
italiano presente all'Aia che riferisce, da testimone, alcuni
particolari sui lavori del congresso.
2. Per una critica della parola d'ordine "anarchia e liquidazione
sociale" spesso usata dagli internazionalisti italiani e spagnoli,
si vedano le interessanti e significative osservazioni di James
Guillaume in una lettera a Victor Cyrille del 22 settembre 1873
pubblicata da Marc Vuilleumier, La correspondance d'un internationaliste:
Victor Cyrille (1871-1874), in "Movimento operaio e socialista"
del luglio-dicembre 1966.
Tratto da: Pier Carlo Masini, Storia degli anarchici italiani
da Bakunin a Malatesta, Milano. 1969.
|

