|
Diaz irae
Ci sono date, e luoghi, che restano impressi nella memoria
di una generazione. O di più generazioni, che però hanno in
comune qualcosa. Genova 2001 lascerà forse come Bologna '77,
o Seattle '99, una traccia indelebile nei tanti che hanno manifestato
nel capoluogo ligure, durante il caldo luglio scorso. Non potrà
essere dimenticato facilmente il trauma di migliaia di persone
– molti dei quali avevano come "esperienze politiche" più
rilevanti un campeggio scout, o la tessera del Wwf in tasca
– padri e madri di famiglia, adolescenti, signori attempati
con i primi acciacchi dell'età, bastonati mentre tengono le
braccia alzate. Ma se di quanto accaduto per le vie e le piazze
genovesi esiste una documentazione sterminata, soprattutto in
video, mancava un tassello importante alle giornate dell'anti
G8: l'incursione notturna alla scuola Diaz. È dunque
una testimonianza preziosa, quella che ricostruisce, con occhio
partecipato ma fedele di cronista, l'assalto delle forze dell'ordine
alla scuola dove dormivano 93 persone, in maggioranza stranieri,
nella notte fra il 21 e il 22 luglio. Lorenzo Guadagnucci, il
giornalista del Resto del Carlino che racconta la sua
esperienza personale, ci è finito per caso, dentro la scuola
dell'orrore, da cui lui e gli altri usciranno con le ossa rotte,
feriti a sangue dalla furia di un gruppo di poliziotti di cui
probabilmente non si saprà mai il nome.
Ma soprattutto non si conoscerà probabilmente mai il perché,
quell'angosciosa domanda che l'autore pone fin dalla prima parola
del libro, alla ricerca di una spiegzione per quella gragnuola
di colpi che lo sveglia, nella notte.
Perché i calci in faccia alle ragazzine, i pestaggi con vari
strumenti di offesa a una persona anziana, già mezza tramortita
a terra? La polizia sostiene di aver avuto notizia che la Diaz
fosse il covo dei black bloc, che hanno "devastato" Genova nei
due giorni precedenti. Questa, almeno è la versione ufficiale.
Ma per comprendere quello che è accaduto a Genova, e come un
giornalista economico può capitare in quella scuola, Guadagnucci
sceglie il metro più adatto: ripercorrere i passi di un movimento
balzato all'evidenza pubblica nel novembre '99 a Seattle, e
che affonda le sue radici ormai in una sperduta città del sud
del Brasile, Porto Alegre, dove l'autore ha partecipato ai lavori
del primo Forum sociale mondiale. Dunque, per tenere fede a
un percorso personale, osservare da vicino le manifestazioni
contro il G8, il giornalista esce di casa alle 4 di mattina,
diretto a Genova, dove seguirà il corteo in compagnia di alcuni
colleghi. Li lascerà solo a sera, alla ricerca di un posto per
dormire. Nel volume Noi della Diaz (ed.Berti, 173 pagine,
8 euro) ci sono le botte di quella tragica nottata, i drammatici
giorni successivi, trascorsi in ospedale con lo spettro di una
carcerazione vissuta come suprema ingiustizia, dopo quanto si
è subito; ma c'è anche lo sfondo, la cornice che avvolge un
quadro dipinto con colori fin troppo accesi nelle giornate genovesi.
Guadagnucci non tralascia mai l'aspetto umano della tragedia:
è una persona come tante, mite, tranquilla, piovuta in un ingranaggio
che pare stritolarlo. Si chiede persino se in qualche modo se
l'è "cercata", se possa essere stato imprudente; e forse nelle
pagine in cui si racconta ai poliziotti che lo piantonano all'ospedale
Galliera sta il succo profondo del libro. È in quei dialoghi
fra vigilato e guardiano che si intuisce che le ragioni di quanto
accaduto risiedono altrove, non possono essere comprese né dal
giovane in divisa, né dal giornalista finito nel posto sbagliato.
E' un senso di oppressione, quello che accompagna il lettore
nelle ore che seguono l'incursione notturna; si dirada solo
quando finalmente c'è il colloquio col magistrato, e l'ombra
di Kafka pian piano evapora. Si torna nella legalità, osserva
l'autore. L'interrogativo aperto dal libro, a cui si spera le
inchieste in corso possano dare risposta, è proprio quello:
"Perché a Genova, in alcuni episodi, la legalità, lo stato di
diritto, sono venuti meno? Chi ha dato quegli ordini?" Noi
della Diaz ha il sapore di un documento completo. Perché
racconta una vicenda umana che ha accomunato un gruppo di persone
che non si erano mai viste prima di metter piede in quella palestra
e forse non si incontreranno più; e perché va oltre la cronaca
di quelle giornate per cercare di spiegare come mai 250 mila
persone hanno sfidato il caldo e la sete, incassato le botte,
in un torrido fine settimane d'estate.

 Fabio Gavelli
Fabio Gavelli
"A"
come Africa
Interessante pubblicazione quella del libro Africa
Ribelle (Sam Mbah, I.E. Igariwey, Africa Ribelle, Zero
in condotta, Milano, 2002).. Per prima cosa perché gli autori
sono africani e non il solito "bianco" che parla dell'Africa,
e poi perché è quanto mai opportuno contribuire a diversificare
i commenti e le riflessioni su questo continente, chiamato spesso
"dimenticato" e lasciato ancora più spesso nel dimenticatoio.
L'Africa è presente nei commenti e nelle analisi della stampa
e della pubblicistica dei paesi ricchi soprattutto per il suo
sempre più forte "ritardo" rispetto al processo di globalizzazione
economica, e per i suoi drammatici problemi sanitari, che hanno
conquistato il primo posto delle emergenze, superando i tradizionali
problemi di diffusa sottoalimentazione. L'idea dominante, questo
sì un vero e proprio "pensiero unico", è racchiusa nella frase
"senza di noi morirebbero di fame". Con il temine "noi" si intendono
i paesi ricchi, e avanzati dal punto di vista tecnologico. Il
libro, invece, ricorda un fatto molto semplice e dimenticato,
e cioè che prima della colonizzazione i gruppi umani africani
hanno avuto una storia di migliaia di anni, ben più lunga della
"nostra" se si considera che gli scienziati genetici (vedi Cavalli
Sforza) identificano la progenitrice di tutti gli esseri umani
esistenti nella famosa "Eva nera" localizzata nella Rift Valley
dell'Africa centro-orientale.
Ne consegue che le culture e le abitudini di vita tradizionali
africane hanno consentito la sopravvivenza di molti gruppi in
tutto il continente e che non siamo stati "noi" a insegnar loro
come non morire di fame. Anzi, l'analisi storico-economica che
viene sviluppata nel libro è molto ben argomentata e sottolinea
che il fattore di cambiamento in peggio è avvenuto a seguito
della conquista coloniale.
Quello che è interessante e nuovo rispetto alle usuali analisi
socio-economiche in circolazione è la sottolineatura dei caratteri
"anarchici" e comunitari di molte tradizioni, senza cadere nella
semplicistica accettazione o valutazione positiva di tutto ciò
che ha a che fare con l'Africa del passato, quasi che ci sia
stata una mitica età dell'oro distrutta dai cattivi bianchi.
Le caratteristiche comunitarie, la capacità di autogestione,
la flessibilità dei ruoli e la fondamentale capacità di negoziare
tipica di molte realtà africane di villaggio, vengono sottolineate
nella prospettiva di vie d'uscita per un futuro più equilibrato,
positivo e meno dipendente, piuttosto che per lasciarsi andare
ai rimpianti. Questo è uno dei pregi principali del libro.
Circa l'analisi della situazione contemporanea fatta nel libro
appare utile ed opportuna la ripetizione del concetto che in
molte realtà africane le strutture burocratiche dello stato,
e la lotta delle fazioni più colte e privilegiate per il suo
controllo, sono le principali cause delle povertà, dell'instabilità
e dell'autoritarismo africano. Appare chiara e semplice anche
l'analisi e la descrizione dei meccanismi di potere diffusi
in Africa: partito unico, militari, burocrazia parassitaria,
classi privilegiate, ecc..
Qualche piccola critica si può fare alla parte finale del libro
dove appaiono affermazioni poco credibili (tipo "l'insuperabile
crisi del capitalismo africano" oppure "l'inevitabile ritorno"
all'anarchismo del comunalismo africano). Il capitalismo non
sembra propriamente in crisi e certa terminologia somiglia troppo
a molte analisi marxiste già viste in passato.
Il pregio maggiore del libro è senz'altro il tentativo, direi
riuscito, di riaffermare la credibilità storica e culturale
dell'anarchismo in particolare in terra d'Africa; una credibilità
che è almeno pari a quella di altre impostazioni ideologiche
che hanno seminato sul proprio cammino disastri, fallimenti
e costi sociali altissimi pagati dalla maggioranza delle popolazioni
dei vari stati africani.
L'auspicio degli autori è quello di un sostegno internazionale
al recupero di alcune tradizioni africane più legate al municipalismo
ed alla soluzione non conflittuale delle divergenze. In questo
senso possono essere significative alcune delle iniziative di
cooperazione in atto, gestite da alcune ONG in stretta collaborazione
con soggetti locali non legati alla burocrazia di stato. Va
però rilevato come ultima notazione che deve aumentare il peso
e la presenza delle donne in questo processo perché la tradizione
africana, pur presentando realtà interessanti, ancora mantiene
una eccessiva separazione tra i ruoli maschili e femminili.
 Fabrizio Eva
Fabrizio Eva
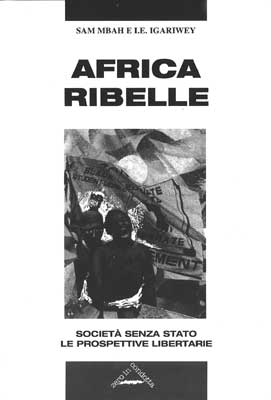
Finalmente gli
anarchici nel Dizionario del Futurismo
Nonostante che i due volumi siano stati stampati
fra ottobre e dicembre 2001, esce solo ora in libreria ed in
distribuzione il Dizionario del Futurismo curato da Ezio
Godoli per le edizioni Vallecchi di Firenze, in collaborazione
col MART (Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e
Rovereto). Opera monumentale di oltre 1200 pagine e cinquecento
illustrazioni, ha avuto una lunghissima gestazione. Iniziata
nel 1990, ha visto coinvolti ottantacinque collaboratori che
hanno redatto oltre 1200 fra voci e nomi, con migliaia di informazioni
e notizie organizzate in due volumi (A-J) e ( K-Z) che indagano
e danno conto dell'intera esperienza futurista in area italiana,
in letteratura, politica, arte, architettura, grafica, cinema,
moda, musica, teatro, spettacolo. Una ricchissima bibliografia
ed un agile sistema di rimandi collega i vari argomenti, e indica
i principali archivi e collezioni ove sono raccolti materiali
finalizzati alla ricerca.
Come afferma Godoli nella premessa, è stato scelto di operare
all'interno dell'area temporale 1909-1944, lasciando fuori quanto
avvenuto successivamente alla morte di Marinetti. La scelta
ha riguardato, specie dopo gli studi e le ricerche dell'ultimo
quindicennio, artisti, scrittori, intellettuali, che, pur
non avendo ufficialmente aderito al futurismo, sono stati spesso
presentati come "compagni di strada" (...) talvolta anche in
forma di accesa contrapposizione polemica. Questo criterio
ha riguardato anche i periodici: sono state schedate riviste
non allineate (...) o anche giornali che della polemica antifuturista
hanno fatto la propria missione.
Il curatore ricorda che proprio il fatto che alcune voci
proponessero informazioni e acquisizioni documentarie inedite
o gettassero nuova luce su argomenti, personaggi o gruppi finora
non adeguatamente esplorati, ha indotto a concedere loro uno
spazio che potrebbe apparire eccessivo rispetto a quello riservato
ad argomenti o figure di maggiore rilevanza storiografica.
È all'interno di questa logica che per la prima volta
ed in modo ampio ed esauriente, il coraggioso Godoli ha introdotto
nomi e voci che a molti appariranno eterodossi rispetto a ciò
che si è pensato "giusto" per lunghi decenni. Chi ha seguito
la storiografia di area anarchica specie da metà degli anni
Ottanta in poi non sarà stupito, ma credo comunque che rimarrà
sorpreso favorevolmente per quantità e qualità delle voci inserite
in questa grandiosa opera che mette un punto fermo alla ricerca,
la quale nonostante ciò proseguirà ed aggiungerà o correggerà,
così come sempre avviene.
Chi avrà modo di acquistare, o magari solo consultare, dato
il costo, che seppur contenuto, sale comunque a 200 euro, si
accorgerà ad esempio che al pari di voci come "fascismo", scontate
e abbondantemente riconosciute, troverà "anarchismo" assolutamente
paritetico per quantità e visibilità. Insomma si è avverato
un sogno al quale chi scrive teneva molto, si è avuta l'opportunità
di dare visibilità ad una componente del Movimento anarchico
che nel futurismo trovò almeno in parte, una possibile, ancorché
parziale, comunione di idee, e di strada da percorrere, avverso
lo stato borghese, la chiesa, la cultura soffocante e dominante.
Ricercatori più o meno noti, con grande efficacia hanno lavorato
duramente accanto a Godoli, dividendo con lui l'attesa e l'angoscia
di numerosi rinvii, di fallimento di case editrici, di aggiornamento
di schede, in questi dodici anni. Barillari, Cammarota, Chirico,
Ciampi, Giacomelli, Lista, Manghetti, Piscopo, Quinterio, Sacchetti,
Salaris e tanti altri, hanno coadiuvato il curatore in questa
interminabile fatica.
Nell'augurare un percorso più rapido e agile al realizzando
Dizionario degli Anarchici di lingua italiana, elenco
sommariamente voci e nomi di interesse immediato per il movimento
anarchico, presenti nel Dizionario del Futurismo, ricordando
che molte altre voci riguardano direttamente o indirettamente
la nostra storia, invitando con la presente succinta scheda,
ad approfondire il contenuto e, se ritenuto necessario e utile
come penso, a realizzare e produrre recensioni o altre azioni
finalizzate alla divulgazione del medesimo.
Il Dizionario contiene:
Aglietti Gino,"Anarchismo", Avanguardia, L'Avvenire
Anarchico, La Barricata, Cavalier Cortese,
La Demolizione, Fede, Ferrari Ricieri Abele, Giglioli
Giuseppe, Governato Giovanni Battista, Gozzoli Virgilio, Iconoclasta!,
Monnanni Giuseppe, Nichilismo, Il Novatore Anarchico,
Il Proletario, Il Proletario Anarchico, Provinciali
Renzo, La Questione Sociale, Rafanelli Leda, Rasi Tintino,
La Rivolta sia di Pistoia che di Milano, Roccatagliata
Ceccardi Ceccardo, Gli Scamiciati, Sciarpa Nera,
La Sferza, Stagi Rina, L'Università Popolare,
Vertice, Vir, Vita Libertaria, ma anche
La Blouse, La Tempra, Ugo Tommei, Carlo Carrà,
Gian Pietro Lucini e tantissime altre piacevoli scoperte.
 Alberto
Ciampi
Alberto
Ciampi
|

