|
Come è vero! Nulla in questo mondo è
perfetto, anzi, più si pensa che un sistema sia perfetto, che
non esistano falle nella concezione e nella prassi della struttura
creata, ecco che, col tempo, si verificano crepe, si evidenziano
pericolosi segni di cedimento. A volte sono gli uomini a sovvertire
il virtuoso svolgersi degli eventi; a volte è la logica stessa
imposta alla costruzione che mostra il fiato corto, l'incapacità
di fondo di gestire le dinamiche, tutte le dinamiche che regolano
o dovrebbero regolare il sistema.
La stampa nazionale – per non parlare dell'informazione
televisiva – è stata prudente, quasi omertosa, nel trattare
la losca vicenda della Enron. Non diciamo che non ne abbia parlato,
questo no, ma ne ha accennato come se si trattasse di un incidente
di percorso, di una devianza tutto sommato recuperabile con
qualche accorgimento in più. Insomma, di un evento che non intacca
il tessuto sostanzialmente sano del capitalismo americano, che
è poi il capitalismo che regola i fatti economici del mondo
intero.
E, invece, si tratta di un cedimento del sistema, di un coperchio
sollevato su una pentola nella quale bollono, sollevando vapori
mefitici, tutti gli ingredienti di una pietanza indigeribile
e, alla fine, venefica.
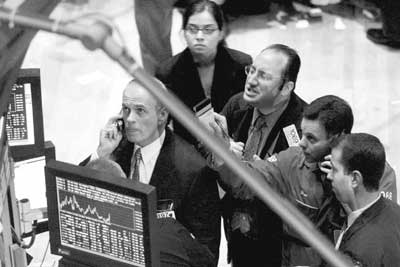
 Il capitalismo globale
Il capitalismo globale
Perché la vicenda della Enron è esemplare per individuare le
logiche interne di processi che il capitalismo oggi innesca
e i guasti che procura nei tesuti sociali direttamente o indirettamente
investiti dalle sue dinamiche. Prima il sistema si reggeva sull'equilibrio
tra la macchina che produceva la ricchezza e lo Stato, nella
sua versione di democrazia rappresentativa, che presiedeva alla
più o meno equa ripartizione delle risorse e fissava, sulla
base di questo rapporto, le norme della convivenza sociale.
La distinzione tra il potere economico e quello politico era
regolata e ci si sforzava di contemperare, almeno in via teorica.
le esigenze del mercato e quelle dei cittadini amministrati.
Si trattava naturalmente di equilibri instabili; l'essere conservatori
o socialdemocratici predisponeva a privilegiare le ragioni del
mercato rispetto a quelle del lavoro e viceversa, senza però
che tra il politico e l'economico vi fosse coincidenza organica
di interessi e, se qualche volta si tentava di stabilirla (col
voto di scambio, per esempio), si trattava di casi sporadici
universalmente deprecati. Certo i politici di tutti i tempi
non sono mai stati indifferenti alle pressioni dei potentati
economici, ma avevano ritegno ad appiattirsi pedissequamente
sui modelli di sviluppo del capitale. Anche se questi modelli,
dalla rivoluzione industriale sino alle soglie del secondo conflitto
mondiale, non pretendevano di esprimere una compiuta e complessiva
visione del mondo, ma a razionalizzare la produzione, a moltiplicare,
e, quindi, in un certo modo, a socializzare la produzione e
la distribuzione di beni e servizi.
Probabilmente – ma questa è una questione che va approfondita
in sede storiografica – è con la progettazione e l'attuazione
del Piano Marshall, concepito certo per dare una mano consistente
alla ricostruzione dell'Europa del dopoguerra, ma anche per
fronteggiare il pericolo sovietico, che il capitalismo percepisce
la possibilità di globalizzare le sue strategie. La forza militare
derivante dalle potenzialità di un'economia forte assurta così
a insostituibile baluardo del Bene – l'occidente industrializzato
– contro il Male – personificato nella contingenza,
dall'Unione Sovietica e dai suoi satelliti – porta ad un
mutamento qualitativo della funzione economica rispetto a quella
politico-sociale. Da qui a concepire un mondo nel quale le ragioni
del profitto fossero prevalenti rispetto a tutte le altre, il
passo è breve. È così che noi, oggi, ci troviamo immersi
in un contesto che precarizza sempre di più la sorte degli uomini
a vantaggio di processi di accumulazione della ricchezza che
non servono ad altro che a supportare logiche di dominio assurde
e distruttive. In via conseguenziale, così, sbaglierebbe chi
giudicasse atto di pura arroganza individuale l'esordio di Bush
che, senza mezzi termini, identificava lui e l'America con la
Verità e il Bene, e tutto il resto – cioè uomini e sistemi
che non condividono il modello capitalistico – con l'Apocalisse.
Ciò che di insopportabile e di patologico ha questo immenso
regime, che tenta di inglobare l'intero universo, è l'autoreferenzialità,
nel senso, soprattutto, che produce o tenta di produrre legislazione,
normative (e, quindi, Stato) per legittimare se stesso.
 Meccanismi perversi
Meccanismi perversi
Ecco perché il caso Enron non è il cancro che colpisce un organismo
sostanzialmente sano, ma "il manifesto" delle logiche che presiedono
al sistema di produzione capitalistica
I fatti sono sufficientemente noti ed io qui li sintetizzo al
massimo.
La Enron nasce nel 1985 dalla fusione della Huston Gas con la
Inter Nort e si avvia a diventare, in pochi anni, la settima
azienda del settore nel mondo, risultato raggiunto anche con
operazioni poco chiare per non dire di rapina (basti ricordare
il black out elettrico dello scorso anno in California, che
molti ritengono provocato dalla stessa Enron per speculare sulle
tariffe ed esercitare pressioni sui promotori di leggi antinquinamento).
Ma il successo ottenuto non soddisfa il management dell'azienda,
il quale decide di diversificare gli investimenti, soprattutto
nella direzione dell'intermediazione finanziaria dei prodotti
energetici (elettricità e gas) e, nel 1999, dei servizi informatici
(accordo con la Blackbuster, destinato a durare poco).
Inutile disperderci nel seguire nei dettagli tutte le operazioni
progettate e portate a compimento dalla Enron, con l'appoggio
sostanziale degli ambienti politici e finanziari degli Stati
Uniti.
Ciò che conta in questa sede è spiegare i meccanismi perversi
– ma perfettamente legali – messi in moto per creare
un colosso dai piedi d'argilla, che sarebbe clamorosamente crollato
sulla testa di migliaia di dipendenti e di risparmiatori che,
sull'onda dell'euforia di un decollo di borsa pilotato e degli
entusiastici servizi di pubblicazioni specializzate, avevano
investito i propri risparmi sulle azioni della società.
Il meccanismo della truffa era assai complicato nelle modalità
di attuazione, ma semplicissimo e quasi del tutto legale nella
impostazione concettuale. Il percorso, nelle grandi linee, è
il seguente. La Enron crea "a latere" una moltitudine ("Il Sole
24 Ore" ne ha contate oltre tremila, una ogni sette dipendenti)
di partnership (aziende collegate ma autonome) alle quali commissiona
lavori e servizi che vengono fatturati a prezzi stratosferici.
La Enron paga le fatture con i proventi delle proprie attività
e con la liquidità che le banche le accordano, allettate dai
faraonici progetti di espansione dell'azienda e garantite dagli
appoggi politici di cui mostra di godere.
A questo punto il flusso monetario che si trasferisce alle aziende
collaterali a fronte di adempimenti mai o solo in minima parte
compiuti, finisce nei paradisi fiscali delle Mauritius, delle
Bermude o delle Cayman oppure costituiscono fondi neri. Questo,
molto semplificato, il meccanismo che consentiva di distrarre
somme ingenti dal bilancio della Enron. Ma perché questo meccanismo
continuasse a funzionare, occorreva naturalmente che le cifre
da distrarre ci fossero ed ecco allora che si mise in moto un
gigantesco sistema di corruzione politica che consentì di superare
agevolmente inghippi burocratici, di ottenere contratti di forniture
privilegiati (come il contratto di 200 milioni di dollari per
la fornitura di energia elettrica alle città del Texas e della
California), sgravi fiscali e addirittura una borsa mondiale
dell'energia e delle materie prime interamente controllata dalla
Enron che, nel 1999, raggiunse le seimila transazioni giornaliere,
per un valore di circa due miliardi e mezzo di dollari.
Alla testa di questo colossale giro di denaro c'era Kenneth
Lay, ma, soprattutto, Joffrey Skilling, il quale capì in fretta
che mai si sarebbero potuti raggiungere i risultati sperati
senza l'appoggio, direi meglio, la complicità dei politici e
di quei politici in particolare che, per interessi concreti,
erano schierati dalla parte della "liberalizzazione dell'economia
senza lacci e lacciuoli": i repubblicani, insomma, ma non soltanto
loro. Certo, si partiva da una certezza incontrovertibile costituita
dall'amicizia personale di Lay con la famiglia Bush, ma questo
non bastava. Dal 1992 Skilling mette in atto un piano organico
di elargizioni – in gran parte perfettamente legali –
di cui godono prevalentemente i repubblicani che contano. Dei
Bush abbiamo già detto, che ricevono, dal 1993 sino alle ultime
elezioni presidenziali, ben due milioni di dollari; ci sono
poi le sovvenzioni al partito, mentre il senatore Phil Gramm,
il vice presidente Dick Cheney, il vice segretario al tesoro
Mark Weinberger, il sottosegretario all'economia Kathleen Cooper
e tanti altri politici di rilievo ricevono somme diverse in
soldi o in azioni, senza considerare un folto stuolo di giornalisti
televisivi e della carta stampata, che vengono chiamati a magnificare
le sorti della Enron con seminari e conferenze. Per di più Dick
Cheney sedeva nel consiglio di amministrazione dell'azienda
texana: quanto dire che l'azienda privata Enron aveva il governo
federale nel salotto buono del grattacielo di Houston. Chiedo
scusa delle omissioni, ma la lista dei politici, degli operatori
finanziari, degli opinionisti o di semplici galoppini è talmente
lunga che, da sola, occuperebbe lo spazio di questo articolo.
 Banche e revisori dei conti
Banche e revisori dei conti
Ma vi sono due ulteriori aspetti della vicenda Enron che vanno
sottolineati, perché ambedue concorrenti al colossale crack.
Il primo riguarda il ruolo delle banche. La dimensione del disastro
sarebbe stata probabilmente assai più contenuta se l'erogazione
del credito fosse stata correlata alla concreta struttura produttiva
e commerciale e alla corretta valutazione dei bilanci di gestione
dell'azienda piuttosto che alla sua dimensione azionaria. Mi
spiego. Le banche, in America come nella maggior parte dei paesi
industrializzati, fungono contemporaneamente da erogatori del
credito e da intermediatori finanziari. Questo che cosa significa?
Significa che l'andamento delle azioni in borsa (condizionato
da fattori psicologici, da manovre speculative o anche soltanto
da aspettative fideistiche) influenza direttamente le decisioni
che un istituto di credito compie nel decidere se e in quale
misura concedere fiducia all'azienda che chiede di essere finanziata.
Può così verificarsi – come si è in effetti verificato
nel caso della Enron – che, per difendere i propri crediti,
per aumentare le speranze di rientro delle esposizioni, le banche
creditrici sostengano oltre il lecito il corso azionario dell'azienda
debitrice. Le banche non potevano non sapere che, dal 2000,
i dirigenti della Enron andavano liberandosi delle azioni dell'azienda,
realizzando colossali guadagni a spese dei propri dipendenti
(ai quali era impedito di commercializzare le azioni) e dei
piccoli risparmiatori. Lay realizza 40 milioni di dollari, Lau
Pai suo collega 65, Skilling 15 e via dicendo. Per di più, si
era volatilizzato il fondo pensioni dei dipendenti, i quali
rimangono senza lavoro e senza futuro. Sul mercato finanziario,
nel giro di pochi mesi, un'azione della Enron precipita da 93
dollari a 27 centesimi di dollari.
Il secondo aspetto della vicenda Enron che volevamo sottolineare
è il ruolo dei revisori dei conti che, nel caso specifico, era
affidato alla Arthur Andersen, per importanza la seconda compagnia
del settore in America, che candidamente confessa di non avere
avuto sentore di nulla sino agli ultimi mesi del 2001, quando,
per tentare di occultare le sue inadempienze, distrusse migliaia
di documenti contabili della società revisionata. Voi direte:
tutto questo a titolo gratuito? Neppure per idea. I dirigenti
della compagnia di revisori erano anche loro chiamati a svolgere
consulenze assai ben remunerate e quando qualcuno all'interno
della Andersen o della Enron stessa, non compromesso, tentava
di vederci un poco più chiaro, veniva scoraggiato con pressioni
che arrivavano all'intimidazione. Non vi è così chi non veda,
oltre all'aspetto inquietante della commistione dei ruoli, quanto
sia incredibile il fatto che la Andersen, sino alla fine del
2001, non abbia avuto alcun sentore dell'implosione imminente.
Per concludere queste note, vorrei riprendere il concetto espresso
nell'esordio: il caso Enron non è la patologia di un sistema
sostanzialmente virtuoso, ma il naturale sviluppo di una prassi
consueta, sia pure portato alle sue estreme conseguenze. Significativo,
a tale proposito, è che le pratiche attuate dalla Enron erano
tutte legali o al limite della legalità, se si eccettuano quelle
di rilevanza penale (l'aggiotaggio, la frode nei riguardi dei
dipendenti, l'utilizzo fraudolento del fondo pensioni). Legale
è in America il finanziamento di partiti e di protagonisti della
vita politica. Per intenderci, in Italia, se vigesse il modello
americano, Tangentopoli non ci sarebbe mai stata e l'operato
dei politici non sarebbe mai stato messo in discussione.
Legale, per il sistema capitalistico non soltanto americano,
è la costituzione di società collaterali (partnerships) sulle
quali equilibrare gli scompensi di attività speculative azzardate
o addirittura incoffessabili.
Assolutamente normale è la schizofrenia delle banche, chiamate
a gestire contemporaneamente il flusso del credito e, direttamente
o indirettamente, ad influenzare l'andamento azionario dei propri
clienti. Il caso Enron dimostra che le banche non hanno finanziato
un'impresa, ma un gruppo dirigente che ha attivato un gigantesco
giro di operazioni speculative, azzardate e fuori mercato, e
un altrettanto gigantesco meccanismo di corruzione politica,
in gran parte, lo ripetiamo, consentito dalla legislazione americana.
 Senza lacci né lacciuoli
Senza lacci né lacciuoli
E poi, ancora. È prassi consolidata, in America (ma
la si vorrebbe instaurare anche da noi) che il privato imprenditore
gestisca i fondi pensione, sia che lo faccia nei confronti dei
propri dipendenti, sia che lo faccia come operatore finanziario.
Così, poiché le fortune economiche sono alterne, in caso di
collasso dell'impresa (fraudolentemente provocato o meno) il
lavoratore è depredato delle risorse accantonate per garantirsi
un minimo di futuro.
Infine, il ruolo dei revisori. In un mondo affaristico che non
esprime alcuna norma etica, nel quale il profitto e la competizione
senza esclusione di colpi sono gli unici valori che contano,
il ruolo dei revisori (come sanno tutti coloro che hanno svolto
tale compito) non è soltanto quello di valutare la congruità
dei documenti contabili, ma anche, e direi soprattutto, quello
di sindacare il comportamento degli amministratori quando esprimono
strategie non compatibili con la dimensione aziendale, alterando
il corretto rapporto tra le voci di bilancio. Non entrano certamente
nel merito delle strategie dell'impresa, ma sono chiamati a
vigilare perché ogni nuova iniziativa risulti compatibile con
le possibilità reali dell'azienda. Ciò implica una rigida separazione
dei ruoli. La presenza in America di grandi Compagnie di revisori,
inserite organicamente in un mercato in cui interagiscono interessi
colossali, fa sì che queste strutture di sorveglianza subiscano
la suggestione di essere parte attiva delle dinamiche del mercato
e, più o meno direttamente, finiscano con l'essere coinvolte
nelle dinamiche di crescita delle imprese sui cui bilanci dovrebbero
sorvegliare. Il che è perfettamente naturale: tanto più grandi
sono le dimensioni delle imprese controllate, tanto maggiore
è il prestigio che acquista la Compagnia di revisione. La Arthur
Andersen, l'altra grande imputata del caso Enron, non si limitava
ad esercitare il controllo che le competeva, ma fungeva anche
da consulente per la formulazione delle strategie operative,
e per questa sua funzione veniva remunerata a parte. Un esempio
emblematico di conflitto d'interesse.
Adesso che il guaio è fatto e l'edificio del liberismo senza
lacci e lacciuoli è scosso nel profondo della sua gaudente euforia,
tutti si stracciano le vesti. Gli economisti illuminati cercano
affannosamente vie d'uscita da una situazione che poche ne offre.
Il Congresso lancia dardi di fuoco alla Casa Bianca. Gli opinionisti
che contano sembra si accorgano solo adesso che la globalizzazione
così come è intesa dal mondo degli affari contemporaneo è all'origine
dei grandi scompensi che esistino al mondo, oltre che dei ciclici
collassi che investono intere aree geografiche, ieri il Sud
Est asiatico, oggi il Giappone e l'Argentina.
Ma il sistema, secondo la nostra ottica, non è emendabile. L'inversione
di rotta non può essere di qualche grado, bisogna voltare pagina,
compiere svolte epocali difficili.
Per queste ragioni, ci hanno profondamente rattristato gli elaborati
conclusivi del raduno di Porto Alegre. La montagna antiglobal
ha partorito il topolino di una risoluzione, se mi consentite,
risibile. Un enunciato di propositi e di lotte per incitare
i popoli a sorvegliare perché i loro governi siano buoni e virtuosi,
decisi ma educati nei consessi internazionali, solleciti a garantire
l'obiettività dell'informazione e via di questo passo. Tutto
ciò dopo aver elencato in sedici paragrafi, con puntualità burocratica,
tutti i mali del mondo in cui viviamo.
Cose da far rivoltare nella tomba i liberal-democratici della
Prima Internazionale di 130 anni fa.
 Antonio Cardella
Antonio Cardella

|

