|
 dossier
militarismo dossier
militarismo
Una guerra di carta
di Vittorio Giacopini
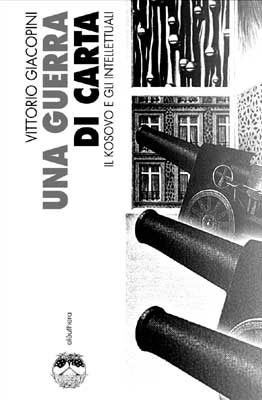
Il ruolo degli intellettuali durante il recente
conflitto balcanico nell'analisi di un giornalista di Radio
Rai e de "Lo Straniero". Stralci dalla sua introduzione all'omonimo
volume in uscita per Elèuthera.
"E quelli, la cui testa è
vuota come una scuola in agosto"
Tra il 24 marzo e l'11 giugno del 1999, per la prima volta
in vita mia mi sono trovato a scrivere un diario. Sono la data
d'inizio della guerra in Serbia e il giorno della fine ufficiale
dei bombardamenti, decretata alle 15,30 del pomeriggio (ora
italiana) dal segretario generale della Nato Solana.
Per tutto questo periodo la guerra in Kosovo mi ha accompagnato
come un'ossessione. (...) La scelta obbligata, l'impulso spontaneo
di tenere un diario, di registrare nel modo più asettico possibile
il succedersi incerto degli eventi, è stato forse un tentativo
minimo di reazione, probabilmente un riflesso meccanico ma impotente
di far fronte a un'irruzione improvvisa della "Storia mondiale"
nella mia vita; nella nostra vita. Una guerra: qui; fatta da
noi. Non c'ero, non c'eravamo abituati. In qualche modo, non
c'era alternativa: l'unica possibilità stava nel limitarsi a
prendere atto di quanto stava succedendo di fuori; laggiù. Probabilmente,
quel "diario di guerra" era soltanto questo: un tentativo di
convivere in modo per quanto possibile consapevole con l'orrore
e con il disgusto, il precipitato neutro di quanto si andava
depositando nella mia immaginazione, il reperto oggettivo di
una paralisi mentale imbarazzante. (...) Avvertivo di trovarmi
in un vicolo cieco ma intuivo, oscuramente, la necessità di
mettere da parte qualcosa di concreto: del "materiale" utile
per poter giudicare, per costruire e mantenere saldo un "punto
di vista" sulle cose; senza l'ausilio di nessuna teoria, senza
nessuna sofisticata forma di interpretazione.
Ma giudicare che cosa? E giudicare chi? Non la guerra, ovviamente,
le sue ragioni equivoche, le sue modalità inaccettabili. Da
subito, infatti, da quella prima sera di bombardamenti su Belgrado,
questa guerra mi era sembrata inutile, sostanzialmente sbagliata,
controproducente. La cosa in sé, mettiamola così, era abbastanza
evidente dall'inizio. Ma già dopo pochi giorni di raid aerei,
con l'intensificarsi delle distruzioni, con la moltiplicazione
- assolutamente speculare - della tragedia della pulizia etnica,
la strategia "umanitaria" della Nato si rivelava fallimentare
in modo incontestabile. Era la conferma di un'intuizione abbastanza
ovvia. Non sarebbero bastati i pochi giorni di guerra promessi
dalla Albright; Milosevic non sarebbe stato piegato in una settimana.
Era un dato di fatto: la guerra stava producendo danni peggiori,
guasti più gravi. Non era come l'ultima volta a Sarajevo; non
poteva esserlo. Però il problema non si esauriva nella negazione
decisa di un evento. Schierarsi contro questa guerra, dire di
"no": non era sufficiente, non poteva bastare. Lo vedo adesso,
lo sapevo anche allora: non esistono giudizi definitivi, validi
sempre, una volta per tutte. Meglio comunque mantenere sempre
aperto uno spiraglio per il dubbio, uno spazio critico per la
perplessità. Ogni mattina, lo stesso "rito" in qualche modo
riapriva il campo del giudizio: potevo sbagliare, potevo essere
stato precipitoso, dovevo essere disposto a rivedere il mio
punto di vista, correggerlo, adeguarlo ai fatti concreti, alle
circostanze. Non ce n'è stato bisogno, ma solo per caso. L'ostinazione
omicida di Milosevic, l'ottusità arrogante della Nato, alla
lunga hanno finito per confermare in modo definitivo quell'intuizione
ancora imprecisa e vaga formatasi spontaneamente nei primissimi
giorni di conflitto. È stata una guerra inutile e controproducente.
Uno sbaglio voluto, una porcheria. (...)
 Con armi molto diverse
Con armi molto diverse
Ma non esistono soltanto le amicizie, le relazioni immediate,
i rapporti concreti, face to face. E poi non ci sono soltanto
i "fatti", il seguito incerto e confuso degli eventi. I bollettini
di guerra riportavano novità smozzicate, verità provvisorie,
affermazioni date per certe smentite in due giorni o in una
notte. Cercavo di non perdere niente, di segnare tutto. Non
bastava. Attorno alla guerra, sopra alla guerra - come un guscio
d'uovo, come un liquido amniotico - iniziavano a depositarsi
le prime letture, le smaliziate spiegazioni degli "opinionisti",
le teorie degli esperti: problem solver, giornalisti,
teste d'uovo, grandi intellettuali & compagnia cantante. Una
guerra di carta avvolgeva impercettibilmente la guerra vera.
Lo scenario tendeva a duplicarsi ma lo spettacolo restava quello
che era: disgustoso. La sequenza dei bombardamenti e un lento,
capillare, bombardamento di parole vuote, di congetture colte,
di discettazioni. Un'altra guerra iniziava a vivere di vita
propria. Chiuso, senza volerlo, nella mia ossessione, cominciavo
inconsapevolmente a registrare anche questo secondo livello
di "crisi". Persino gli scabrissimi appunti del mio diario iniziavano
a prenderne atto, in modo del tutto casuale, senza intenzione,
senza nessun programma specifico. Era inevitabile, del resto,
ed era ovvio. Tra un "fatto" e l'altro, si inserivano (non so
bene come, non so bene perché) brevi note di lettura, appunti
per così dire di "secondo grado", commenti quasi sempre irritati,
infastiditi. Niente di strano. Leggevo i giornali, li guardavo.
Gli inviati al fronte, quando potevano, facevano il loro lavoro
con serietà, decenza, con coraggio spesso, sempre con un certo
impegno. Era utile leggere i giornali; era utile anche la televisione.
Per quanto in qualche misura sempre vittima dei meccanismi della
propaganda, bene o male l'informazione si rivelava all'altezza
della prova. Del resto non avevo gli strumenti per giudicare,
non potevo farlo.
Loro stavano là: vedevano quello che erano in grado (o gli era
consentito) di vedere; scrivevano quello che sapevano. Spesso
i loro articoli smentivano le versioni ufficiali, le dichiarazioni
del regime serbo, le balle della Nato: mi bastava. Ma questa
guerra - si vedeva in modo sempre più chiaro col passare del
tempo, dopo i primi momenti di stasi e di sorpresa, passato
lo sgomento iniziale - veniva combattuta anche con armi molto
diverse, più infide e sottili, meno nette. La "persuasione e
la retorica", le questioni di immagine, una forma di propaganda
o, per essere più precisi, proprio di retorica: queste forme
di controllo e di guida latente dell'opinione pubblica, questi
modelli di costruzione occulta del consenso (e del dissenso),
prendevano piede in forma sempre più regolare e più massiccia.
Leggevi i giornali, guardavi la televisione, ascoltavi la radio.
A un certo punto è diventato ovvio. Il lavoro "sporco" dovevano
farlo politici, militari, giornalisti. Il sofisticato compito
di indirizzo e di interpretazione, la rete di ragno mentale
che avrebbe dovuto spiegare il conflitto era invece stato affidato
(non so fino a che punto in modo consapevole e coerente) a una
categoria diversa e specifica: agli intellettuali, agli opinionisti.
(...) Questa guerra, forse, è stata diversa dalle altre. Combattuta
e legittimata su basi "umanitarie" - la tutela dei diritti umani,
la difesa degli oppressi, la stessa lotta per la libertà - questa
guerra doveva trovare un vocabolario per esprimersi, una formula
per "giustificarsi", una retorica. Gli intellettuali sono serviti,
dovevano servire, a questo. A dare un senso ad azioni stupide
e insensate, a vedere un fine, uno scopo e una meta, in un meccanismo
quasi automatico, palesemente privo di obbiettivi definiti,
costantemente incerto, poco chiaro. Oltre alla politica-politica
e alle armi è diventata essenziale questa "politica delle relazioni
pubbliche", una strategia verbale, la disperata ricerca di una
"filosofia politica" a presa rapida, da consumo immediato, metabolizzabile
subito, senza incertezze, esitazioni, dubbi, ripensamenti. Per
chi, come me, come (quasi) tutti noi, restava distante e separato
dal centro dei fatti, lontano dal vortice vivo degli eventi,
questo conflitto di "secondo grado" è diventato molto presto
il nodo vero di tutta la faccenda e il problema più serio. Chi
non è in grado di agire resta sempre coinvolto sul piano del
giudizio ma il giudizio era sistematicamente inquinato, ostruito,
preconfezionato da questo autentico fuoco di sbarramento di
parole vuote, analisi faziose, amenità. (...)
 Inganno e controinganno
Inganno e controinganno
In modo abbastanza paradossale questa guerra ci ha offerto
l'occasione davvero unica di vedere una classe intellettuale
impegnata in un sistematico lavoro di mistificazione, di verificare
un'intera "cultura"at work. Uno spettacolo desolante
ma istruttivo. Bastava guardare le colonne degli editoriali,
sfogliare le pagine dei commenti, le rubriche culturali di tutti
i giornali. Senza essere al "soldo" di nessuno, gli intellettuali
si sono distinti in una gara di esibizionismo, di vanteria,
di stolida saccenza, in un grande concorso di verbosità futile
e dannosa, in un inutile sfoggio di cultura colta. Questi bonzi,
questi sepolcri imbiancati, questi filistei (non tutti, naturalmente,
quasi tutti1). Ci siamo sempre chiesti a cosa servissero gli
intellettuali, che significato avesse ancora una parola logora
come impegno. La lezione (e la risposta) di questa drole
de guerre è stata tutto sommato esemplare. (...)
Leggevi e ti imbattevi sempre nello stesso "stile" uniforme,
inevitabile: un clima di inganno e di autoinganno, uno spettacolo
penoso di falsa intelligenza, di arroganza mentale, di presunzione
vuota. Una guerra "di carta" altrettanto cattiva e velenosa
della guerra vera: anche questa stava diventando una questione
privata, un conto da regolare e una specie di sfida. È cambiato
qualcosa. La rabbia e l'insofferenza hanno cominciato a prendere
il posto dello sgomento, a scandire i tempi di un'ossessione
finora passiva, senza sbocco. A questa guerra di carta - intuivo
- almeno si poteva reagire. Su questo piano era ancora possibile
fare qualcosa, dire qualcosa. Doppiamente coinvolto - da cittadino
italiano, da "intellettuale" - mi sono sentito colpito e offeso
anche nella mia intelligenza, nell'intimo delle reazioni istintive,
delle opzioni personali, sul piano pubblico-privato della capacità
di pensare le cose che stavano succedendo, di giudicare il nostro
"mondo comune", la sua logica. Da cittadino
da intellettuale.
Non c'è poi tanto da spiegare. Per quanto mi riguarda, scrivere
significa solo seguire un itinerario interiore, cercare in qualche
modo la propria "voce" attraverso la voce degli altri, in un
dialogo muto con modelli, figure, situazioni di vita e di pensiero
capaci di allargare la tua esperienza, il tuo sguardo sul mondo,
sulle cose. Può accadere che questo lavoro di scavo, questa
esplorazione vagabonda, ti portino lontano dal presente, tra
le ombre del passato, nei libri degli altri e in altre vite.
Spesso sei costretto a guardare "il futuro alle spalle". Voltarsi
indietro, parlare coi morti. Strana faccenda: devi trovarti
guardando fuori di te, dietro di te. Sempre le stesse domande,
la medesima ansia ricorrente: "dove andrei, se potessi andare,
cosa sarei, se potessi essere, cosa direi, se avessi una voce,
chi parla così dicendosi me?" (S. Beckett). Ma l'attualità ha
le sue ragioni - urgenti - e a volte è necessario lasciarsi
distogliere dagli eventi, rispondere subito, mettere da parte
se stessi, trascurare le proprie idiosincrasie, i propri gusti.
This is no time for inner searching
canta Lou Reed.
Non è tempo; non c'è tempo. A volte devi restare attaccato alle
cose così come sono, giocare "di prima", installarti in uno
scenario che non hai scelto tu, in un percorso deciso dal caso
o dalla storia. Più che una forma di onestà è una questione
di puro e semplice buon senso, di decenza, di curiosità. Non
puoi fermare la guerra, non la puoi evitare. Ma puoi (e devi)
discutere la sua "ideologia", protestare, criticare, tirartene
fuori. Altrimenti non vali niente, non sei niente. Resti un
parolaio, un chiacchierone fatuo, inconcludente. Dialogare con
i "vivi" (con certi vivi) può essere molto più frustrante che
parlare coi morti.
 La mia rappresaglia
La mia rappresaglia
Non importa. Il paesaggio è questo, il panorama mentale di
un'epoca non te lo scegli: ti ci ritrovi dentro, ci fai i conti.
Rispondere, dunque, criticare. Con una cautela: forse la cosa
peggiore da fare era provare a rispondere colpo su colpo, accettare
quel piano mentale, quei discorsi. Non ne valeva la pena, rischiava
di essere una trappola. Più semplicemente mi sono accorto che
era sufficiente lasciarli parlare, ascoltare e far ascoltare
la loro "voce". (...)
La mia "rappresaglia" è stata semplice. Ho conservato le "tracce":
montagne di carte, ritagli, foglietti smozzicati, pagine di
giornale, fotocopie. È un'operazione elementare. Non ho lasciato
scivolare via quel quotidiano rosario di idiozie. Mi sono accorto
in fondo che sarebbe bastato questo: un paziente lavoro di "montaggio"
e la critica implicita di un linguaggio, di un modo di essere,
di uno stile. Leggere, assemblare, mettere in evidenza i punti
chiave, escogitare una sorta di ordine. Fare la prova non costava
niente. Tutte quelle vocine garrule, tutte quelle prese di posizioni
petulanti, tendevano infatti a confluire in zone inerti ma identificabili,
a raggrupparsi in categorie riconoscibili. Ricomposte in un
insieme unitario, saldate insieme, quelle leziose performance
fanno subito tutto un altro effetto. Non sono così ispirate,
così ricche. Non hanno quell'originalità sussiegosa che pretendono
o pensano di avere. Non sono tanto speciali o intelligenti.
Metti insieme le tessere del puzzle e hai la tipica sorpresa
che non ti sorprende: i pezzi si incastrano alla perfezione,
il quadro si definisce, tutto torna. Affiora la solita "trama
nel tappeto"; cogli le affinità sottili, i richiami interni
e si impone sempre un tratto comune: un tono diffuso di ipocrisia,
di arroganza mentale, di sufficienza fatua, presuntuosa. Un
gergo tedioso, soffocante. Provare a lasciarli parlare con la
loro voce - allora - non dimenticare. Non fargliela passare
liscia. Senza rabbia, senza cattiveria: non dimenticare, semplicemente.
Per una questione di "ecologia mentale"; per autodifesa. Non
fargliela passare liscia.
Dopo un primo, breve capitolo, su cosa resta dopo questa guerra
(per la sinistra, innanzi tutto, per la cultura, per una dimensione
politica senza più respiro) questo pamphlet ha preso
così in modo del tutto naturale la forma di un'antologia sarcastica
e l'aspetto aggressivo di una parodia. Ma è una parodia senza
invenzioni, senza simulazioni, ipotesi e illazioni. "È tutto
vero, più o meno", come dice Vonnegut. Non ho avuto bisogno
di inventare nulla. Bastavano le parole autentiche delle parti
in causa, una selezione relativamente ampia e, appunto, un semplice
lavoro di "montaggio", di giustapposizione mirata, ragionata.
Lo stile di fondo, i punti di connessione, i criteri di scelta,
le parti di raccordo ovviamente dipendono da me. Me ne rendo
conto: prevale lo humour nero, prevale il sarcasmo. Non credo
che sia un limite o un difetto. Non solo perché non avrei saputo
fare in un altro modo. Ma anche perché mi sembra legittimo,
corretto, inevitabile. Come si fa a discutere con certa gente?
Come si può? Quest'asfissiante cultura, quest'atmosfera intrisa
di malafede e di stupidità. Rischi sempre di restare paralizzato
dalla Medusa dell'idiozia, dalla fata Morgana dell'imbecillità.
L'ironia e il sarcasmo restano le armi (per quanto spuntate)
di una possibile forma di resistenza, un modo per dire "no",
per disertare.
La beffa finale forse sta tutta in questo bizzarro paradosso:
l'ossessione della guerra non si è cristallizzata nel lutto
senza parole della disperazione, nel mutismo obbligato di un'estraneità
precaria e sofferta ma ha trovato la sua "uscita di sicurezza"
nel lugubre sarcasmo e nell'ironia nera di una risata liberatoria.
Tutto sommato, mi sembra anche giusto. Il lutto, il senso di
perdita, l'angoscia: non interessano a nessuno, restano sempre
cose private, riservate. Per criticare questa "guerra di carta"
era necessario trovare un tono diverso. Torniamo sempre al solito
punto, giriamo in tondo. Imagination dead imagine: inventarsi
qualcosa: contro l'evidenza, contro la storia, contro tutto.
Magari rimasticando tra sé e sé con un ostinato briciolo di
speranza un vecchio slogan; una bella frase carica di fiducia
ferita e di amara allegria. Una risata vi seppellirà.
 Vittorio Giacopini
Vittorio Giacopini
|
Per
una questione di
"ecologia mentale";
per autodifesa.
Non fargliela passare
liscia
|
|

