|
Di recente ho letto la storia delle
Brigate Rosse di Mario Moretti, raccolta sotto forma di intervista
da Carla Mosca e Rossana Rossanda. E ho visto lo spettacolo/racconto
di Marco Baliani Corpo di stato, sui 55 giorni del sequestro
Moro. Nel primo caso una ricostruzione che pretende di spiegare
tutto (il leitmotiv di Moretti è implacabile: "non
ci sono misteri, zone dombra
i magistrati sanno da tempo ogni
cosa, per filo e per segno") e lascia invece coi dubbi
di sempre, non risolvendo in particolare quellenorme "perché?"
che stringe lintera vicenda del sequestro Moro fino al suo
esito, e avvolge attorno a un nodo senza ritorno la storia di
uninsurrezione giovanile nata gioiosa e finita col piombo.
Nel secondo caso un racconto che non pretende di spiegare niente,
limitandosi a far riemergere dal passato sequenze di fatti,
volti, vicende personali, piccole storie, ripercussioni intime
e conseguenze palesi, in un affresco non privo di lacerazioni,
che spiega in realtà la sostanziale impossibilità
di comprendere da parte di chi si è trovato scavalcato
dalla contrapposizione fra stato e Br.
I racconti di Marco Baliani fanno sempre un po lo stesso
effetto. Se ne esce con la voglia di continuare a raccontare.
In questo caso limpazienza e la necessità di sostituirsi
al narratore, o di dialogare con lui attraverso le proprie storie,
nasce prima: durante lo spettacolo. E una storia plurale quella
a cui dà voce, e perciò sollecita e mobilita i
ricordi di chi ascolta, così che il silenzio della platea
sembra divenire a tratti rumoroso, ricolmo dei tanti pezzi di
memoria che si levano come in un coro sommesso eppure incalzante,
a caricare la narrazione di Baliani di un senso epico.
Non sembra di trovarsi di fronte a uno spettacolo, allinizio.
Il racconto prende gli spettatori per mano per riportarli al
tempo in cui le vicende si sono svolte: di quei momenti ritrova
i colori, le parole e i paesaggi, e li condensa in piccole storie
folgoranti, che hanno da subito la vivezza della contemporaneità.
La storia scorre come al presente, non cè di mezzo il
filtro della ricostruzione del passato, più o meno riscritto
nelle aule dei tribunali, nelle pagine dei giornali, nelle tante
biografie dei pentiti; non ci sono ripensamenti né rimozioni,
nessuna distanza di sicurezza, e il rischio del racconto fa
persino un po paura: saremo in grado, a distanza di ventanni,
di tornare a guardare?
Nello stesso giorno, il 9 maggio 1978, Aldo Moro viene ucciso
a Roma dalle Br, e Giuseppe Impastato viene trovato morto accanto
ai binari ferroviari di Cinisi, imbottito di tritolo dalla mafia,
di cui quotidianamente denunciava per radio crimini, connivenze
e interessi. Le due storie non si mantengono parallele né
ugualmente presenti nel racconto, ma fra salti avanti e indietro
nel tempo e continui spostamenti dellobiettivo della memoria
dalle piccole alla grande storia, si ridisegna - senza bisogno
che sia troppo spiegato - il quadro che ha prodotto luno e
laltro omicidio, la "fede cieca che occorre per non sentirsi
più umani", leterna piaga italiana dei depistaggi
(per cui si è persino tentato di far credere che Impastato
fosse un terrorista andato a mettere tritolo in quella linea
ferroviaria), e il diverso modo in cui le vicende continuano
a vivere nella memoria di un paese.
Corpo di stato racconta il movimento studentesco
nato nel 68, poi i primi anni 70, le manifestazioni politiche
pressoché quotidiane, le occupazioni allUniversità,
e quindi i primi scontri, la necessità di organizzare
servizi dordine sempre più "militarizzati",
la comparsa delle prime armi nei cortei, lalzarsi del livello
dello scontro, lassemblea in cui si decide il "salto di
qualità nella lotta": una storia collettiva, che
tutti coloro che lhanno vissuta potrebbero ripercorrere attraverso
le stesse tappe seguendo ricordi personali. Baliani lo fa coi
propri. E sono volti e vicende a cui non manca lironia, ma
sempre sospesi (anche in termini teatrali) sulla tragedia di
una storia più vasta che non concede scampo individuale,
e conduce alla collettiva condanna al silenzio. I ricordi personali
una volta risvegliati rievocano un turbinio di cose simili accadute
a noi stessi, o a persone a noi vicine. E se non è andata
così anche per noi è stato in buona parte per
caso. Poteva capitare: bastava accettare un pacco in custodia,
o accogliere in casa un amico, o essere fermati a un posto di
blocco e quindi fare sventatamente un movimento sbagliato
E parallelamente alle molte storie vissute comincia a sfilare
la vicenda evocata, i 55 giorni del sequestro Moro. Che tutto
il movimento ha vissuto senza viverli. Anche qui: grappoli di
ricordi tutti uguali e tutti diversi. Quando abbiamo saputo
del rapimento: quello che stavamo facendo in quel momento e
i pensieri che abbiamo avuto, tutto fissato indelebilmente nella
memoria. Una memoria che forse abbiamo voluto correggere negli
anni a venire, o appena 55 giorni dopo, ma che Baliani ci consiglia
di ripercorrere per quel che è stata: "Bisogna raccontarli
tutti, quegli anni", dice, e ricorda che uno come lui,
lontano dalle Br, che faceva teatro da quattro anni, che nutriva
molti dubbi sul fatto che lotta armata e trasformazione rivoluzionaria
potessero andare di pari passo, uno come lui provò in
quel momento una specie di euforia, di eccitazione. E si sa
che ci furono brindisi in certi consigli di fabbrica
Poi i
pensieri successivi, perché proprio Moro? ("Inaugurava
sempre la Fiera del Levante
più che simbolo del potere
era simbolo della politica democristiana
con quelle frasi che
giravano sempre su se stesse
"). E, alla pubblicazione
delle prime foto, limmagine di un prigioniero: "quella
faccia mi visitava, come se dovessi farmene carico". E
intanto Almirante e La Malfa invocavano la pena di morte, il
Manifesto parlava di un "disegno criminale coperto
dallo stato" e LUnità scriveva che occorreva
fare terra bruciata attorno ai terroristi
Cosa cera da bruciare?
Si chiede Baliani. Il movimento, risponde. E tutto il racconto
successivo, fatto di vicende grandi e piccole, eroiche e inconsapevoli,
parla di questo. Roma in stato di assedio, come ci fosse un
colpo di stato in atto, i posti di blocco, le perquisizioni.
E intanto le Br producevano i loro comunicati: "avrebbero
fatto sapere tutto di 30 anni di regime democristiano".
E a questo punto dello spettacolo è come se il coro a
più voci dei pensieri individuali raggiungesse un unisono
esplosivo e insieme una consapevolezza semplice, limpida, incontrovertibile:
ecco come mai a quel grande gigantesco "perché?"
non è mai stata data una risposta, dopo tutte le dichiarazioni
dei pentiti e dopo una vicenda giudiziaria che è arrivata
fino al "Moro quater" e che, come vuole far sapere
Moretti, "si è avvicinata al cento per cento della
verità". Non ci hanno, non hanno mai fatto sapere
niente. Hanno sempre deciso da sole e le loro decisioni sono
ricadute su tutti. Il racconto che non ci sembrava spettacolo,
che ci chiamava piuttosto a raccolta, ciascuno con le proprie
storie, come attorno a un tavolo dosteria, prende le distanze
dalle vicende dei singoli per acquistare il ritmo ineluttabile
della tragedia greca.
Ritorno al libro di Moretti. Colgo un altro scollamento
enorme. E come se Baliani, ossia la voce della maggioranza
del movimento che non ha preso le armi, raccontasse unaltra
storia. Nei capitoli dedicati al sequestro Moro il capo delle
Br non parla mai del movimento. Suo interlocutore unico era
lo stato. E intanto il movimento continuava a ragionare, a coltivare
sogni, a vivere scelte perdenti e totali, oppure a cercare altrove,
nel teatro ad esempio, mentre il terreno bruciava realmente,
e si preparava una criminalizzazione che, nata dal teorema di
un magistrato, sarebbe finita nelle aule dei tribunali, per
poi assumere consistenza e autorità di interpretazione
storica; finché la vicenda politica di un intero, sconfinato
movimento giovanile non è stata riscritta in termini
di storia criminale, con la sanzione finale del processo Sofri.
(Che giustamente Marco Baliani ricorda, interrompendo gli applausi,
a spettacolo finito).
Se il sequestro Moro ha fallito i suoi obiettivi non è
stato perché non è riuscito a porsi come avanguardia
dello scontro coagulando attorno a sé frange disponibili
del movimento. Al di là delle cose che volutamente Moretti
non dice (e che riguardano livelli occulti rispetto ai quali
non riesce a dare smentite convincenti, e non cè bisogno
di essere particolarmente dietrologi per accorgersene) le sue
spiegazioni non rispondono alle domande del movimento. Perché
le azioni delle Br non era al movimento che guardavano, ma al
potere rappresentato dalla politica portata avanti congiuntamente
da Dc e Pci col progetto di compromesso storico.
Tutto questo avrà forse a che fare con quello che
dice Baliani: che le Br, andando a leggere le loro biografie,
sono figlie della grande tradizione comunista di fabbrica, oppure
vengono dai cattolici. "Figli di due grandi chiese",
le definisce; ed allargando lo sguardo alla generazione parla
di "una gioventù con troppo dio".
Un racconto con pochi ausili scenografici, che è
un grande spettacolo corale, con momenti di straordinario teatro:
la descrizione della manifestazione in cui, di fronte allaggressione
bruta e gratuita di un compagno da parte della polizia, appena
dopo aver deprecato quelli che hanno cercato lo scontro, la
mano va a raccogliere la molotov caduta a terra per lanciarla;
e altri affreschi: le case dei compagni, la vita di quegli anni,
il senso della collettività, e poi esistenze finite in
tragedia quasi per caso (lamico Giorgio ucciso a sangue freddo
dai carabinieri durante una rapina del tutto improvvisata "per
finanziare la lotta", laltro finito in carcere per tre
anni per aver tenuto un pacco in garage), e storie che conservano
la possibilità dellironia (la perquisizione a un compagno
in moto e questo che si rivolge allinterno del serbatoio dicendo
"Aldo, vie fuori, ci hanno beccato!
" : si prende
tre mesi di carcere, ma ancora lo si racconta ridendo).
Le due vicende sempre più distanti: da una parte
le Br coi loro comunicati, dallaltra i compagni del movimento
che si muovevano in una città sovrastata da una rete
invisibile, una ragnatela di azioni, luoghi e contatti che solo
i brigatisti conoscevano. In questa lacerazione, una presa di
posizione che sembrò risolutiva: "Né con
lo stato né con le Br". Il narratore abbandona la
memoria per tentare una simulazione: "se avesse suonato
alla mia porta la ragazza con cui avevo militato, per la quale
avevo provato affetto e attrazione, che avrei voluto portare
a casa dopo lassemblea e che in quelloccasione si era schierata
dalla parte di quelli che volevano il salto di qualità,
se quella ragazza fosse arrivata qualche tempo dopo a chiedermi
ospitalità, per potersi nascondere
" Il narratore
si immagina sulla soglia di quella porta, immobile. E il film
dellimmaginazione non può andare né avanti né
indietro. A quella ipotesi non può seguire che limmobilità.
"Né con lo stato né con le Br", unico
slogan possibile, portava anche la maggior parte del movimento
che non aveva voluto prendere le armi allunica posizione possibile:
limmobilità. ("Contro lo stato e contro le Br"
fu detto da un numero troppo esiguo di compagni: gli irriducibili
oppositori di ogni potere, decisi a contrastare fino in fondo
la volontà egemonica espressa dalle Br in seno al movimento
rivoluzionario).
E, al di là della criminalizzazione che ne fece il
partito, la posizione di chi si diceva "né con lo
stato né con le Br" fu forse condivisa da certa
base del Pci: che nel racconto prende le parole del bidello
Pietro, con cui Baliani discute animatamente, fra unentrata
e unuscita di scena, in occasione di uno spettacolo fatto in
una scuola
Dopo aver sostenuto a spada tratta la linea ufficiale
del partito, ossia il fronte della fermezza, il bidello Pietro
cede alla sconsolatezza dicendo: "la verità è
che siamo tutti incartati".
In questo di certo i 55 giorni del sequestro Moro hanno
ottenuto un risultato: di immobilizzare un intero movimento
giovanile e di "incartare" la base ancora vitale del
più grande partito comunista europeo. Al resto ha pensato
chi ha avuto il potere di riscrivere la storia. "Per tutti
quelli che non avevano preso le armi, ed eravamo la maggioranza,
ci fu la condanna al silenzio. Eppure venivamo tutti dallo stesso
grande sogno, nato nel 68".
Lo spettacolo si chiude. Subito fuori, chi allora aveva
ventanni riprende a raccontare, i più giovani, forse,
desiderano un po di più ascoltare.
 Cristina Valenti
Cristina Valenti
| i conti con un corpo prigioniero
[
] La materia
è ancora così pulsante e non dipanata dalla
lontananza, che si rischia di leggerla col senno di poi,
filtrandola e mettendola a distanza di sicurezza. Ho cercato
allora di tornare laggiù, in prima persona, ricordandomi
di me in quei giorni, trovando nelle mie esperienze di
allora quelle "piccole storie" che sole possono
tentare di illuminare la Storia più grande. Ho
ripercorso momenti dolorosi senza perdere però
le atmosfere di quegli anni, gli entusiasmi, i paesaggi
metropolitani, le contraddizioni.
Nei 55 giorni della prigionia di Moro ho raccontato
di una lacerazione, di come il tema della violenza rivoluzionaria
abbia dovuto fare i conti con un corpo prigioniero, e
come questa immagine sia divenuta via via spartiacque
per scelte fino allora rimandate, abbia fatto nascere
domande e conflitti interiori non più risolvibili
con slogan o con pratiche ideologiche.
[
] Quando si esce da momenti e tempi in cui la vita
è stata pregna di avvenimenti, quando il vivere
è sembrato intenso anche nel dramma, dopo, col
tempo, ci si sente sempre un po stranieri, come reduci,
testimoni di eventi troppo densi per essere dipanati.
Camus dice: "Non essere ascoltati: è questo
il terribile quando si è vecchi". Il narratore
compie sempre questa sfida, straniero nel tempo cerca
di vivere con il racconto la vecchiezza che stende sulle
cose del mondo un manto spesso di oblio.
Marco Baliani
|
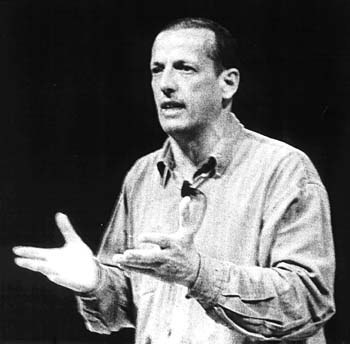
|

