
 Botta.../Ma
in Libano non è proprio così Botta.../Ma
in Libano non è proprio così
Sono rimasto perplesso nel trovare un servizio
sui campi profughi siriani in Libano nell'articolo: “Sguardi
dal Libano”, pubblicato nel numero 389 di “A”.
Mi risulta infatti che il Libano, pur avendo lasciato aperte
le frontiere ed accolto tutti i profughi in fuga dalla Siria,
abbia però rifiutato di costituire campi profughi sul
suo territorio. Per questo motivo i profughi siriani sono sparsi
in Libano nelle varie comunità o hanno costituito accampamenti
informali.
Un'operatrice umanitaria, profonda conoscitrice della realtà
mediorientale, attualmente in Libano, dopo aver letto l'articolo
mi ha mandato queste riflessioni: “Mi sembra che l'articolo
sia pieno di imprecisioni e semplificazioni: mira ad un impatto
emotivo ma non fornisce elementi utili a illustrare quanto accade
in questa parte del mondo.
Qualche commento in ordine sparso:
1. Sembra che un articolo sul Libano non possa non contenere
un richiamo alla guerra civile, peccato che qui sia fatto senza
alcun nesso logico con quanto sta accadendo oggi. Inoltre, accostando
la guerra civile all'antico odio sunniti-sciiti, si fornisce
un'interpretazione semplificata sia della guerra civile (che
in Libano ha visto diverse confessioni religiose scontrarsi,
a cominciare da quelle cristiane e druse) sia di quanto sta
avvenendo oggi in Siria.
2. Usare la definizione di “campi profughi” per
indicare quelli che sono invece insediamenti informali è
alquante fuorviante. In ogni caso non esiste un campo profughi
di Akkar anche perché l'Akkar non è una località
ma una regione nel nord del Libano, con decine di villaggi che,
al loro interno, ospitano rifugiati. Un articolo serio avrebbe
dovuto specificare questo dato e contenere qualche carta dove
ritrovare località che sono poco familiari al pubblico
italiano.
3. Non commento sulla lettura del conflitto siriano: in questo
mi sembra che l'autore si limiti a riportare un'interpretazione
dominante, senza tuttavia offrire spunti problematici o di approfondimento.
4. Il corredo fotografico non è chiarissimo: su quali
dati si è basato l'autore per affermare che “oltre
il 90% della popolazione dei campi profughi è rappresentata
da bambini”? (Foto 1), e di quali campi profughi parliamo?
Che significato hanno il bambino che mostra le dita a V in segno
di vittoria (Foto 2) e il proiettile nella mano di un bambino
trovato tra le vie di Al Qusayr in Siria (foto 6)?
Insomma, l'impressione complessiva è che il giornalista
abbia fatto un giro frettoloso nelle zone dell'Akkar e della
Bekaa e non abbia avuto tempo per rielaborare il materiale e
acquisire documenti e dati sul tema.
Infine il titolo: “Sguardi dal Libano”, mi sembra
abbastanza pretenzioso in quanto, in realtà, si limita
a citare Arsal e l'Akkar, quando qui c'è più di
un milione di profughi, sparsi in oltre 1000 municipalità
libanesi''.
Condivido l'impressione di quest'operatrice. Al di là
dei commenti critici sull'articolo resta fondamentale ricordare
la crisi siriana, i cui dati sono davvero impressionanti (oltre
150.000 vittime dall'inizio del conflitto, oltre 6 milioni di
sfollati interni e quasi 3 milioni di rifugiati nei Paesi limitrofi).
In questa crisi il Libano appare come il Paese a maggior rischio
per la propria stessa stabilità, avendo accolto ad oggi
una quantità di rifugiati pari a circa un quarto dell'intera
popolazione libanese (più o meno come se in Italia fossero
arrivati, in tre anni, oltre 14 milioni di profughi). Alcuni
villaggi libanesi hanno visto più che raddoppiata la
popolazione residente, con un impatto fortissimo, a volte devastante,
sui servizi e sull'economia locale.
Vorrei aggiungere che il Libano, che con la sua fragilità
sociale e istituzionale comunque non chiude le porte in faccia
ai profughi, rappresenta certamente un esempio assordante per
l'Italia e per l'Europa, che non sono capaci di accogliere degnamente
poche migliaia di rifugiati e lasciano che il medio oriente
affondi nei numeri immani di questa tragedia.
Un caro saluto,
Renzo Sabatini
Roma
 ...e risposta/La mia esperienza diretta
...e risposta/La mia esperienza diretta
Ringrazio l'operatrice umanitaria, citata da Renzo Sabatini,
per le critiche e per l'analisi dell'articolo che mi ha dato
modo di riflettere rispetto alla chiarezza, ai tempi ed agli
spazi sui quali porre attenzione nello scrivere determinati
articoli su tali questioni. Senza alcuna presunzione, voglio
comunque precisare alcune cose, rispondendo a tali considerazioni.
1. Il richiamo alla guerra civile fatto nell'articolo, mira
a dare un incipit in merito alla situazione odierna del paese
che, con le dovute differenze rispetto al passato, non vede
l'interrompersi delle escalation di violenze. Come lei bene
osserva è vero che la guerra civile del passato non può
essere accostata all'odio tra sunniti e sciiti, anche in virtù
del fatto che esso non si manifestava come e quanto oggi; i
conflitti erano ben altri. C'è però da osservare
che una delle problematiche di cui soffre il Libano è
legata comunque al conflitto tra alcuni movimenti politici che
richiamano al sunnismo ed allo sciismo, accentuatosi drasticamente
negli ultimi anni, soprattutto con la crisi siriana. Il Libano,
come in passato, rimane uno degli scacchieri preferiti per i
giochi politici di molte potenze esterne che, gettando benzina
su fragili equilibri interni, ne disintegrano il già
precario equilibrio sociale e politico; una spiegazione più
esaustiva e completa delle tematiche legate alla Siria avrebbe
richiesto un articolo a parte.
2. In merito a tale punto, ha perfettamente ragione nel dire
che non esiste “Akkar”. So bene che si parla di
Akkar come regione del nord del Libano e se guarda le foto,
proprio in una di esse scrivo“distretto di Akkar”.
Io mi sono recato in una zona periferica di uno di questi villaggi,
in un piccolo accampamento gestito da una ONG internazionale
composta prevalentemente da Siriani. L'avere scritto “in
quello di Akkar” è un errore che ammetto non avere
corretto. È giusto comunque farmi notare che la definizione
“campo profughi” non sia giusta, e che sia meno
fuorviante utilizzare il termine “insediamento informale”.
Nel mio articolo vi è comunque scritto che “le
persone si accampano come possono o vengono ospitate dai locali
in assenza di un programma nazionale di ufficializzazione dei
campi”.
3. Come spiegato nel primo punto, non ho incentrato la mia testimonianza
sulla spiegazione e sulla lettura del conflitto siriano, bensì
ho solamente riportato le parole di alcuni volontari incontrati
negli insediamenti visitati che mi hanno descritto la situazione
odierna siriana secondo i loro occhi. Non mi sembra di avere
dato una lettura di un certo tipo del conflitto siriano o peggio
ancora avere riportato un'interpretazione dominante. L'articolo,
dato anche il ristretto spazio in termini di caratteri, mira
principalmente a testimoniare l'esperienza personale vissuta
negli insediamenti e (tornando anche al suo primo punto) non
a dare una spiegazione/interpretazione in merito al conflitto
civile del passato e alle dovute differenze rispetto al presente.
Un discorso a parte meriterebbe il corredo fotografico. All'inizio
dell'articolo vi è scritto “Reportage di Giacomo
Maria Sini”; le foto quindi sono le mie, dato che di narrazione
d'un reportage fotografico si tratta. Nell'articolo ho scritto
che gran parte degli abitanti dell'insediamento visitato ad
Arsal provengono da Homs, dalla regione di Qalamoun e da Qusayr.
Credo che ognuno possa avere qualsiasi impressione rispetto
all'articolo e al fotoreportage prodotto nelle zone visitate
e le sue sono state legittime considerazioni che ho letto con
attenzione. Mi conceda però di ripeterle che con un numero
di caratteri ristretto, non ho avuto la possibilità e
non mi sono voluto dilungare su svariate riflessioni specifiche
prodotte in tali zone dove è chiaro che io sia stato,
dato che di testimonianza si tratta. Non era la prima volta
che mi recavo in Libano e ho sempre avuto un profondo interesse
per il mondo arabo e per il Medio Oriente, “operando”
spesso in tali zone. Mi conceda quindi di affermare che anche
io ho il mio umile bagaglio di informazioni dato da esperienze
dirette e letture sul tema.
Il titolo è un diretto riferimento al fotoreportage.
Come ben può notare gran parte delle foto che ho fatto
nel reportage sono ritratti che arrivano principalmente da uno
dei due insediamenti visitati in Libano. L'articolo quindi,
non mira a descrivere la situazione generale di tutti i profughi
sparsi per il paese, ma testimonia un'esperienza diretta con
alcuni di essi in quelle due zone. Per quanto riguarda Tripoli,
in questo articolo ho deciso di nominarla per rimembrare brevemente
una delle situazioni più complesse per una delle più
importanti città del Libano, dove mi sono recato, sono
stato ospitato e ho avuto modo principalmente di discutere del
pesante conflitto interno, respirandolo direttamente con alcuni
siriani e libanesi.
In definitiva, sperando di poterne discutere di persona, le
mando un sincero saluto.
Giacomo Sini
Livorno
 Camillo Berneri e Piero Jahier/Un sodalizio umano e intellettuale nella Firenze antifascista dei fratelli Rosselli
Camillo Berneri e Piero Jahier/Un sodalizio umano e intellettuale nella Firenze antifascista dei fratelli Rosselli
Cari compagni,
ho trovato tra le pieghe dei vecchi libri della biblioteca di
famiglia due bei ricordi di Camillo Berneri.
Il primo è tratteggiato nel secondo dopoguerra dal bisnonno
Piero Jahier, che aveva avuto Berneri per intimo amico a Firenze
tra la fine dei '10 e i primi anni '20. Concepito in forma di
lettera come prefazione al volume in memoria di Camillo scritto
dalla madre Adalgisa Fochi Berneri Con te, figlio mio,
comparso nel 1948, è contenuto nella raccolta Con
me.
Il secondo ricordo è un originale dattilografato e incollato
in fondo all'edizione di Pensieri e battaglie stampata
per il Comitato “Camillo Berneri” a Parigi il 5
Maggio 1938, nel primo anniversario della morte. Si tratta di
una breve nota biografica redatta verosimilmente dalla stessa
Adalgisa Fochi Berneri, che donava questa copia al bisnonno
in segno di gratitudine proprio per la stesura di quella prefazione,
con una dedica autografa datata 1 Ottobre 1947: “All'avv.
Piero Jahier con commosso animo, riconoscente per il ricordo
che serba all'amico perduto, La mamma di Camillo”. Il
volume è sottolineato e annotato a margine dal possessore
ed arricchito con due ritratti fotografici di Berneri ritagliati
da giornali e incollati in terza e quarta pagina che riportano
le didascalie autografe: “Nel 26 a 29 anni appena a Parigi”
e “In Germania dopo sei anni circa di aspra vita”.
Camillo: eclettico, eterodosso, coerente pensatore anarchico
di lingua italiana, filosofo allievo di Salvemini, perseguitato
e esule antifascista, collaboratore tra molte e non solo libertarie
anche della rivista di cultura protestante Conscientia,
miliziano nella rivoluzione spagnola, vittima dello stalinismo
di cui fu critico lucidissimo.
Piero: di antica famiglia valdese, poeta vociano, esteta e moralista
originale e contraddittorio, interventista democratico, intellettuale
antifascista del Non mollare che accoglieva nella sua
biblioteca tutto Proudhon.
Due figure inquiete, vicine e distanti, intrecciate negli anni
dell'imporsi dell'impostura nera, accomunate nella Firenze intellettuale
e resistente dei Rosselli. Memoria liberata dal chiuso delle
pagine.
Paolo Papini
Roma
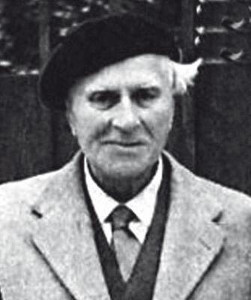 |
| Piero Jahier |
Cara mamma di Camillo Berneri,
leggendo il suo libro, mi son veduto venire incontro, per
mano alla sua mamma, non più ottuagenaria, quel ragazzo
che ho amato giovane uomo, così come me lo vedevo venire
incontro, trent'anni fa, dal viale Alessandro Volta, tenendo
per mano, orgoglioso padre novello, le due bimbe: Maria Luisa
e Giliana.
Veniva a cercarmi alla Casa Rossa, e le due belle bimbe,
agghindate nelle leggiadre vesticciole casalinghe da mamma e
nonna, tacevan compunte, mentre i grandi, chissà perché
eccitati, difendevano l'anticomunismo di Proudhon, o ragionavano
dell'esilio di Kropotkine e della alternativa che la tirannide
fascista andava imponendo a chiunque avesse coscienza di dignità
umana: degradarsi più o meno ad abbietto conformista,
o essere uomo.
Essere uomo significava tra l'altro, per quel giovane dallo
sguardo limpido e diritto, che aveva trovato nell'amore coniugale
proudhoniano il proprio equilibrio (aveva scritto: anche in
amore le tendenze poligame o poliandriche rivelano l'esaurirsi
della poesia), e si confessava “madre” nell'intensità
affettiva della sua paternità, significava sottoscrivere,
di propria iniziativa, al disfacimento di quel nido familiare
appena costruito, che era il suo porto di poesia sulla terra.
Ma già allora Camillo cercava, attraverso le molteplici
spinte e curiosità del suo ingegno vivace, una armonia
totale della personalità al di là di ogni sentimentalismo,
al di là dei valori meramente decorativi dell'arte gioco.
Cercava come Slataper “l'eroismo dell'atto, miracolo
che può infiorare un ramo secco”.
Cercava, cioè, quel che già possedeva, che
era la sua grazia, indelebilmente impressa su quella sua fronte
di arcangelo: la grazia di tradurre in atto le verità
dell'anima, senza paure e senza esitazioni; quella grazia che
i migliori tra i suoi compagni han chiamato la sua santità.
“Guardai intorno a me nella vita. E vedendo dovunque
disarmonie, cioè ingiustizie schiaccianti ed arbitrii
bestiali, mi dissi: “Ecco una via certa. Ed era quella
di battermi contro quei mostri reali”.
Ora, in epoche meno vili e feroci della attuale decadenza
europea, sarebbe forse stato possibile ad un giovane idealista
battersi contro quei reali mostri altrimenti che facendosi rimpallare
da un carcere all'altro delle sedicenti nazioni libere d'Europa,
o tirando una carretta di manovale fino allo sfinimento, in
terra straniera, od oscurando la fronte serena della propria
bimba, con la visione del padre dietro le inferriate di una
prigione: “mentre giocavamo nei campi, io mi rimproveravo
di divertirmi, mentre tu ti trovi in prigione”.
Ma erano gli anni in cui i letterati, figli di quei liberali
che avevano giurato e garantito la libertà di coscienza
come un diritto naturale, scoprivano – guarda caso! –
non la retorica e la violenza fascista, ma la retorica e la
violenza dei romantici rivoluzionari, la retorica di Bakounin,
e un loro campione, con tale meritoria scoperta alla mano, bussava
alle porte dell'accademia mussoliniana. Eran gli anni in cui
i poetini ermetici spremevano gli ovidutti per offrire alla
ammirazione dei Guf logogrifi letterari che non recassero traccia
dell'argomento pericoloso.
Quando una generazione giunge a tale annichilamento da accettare
la depravazione dell'arte a gioco tecnico, la corruzione della
religione ad instrumentum regni, l'asservimento della politica
alla possidenza, è provvidenziale e indefettibile che
il più generoso balzi all'avanguardia nella posizione
estremista più rischiosa, quale quella affermata dall'idea
libertaria, che diffida di ogni autorità e tradizione,
ed esige da ogni coscienza la capacità di emanciparsi
da sola nell'eroismo dell'atto “miracolo che può
infiorare un ramo secco”.
Io non avevo conosciuto la “mamma di Camillo”
che attraverso qualche indiscrezione affettuosa di lui, come
la mamma che guardava le spalle al proscritto, aiutando i suoi
cari col proprio lavoro di maestra elementare; ignoravo la tradizione
mazziniana materna in cui era cresciuto, analoga a quella dei
Rosselli, amici comuni; non avevo avuto che un barlume della
purezza del suo quadro familiare.
Queste memorie della prima età di Camillo Berneri,
anche se non immuni dal difetto di ogni scritto materno: “ipsum
quem genuit adoravit”, danno, attraverso gli episodi infantili,
rivissuti con genuinità assoluta, il senso della continuità
psicologica di una personalità che primeggia nella lotta
politica di questo trentennio.
È bello, mamma Berneri, aver generato in quegli anni
un uomo intero, capace di fare in piena coscienza l'aborrita
scelta dell'eroica follia della bontà armata, la scelta
che si è imposta, unica e inderogabile ai migliori dei
suoi coetanei: la scelta di Carlo Rosselli, di Gramsci, di Gobetti,
che fraternamente lo amarono.
Anche se l'affetto di quella mamma, lo strazio di averlo
così atrocemente perduto le strappa l'assurdo autorimprovero
di aver cresciuto, per una sua incapacità di adattarsi
agli usi del mondo, un figlio che “troppe volte si sentì
solo, e fu refrattario alle convenzioni sociali, e ribelle a
ogni forma di coercizione”.
Si rimane muti di angoscia davanti all'inconsolabilità
di un dolore di madre. Come sono rimasto, giorni fa, per le
scale di Casa Rosselli, incontrandomi, dopo venti anni, con
l'esile figura della mamma di Carlo e di Nello.
Ma è proprio il dono d'una creatura redentrice, inesorabile
nell'opporre il proprio “non serviam” al mondo più
indegno, il più alto dono che possan fare ai perduti
le viscere di una madre.
1947
Camillo Berneri fu ucciso, sembra, da comunisti, durante
la rivoluzione spagnola. Anch'egli scolaro di Salvemini, fu
tra i più anziani del nostro primo gruppo di antifascisti
(n.d.a.)
Prefazione al libro di Adalgisa Fochi Berneri Con te, figlio
mio, Officine grafiche Fresching, Parma, 1948 in Piero Jahier,
Con me, Editori Riuniti, Roma, 1983
Su Piero Jahier ascolta su wikiradio.rai.it la trasmissione
Piero Jahier raccontato da Mario Isnenghi dell'11 Aprile
2014.
 Botta.../Ma Kant non era per la tortura
Botta.../Ma Kant non era per la tortura
Cara redazione,
leggo su “A” 389 (maggio 2014), nello scritto del
Collettivo Altra Informazione (Beccaria,
Kant e il terrore di stato, pagg. 17-19), che Kant avrebbe
giustificato l'impiego della tortura.
A me veramente non risulta. Chi lo afferma dovrebbe produrre
almeno un rigo di Kant in cui ciò si sostenga. Dubito
fortemente che esista.
È vero, Kant non è contro la pena di morte, e
su ciò critica Beccaria, ma sulla tortura non mi pare
affatto favorevole o giustificazionista. Insomma: a ciascuno
il suo.
Saluti
Massimo La Torre
Catanzaro
 ...e risposta/Pena di morte e tortura: distinzione labile e ambigua
...e risposta/Pena di morte e tortura: distinzione labile e ambigua
Volentieri precisiamo a riguardo, riconoscendo una parziale
fondatezza all'osservazione mossaci dallo stimato Massimo La
Torre.
La citata lettera del 1796 in cui Kant rimproverava a Beccaria
«il sentimento di falsa umanità» e legittimava
«il diritto del sovrano nei confronti dei suoi sudditi
di infliggere loro una pena dolorosa» è stata ripresa
dal recente saggio di Michel Porret, “Beccaria. Il diritto
di punire” (Il Mulino, 2014) e, secondo la nostra modesta
interpretazione, non è circoscrivibile solo alla pena
capitale; d'altra parte, la distinzione etica e materiale tra
pena di morte e tortura appare sempre alquanto labile, nonchè
politicamente ambigua.
Cordialmente.
Altra Informazione
aranea.noblogs.org
Prosegue
il dibattito su
movimenti e potere
Pubblichiamo
qui di seguito il sesto, settimo e ottavo intervento nel
dibattito sulle tematiche toccate nei quattro articoli
di Antonio Senta (“potere e movimenti”) pubblicati
sulla nostra rivista tra l'ottobre 2013 (“A”
383) e il febbraio 2014 (“A” 386). In precedenza
erano intervenuti Andrea
Papi e Andrea
Aureli (“A” 388) e Francesca
Palazzi Arduini (“A” 389), Andrea
Staid e Federico
Battistutta (“A”390). Ricordiamo che gli
interventi in questo dibattito, come sempre aperto a tutti,
non possono superare le 6.000 battute (spazi compresi).
|
Dibattito
Movimenti e potere/6
e 7 e 8
 Walter Siri/L'autogestione di oggi, le lotte di domani
Walter Siri/L'autogestione di oggi, le lotte di domani
Sulla questione della lotta di classe sollevata da Andrea
Papi nella prima risposta alla serie di articoli proposti da
Antonio Senta.
Il termine usato da Toni allude alla definizione di Lotta di
Classe “dall'alto” che Luigi Fabbri poneva alla
base dell'analisi del nascente fascismo*.
Il dibattito su questi temi non è datato. Sul finire
degli anni '90 e per metà dei primi anni 2000, si è
discusso molto - anche in ambito anarchico - di turbo-capitalismo
e di lotta di classe dei ricchi contro i poveri.
Ciò che caratterizza anche l'attuale fase vede le organizzazioni
(per quanto sovranazionali, reticolari, informali, destrutturate)
delle classi dominanti all'attacco. Alcuni scenari sembrano
prefigurare una sorta di apocalisse dove chi ha i mezzi, le
capacità e le relazioni di potere immagina di sopravvivere
tenendosi lontano dalla discarica sociale.
Non mi pare arbitrario riconoscere nella molteplicità
dei soggetti che soffrono dello sfruttamento e dell'oppressione
quei caratteri comuni che definiscono una composizione (per
quanto tecnica) della classe subalterna. Volendo possiamo
pluralizzare: le classi subalterne, le masse diseredate, i flussi
migratori, le favelas, le comunità indigene, etc.
L'eterna guerra fra sfruttati e sfruttatori è ancora
motore di istanze di liberazione. Sta a noi coglierne spunti
e criticarne limiti ma non credo si possa negarne l'esistenza.
Il pregio del lavoro di Toni, mi sembra, è quello di
coglierne la portata analizzando non già i movimenti
carsici quanto le emergenze che salgono all'onore delle cronache.
Parlando dell'universo-mondo si è necessariamente superficiali
e schematici e, forse, agiografici, ma credo sia di interesse
comune avere a disposizione storie che ci raccontano delle lotte.
Ciò ci permette di trovare le conferme o le smentite
alle ipotesi che quotidianamente mettiamo in campo in quanto
minoranza agente.
Ma, come viene riconosciuto, Senta non tocca, nel suo excursus,
solo i movimenti di piazza che si scontrano con le forze armate
del potere o che hanno modalità e immaginari riconducibili
alle ideologie otto-novecentesche. Mette in evidenze le reti
sociali ed i progetti che tentano, qui ed ora, di dare
risposte alle esigenze quotidiane e che prefigurano modalità
relazioni che possono oltrepassare lo schema sociale determinato.
Esiste dicotomia fra pratica rivoluzionaria e pratica autogestionaria?
Per gli/le anarchiche il problema non si pone: è nell'autogestione
delle lotte di oggi che si costruisce il futuro di domani.
Ad un movimento impegnato in una lotta libertaria complessiva
non può sfuggire l'importanza di adottare dei modelli
di riferimento con tutti i rischi della superficialità
e dell'approssimazione.
Il modello anarchico prefigura una lotta radicale (tanto radicale
da essere definita sovversiva e rivoluzionaria) per l'oltrepassamento
di ogni relazione di potere e/o dominio.
Come? È evidente che ci possono essere modalità
e contesti molteplici.
Che si possono realizzare spazi nei quali il potere è
bandito. Che si possa lottare contro tutte le forme di potere.
Che si possa abbattere il governo di turno.
Che si possano ottenere degli obiettivi intermedi o parziali.
Ciò che ci caratterizza rispetto alle ipotesi riformiste
non è la velleità del tutto e subito ma
la prospettiva di una soluzione concreta alle contraddizioni
contemporanee. Una prospettiva che non può non tenere
conto delle esigenze immediate nella relazione intrinseca fra
mezzi e fini ma, sopratutto, fra condizioni e possibilità.
La lotta di classe torna a fare capolino.
Tornando all'intervento di Andrea Papi rilevo un altro tema
di dibattito: la questione della violenza.
Sull'argomento, dirò subito, l'intervento
di Stefano Boni (ospite della rubrica di Andrea Staid, “A”
387) mi pare pratico-sensibile, mettendo in evidenza come l'uso
della forza fisica sia imprescindibile sia come forma minima
di autodifesa, sia per manifestare nella maniera più
incisiva possibile l'opposizione al potere costituito.
Non c'è relazione – se non velleitaria –
fra uso della forza, pratiche di illegalità (anche di
massa), capacità di contenimento nei confronti delle
forze di polizia e strategie insurrezionali.
Il tanto vituperato Blocco Nero è stato e continua ad
essere uno degli strumenti che i movimenti hanno per difendersi
dalle brutalità del potere e degli agenti del potere
che contrastano le proteste.
Uno e non LO strumento. Così come sarebbe disarmante
considerare qualsiasi forma di resistenza alle soverchianti
forze armate dello stato come eticamente inaccettabile in virtù
di un malinteso anti-violentismo, altrettanto sarebbe suicida
indirizzare gli sforzi di lotta dei diseredati e dei ribelli
verso una soluzione militare.
La sollevazione generale, l'insurrezione, la rivoluzione hanno
più bisogno di zone liberate che di pistole. Ma
le zone liberate devono essere difese contro gli attacchi degli
scherani.
Sempre per citare Boni: “Non sostengo né la
bellezza né l'indispensabilità dell'azione diretta
violenta. Sarebbe però ingenuo pensare che l'attività
politica più efficace sia iscrivibile nello spazio pacificato
consentito dalle istituzioni. Il tema della violenza, dopo decenni
di tabù, torna a far riflettere e discutere per varie
ragioni. Per non farsi cogliere impreparati, sono gli eventi
contemporanei ad imporlo. Per trovare percorsi di analisi e
prassi condivisa, attraverso un dialogo senza preclusioni, in
una galassia libertaria in cui le posizioni sono molto distanti
ma spesso non esplicitate. Per riuscire a concepire, e possibilmente
costruire, una forza che permetta di difendersi dalla violenza
statale. Questa è riuscita a seccare sistematicamente
i germogli libertari che si sono timidamente manifestati in
questi ultimi secoli. Se dovessero dare nuovi frutti in questi
anni imprevedibili, sarebbe scellerato lasciarli devastare senza
opporre una seria resistenza.”
Walter Siri
Bologna
* Introduzione a “La Controrivoluzione Preventiva”,
Zic, Milano, 2009, note a cura dell'Assemblea Antifascista Permamente
di Bologna
 Un compagno della Federazione Anarchica Reggiana – FAI/Non
esistono scappatoie per pochi
Un compagno della Federazione Anarchica Reggiana – FAI/Non
esistono scappatoie per pochi
Tento di entrare nel dibattito proposto da Toni e rilanciato
da “A” facendo un passo indietro. E cioè
dalla crisi del modello democratico occidentale. Toni ha presentato
vari contesti con accenni alle condizioni specifiche che hanno
fatto nascere movimenti di protesta e di rivendicazione, evidenziando
tratti comuni dipendenti da “processi internazionali
di accumulazione del capitale, laddove il capitale per vivere-cioè
produrre, sfruttare e ricavare profitto - deve necessariamente
modificarsi, aggredendo sempre nuovi e ulteriori spazi, materiali
e immateriali”.
Queste proteste mostrano comunque profonde differenze sia di
tipo organizzativo che di carattere rivendicativo – progettuale,
addirittura riscontrabili all'interno delle singole esperienze.
Così troviamo chi lotta per un progetto autogestionario,
chi per ripristinare corretti rapporti di delega democratica
(come ancora parte del movimento 15-M chiede in Spagna), chi
per riottenere condizioni di vita (e di consumo) vissute prima
della crisi ed ora perse (smarrimento della classe media). Rispetto
al movimento no-global (l'ultimo movimento di rottura, di base
e di massa con una prospettiva internazionale) una differenza
sostanziale è data dal fatto che questo lottava contro
un sistema capitalistico-democratico in espansione, che dopo
la caduta del muro di Berlino trovava negli Stati Uniti l'unico
riferimento di una presunta omogeneità politica globale.
Ora i nuovi competitori internazionali, Cina e Russia in primis,
rivendicano la lontananza da sistemi democratici immobili, caratterizzati
dalla scarsa capacità decisionale1,
e su questo i modelli occidentali si stanno adeguando riducendo
gli spazi di espressione e di partecipazione nel nome della
governabilità. “Paura e crisi costituiscono
l'orizzonte insuperabile della governamentalità del capitalismo
neoliberista... La crisi è la modalità di governo
del capitalismo contemporaneo2”.
La mancanza di alternativa è la parola d'ordine dei nostri
giorni. L'impoverimento dell'immaginario3.
Questo è il quadro che ci aspetta sia che si parli di
austerity e Comunità Europea, sia che si parli di piccole
patrie, di forconi e di grillismo. In entrambi, i processi di
governamentalità che sempre più strutturano relazioni
di dominio riducono gradualmente l'autonomia dei singoli
e rafforzano l'idea di Stato e di Governo, permettendo
a questi di esercitare forza e condizionamento4.
La piazza è un momento di risposta alla crisi, di ricomposizione
di questa condizione di atomizzazione sociale e di costruzione
di immaginario. La piazza assume il ruolo dello spazio del confronto,
così come le cooperative sociali e di consumo, gli spazi
collettivi per l'autoproduzione e l'educazione
libertaria. Gli spazi occupati, quelli alternativi e i circoli
anarchici. Le cucine del popolo, gli orti collettivi e i GAS.
Le casse di solidarietà libertarie, i comitati di assistenza
e di resistenza, le esperienze mutualistiche. Le esperienze
comunaliste, di autogoverno e le forme di sperimentazione comunitarie.
Tutto questo è piazza.
“Le conseguenze delle azioni che ognuno di noi compie
nella vita quotidiana determinano il corso della politica. Ognuno
di noi per il fatto stesso di vivere, modifica il mondo, che
ne sia consapevole o meno, che lo voglia o meno, che lo accetti
o meno5”. Ecco
io penso che per la realizzazione di questo “esodo
e resistenza”, non sia sufficiente accontentarsi
degli spazi di libertà individuali che ognuno di noi
cerca di costruirsi. Non esistono scappatoie per pochi. Non
esistono alternative alla necessità di organizzarci,
di condividere percorsi, di dare continuità e lungimiranza
al nostro agire politico. Il caso greco mi sembra esemplare:
dopo la crescita numerica, la capacità di mobilitarsi
nelle strade, l'occupazione di spazi e la costruzione
di lotte a fianco di lavoratori, di immigrati, per la difesa
dei territori dallo sfruttamento delle imprese e delle multinazionali,
parte del movimento ha compreso che per riuscire a far fronte
alle condizioni di vita che la crisi imponeva, per riuscire
ad essere incisivi, doveva organizzarsi. Per questo stanno nascendo
due federazioni anarchiche, per questo il tema dell'organizzazione
è centrale nel dibattito politico. I movimenti di piazza
sono momenti importanti di emersione di pratiche alternative,
di conflitto e di sperimentazione. Ma appunto, sono momenti.
La possibilità data dall'organizzazione anarchica è
quella di costruire quotidianamente un nuovo immaginario che
scardini gli elementi del dominio. È dare radicamento
sociale all'anarchia così da garantire impulso e sostegno
alle pratiche di libertà nate dai momenti di rottura,
è la costante capacità perciò di contaminare
e di farsi contaminare. È l'essere in grado di dare continuità
a questi momenti di rottura anche dopo il loro esaurimento.
È impedire che le aspirazioni di trasformazione rifluiscano
in nuovi ceti politici, funzionali a ricomporre un quadro di
delega e a deviare le energie rivoluzionarie verso nuovi o vecchi
riformismi. È dare una prospettiva complessiva a istanze
che spesso sono legate all'oggi o all'individuo, è dare
risposte collettive a problemi collettivi e al contempo della
collettività. Far assumere cioè un piano politico
all'agire e allo sperimentare, secondo percorsi chiari, assembleari
e collettivi. La trasformazione del contesto in cui viviamo
nasce sempre dalle condizioni sociali e da un atto di volontà
individuale che diventa collettivo. L'organizzazione anarchica,
io credo, è il miglior modo per agire questo atto di
volontà in un quadro di libertà, attraverso la
conciliazione di pensiero e realtà, di desiderio e di
reale.
Un compagno della Federazione Anarchica
Reggiana – FAI
- Si veda per esempio il numero 1044 del 28 marzo 2014 della
rivista Internazionale, C'era una volta la democrazia
- Maurizio Lazzarato, Il governo dell'uomo indebitato, saggio
sulla condizione neoliberista, Derive e Approdi, 2013
- Si veda David Graeber, La rivoluzione che viene, Manni, 2012
- Eduardo Colombo, Le due rappresentazioni delle stato, in
L'anarchismo oggi, un pensiero necessario, Mimesis, 2014
- Flavia Monceri, Anarchici; Matrix, Cloud Atlas, Edizioni
ETS, 2014
 Eugen Galasso/Ma non parliamo solo di classe operaia
Eugen Galasso/Ma non parliamo solo di classe operaia
Su movimenti e potere credo si stia sviluppando un dibattito
estremamente interessante, su “A”, che spero sia
foriero di sviluppi e applicazioni pratiche: senza teoria, ritengo,
non c'è prassi, ma anche la teoria deve confrontarsi
con la prassi.
Escludendo il mito della prassi à la von Ciezlowsky
(ma è Ottocento, sinistra hegeliana), che oggi sembra
far scuola nei “Black Block” e movimenti analoghi,
i cui risultati sembrano favorire sempre solo i detentori del
potere, c'è da intendersi su come concepiamo movimenti
e potere. Riandando al primo
intervento di Antonio Senta (ottobre 2013, “A”
383, pp.13-15) credo sia importante segnalare come l'autore
evidenzi i testi prodotti da Huntington e altri, per difendere
una “democrazia american style” contro la “cultura
antagonista” (sic!). Ne possiamo indurre la strategia
dei poteri “occidentali”, con le loro indubbie differenze,
rispetto a tutto ciò che può essere “antagonistico”...
Da qui e naturalmente da altri testi analoghi possiamo ricostruire
strategia e tattica (al plurale, se si vuole) dei poteri verso
i movimenti, addirittura da fine anni Sessanta (anche se i testi
citati all'inizio di “The crisis of democracy” sono
successivi, metà anni 1970, la loro elaborazione è
appunto precedente) fino ad oggi. Non citerò ulteriori
testi sentiani per brevità, ma non mi scandalizza affatto,
anzi mi conforta il fatto che Senta parli di “lotta di
classe”. Posso accettare la relativizzazione proposta
da Andrea Papi, per cui “in sociologia il concetto
di classe è dificilmente definibile” (“A”
388, aprile 2014, p.125), pur tuttavia esso è usato da
molti sociologi, politologi e non pochi economisti. È
una di quelle espressioni che, al di là di ulteriore
definizione, sono comunque diffuse quasi convenzionalmente e
“universalmente”. Che poi la pauperizzazione data
dall'attuale crisi come dalle altre (precedenti e future, sempre
che usciamo dalla presente...) non coinvolga più solo
il “proletariato” è assolutamente vero, perché
coinvolge anche piccola borghesia, studenti, disoccupati di
diversa “estrazione” etc., ma che la situazione
di operai e contadini poveri sia particolarmente “traballante”-
ed è un eufemismo - pare evidente.
“Datata la lotta di classe”, come più sopra
nel suo intervento propone Andrea Papi, brillante teorico del
libertarismo e anarchismo? Direi di no: se chiediamo ad un sindacalista
latinoamericano, per es., dirà sicuramente di no, che
l'espressione è ancora attuale, visto il clivage
(stacco, divisione) di cui, per es. parla ampiamente e giustamente
(almeno ritengo sia così) Etienne Balibar nel recentissimo
saggio “Un nouvel élan, mais pour quelle Europe?”
(Le Monde diplomatique, N.720, 61 année, mars 2'14).
Vogliamo dire “poveri” versus “ricchi”
invece di “proletari” versus “borghesi”?
Va bene, lo fa anche Balibar, di provenienza marxista, ma non
credo che ciò cambi molto i termini della cosa. Fermarsi
qui sarebbe sterile nominalismo, un nominalismo che certo ad
Andrea non è mai appartenuto né appartiene. I
“grands commis d'état” rispetto ai piccoli
impiegati ma anche a qualche funzionario “di basso rango”,
con un divario a livello retributivo non solo geometrico ma
astronomico, dove però lo stacco vale altrettanto nel
settore privato.
Ormai nessuno o quasi (forse qualche dogmatico nostalgico operaista)
si limita a parlare della classe operaia come unica vittima
di ogni crisi ma anche di ogni condizione “normale”
del capitalismo, ammesso che sia sensato parlare di “normalità”
in questo come in altri ambiti... Peraltro di “capitalismo”
parla correttamente Papi stesso nel suo bel testo “Renzi,
ultima illusione” (“A” 388, pp.11-12).
Spesso, anche per valutare come i poteri, nella loro ampia diversità,
si rapportino ai movimenti, anch'essi non riconducibili mai
a un illusorio “minimo comun denominatore”, intendersi
su problemi come questo non è oziosa questione definitoria,
ma una premessa necessaria.
Eugen Galasso
Firenze
 Il 25 aprile, il Primo Maggio e il PD
Il 25 aprile, il Primo Maggio e il PD
Parlando di politica con gli amici, prima o poi, salta sempre
fuori qualche paura sul ritorno del fascismo, soprattutto in
quel periodo che va tra la fine di aprile e l'inizio di maggio,
nella quale casualmente si collocano due celebrazioni fondamentali
dell'antifascismo italiano: la festa della Liberazione e la
festa del Lavoro. “Se tornasse il fascismo, queste feste
sarebbero vietate”, tuona sempre qualcuno, ad un certo
punto della discussione.
E qui, secondo me, sta un grande errore: oggi, il fascismo,
quel fascismo a cui pensiamo di solito, è superato dal
tempo ed inattuabile; le minacce per la libertà arrivano
da altre parti, mascherate sotto volti, nomi e discorsi più
rassicuranti. Oggi, non si vietano le feste, anzi l'opposto;
oggi, le feste, le si occupa.
L'abbiamo visto il primo maggio a Torino, ma potevamo accorgercene
già negli anni passati. Il Partito Democratico discende
da quel monolito rosso che era il vecchio Partito Comunista,
che in un modo o nell'altro si è sempre sentito il maggiore
avente diritto a festeggiare la Liberazione e il Lavoro, per
ben noti motivi storici; ma, se un tempo era partito d'opposizione
e, quindi, poteva godere di un appeal ribelle e antigovernativo,
oggi il Pd comanda e si appresta a farlo in maniera sempre più
netta (causa defaillance dei principali contendenti).
Il 25 aprile è la festa degli antifascisti, ma la domanda
è: chi sono i veri antifascisti? Oggi, il Pd di governo
si assume l'onere e l'onore dell'antifascismo e della sua definizione,
in quanto unica definizione possibile. Non è raro trovare
esponenti del Pd (o dei gemelli diversi di Sel) nelle file dell'Anpi,
a significare quello stretto legame, quasi implicito, tra il
partito e l'antifascismo enciclopedico. In questo modo, tu che
non sei concorde con la loro nozione di antifascismo, sei implicitamente
fascista, sei dalla parte del torto e automaticamente escluso
dal confronto.
Allo stesso modo, il 1° maggio è la festa del Lavoro,
ma la definizione di lavoro quale può essere se non quella
del Pd (che, in questo caso, è orwellianamente anche
quella del governo)? Loro, che discendono dal Partito Comunista,
da quelli che han sempre fatto gli scioperi e le grandi battaglie
per il lavoro, sanno di cosa si tratta e hanno il diritto ed
il dovere di sfilare in prima fila nei cortei. Di più:
loro sono il Lavoro. Se li contesti, contesti il lavoro, e quindi
non hai diritto di festeggiare il 1° maggio.
Questo è quello che è accaduto a Torino, ma eventi
minori si sono verificati altrove. Di certo il clima pre-elettorale
ha influito (non solo le europee, ma anche varie amministrative
e, proprio in Piemonte, le regionali), ma a tutti sarà
capitato di incontrare politici a pranzi o eventi per il 25
aprile intenti a propagandare la loro candidatura ad una delle
prossime competizioni politiche, o di notare il gruppo ben in
vista dei suddetti esponenti sfilare il 1° maggio. Tutti
del Pd ovviamente, perché quelle sono le loro feste,
quello è il loro pubblico, e gli altri sono solo loro
ospiti. A chi gli fa notare, scioccamente, che stanno facendo
campagna elettorale in un momento non opportuno, rispondono
sconcertati che, essendo loro gli unici veri portatori degli
ideali che quelle festività incarnano, antifascisti e
lavoratori non possono che essere fieri e felici che il Pd sia
lì, poiché è il loro partito.
Oggi, le feste non si vietano, si occupano, o se preferite si
affittano (a costo zero, ovviamente). E, siccome, siamo nel
mondo capitalista, la proprietà privata è un diritto
che va difeso anche dietro ai cordoni di polizia in assetto
antisommossa. Le cariche allo spezzone sociale del corteo di
Torino non sono state fatte come risposta a provocazioni né
per provocare, ma al solo scopo di sancire un diritto di proprietà
privata: “questa non è la vostra festa, è
la nostra; noi siamo il Lavoro, voi siete contro di noi e quindi
contro il Lavoro; questa è la nostra festa, non la vostra”.
Queste ultime festività sono state occupate dal partito
che le ha sempre, più o meno gentilmente, rivendicate;
occupate per poter esercitare la loro campagna elettorale. Non
più le piccole, grige e anonime sedi di partito, che
negli anni diventano via via più piccole e decentrate
per via degli alti costi immobiliari, ma le piazze e le vie
delle ‘grandi feste della sinistra'. Occupate, paradossalmente,
come gli sfrattati occupano le case abbandonate, per rivendicare
un diritto fondamentale: d'altronde, un partito senza campagna
elettorale è implicitamente escluso dal mondo politico,
così come un uomo senza casa è escluso dalla società.
La differenza è che le case occupate il 25 aprile ed
il 1 maggio non erano abbandonate; forse non godevano di grande
manutenzione, ma di sicuro non erano abbandonate.
Valerio Moggia
Novara
 No Tav/ Schizzi dall'aula bunker
No Tav/ Schizzi dall'aula bunker
Salve a tutti compagni
mi chiamo Alex, forse qualcuno di voi mi conosce o mi ha incontrato in qualche manifestazione o altri posti (son di Pistoia). Vi scrivo dopo che il nostro mitico compagno Gianni Milano mi ha chiesto vivamente di farlo!
Sono stato nella tristissima aula bunker di Torino lo scorso martedì (13 maggio) durante il processo ai No-Tav, dove ho conosciuto Gianni e altre belle persone; là ho buttato giù alcuni skizzi che sono piaciuti tanto ai compagni, che mi hanno detto di mandarli a voi per pubblicarli magari come illustrazioni di qualche articolo sul processo.
Vi ringrazio dell'attenzione!
Alex Simone Niccolai
Pistoia
|
 |
 Black block, G8, violenza, ecc./Proporre nuove visioni e nuove prospettive
Black block, G8, violenza, ecc./Proporre nuove visioni e nuove prospettive
Ho letto sullo scorso numero (“A” 390, giugno 2014)
l'intervento di Andrea
Staid e la lettera
di Massimo Ortalli. Su quest'ultima vorrei fare una breve
considerazione.
La riflessione di Massimo è diretta: anziché abbarbicarsi
nel cielo della teoria parte da un'immagine fin troppo eloquente,
quella del casseur di turno (madrileno nella fattispecie)
alle prese con una vetrata o un bancomat, circondato da fotoreporter,
cineoperatori e compagnia discorrendo, pronti a riprenderlo
e immortalarlo. Qui non c'è più l'innocenza del
gesto spontaneo, seppur violento: tutto viene risucchiato
ipso facto nel gorgo mediatico, ridotto a spettacolo per
il telegiornale della sera o per il circo youtube. Ha
ragione da vendere Ortalli, nel sottolineare ciò.
Ma il problema è un altro. E qui viene il mio disaccordo
per il documento sui fatti del G8 (a cui fanno riferimento sia
Andrea che Massimo) o per gli interventi che appaiono su “A”
pronti a stigmatizzare ogni atto rubricabile alla voce violenza.
Non mi ricordo bene quanto andava dicendo quel documento –
non è questo il punto -, so solo che quando lo lessi
mi colpì il tono da dissociazione (peraltro non richiesta),
che in qualche maniera ritrovo anche in certi articoli su “A”.
Su questo proprio non mi ritrovo: reagire così dinanzi
a una posizione ritenuta errata (in questo caso la pratica della
violenza fine a sé stessa) innanzitutto non serve a nulla,
se non a creare ulteriori solchi e divisioni interne.
Invece ritengo più utile, in simili frangenti sapersi
dislocare, volando più alto, spiazzando e rilanciando
con proposte che svuotano di senso pratiche criticabili. Tanto
per parlare di nonviolenza: Gandhi ha avuto ascolto, è
stato efficace e lo ricordiamo ancora per la marcia del sale,
per lo sciopero della fame o iniziative del genere, non per
le filippiche (facilmente strumentalizzabili dagli inglesi)
contro i suoi connazionali violenti. Perciò, prima di
criticare il violento di turno sarebbe utile fare l'autocritica
per la incapacità nostra a pensare e sognare in grande,
a proporre nuove visioni e nuove prospettive. È lungo
questa linea che vanno spese le energie. Se le immagini violente
continueranno ad avere le prime pagine dei giornali in fondo
è anche per colpa nostra.
Federico Battistutta
Gropparello (Pc)
| I
nostri fondi neri
|
Sottoscrizioni. Roberto Carloni (Roma) 10,00;
Cecilia Tamplenizza (Brasile) 50,00; Istituto “Ernesto
De Martino” (Sesto Fiorentino – Fi) 40,00;
Giuseppe Loche ed Elisa Braibanti (Cortemaggiore –
Pc) ricordando Aldo Braibanti, 50,00; Aurora e Paolo
(Milano) ricordando Amelia Pastorello e Alfonso Failla,
500,00; Danilo Sidari (Sydney – Australia),
200,00; Andrea Cassol (Cesio Maggiore – Bl)
20,00; Mirko Cervi (Medicina – Bo) 30,00; Piero
Cagnotti (Dogliani – Cn) 10,00: Andrea Zontin
(Storo – Tn) 15,00; Gianni Milano (Torino) 50,00;
Roberto Palladini (Nettuno – Rm) 20,00; Ernesto
Cosimo D'Arienzo (Presicce – Le) 30,00; Andrea
Della Bosca (Morbegno – So) 10,00; Giuseppe
Ciarallo (Milano) 100,00.; Francesco Papappicco (Palo
del Colle – Ba) 5,00; Andrea Ronsivalle (Lodi)
10,00; Edo Bodio (Condino – Tn) 10,00; Bastiano
Sias (Barrali – Ca) ricordando Jeremia: poeta,
fotografo, anarchico, aveva famiglia numerosa. Non
diceva mai la verità, quindi la diceva sempre”,
50,00; Angelo Roveda (Milano) 20,00; Vincenzo Laschera
(Verona) 8,37; Libreria San Benedeto (Sestri Ponente
– Genova) 3,20; Antonio Cecchi (Pisa) 20,00;
raccolti durante l'iniziativa “Il miglio delle
culture” (Milano, 18 maggio) al banchetto dell'Associazione
Zona 3 per la Costituzione, 50,00. Totale €
1.311,57.
Abbonamenti sostenitori. (quando non altrimenti
specificato, trattasi di euro 100,00). Germano
Porro (Erba – Co); Federico Torza (Brugherio
– Mb) 180,00; Maurizio Guastini (Carrara) 200,00;
Giancarlo Tecchio (Vicenza) 200,00; Paola Mazzaroli
(Trieste); Giorgio Bixio (Sestri Levante – Ge);
Natalia Castiglioni (Carnago – Va); Battista
Saiu (Biella); Giulio Abram (Trento); Lorenzo Guadagnucci
(Firenze); Francesco Alioti (Genova); Giorgio Barberis
(Alessandria). Totale € 1.480,00.
|
|

