
L'etica dalla padella della biologia
alla brace della filosofia
1.
Allorché cerca di concludere qualcosa intorno all'origine
ed all'evoluzione del senso morale, Piero Borzini – in
Diventare umani - dice che esso “deriva da intricate
interazioni tra biologia e cultura”, non certo da “inesplicabili
salti ontologici”, evolvendosi “in modo naturalistico
all'interfaccia tra le capacità cognitive e gli adattamenti
culturali”.
2.
Ormai famoso nella letteratura neurologica è il caso
di Phineas Gage. Minatore americano, venticinquenne, nel 1848
fu vittima di un incidente mentre lavorava ad una ferrovia:
provocò incautamente un'esplosione e la sbarra di ferro
che stava utilizzando gli schizzò in faccia entrandogli
da sotto un occhio e uscendogli dalla zona prefrontale del cervello.
Dopo il primo stordimento e nonostante la ferita, Gage fu in
grado di andare con le proprie gambe fino al medico più
vicino e sopravvisse altri dodici anni. Ce ne sarebbe già
a sufficienza per entrare nella storia, ma, nella storia della
neurologia, il caso è stato oggetto di infinite discussioni
anche per un'altra ragione. Dopo l'incidente, furono rilevate
nel giovane “rilevanti alterazioni del carattere”,
ovvero “modifiche dei tratti psichici” – detto
più esplicitamente: prese a bestemmiare come un carrettiere
(il che, sia detto di passaggio, sarebbe anche comprensibile
per uno che subisce un incidente del genere), divenne violento
e irascibile e, dunque, del tutto inaffidabile. Forte –
di conseguenza – è stata la tentazione dei neurologi
di identificare la zona prefrontale del cervello – quella
squarciata dalla barra di ferro del povero Gage – come
la “sede” delle facoltà morali, la cabina
di regia in cui si decide cos'è bene e cos'è male
scegliendo magari l'uno e non l'altro.
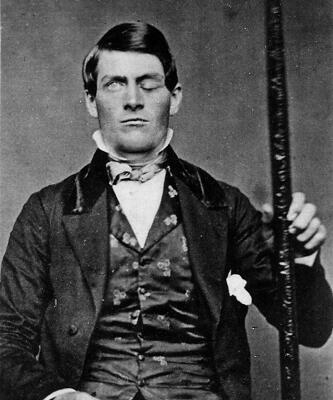 |
| Phineas Gage con l'asta di metallo
che gli trapassò
il cranio |
3.
Borzini rifugge, dunque, dai facili riduzionismi, evita con
cura di confinare in una zona del cervello una facoltà
fondamentale per la vita sociale come quella del senso morale.
Fa bene, perché le conseguenze politiche della sostituzione
di qualcosa di mentale con qualcosa di fisico sono sempre gravi.
4.
La sottrazione dell'etica all'ambito di competenza del biologo
dovrebbe essere ricompensata meglio di quanto non sia avvenuto
e di quanto, tuttora, avvenga.
Da scettico onesto qual era, in Critica della morale,
il filosofo Giuseppe Rensi finisce con l'affermare che, alla
luce delle “teorie morali che sono andate formulandosi
nel corso della storia della filosofia”, è impossibile
“formulare un principio che possa anche lontanamente vantare
una legittima pretesa alla validità universale”.
Per esempio: “stringi stringi, in fondo alla dottrina
morale di Platone (come in fondo forse a tutte) v'è un
circolo vizioso, derivato necessariamente dall'impossibilità
di dare una determinazione del bene: l'uomo buono è colui
che ha la conoscenza del bene (che sa rivolgere la propria anima
all'idea del Bene, come vuole La Repubblica); e il bene
è ciò che è conosciuto come tale dall'uomo
buono”.
5.
Si ricorderà che sia Mussolini che Hitler – diciamo
in gioventù – hanno avuto i loro guai giudiziari.
Il primo, ancora socialista rivoluzionario, portato in giudizio
nel 1911 non rinuncia alla propria filippica e, ai giudici,
dice: “assolvendomi, soddisferete i miei desideri, restituendomi
al mio lavoro e alla società. Ma condannandomi mi onorerete
perché davanti a voi non siede un malfattore né
un delinquente comune, ma un assertore di ideali, un agitatore
di coscienze, un soldato di una fede che esige il vostro rispetto,
poiché reca in sé il presentimento del futuro
e la grande forza della verità”.
Il secondo, nel 1923, dopo il putsch di Monaco, davanti ai suoi
giudici, pur mettendola giù con minor aulicità,
dice: “Io sono l'unico responsabile, ma non per questo
sono un criminale (...) perché la storia ci assolve”.
Rappresentano una scappatoia pragmatica – pragmaticissima
– al circolo vizioso di Platone. Non ce la fanno a dire
che ciò che è buono lo decido io, ma dicono che
ciò che è buono lo decide la Storia. Inventano
un Senno di Poi assolutizzato e nobilitato – facendo finta
di dimenticare che, comunque, questo Senno di Poi è quello
di chi vincerà – di chi avrà il potere di
scrivere la Storia fino a che, qualcuno, poi, a sua volta, avrà
il potere di riscriverla.
6.
D'altronde, come dice Carl Schmitt “ogni idea politica
prende una certa posizione nei confronti della 'natura' dell'uomo
e presuppone che esso sia 'per natura buono' o 'per natura cattivo',
inevitabile” – per lui che si iscrisse al Partito
Nazionalsocialista tedesco – “è la conclusione:
l'uomo è cattivo e ingannatore”.
Che “il male proviene dall'uomo” sia la tesi preferita
del pensiero destrorso - la tesi in virtù della quale
ogni forma di autoritarismo ed ogni soluzione repressiva diventano
non solo legittime ma doverose – non credo possa ringalluzzire
un granché il versante ideologico opposto o qualsiasi
altro versante. Non è che l'affermazione opposta –
quella che vorrebbe la natura dell'uomo “buona”
– porti a chissà quali soluzioni migliori. Pur
sempre si tratterebbe di valori contro valori, giudizi contro
giudizi, infondati gli uni come gli altri – dichiarazioni
per partito preso.
7.
Il giudizio etico – come qualsiasi altro giudizio –
dipende dall'aver assunto qualcosa – un comportamento
sociale, per esempio - come punto di riferimento, come paradigma
e dall'aver poi confrontato un comportamento successivo con
questo. Se il risultato del confronto è un'uguaglianza
avremo, dunque, il giudizio di “buono” – “bene”,
“giusto”, etc. – e se il risultato è
una differenza avremo il giudizio opposto. Se un'autorità
sociale sufficientemente forte – il Mosé di turno
– fa approvare la Tavola delle Leggi, tutto ciò
che da questa Tavola si discosta in termini di comportamenti
individuali potrà essere considerato “deviante”,
pericoloso per la stabilità dell'ordine sociale. Se,
poi, questa Tavola delle Leggi riesco ad ascriverla ad un'autorità
superiore al Mosè di turno medesimo, meglio, perché
la sua validità non potrà più essere messa
in discussione venendo meno, per esempio, l'autorità
del Mosé di turno.
Assumendo questo punto di vista – riconducendo, cioè,
l'etica ai processi decisionali che l'hanno costituita –,
allora, l'uomo – con buona pace dei filosofi e di tutti
i moralisti – non è né buono né cattivo,
ma viene definito in un modo o nell'altro a seconda che rispetti
o meno i paradigmi dati e presi in considerazione. Una morale
rivoluzionaria dovrebbe prendere le mosse da questa consapevolezza.
8.
Tornando all'evoluzione. I paradigmi cambiano. Cambiano i paradigmi
scientifici come i paradigmi di ordine etico. Solo una concezione
autocontraddittoria della scienza e della morale – quella
che le vorrebbe farsi carico l'una del rappresentare la realtà
e l'altra del rappresentare la verità – può
indurre a pensare che i paradigmi, inscalfibili dall'evoluzione
di natura e cultura, permangano in eterno.
Felice Accame
Nota
Il libro di Borzini è pubblicato da Aracne, Roma 2013
e la citazione è a pag. 387. La vicenda di Phineas Gage
può esser letta in tanti libri di storia della neurologia.
Fra questi, cfr. C. Morabito, La cartografia del cervello
(Franco Angeli, Milano 1996). Il libro di Rensi fu pubblicato
da Etna Editrice, Catania 1935. Le citazioni sono rispettivamente
a pag. 43 e pag. 169. Le argomentazioni di Mussolini e Hitler
– che sono, peraltro, in buona compagnia – sono
ricordate da I. Kirkpatrick, Mussolini: Study of a Demagogue,
Odhams London 1964 e citate da Philip Abrams, Sociologia
storica, Il Mulino, Bologna 1983, a pagg. 359-360. La citazione
di Carl Schmitt è tratta da Teologia politica,
in G. Miglio e P. A. Schiera (a cura di), Le categorie del
'politico', Il Mulino, Bologna 1972, pag. 77. La sciocca
banalità del “male” che “proviene dall'uomo”
è un luogo comune diffusissimo non solo nel pensiero
delle destre storiche, ma anche – il che sia detto senza
volerlo distinguere di un granché – in consistenti
porzioni del pensiero cattolico. Per un caso, cfr. J. Donoso
Cortes, Saggio sul cattolicesimo, il liberalismo e il socialismo,
Rusconi, Milano1972, pp. 185-186. |

