|
tortura
Beccaria, Kant
e il terrore di stato
del collettivo Altra Informazione
A 250 anni dalla pubblicazione del libro di Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”, si sente in giro molta retorica.
Anche in Italia, dove la tortura come reato non esiste.
In pratica, invece....
Il fine della tortura è la tortura.
Il fine del potere è il potere.
George Orwell
Sono ormai trascorsi 250 anni
dalla prima pubblicazione del trattato “Dei delitti e
delle pene”, in cui Cesare Beccaria aveva con forza sostenuto
che “non vi è libertà ogni qual volta le
Leggi permettono che in alcuni eventi cessi di essere Persona,
e diventi cosa”.
Certamente l’autore non poteva immaginare, nell’illusione
di avere contribuito col suo atto di accusa a mettere fine alla
pena di morte e alla tortura, che due secoli e mezzo dopo potesse
circolare una notizia come quella riportata nello scorso febbraio
da vari giornali.
La notizia riferisce di una band canadese di musica metal che
ha presentato una fattura da 666 mila dollari al governo degli
Stati Uniti per l’indebito utilizzo da parte dei militari
di alcuni suoi brani, “sparati” ad altissimo volume,
per torturare i detenuti nel lager-carcere speciale di Guantanamo
Bay, ancora operativo nonostante il presidente Obama, insignito
col premio Nobel per la pace, ne prometta la chiusura dal 2008.
La storia della tortura continua così ad attraversare
i secoli, i continenti e le diverse forme di dominio biopolitico,
con un medesimo intento punitivo che prescinde ogni altra considerazione
sul rispetto dei diritti umani, giustificata moralmente anche
da non pochi intellettuali del tempo, da Bentham a Kant.
In particolare, alcuni anni dopo l’uscita del “Dei
delitti e delle pene”, già messo all’Indice
dalla Chiesa di Roma, fu l’illuminista Kant a stigmatizzare
Beccaria per il suo “sentimento di falsa umanità”
sostenendo che “il diritto di punire è il diritto
del sovrano nei confronti dei suoi sudditi di infliggere loro
una pena dolorosa” perché altrimenti “il
diritto cede, l’ordine crolla, il legame sociale si sfalda,
lo Stato vacilla”. Nonostante i risibili tentativi di
chi oggi cerca di rivalutarlo come un filosofo “libertario”,
Kant in questo modo si dimostrava invece preoccupato dal potenziale
sovversivo insito nelle tesi di Beccaria. Queste, infatti, mettevano
in discussione il principio per il quale la volontà generale,
il collettivo, le istituzioni possono arrogarsi un potere che
non sia loro direttamente trasferito dalla volontà dei
singoli individui concreti.
Analoga incapacità, peraltro, si riscontra ancora in
questo secolo tanto che il ricorso sistematico alla tortura
nei confronti dei sospetti terroristi, è stato ritenuto
un mezzo giustificato dal fine persino da settori ed esponenti
liberal della società statunitense, quali ad esempio
Alan Dershowitz, esimio professore di legge ad Harvard, favorevole
alla sua formale legalizzazione, riecheggiando la cosiddetta
“eccezione” di Josef von Sonnenfels, consigliere
della corona asburgica.
 |
| Cesare Beccaria
(1738-1794) |
Il monopolio dell'uso della violenza
Così, pur in contrasto con tutte le convenzioni e i
trattati internazionali, il presente e persino il futuro continuano
a non liberarsi dal passato, un passato che può essere
utile rammentare.
Non appena la società passò da uno stato “primitivo”
a uno “civilizzato” e vennero promulgati i codici
e le norme, la tortura che fino ad allora era stata attuata
dall’uomo “selvaggio” per soddisfare la propria
sete di vendetta, si cristallizzò in una determinata
pratica, che trovò puntuale giustificazione in un preciso
sistema punitivo: divenne così lo strumento, adottato
dal regnante in un paese autocratico o dallo Stato in un’oligarchia,
per costringere alla sottomissione verso l’autorità
oppure, nel caso di folle o di gruppi sociali più limitati,
per mantenere semplicemente la disciplina dei sudditi.
Nell’Antica Roma, tale esercizio legittimo della violenza
si estendeva sino all’ambito domestico, in cui il capo-famiglia
poteva sottoporre a tortura oltre agli schiavi, pure la moglie
e i figli. La prima legittimazione delle sevizie fisiche deriva
dalla sua efficacia, reprimendo e prevenendo ogni ribellione
nei confronti del potere dominante e i suoi principi fondativi.
Combattendo, l’uno il tradimento e l’altra l’eresia,
sia lo Stato che la Chiesa si sono avvalsi infatti di tale metodo
basato sul terrore.
Nel 1252, fu Innocenzo IV, nella bolla papale Ad extirpanda
a introdurre la tortura come metodo per la ricerca della verità;
d’altronde, l’idea stessa di “castigo divino”
implicava il principio per il quale, attraverso la sofferenza,
era possibile cancellare la colpa riscattandola attraverso la
punizione inflitta, sacralizzando così la coincidenza
di significato tra dolore e pena e, conseguentemente, benedicendo
la figura del boia e dei patimenti impartiti dall’Inquisizione.
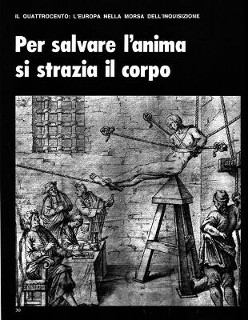 Dissimulato
e coperto dalla “ragione superiore” Persino secondo l’attuale definizione giuridica, la tortura
è una forma di violenza o un metodo di supplizio decretato
dallo Stato ed eseguito da ufficiali debitamente autorizzati
o designati dalle autorità giudiziarie, per cui risulta
quantomeno elusivo parlare e condannare il ricorso alla tortura
senza mettere in discussione il monopolio dell’uso della
violenza - anche estrema e senza limiti - che lo Stato assicura
a sé stesso, sia legalmente che illegalmente.
Se nei regimi totalitari e nelle dittature più feroci
del secolo passato questo aspetto appare intrinseco alla loro
ideologia liberticida, nelle democrazie appare dissimulato e
coperto dalla ragione “superiore”, a tutela di una
sicurezza collettiva minacciata da presunti nemici esterni e
interni. Per cui, anche negli Stati liberali, il confine tra
azione politica legale e abuso criminale tende ad annullarsi
con la complicità di milioni di “spettatori consenzienti”
che ritengono come normale il lavoro dei torturatori, assieme
a campi di concentramento, stupri autorizzati, soppressione
delle libertà formali, assassinii mirati e altre attività
terroristiche compiute dagli apparati statali. Si pensi ad esempio
alla democratica Francia che, nonostante la soppressione dell’uso
della tortura sancita dopo la Rivoluzione del 1789, si renderà
responsabile di sistematiche quanto atroci torture nel corso
dell’occupazione coloniale dell’Algeria (1954-’62).
Da parte loro, la borghesia e la monarchia inglese, ad esempio,
si sono sempre vantate del fatto che nel loro paese la tortura
non sia mai stata praticata, in quanto non legalmente riconosciuta
dalla Common Law; sappiamo invece fin troppo bene di cosa è
stato capace l’imperialismo britannico non solo nelle
guerre e nelle dominazioni coloniali, ma anche in Irlanda del
Nord nella repressione ai danni degli indipendentisti repubblicani.
Stesso dicasi per gli Stati Uniti dove la pratica della tortura
non solo non si è esaurita con la fine dello schiavismo,
ma ha visto nel secondo dopoguerra la sua ininterrotta pianificazione
nei centri d’addestramento militare come una qualsiasi
altra materia di carattere tecnico, seguita dalle atroci applicazioni
sul campo e sui corpi in Corea, Vietnam, America Latina, Irak,
Afghanistan...
Cesare Beccaria un ingenuo utopista?
La stessa Italia democratica che oggi si appresta a commemorare
la prima edizione del “Dei delitti e delle pene”,
come riprova della propria civiltà giuridica, a tutt’oggi
non ha ancora introdotto il reato di tortura nel codice penale
e non ha abolito l’ergastolo, dopo essersi presto assolta
per le torture e gli stupri perpetrati – e fotografati
– dai parà italiani in Somalia durante la missione
Restore Hope (1992-’94), per non parlare di quanto avvenuto
a Napoli e Genova nel 2001 o degli “eccessi” compiuti
in Val di Susa ai danni degli e delle attiviste No Tav..
Un presente che se da un lato può far apparire Beccaria
un ingenuo utopista, dall’altro conferma gli sviluppi
della sua critica che sono stati ritrovati alcuni anni fa sotto
forma di suoi appunti in calce ad una copia dei suoi scritti,
editi a Livorno dall’Editore Aubert nel 1766.
In queste annotazioni si scorge l’intenzione di Beccaria
di riscrivere la sua opera, giungendo ad una critica radicale
della pena e del controllo sociale degli individui, al punto
che qualcuno è giunto ad alludere ad un “Beccaria
anarchico”.
Confermando la già nota difesa dell’individuo contro
il potere statuale, viene sottolineato come il controllo sociale
e il diritto a punire di cui le istituzioni detengono il monopolio
è ammesso solo per quel tanto che le persone sono consapevolmente
disposte a sacrificare della propria libertà. Inoltre
e soprattutto, affrontando la questione della pena di morte,
Beccaria intuisce che la vita non può essere separata
dal soggetto vivente, trattata come un oggetto, ossia posta
di fronte a colui che vive in modo tale da poter creare tra
se e questa cosa un rapporto di effettiva proprietà.
E proprio perché l’individuo non può separarsi
dalla propria vita, è per lui impossibile cederla come
se fosse una sua proprietà nelle mani dello Stato. Il
ragionamento si chiude quindi con la radicale messa in discussione
del diritto delle istituzioni di limitare o addirittura sopprimere
la vita, per il semplice fatto che questo diritto non può
venir loro trasferito dagli individui.
In altre parole, se l’individuo può privarsi solo
di ciò di cui è proprietario, nessuno è
padrone di vendersi, anima e corpo, come una merce, rendendosi
così proprietà dell’altro, suo schiavo.
Da qui, nella consapevolezza che non esiste libertà nella
scelta di farsi schiavizzare, tanto meno è ammissibile
che un individuo si sottometta all’arbitrio dello Stato
nel disporre della sua vita e della sua morte.
In tale riflessione che vede Beccaria distinguersi da altri
teorici della democrazia, sostenitori del primato del collettivo
e quindi dello Stato sull’individuo, è così
possibile ritrovare le questioni fondanti del pensiero antiautoritario
nei confronti dell’istituzione della giustizia, ritenuta
alla stregua di un alibi della punizione, identificando –
attraverso le parole di Rafael Sanchez Ferlosio – “i
giudici, l’avvocato difensore e il pubblico ministero
come il personale di servizio del boia”.
collettivo Altra Informazione
aranea.noblogs.org |

