
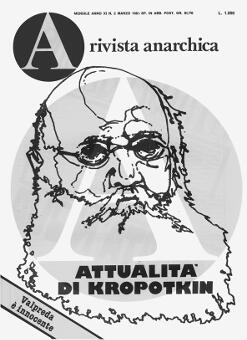 Un
bel faccione di Pëtr Kropotkin campeggia nella copertina
di “A” 90 (marzo 1981). E un piccolo
strillo in basso a sinistra ricorda “Valpreda è
innocente”. Storia e attualità, come sempre intrecciate. Un
bel faccione di Pëtr Kropotkin campeggia nella copertina
di “A” 90 (marzo 1981). E un piccolo
strillo in basso a sinistra ricorda “Valpreda è
innocente”. Storia e attualità, come sempre intrecciate.
Nel primo interno di copertina vengono riprodotte le testate
de L'Internazionale e di Umanità Nova,
espressione rispettivamente dei Gruppi d'Iniziativa Anarchica
e della Federazione Anarchica Italiana, la prima quindicinale,
il secondo settimanale. A distanza di 37 anni da allora, solo
“Uenne”, come viene chiamata spesso Umanità
Nova, continua a uscire regolarmente.
A parte la decina di pagine dedicate al “principe”
russo, in vista del convegno di studi promosso a Milano dal
Centro Studi Libertari, in effetti tutto il numero (allora di
44 pagine) è dedicato all'attualità.
Luciano Lanza si occupa del processo a Valpreda e agli altri
imputati per la strage di piazza Fontana (12 dicembre 1969).
E, parallelamente, del “processo itinerante” contro
lo Stato che viene portato in alcune città dagli anarchici,
appoggiandosi a gruppi libertari locali. “Il nostro processo
itinerante – scrive Lanza – assume un valore che
va al di là della oggettiva limitatezza, perché
(...) rappresenta la società che processa lo Stato per
rivendicare la sua separatezza, la sua alterità, la sua
autonomia rispetto alle istituzioni che pretendono di rappresentarla”.
Paolo Finzi segnala il relativo successo della raccolta di firme
a favore dell'introduzione della pena di morte, promossa dalla
destra, e ne attribuisce la responsabilità sia ai partiti
dell'arco costituzionale sia ai lottarmatisti. All'interno di
questo scritto viene (ri)pubblicato uno scritto di Errico Malatesta,
uscito postumo su Il Risveglio di Ginevra nel 1933, un
anno dopo la morte dell'anarchico campano. Il tema è
quello della pena di morte e della sua imminente reintroduzione
in Italia. Le motivazioni di Malatesta sono decisamente originali
e offrono più di uno spunto per la riflessione. A conferma
della continua evoluzione del pensiero malatestiano.
Roberto Ambrosoli si occupa di carceri, Brigate Rosse, lotta
armata, ecc. Rosanna Ambrogetti e Maria Teresa Romiti di aborto,
autogestione, referendum. Pasquale Masciotra (un ottimo compagno,
morto prematuramente), operatore dei servizi psichiatrici provinciali
di Isernia, pubblica su “A” una sua relazione professionale,
profondamente libertaria. Due giovani militanti milanesi raccontano
un loro viaggio a Zurigo (“Zurigo brucia”) in occasione
di manifestazioni, di “prassi anarchica istintiva”,
del clima in una delle città più vivaci dal punto
di vista dei movimenti giovanili di quell'epoca.
Dalla vivace rivista libertaria spagnola Bicicleta vengono
tradotti alcuni scritti dall'/sull'America Latina: Argentina,
Bolivia, Brasile, Cuba. E si riferisce di un incontro a Parigi
tra anarchici sudamericani residenti in Europa.
Il citato dossier su Kropotkin si compone di una premessa di
Giampietro Nico Berti e di quattro stralci di Kropotkin sul
rapporto industria/agricoltura, sull'integrazione tra lavoro
manuale e intellettuale, sul “governo rivoluzionario”
e sulla sua fuga dal carcere e altre vicende della sua vita
avventurosa.
Frutto della collaborazione tra un redattore di “A”,
Luigi Tadolini, Franco Melandri e Giovanni Zambon, viene pubblicato
anche un breve dossier sull'esperanto, la lingua internazionale
creata da Lazaro Ludovico Zamenhof nell'Ottocento. In due paginette
conclusive trova spazio anche un primo veloce manuale per acquisire
le prime regole, parole, costruzioni di questa lingua che ha
sempre trovato estimatori in campo anarchico e libertario. Uno
per tutti, Giuseppe Pinelli: che al corso di esperanto incontrò
Licia Rognini. Innamorarsi al corso di esperanto, non capita
spesso.
A chiudere il numero, una bella paginetta di Emilio Pucci sulle
favole per bambini. Poi notizie “di servizio”, i
(consueti) problemi finanziari, l'attenzione per la distribuzione
nelle edicole, l'elenco delle librerie in cui si dovrebbe trovare
“A”, le sottoscrizioni. Uno sforzo, questo per la
reperibilità della rivista, che ci ha sempre visto impegnati,
tantopiù quando non esistevano la Rete e la possibilità
che oggi è data di leggerla (gratis) sul video.

|

