
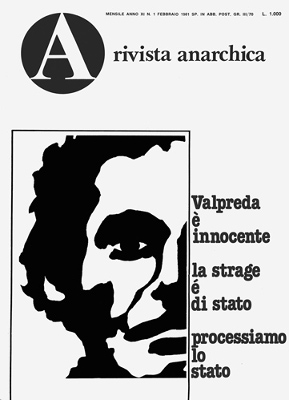 Con
l'uscita di “A” 89 (febbraio 1981)
si apre il secondo decennio di “A”. Tempo di bilanci:
a tracciarlo è Nico Berti, con un denso saggio del significativo
titolo “Dieci anni di A-pensiero”, in cui sottolinea
il ruolo svolto dalla rivista sul doppio binario di una riaffermazione
dei valori e delle scelte politiche fondanti, un secolo prima,
l'anarchismo e – al contempo – il profondo rinnovamento
del patrimonio storico-ideologico anarchico, grazie a un'attenzione
e sensibilità orientate verso il nuovo che si muove nella
società. Interessante che Berti, andando al di là
del proprio identificarsi con i primi quattro anni di “A”
- quelli della fase “iniziale”, particolarmente
dedicata (anche tramite articoli dello stesso Berti) anche alla
riaffermazione della netta distinzione pratica e teorica tra
pensiero anarchico e pensiero marxista – colga positivamente
l'inizio di quel lungo processo di apertura di “A”
all'ecologia, al femminismo (e all'anarco-femminismo) e in genere
a tendenze e movimenti non necessariamente anarchici ma sicuramente
anarco-compatibili. Avremo modo di ritornarci, in questa rubrica. Con
l'uscita di “A” 89 (febbraio 1981)
si apre il secondo decennio di “A”. Tempo di bilanci:
a tracciarlo è Nico Berti, con un denso saggio del significativo
titolo “Dieci anni di A-pensiero”, in cui sottolinea
il ruolo svolto dalla rivista sul doppio binario di una riaffermazione
dei valori e delle scelte politiche fondanti, un secolo prima,
l'anarchismo e – al contempo – il profondo rinnovamento
del patrimonio storico-ideologico anarchico, grazie a un'attenzione
e sensibilità orientate verso il nuovo che si muove nella
società. Interessante che Berti, andando al di là
del proprio identificarsi con i primi quattro anni di “A”
- quelli della fase “iniziale”, particolarmente
dedicata (anche tramite articoli dello stesso Berti) anche alla
riaffermazione della netta distinzione pratica e teorica tra
pensiero anarchico e pensiero marxista – colga positivamente
l'inizio di quel lungo processo di apertura di “A”
all'ecologia, al femminismo (e all'anarco-femminismo) e in genere
a tendenze e movimenti non necessariamente anarchici ma sicuramente
anarco-compatibili. Avremo modo di ritornarci, in questa rubrica.
Numerosi i temi di attualità che caratterizzano questo
numero. La copertina e l'articolo di apertura sono dedicati
alla campagna sulla strage di Stato, seguendo le vicende giuridico-politiche
del processo a Valpreda ed altri, all'epoca a Catanzaro. “A”
riferisce della vasta mobilitazione degli anarchici un po' in
tutta Italia, mentre numerose forze che si erano mobilitate
in passato ora stentavano a riprendere la battaglia.
I due interni di copertina sono dedicati a foto di macerie e
distruzioni dopo il terremoto dell'Irpinia. Francesco Codello
(“Dopo il terremoto... lo Stato”) analizza il post-terremoto
in Campania e sottolinea la vitalità (e la nocività)
dell'intervento della Chiesa. E il Centro redazionale della
provincia di Napoli analizza la realtà del capoluogo
e dell'economia di vicolo, sempre dopo le scosse telluriche.
Un anarchico spagnolo, Pep Castells i Casellas, analizza la
situazione socio-sindacale iberica, rifiutando qualsiasi ipotesi
di prospettiva di rivoluzione “operaia” ed entrando
nel dibattito “organizzativo”. Visto a distanza,
un approccio “iper-critico” che non aiutava a comprendere
la realtà. E questo pone la difficoltà per noi,
spesso, di trovare contributi sereni ed equilibrati per cogliere
la presenza anarchica e libertaria in altri Paesi.
Una stimolante intervista a Giorgio Gaber è realizzata
da Luciano Lanza all'indomani – in particolare –
dell'uscita della canzone “Io se fossi dio”. Titolo
dell'intervista: “Io se fossi Gaber”. Una bella
chiacchierata, che conferma l'originalità del suo approccio
ma anche la sua profonda sensazione di impotenza: che non è
mai stata la nostra.
E poi droga, cinema, ecologia e autogestione.
In chiusura un piccolo dossier dedicato a Pietro Gori (Messina
1865 / Portoferraio – Isola d'Elba 1911) una delle figure
più note e influenti del movimento anarchico di lingua
italiana. Ne viene pubblicata un'arringa, una delle tante nella
sua professione di avvocato. E Cesare Bermani, un ricercatore
(e un amico) che spesso si è occupato di storia anarchica,
scrive per “A” un articolo (“Anarchia in pentagramma”)
che davvero segna lo stato dell'arte dell'influenza di Gori
nella storia della musica e più in generale nella storia
del movimento operaio e socialista, ben al di là dei
confini dell'anarchismo.
Che è un po' anche il fine della nostra rivista: una
rivista anarchica, ma non per sole anarchiche e anarchici. Una
rivista che sappia parlare con “gli altri” e con
loro dialogare. Compito che, come lo si voglia valutare, anche
questo n. 89 ha inteso realizzare. E, se proprio vogliamo dirla
tutta, anche questo n. 421 che hai tra le mani. E un po' tutta
la serie dei 421 numeri finora usciti.

|

