
La mela di Ippocrate
1.
Sappiamo tutti com'è nata la guerra di Troia –
per questioni estetiche. Andò così: Eris, dea
della discordia, ovviamente – con la nomea che aveva –
non viene invitata al banchetto – e lei si vendica. Butta
lì tra gli invitati bicchieri e vol au vent in
mano una mela tutta d'oro su cui aveva scritto “alla più
bella”.
Da subito, l'atmosfera non è più quella di prima:
a chi tocca? Chi è la più bella? Com'è
giusto che fosse, tirano per la giacca Zeus – decida lui
che è il capo – ma quello da quell'orecchio non
ci sente – un capo davvero sveglio, fin che può
cerca di non inimicarsi nessuno dei suoi potenziali elettori.
Dice: “La più bella? Decida il più bello?”.
E chi è il più bello? Tal Paride, principe di
Troia che, al momento, come tirocinio fa il pastore.
Portano allora a Paride le tre pretendenti principali e lì,
prima che lui si pronunci, cominciano le manovre di corruzione:
in cambio del voto, una gli promette la sapienza e l'imbattibilità,
l'altra la ricchezza e il potere e l'altra ancora, tal Afrodite,
una che evidentemente la sa lunga sulla vita sessuale dei giovani
pastori, gli promette l'amore della più bella donna del
mondo. Paride abbocca e, detto e fatto – addio pecore
–, consegna la mela a quest'ultima e in un amen si ritrova
fra le braccia accoglienti di Elena, legittima moglie di Menelao,
re di Sparta. Non l'avesse mai fatto – chissà quanti
accidenti gli hanno mandato quelli che, poi, ci hanno rimesso
la pelle.
2.
La vita di Ippocrate di Coo sembra collocabile tra il 460 e
il 377 a. C. A costui si deve il testo di un giuramento al quale
– fatti i dovuti aggiornamenti – hanno il dovere
di sottostare tutti coloro che hanno scelto la professione medica.
Tuttora.
Nei vari articoli di cui si compone questo giuramento si parla
della stima che il medico deve avere per il proprio Maestro;
della necessità che, in cambio dell'insegnamento della
propria arte, non debba essere richiesto compenso alcuno; dell'opportunità
di riservare il proprio sapere per i propri figli e per i figli
del Maestro e, ovviamente, dell'impegno che il medico contrae
nei confronti del malato: deve fare del proprio meglio per lui,
non può somministrargli farmaci mortali e dovrà
astenersi da ogni azione corruttrice, non lo potrà operare
del “mal della pietra” – per il quale, evidentemente,
si doveva richiedere l'intervento di un macellaio di altra corporazione
– e, ovviamente, dovrà mantenere il segreto su
quanto venuto a sapere, riguardo al paziente, nell'esercizio
delle proprie funzioni.
3.
Come dicevo, come tutti i giuramenti anche il giuramento di
Ippocrate, di tanto in tanto, va aggiornato. Del “mal
della pietra”, ovvero della calcolosi, oggi si occupano
i medici che, con i chirurghi, nel frattempo, sono diventati
pappa e ciccia. Scorro il Codice di Deontologia Medica approvato
recentemente dalla Federazione Nazionali degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri e, constatando innanzitutto come
il testo, nei secoli, tenda ad espandersi, giungo all'articolo
76 – titolato “Medicina potenziativa ed estetica”
– e lì mi fermo.
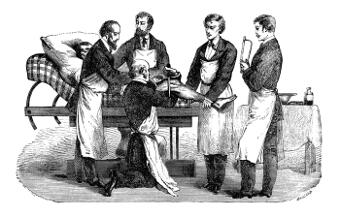 Dice
questo articolo, infatti, che “il medico, quando gli siano
richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle
fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera
(...) secondo i principi di precauzione, proporzionalità
e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo
il consenso informato in forma scritta”. Immagino che
produttori di viagra e di sostanze dopanti in genere stiano
festeggiando: la ratifica sociale del “potenziativo”
è avviata – con tutti gli utili conseguenti –
e sembra mancare pochissimo a quel “soma” –
o droga di Stato – che, allo scopo di estirpare alla radice
il pensiero negativo, veniva distribuito agli abitanti de Il
mondo nuovo preconizzato da Aldous Huxley già nel 1932. Dice
questo articolo, infatti, che “il medico, quando gli siano
richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle
fisiologiche capacità psico-fisiche dell'individuo, opera
(...) secondo i principi di precauzione, proporzionalità
e rispetto dell'autodeterminazione della persona, acquisendo
il consenso informato in forma scritta”. Immagino che
produttori di viagra e di sostanze dopanti in genere stiano
festeggiando: la ratifica sociale del “potenziativo”
è avviata – con tutti gli utili conseguenti –
e sembra mancare pochissimo a quel “soma” –
o droga di Stato – che, allo scopo di estirpare alla radice
il pensiero negativo, veniva distribuito agli abitanti de Il
mondo nuovo preconizzato da Aldous Huxley già nel 1932.
Glossa al punto 3.
Che cosa sia l'autodeterminazione della persona, ovviamente,
è tutto da vedere. Non solo sul piano strettamente epistemologico
è difficile definirla – e più passa il tempo
e sempre meno contorni chiari ha (si pensi a come le neuroscienze
hanno messo in crisi la vecchia nozione di “libero arbitrio”)
–, ma anche sul piano, diciamo così, della pratica
alla buona – si veda la discussione in atto sull'obbligatorietà
delle vaccinazioni – lascia parecchio a desiderare. Ci
sono momenti della vita in cui te la attribuiscono volentieri,
questa autodeterminazione – per esempio, quando sei accusato
di un reato –, e momenti in cui – per esempio, quando
sei bambino e quando sei anziano – non te l'attribuiscono
nemmeno per scherzo.
4.
Ma l'articolo 76 prosegue: “il medico, nell'esercizio
di attività diagnostico-terapeutiche con finalità
estetiche, garantisce il possesso di idonee competenze e (...)
non suscita né alimenta aspettative illusorie, individua
le possibili soluzioni alternative di pari efficacia e”
– ci mancherebbe altro – “opera al fine di
garantire la massima sicurezza delle prestazioni erogate”.
E qui l'espansionismo della medicalizzazione, andando ben oltre
l'ambito circoscritto da Ippocrate, raggiunge il suo apice.
A costo del buon senso, d'accordo, perché stabilire la
“pari efficacia” delle alternative – ovvero
uno stato futuro – e nella “massima sicurezza”
lo si può fare, davvero, soltanto suscitando “aspettative
illusorie”. Ma anche a costo della correttezza metodologica
o, per dirla in altri termini, della scientificità stessa
della disciplina.
D'accordo, come viene giustificato il doping, viene anche giustificata
la chirurgia estetica – questo è il senso delle
cose –, perché alle ghiotte e promettenti fette
di mercato non si può rinunciare a cuor leggero. Ma,
annoverando fra le attività diagnostiche anche quelle
con “finalità estetiche”, al medico tocca
una facoltà del tutto nuova, una facoltà che nella
sua tribolata storia mai ha avuto – riequilibrare due
zigomi, gonfiare labbra, rialzare palpebre, tagliar via pannicoli
adiposi, raddrizzare tibie, e via manipolando per un catalogo
in offerta sempre più vasto – e che ne fa, hic
et nunc, un novello Paride.
5.
Con ciò tutta la gamma dei criteri estetici prodotti
dall'evoluzione naturale – si pensi ai manti delle zebre,
alle penne dei pavoni o ai colori aposematici di certi insetti
e ai corrispettivi di queste soluzioni negli esseri umani –
finisce nella pattumiera della Storia – della nostra Storia
e, prima o poi, per lo strapotere dell'uomo, della Storia di
tutti i viventi. Nel momento stesso in cui sanano una differenza,
i novelli Paride ottemperano ad un paradigma, ovvero ad un termine
di confronto, e non sarà inutile, allora, far notare
che questo paradigma è deciso da qualcuno – qualcuno
che stabilisce i modelli vincenti, quelli cui, in nome dell'estetica,
vengono ridotte tutte le differenze e che non si fa fatica alcuna
ad individuare come “mercato”.
Glossa al punto 5.
Aposematici sono quei colori di cui sono dotati alcuni insetti
e che, a quanto pare, hanno la funzione di avvertire a distanza
l'incauto predatore che è meglio lasciar perdere –
che come alimento, il soggetto che li può sfoderare,
fa veramente schifo. Perlopiù sono il rosso, il giallo,
l'azzurro e l'arancione. Mi stavo chiedendo se, come strategia
diversiva per reperire un partner sessuale, non stia avvenendo
qualcosa di analogo – pensavo alle estese planimetrie
di certi tatuaggi - nell'evoluzione culturale dei corpi umani:
come dire che, al rapporto si è disponibili, ma che questo
rapporto è molto impegnativo.
6.
La leggenda di Paride, però, insegna anche un'altra cosa
– politicamente più rilevante: che il criterio
estetico – peraltro non definito da nessuno – lascia
il tempo che trova, visto che, alla finfine, il giudizio conclusivo
è ottenuto con la corruzione. Ciascuna delle tre concorrenti
promette qualcosa in cambio del voto. Di concorrere per la loro
sola bellezza non ci pensano neppure. Paride sceglie in base
a tutt'altri criteri. Ed è la guerra. Ci si pensi: tanta
deontologia professionale – tanto tradimento della deontologia
professionale, tanti argomenti zoppicanti a giustificazione
del proprio operato – e, alla fine, i motivi sono altri.
Felice Accame
Post scriptum: Mi accorgo anche – leggendo
l'articolo successivo – titolato alla “Medicina
militare” (concetto su cui si potrebbe spendere un libro
intero) – che le “conoscenze scientifiche più
aggiornate” sono richieste al “medico militare”,
ma non a quello “potenziativo ed estetico”. La virtù
guerresca, insomma, ha ancora il predominio sulla vanità.
|

