
“Il grande circo di Pechino” è la scritta
che appare nella copertina del n. 78 (novembre 1979) di “A”.
Sullo sfondo, una foto del Grande Timoniere Mao-Tse-Tung. All'interno
un articolo-quadro di un redattore e tre documenti elaborati
da militanti anarchici cinesi sulle lotte degli studenti, la
condizione della donna e la situazione contadina. Tutti materiali
– come altri presenti su codesto numero di novembre –
provenienti dal Convegno internazionale di studi sull'autogestione
(Venezia – 28/30 settembre 1979) tenutosi poco prima
con buona partecipazione di pubblico e notevole qualità
dei numerosi dibattiti. Come spesso in occasioni simili, oltre
alle relazioni “ufficiali”, a margine dell'incontro
e nelle settimane precedenti e successive – grazie alla
sosta prolungata di numerosi relatori e militanti – si
è svolta una notevole attività di scambio di informazioni,
dibattiti, diffusione di documenti, in quell'epoca precedente
all'avvento del web.
Una relazione ripresa dal Convegno veneziano è quella
dello studioso jugoslavo Slobodan Drakulic (che più tardi
emigrerà in Canada, dove morirà) su “Burocrazia
e autogestione in Jugoslavia”. Ma l'articolo di apertura
della rivista è del torinese Piero Flecchia ed è
dedicato ai licenziamenti alla Fiat (titolo: “Il fantasma
di Valletta”), al quale segue un pezzo ironico sui papi
e la Chiesa cattolica. Lo firma Gabriele Roveda (con lo pseudonimo
“Palluntius”), allora e per qualche anno membro
della redazione di “A”.
Quattro dense pagine sono dedicate alla Sac, il sindacato libertario
tuttora esistente in Svezia: un'organizzazione non appartenente
all'Associazione Internazionale dei Lavoratori che raggruppa
alcuni sindacati di ispirazione anarco-sindacalista ma non questa
significativa organizzazione sindacale libertaria svedese, di
cui in un bel box si racconta la lunga storia. L'intervistato
(da Paolo Finzi, sotto le pseudonimo di Camillo Levi) è
Lars Tormbionsson, per un decennio segretario generale della
Sac. Il quale racconta dell'originale presenza di un sindacato
libertario e autogestionario non – come in genere si pensa
– in Paesi caratterizzati da forti diseguaglianze sociali,
ma nella Svezia di quegli anni, considerata una delle patrie
del relativo benessere e di una lotta di classe sicuramente
attutita. È un'esperienza storica molto interessante
questa della Sac, che prosegue tuttora e della quale torneremo
di sicuro ad occuparci.
Uno scritto non firmato, quindi redazionale, si occupa della
situazione all'interno delle carceri italiane e in particolare
delle differenze e della contrapposizione tra detenuti per fatti
di lotta armata (e dintorni) di fede marxista (a partire dagli
esponenti delle Brigate Rosse) e altri di impostazione libertaria.
Un tema che ricorre in quegli anni sulle colonne di “A”.
A quelle vicende non sempre – con l'occhio di oggi –
si guarda da parte della redazione con sufficiente spirito critico,
all'altezza di una lucida visione del contesto generale. L'attenzione,
in genere attenta e critica, data a quei fenomeni e a quelle
vicende – e anche a storie di singole persone –
testimonia certo la volontà della redazione di essere
orgogliosamente attiva e indipendente nell'attenzione critica
verso gli episodi di violenza “rivoluzionaria” e
di lotta armata.
Certo è che gli sviluppi di quei movimenti e anche tanti
episodi che sarebbero accaduti negli anni successivi accentuarono
di molto la nostra critica al lottarmatismo quale modalità
di possibile “avanzata” delle tematiche libertarie.
Senza se e senza ma, si sarebbe poi detto.
I conti con le drammatiche conseguenze di un attentato compiuto
da tre anarchici nel 1921 a Milano si colgono anche nella recensione
(non firmata, quindi anch'essa redazionale) del volume Mazurka
blu, scritto da Vincenzo Mantovani, che all'attentato al Teatro
Diana del marzo 1921 ha dedicato anni di ricerca storiografica
e poi la pubblicazione di un librone che da allora segna lo
stato dell'arte nella ricerca storiografica sul tema. Mantovani,
all'inizio del suo lavoro di ricerca, era venuto a trovarci
in redazione, tenendoci poi informati dei risultati del suo
impegno. Che non ha potuto fare luce chiara e completa su eventuali
responsabilità indirette (provocazione da parte delle
forze dell'ordine?), ma ha comunque illuminato la scena socio-politica
di quelle vicende.

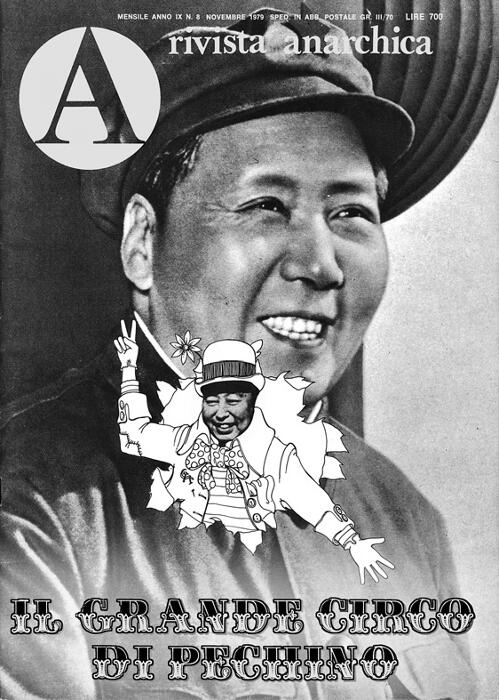 |

