|
controsservatorio Giubileo
Toh, inquinare è “peccato”
di Francesca Palazzi Arduini
Il papa affronta la questione ecologica.
E tenta di fagocitare i movimenti ecologisti.
“I comandamenti green
di Papa Francesco”, “rivoluzione culturale green
e resistenza immediata”, “grandioso affresco sul
mondo”, “un'enciclica a 5 stelle”... Celebrazioni
universali per la seconda enciclica di Bergoglio, “Laudato
si'”, diffusa nel giugno scorso in dosi massicce. In Italia
“Famiglia Cristiana”, che tira 350mila copie, la
pubblica immediatamente, la rivista “Credere” quella
del Giubileo (venduta a un euro e cinquanta) e anche i periodici
profani (l'anteprima de L'Espresso ma anche la Repubblica) con
tirature stratosferiche, danno accesso all'edizione integrale.
Tutto il mondo sembra aver accolto con favore, considerandolo
fortemente innovativo, questo semplice testo la cui eccezionalità
in realtà è data a mio parere più dalla
tematica che dalla trattazione.
Se infatti i toni dell'enciclica sono eccezionalmente gravi,
poiché concordano con l'ipotesi scientifica di una catastrofe
ambientale in corso, non lo è la tecnica espositiva né
lo sono i contenuti principali, che mimano e riprendono ben
note argomentazioni.
A ben guardare, leggendo il testo nella sua interezza come molti
“esegeti” non hanno fatto, essa richiama la metodica
tipica di una moderna enciclica, definibile in tre fasi: la
descrizione di un problema attuale (con citazioni solo da testi
sacri e dottrina cattolica), l'esame delle soluzioni possibili
(con ampio ricorso al discrimine di quelle laiche e quindi “incomplete”
e non apprezzabili), presentazione della linee risolutive (approvate
da dio) e preghiere finali.
Esiste un campionario di encicliche “di emergenza”,
cioè intervenute su problematiche sociali da bonificare
con urgenza, basti qui ricordare il prototipo, la “Rerum
novarum” di Leone XIII (1891) che sentenziava la necessità
di fruttuosa relazione tra Capitale e Lavoratori, e la “Quadragesimo
anno” di Pio XI (1931) che si affannava ad avvertire che
non era lecito il collettivismo stile real socialista. Il metodo
dell'enciclica sociale è continuato poi con una linea
più “inclusiva”: si descrive cioè
una tematica dandone una visione panoramica e facendo proprie
analisi profane, è il caso dell'enciclica “Centesimus
annus” (1991) nella quale Karol Wojtyla, dopo un'accurata
analisi dei mali della nostra società (Tangentopoli)
ne incolpava con sicumera lo Stato corrotto, come se la DC non
fosse mai stata cosa loro.
I Formichieri
Il lavoro dei papi insomma pare consistere essenzialmente nel nutrirsi di idee e fatti come i formichieri di formiche, assumendo in sé tutti i dati necessari ad una rielaborazione in chiave cattolica, e dominante, dei problemi sui quali sta loro a cuore dettare una linea.
Nel caso dell'ecologia, già varie sperimentazioni di altri papi avevano “sussunto”. Benedetto XVI nella sua “Caritas in veritate” (2009) condannava il degrado naturale per colpa umana, lo stesso Wojtyla già aveva trattato di “ecologia umana” e “conversione ecologica”, ed anche in vitro Giovanni XXIII e Paolo VI. Ma Bergoglio coglie in quanto “Francesco” la possibilità di fare tendenza in questo campo, non limitandosi quindi a definire “un crimine contro la natura come crimine contro Dio” ma colorando di religiosità l'ecologismo tutto, con la solita pretesa che questa visione sia più “integrale” e completa di altre.
Eco-frullato in nomine Patri
Da ben prima del protocollo di Kyoto (1997) le potenze mondiali
si scontrano sull'applicazione più o meno hard
del concetto di sostenibilità ambientale; questo termine,
dal noto Rapporto sui limiti dello sviluppo (1972), dovrebbe
definire quanto l'attività umana possa esercitarsi senza
danni all'ecosistema.
I movimenti ambientalisti, unitamente a molti di quelli impegnati
a contrastare il capitalismo, si sono impegnati da oltre cinquant'anni
a proporre soluzioni e contrastare scelte consumiste e nocive.
Ma l'enciclica di Bergoglio, se si escludono alcuni sbrigativi
ringraziamenti, è interessata a trascrivere il problema
a partire da uno scenario vuoto: dove il primo soggetto è
il Padre e la scenografia è il Creato.
“Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare
tutti coloro che, nei più svariati settori dell'attività
umana, stanno lavorando per garantire la protezione della casa
che condividiamo”.
Con questi ringraziamenti da parte di dio, e la frase “Il
movimento ecologico mondiale ha già percorso un lungo
e ricco cammino, e ha dato vita a numerose aggregazioni di cittadini
che hanno favorito una presa di coscienza.”, evitando
di citare qualsiasi testo o fonte storica dell'ecologismo, il
papa ridefinisce i confini di un'emergenza che a suo dire può
essere risolta solo ricorrendo ad un'alleanza e solidarietà
nelle quali i capi religiosi faranno certo da ispiratori. Si
tratta di ispirare una nuova “Autorità mondiale”.
Non per niente sono frequentissime invece le citazioni da lettere,
summit e documenti episcopali di ogni paese.
Solo alcune citazioni di Romano Guardini, uno dei teologi più
citati anche da Ratzinger, costellano poi le pagine che riassumono
tutte le problematiche ecologiche inserendole in un contesto
religioso. Dal nocivo fumo delle cucine (“Ci si ammala,
per esempio, a causa di inalazioni di elevate quantità
di fumo prodotto dai combustibili utilizzati per cucinare o
per riscaldarsi”) a quello delle fabbriche, il problema
ambientale è collegato alla tematica del capitalismo
in modo da non menzionarlo come tale ma come “sfruttamento”,
legato al peccato dell'avidità.
Facendo il suo mestiere, il papa tenta anche una rilettura della
Genesi che non descriva il nostro Pianeta come alternativa infernale
al Paradiso terrestre, egli richiama quindi l'idea di un terreno
paradiso naturale, citando il Francesco d'Assisi, di una visione
integrata di natura ed esseri umani. Nessun altro autore, né
laico né credente, tra i tanti che hanno affrontato questo
tema, non solo i mistici ma anche gli scienziati, viene citato.
Per un'ecologia di noi bastardi/e
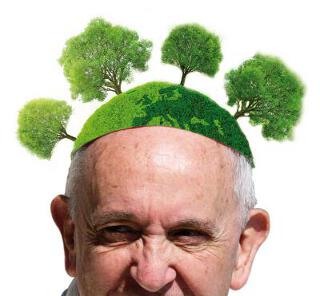 Potremmo,
di queste pagine, apprezzare la lancia spezzata a favore della
gestione pubblica dell'acqua (“Mentre la qualità
dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi
avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata
in merce soggetta alle leggi del mercato”). Potremmo anche
allietarci del tentativo di reinterpretazione di quel passo
della Genesi (1,28) in cui dio invita gli umani a “soggiogare
la terra”, invito che riletto in chiave Sette Nani offrirebbe
una visione più allegra di attività quali l'estrazione
mineraria... Potremmo,
di queste pagine, apprezzare la lancia spezzata a favore della
gestione pubblica dell'acqua (“Mentre la qualità
dell'acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni luoghi
avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata
in merce soggetta alle leggi del mercato”). Potremmo anche
allietarci del tentativo di reinterpretazione di quel passo
della Genesi (1,28) in cui dio invita gli umani a “soggiogare
la terra”, invito che riletto in chiave Sette Nani offrirebbe
una visione più allegra di attività quali l'estrazione
mineraria...
Ma il costante richiamo alla mano benevola del “Padre”
ci ricorda che la visione nuovamente “divinizzata”
della natura è tale per Bergoglio in un'ottica di primato
della fede sull'etica, o di una etica religiosa, poiché
chi non la possiede finirà “per adorare altre potenze
del mondo”, mentre lo spirito religioso darebbe libertà.
Per confermare questa tesi sono presenti nell'enciclica dei
graziosi inserti che affermano la volontà Bergogliana
di avere l'enciclica piena e la folla ubriaca. Parlo dei punti
in cui sono trattati la sperimentazione sugli animali, il controllo
delle nascite, l'aborto, il genere e l'uso di OGM in agricoltura.
La vivisezione, ad esempio, è ritenuta come per il Catechismo
legittima se contribuisce a “salvare vite umane”,
la decisione in merito spetta ai religiosi, visto che “Qualsiasi
uso e sperimentazione esige un religioso rispetto dell'integrità
della creazione”. Il controllo delle nascite poi, è
sicuramente inutile, visto che il problema demografico non esiste:
“l'ineguale distribuzione della popolazione e delle risorse
disponibili” sarebbe il vero problema, guai ad accettare
profilattici e politiche di libertà femminile: “Invece
di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso,
alcuni si limitano a proporre una riduzione della natalità.
Non mancano pressioni internazionali sui Paesi in via di sviluppo
che condizionano gli aiuti economici a determinate politiche
di salute riproduttiva”. Qui la demonizzazione dei programmi
Onu a favore delle donne è evidente, e appare più
chiara anche nel caso dei diritto all'aborto: “Dal momento
che tutto è in relazione, non è neppure compatibile
la difesa della natura con la giustificazione dell'aborto”.
Dal momento che tutto è in relazione? Ma in questo copiaticcio
di Gaia non solo le donne ma anche le persone Lgbt non sono
ben accette soprattutto se non recitano il mea culpa: “Anche
apprezzare il proprio corpo nella sua femminilità o mascolinità
è necessario per poter riconoscere sé stessi nell'incontro
con l'altro diverso da sé... non è sano un atteggiamento
che pretenda di cancellare la differenza sessuale perché
non sa più confrontarsi con essa”. Qui è
evidente una malevola rilettura, volutamente superficiale, della
questione del Genere sessuale nella storia e nelle culture.
In questo periodo cruciale per la cultura italiana, nel quale
l'appellativo di “bastardo” riassume il suo più
pieno significato nelle frasi dei cattolici dei Family Day che
imprecano contro le famiglie non composte da un padre e una
madre biologici, è importante capire le radici culturali
della tragedia umana della normalizzazione. E noi “bastardi”
non siamo ecologici.
Vogliamo passare alle parole del Grande Esperto in merito al
pericolo OGM? Il discorso sul cibo non poteva mancare da questa
rivoluzionaria enciclica, in anno di Expo, ed ecco il bivalente
gesuita: “Sebbene non disponiamo di prove definitive circa
il danno che potrebbero causare i cereali transgenici agli esseri
umani, e in alcune regioni il loro utilizzo ha prodotto una
crescita economica che ha contribuito a risolvere alcuni problemi,
si riscontrano significative difficoltà che non devono
essere minimizzate”.
Soluzioni cinesi
Nonostante Bergoglio, attingendo a piene mani da un bignami ecologista, voglia fare sue le tesi di Murray Bookchin, e pure quelle libertarie del no-globalismo, lo scenario dell'enciclica è estremamente retorico e non presenta idee nuove non solo per i laici, cui si pretende di insegnare (“Ugualmente si rende necessario un dialogo aperto e rispettoso tra i diversi movimenti ecologisti, fra i quali non mancano le lotte ideologiche”) ma neanche per la Chiesa, alla quale la riproposta ricetta della sobrietà e del sacrificio parrà pappa riscaldata e da tempo indigesta.
Quali soluzioni propone questo manuale lastricato di buone intenzioni? Il summit sul clima è finito con la buona intenzione della Cina di costruire sei centrali nucleari all'anno, quali sono le sue ricette? Seppure piacevolmente intento ad affabulare, addirittura consigliando il metodo della condivisione per le decisioni riguardanti i territori, mentre non le attua per i suoi Sinodi (“Bisogna abbandonare l'idea di “interventi” sull'ambiente, per dar luogo a politiche pensate e dibattute da tutte le parti interessate”), Bergoglio infine torna a Santa Marta, con consigli più pratici, ecologismo è “fermarsi a ringraziare Dio prima e dopo i pasti”...l'orizzonte del digiuno di protesta è ancora lontano.
La contemplazione francescana della natura dal canto suo diviene spot pubblicitario: “c'è un mistero da contemplare in una foglia, in un sentiero, nella rugiada, nel volto di un povero”, ecco come l'umanità dietro la povertà diventa fenomeno naturale, in tutta la sua mediaticità.
Francesca Palazzi Arduini
|

