
Dalla zampa del Padre
1.
Andando a sfrugugliare la caligine millenaria che avvolge le
nostre parole, si può anche scoprire che al termine “mano”
o, meglio, alla sua radice (la stessa di madre, mensa, mese
e metro), corrispose il significato del misurare – un
qualcosa che si estende, che nell'estendersi costruisce. Più
o meno come il piede, che, nella cultura anglosassone, rappresenta
tuttora 30,48 centimetri del sistema metrico. E, tuttavia, la
mano – a cominciare da quella mappa somatosensoriale che
il neurochirurgo canadese Wilder Penfield individuò già
nella prima metà del secolo scorso – ebbe maggior
fortuna. Destinata a crescere ancora con l'attuale papa. Già
negli Estratti dal diario di Adamo firmati dal sottile
Mark Twain, però, era evidente – laddove parla
di Eva che si asciuga le lacrime “col dorso della zampa”
- quanto fosse sufficiente cambiare categorizzazione per ricondurre
i valori della cosa ad una loro dimensione più equa.

2.
Mi immagino che il compito della guida suprema della Chiesa
Cattolica nel XXI secolo dopo Cristo – almeno il compito
autoimpostosi – sia quello di salvare il pianeta e la
sua umanità – qualcosa del pianeta e della sua
umanità; salvare, presumibilmente, in più sensi
–, non indagando troppo per il sottile per quanto riguarda
le responsabilità del passato (che, magari, proprio a
questa necessità di salvezza hanno condotto), inducendo
alla conservazione della fede in Dio – un Dio ben propenso
verso l'umanità – e, al contempo, gettando qualche
manciata di ottimismo. Almeno, mi immagino che queste siano
le sue intenzioni. Opinioni di questo genere, beninteso, avrei
anche potuto farmele da tempo, ma, ora – dopo la lettura
di Laudato si' – Lettera enciclica sulla cura della
casa comune (Ancora, Milano 2015) di papa Francesco I –
posso dire che se da un lato il succo di queste opinioni mi
è stato confermato, dall'altro ho potuto aggiornarmi
sulla strategia argomentativa in virtù della quale tale
compito è andato giustificandosi. Perché è
ormai ovvio che la Chiesa, oggi, pensi al pianeta e all'umanità
– e alle cause individuali e collettive relative ai loro
guai – in modo diverso dal passato – come è
ovvio che ai fini della conservazione della fede in Dio e della
diffusione di ottimismo si serva di argomentazioni ben diverse
da quelle usate in passato. Avendo ben presente, allora, che
“a nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non
riconosciamo la radice umana della crisi ecologica”, mi
provo a seguire l'ordine delle argomentazioni così come
proposto dal papa.
3.
La nostra “casa comune” – è questa
la ricategorizzazione del pianeta – ce lo ricorderebbe
San Francesco – è “come una sorella”
e “come una madre bella”. Mi chiedo perché
“bella” e perché non è bella anche
la sorella, ma qui è forse il caso di lasciar perdere.
È già chiaro che si prende le mosse da una tirata
sul “rispetto dell'ambiente” e annessi e connessi,
per arrivare alla conclusione che “anche l'ambiente sociale
ha le sue ferite. Ma tutte sono causate in fondo dal medesimo
male, cioè dall'idea che non esistano verità indiscutibili
che guidino la nostra vita”. E qui Francesco I si gioca
già l'asso di briscola: le “verità indiscutibili”
da cui proverrebbe il male – sicuro del fatto che questo
male non possa invece provenire proprio dalle “verità
indiscutibili”. Ma come dargli torto quando afferma che
“un vero approccio ecologico diventa sempre un approccio
sociale” o quando associa il “grido della terra”
a quello dei “poveri” o invita alla salvaguardia
della “biodiversità” e – contro il
mito del progresso – si dichiara contrario al “rumore
dispersivo dell'informazione”?
Diciamo che formulazioni del genere avrebbero bisogno di qualche
ritocco (più che esser “vero” l'approccio
ecologico non dovrebbe basarsi su presupposti contraddittori;
sulla salvaguardia della biodiversità occorrerebbe intendersi
e sul categorizzare come “rumore” le informazioni
che non ci piacciono ci andremmo cauti), ma che, in definitiva,
sono ampiamente condivisibili. Tuttavia, i nodi sono destinati
a giungere presto al pettine.
La scienza e la religione, infatti, fornirebbero “approcci
diversi alla realtà”, ma potrebbero “entrare
in un dialogo intenso e produttivo per entrambe”. Qui
il discorso si farebbe lungo – e soprattutto si farebbe
ripetitivo –, ma è inutile farlo perché
è già chiaro che, comunque la si metta, si rimarrà
nell'ambito della teoria (insostenibile) del “doppio magistero”
di Gould: scienza e religione costituiscono due ambiti diversi
e l'una non può di principio metter becco negli affari
dell'altra e viceversa; tesi che non sta in piedi perché
entrambe usano lo stesso linguaggio per esprimere le loro “verità”
e perché fra i compiti della prima c'è quello
di analizzare i significati espressi da essa stessa e dalla
seconda – se questi significati risultano privi di senso
o autocontraddittorii, le “verità” crollano.
Vale più la pena, invece, sottolineare che, senza la
figura di un Padre “creatore e unico padrone del mondo”,
l'uomo “tenderà sempre a voler imporre alla realtà
le proprie leggi e i propri interessi”, cioè vale
la pena sottolineare l'impianto realistico dell'argomentazione:
alle verità indiscutibili viene ad aggiungersi –
o, meglio, deve venire ad aggiungersi – un insieme di
leggi indipendenti dall'uomo e attribuite ad una creazione altrui:
“un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di
tutti, come una realtà illuminata dall'amore che ci convoca
ad una comunione universale”, dove, come in una mappa
somatosensoriale dell'universo, spicca la metaforica “mano”
che, nella fase benevola dello schiudimento, elargisce (si riscontri
nella Preghiera cristiana con il creato: “Ti lodiamo,
Padre, con tutte le tue creature,/che sono uscite dalla tua
mano potente”). L'uomo è ancora e sempre cattivuccio
e, conseguentemente, senza tanta necessità di dimostrarne
l'esistenza, di un “padrone” ha bisogno. La nuova
metafora, ovviamente, non è giocata per caso, perché
in questa creazione così benignamente elargita qualche
distinguo va fatto. Uno in particolare è ancora fondamentale
ed è quello tra umano e animale – salvaguardiamo
sì la biodiversità, ma con giudizio: “la
capacità di riflessione, il ragionamento, la creatività,
l'interpretazione, l'elaborazione artistica ed altre capacità
originali mostrano una singolarità che trascende l'ambito
fisico e biologico”.
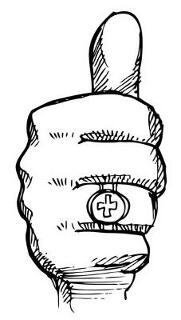 Fermo
restando – statene sicuri – che “nessuno dei
cinque passeri” (Luca, 12, 6) “è dimenticato
davanti a Dio”, ahinoi, difenderemmo le specie animali
più di quel che ci diamo da fare per “difendere
la pari dignità tra gli esseri umani”. L'umano,
insomma, sarebbe superiore, se non altro per rispondere ad uno
scopo nobilissimo, perché “quando il pensiero cristiano
rivendica per l'essere umano un peculiare valore al di sopra
delle altre creature, dà spazio alla valorizzazione di
ogni persona umana, e così stimola il riconoscimento
dell'altro”. Sul perché questo sacrosanto “riconoscimento”
possa avvenire soltanto in rapporto ad un decreto di superiorità,
il papa non ritiene opportuno di spendere neppure una parola
– si affida all'analogia: padrone uno, padroni gli altri
scivolando giù verso un fondo della gerarchia dove un
anonimo disgraziato rimarrà senza nessuno sul quale infierire. Fermo
restando – statene sicuri – che “nessuno dei
cinque passeri” (Luca, 12, 6) “è dimenticato
davanti a Dio”, ahinoi, difenderemmo le specie animali
più di quel che ci diamo da fare per “difendere
la pari dignità tra gli esseri umani”. L'umano,
insomma, sarebbe superiore, se non altro per rispondere ad uno
scopo nobilissimo, perché “quando il pensiero cristiano
rivendica per l'essere umano un peculiare valore al di sopra
delle altre creature, dà spazio alla valorizzazione di
ogni persona umana, e così stimola il riconoscimento
dell'altro”. Sul perché questo sacrosanto “riconoscimento”
possa avvenire soltanto in rapporto ad un decreto di superiorità,
il papa non ritiene opportuno di spendere neppure una parola
– si affida all'analogia: padrone uno, padroni gli altri
scivolando giù verso un fondo della gerarchia dove un
anonimo disgraziato rimarrà senza nessuno sul quale infierire.
Le contraddizioni, peraltro, non lo spaventano. E anche quando
non trova pronta una metafora con cui occultarle va dritto per
la sua strada. È così, per esempio, che la “proprietà
privata” – eccoci ad un punto delicato – deve
essere subordinata alla “destinazione universale dei beni”.
Come ciò possa accadere rimane misterioso: se qualcosa
è proprietà del singolo non si vede come possa
poi trasformarsi in proprietà collettiva – che
vi sia “destinata” promette di certo un futuro migliore,
ma un criterio in virtù del quale far sì che questo
futuro diventi un presente almeno per qualcuno non è
esplicitato.
Similmente vanno le cose per quell'argomentazione più
complicata che riprende – e approfondisce – il tema
della scienza. Se la “tecnoscienza” fosse “ben
orientata” – inizia così l'argomentazione
– sarebbe “anche capace di produrre il bello e di
far compiere all'essere umano immerso nel mondo materiale, il
“salto” nell'ambito della bellezza”. Faccio
notare che, a differenza di tutti quei fessacchiotti che si
sono occupati di estetica per qualche millennio, lui lo sa cosa
è il “bello” e faccio anche notare che, non
so il perché o forse lo so ma mi ci vorrebbe troppo per
dirlo, da un po' di tempo in qua quando mi si parla di “bellezza”
ho l'impressione che me lo stiano mettendo in quel posto, ma
vado avanti. “Di fatto”, purtroppo, “l'umanità
ha assunto la tecnologia e il suo sviluppo insieme ad un paradigma
omogeneo e unidimensionale”. “In tale paradigma
risalta una concezione del soggetto che progressivamente, nel
processo logico-razionale, comprende e in tal modo possiede
l'oggetto che si trova all'esterno. Tale soggetto si esplica
nello stabilire il metodo scientifico con la sua sperimentazione,
che è già esplicitamente una tecnica di possesso,
dominio e trasformazione” – la “realtà
informe”, insomma, sarebbe “totalmente disponibile
alla sua manipolazione”. C'è da chiedersi che c'è
di diverso da prima, se questo stesso allarme non poteva esser
lanciato anche all'età della pietra, ma, a quanto pare,
prima “si trattava di ricevere quello che la realtà
naturale da sé permette, come tendendo la mano”
(e ci risiamo con la mano).
L'essere umano – quello che “non è pienamente
autonomo”, perché “la sua libertà
si ammala quando si consegna alle forze cieche dell'inconscio,
dei bisogni immediati, dell'egoismo, della violenza brutale”
– e le “cose” sono diventati “contendenti”,
mentre “prima” (ma quando?) si davano “amichevolmente
la mano” (e ridalli con la mano).
Va da sé, allora, che – abbracciando tesi di chi
lo ha preceduto – Francesco I sia contro il relativismo
la cui definizione resta molto nel vago (più nel vago
di quanto abbia fatto chi lo ha preceduto), ma la cui cultura
costituirebbe “la stessa patologia che spinge una persona
ad approfittare di un'altra e a trattarla come un mero oggetto”.
Contrario anche alla “frammentazione del sapere”
(cui si dimentica di aver contribuito lui stesso dividendo la
scienza dalla religione) e all'eventuale subordinazione della
politica all'economia (sulla scia di Giovanni XXIII, propone
la costituzione di un'Autorità politica mondiale), si
dice convinto che “non si può sostenere che le
scienze empiriche spieghino completamente la vita, l'intima
essenza di tutte le creature e l'insieme della realtà”,
perché “questo vorrebbe dire superare indebitamente”
quei loro “limitati confini metodologici” sui quali,
però, non spende una parola
4.
Un'ultima considerazione la merita tutta questa buona dose di
esteticità con cui, recuperando formule antiche che già
i Padri della Chiesa avevano attinto da Platone, cerca di condir
via il suo gregge. Se la nostra “casa comune” è
come una madre “bella”, anche su altre bellezze
possiamo far conto per uscire dai nostri guai. “Prestare
attenzione alla bellezza e amarla”, infatti, “ci
aiuta ad uscire dal pragmatismo utilitaristico”. Come
ciò sia possibile lo sa solo lui ma un tentativo di comunicarcelo
in forma di preghiera lo fa: “(...)riversa in noi la forza
del tuo amore/affinché ci prendiamo cura/della vita e
della bellezza”, “risana la nostra vita (...)/affinché
seminiamo bellezza” (alla conclusione della Preghiera
per la nostra Terra) senza dimenticare di darci da fare
“...affinché venga il tuo Regno di giustizia, di
pace, di amore e di bellezza” (nella Preghiera cristiana
per il creato).
Concomitantemente ai miei sospetti, allora, posso constatare
che, sul mercato azionario dei valori belli e fatti nel pacchetto
dei realisti, il bello, insomma, “va”.
Felice Accame
|

