|
personaggi
Il filo di Ariandersen
di Giuseppe Pontremoli
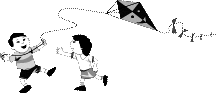
|
– Guardatemi, io vengo col seguito! – disse
l’ago da rammendo, e si tirò dietro un filo lungo,
che però non aveva nodo (1).
Di questo ago Andersen dice subito che aveva sentimenti delicati,
e che per questa ragione si sentiva più che altro un
ago da ricamo. A me sembra che avrebbe dovuto piuttosto parlare
di spocchia, di millanteria, di vanagloria, però non
ho alcuna intenzione di infierire su un povero ago, anche
perché il fatto di trovarsi in un racconto di Andersen
– che era un bravissimo narratore – è di
per sé una condizione che assicura una dose robusta
di amarezze.
Quel che mi interessa invece è che, anche nella vita
di un ago, è decisiva la questione dei nodi; e poi
il fatto che, a trascurare i nodi, si può forse finire
soltanto col perdere il filo – il che non è senza
conseguenze, come tutti ben sanno, soprattutto poi se nei
paraggi Arianna non c’è. L’Arianna del
mito, beninteso, colei che diede a Teseo il filo che gli consentì
di non perdersi nel labirinto, non l’Arianna di una
poesia di Pinin Carpi, che invece è soltanto una bambina
di panna /che sta in braccio alla sua mamma / e canta tutta
tutta tutta / questa bella o brutta canzone (2).
Soltanto una bambina. Che canta.
Soltanto? Come se fosse impresa da poco essere una bambina
e cantare. E come se fosse sufficiente avere tra le mani un
filo; come se bastasse riuscire a tornare indietro; e come
se anche per cantare non fosse necessario un filo.
E allora direi che forse anche il filo di Arianna non basta,
e più utile ancora mi sembra senz’altro il filo
di Ariandersen. Un filo, questo, che consente sì di
ritrovare la strada, ma soprattutto di individuarne una nuova,
aperta in parte dalla scoperta della necessità di non
trascurare i nodi che emerge da L’ago da rammendo
di Andersen, ma soprattutto da quell’altra straordinaria
vicenda di sartoria che è I vestiti nuovi dell’imperatore
(3) – storia che non Andersen
inventò, giacché lui stesso ci dice essere questo
un racconto di origine spagnola: tutta la spassosa idea, la
dobbiamo al Principe don Manuel, nato nel 1277, morto nel
1347 e che la stessa idea è utilizzata anche dal Cervantes
(4), ma che proprio Andersen ci
ha lasciato in una magistrale versione.
Quest’idea Cervantes l’ha utilizzata nell’Intermezzo
del Teatrino delle Meraviglie, e così ce ne informa
Oreste Macrì:
L’idea di base dell’intermezzo può
darsi derivi da un racconto del Conde Lucanor, di Juan Manuel,
in cui dei burloni fingono di tessere un panno che resterà
invisibile ai figli illegittimi. L’allargamento che
Cervantes fa del quadro delle esclusioni (il panno è
invisibile anche a chi ha sangue ebreo o moro fra gli ascendenti),
oltre a arricchire il tema, gli dà una folgorante e
coraggiosissima attualità, elevando un topico farsesco
a una chiara presa di posizione contro la violenza di stato
esercitata contro i non cattolici. Siamo in un’epoca
di spietate persecuzioni razziali contro ebrei e mori anche
se convertiti; macchinosi processi della purezza della razza
tendono a escludere dal più piccolo impiego o lavoro
chi non possa dimostrare di avere quattro quarti di cristiano
viejo. In tale stato di cose non v’è dubbio che
l’intermezzo, coprendo di ridicolo tali pregiudizi,
è un’audace denunzia di un’ingiustizia
del potere (5).
La stupidità
del potere
Ne I vestiti nuovi dell’imperatore di Andersen
il potere si svela in tutta la sua stupida essenza e nessuno
– né chi il potere detiene, né chi al
potere è incondizionatamente acquiescente, né
chi del potere ha soltanto paura e teme forse di essere più
in difficoltà ad essere libero e pensante che sottomesso
– nessuno osa dire che quel vestito è fatto di
un tessuto che semplicemente non esiste. Nessuno, tranne un
bambino: cioè chi con il potere non ha nulla a che
fare, essendone nient’altro che la negazione. Un bambino,
cioè chi con il potere non può che avere “vincoli
puerili” – e il fatto che poi l’infanzia
abbia fine e si inneschino con il potere vincoli non più
puerili sarà anche qualcosa che porta a sopravvivere
e pure a vendicarsi, ma è cosa che si connota come
tristezza infinita, perché altro non è che il
perpetuarsi di oppressione e calcolo, di cancellazione e silenzio.
Certo, a rapportarsi “puerilmente” rispetto al
potere anche in età adulta, forse non può succedere
qualcosa di diverso da quello che è successo a Osip
Mandel’stam, che in una poesia del 1931 scriveva: Col
mondo del potere non ho avuto che vincoli puerili: / temevo
le ostriche, e alle guardie lanciavo occhiate di sottecchi;
/ nemmeno di una briciola d’anima gli sono debitore
(6).
E Mandel’stam, proprio per il carattere dei suoi vincoli
con il potere, è morto in un gulag staliniano, forse
nel 1938, forse di consunzione, giacché pare che puerilmente
là dentro non mangiasse più nulla, per il terrore
puerile – cioè infinito – di essere avvelenato.
Ma è forse preferibile sopravvivere strisciando? È
forse preferibile aderire mollicciamente alle gelide figure
delle colonne che reggono e sostanziano il Palazzo? Ognuno
può rispondere come vuole; a me qui preme soltanto
dire che è un problema di filo, cioè un problema
politico e culturale e etico. Seguire il filo di Ariandersen
probabilmente porta anche alla consunzione, ma è preferibile
un meschino sopravvivere o il perseguimento tenace della dignità?
È un problema di filo.
Probabilmente Pinin Carpi apprezza quell’affermazione
di Ursula K. Le Guin (7) circa l’inesistenza
di culture che non hanno narrato storie a fronte di numerose
culture che non hanno mai fatto uso della ruota; probabilmente
la apprezza perché le sue storie sono numerosissime,
e soprattutto perché ogni suo lavoro è connotato
principalmente come una storia: i romanzi, i racconti, le
poesie, le ballate, i poemetti, le ninne nanne, le cantilene,
le illustrazioni, i lavori di divulgazione. Tutte storie,
e storie dentro le storie, con decine e decine di personaggi,
seguiti assiduamente o incontrati per caso, in forte evidenziata
presenza oppure soltanto evocati; a camminare camminare per
il vasto mondo oppure accucciati in un prato tra i rami sui
tetti nel mare nell’ovunque; a ridere dormire apparire
sparire cantare suonare mangiare guardare riempire il proprio
e l’altrui cammina cammina. Non so quanti possano essere,
tra umani – soprattutto bambini – , animali –
soprattutto gatti – , maghi, fate, folletti e quant’altro.
Non lo so e non ha alcuna importanza. E probabilmente il numero
dei personaggi delle storie di Carpi è cosa che può
interessare teste come quelle dell’uomo d’affari
del XIII capitolo del Piccolo principe di Saint-Exupéry
(8), che contava le stelle per possederle,
e voleva possederle per essere ricco, e voleva essere ricco
per comperare altre stelle; oppure a qualcuno che guardando
in un caleidoscopio si metta a contarne le immagini.
No, non è il caso; se qui ho sottolineato le tante
presenze è solo per dire che potrebbe sembrare un po’
arduo non perdere il filo, o che potrebbe forse sembrare difficile
individuarlo. Eppure a me sembra vi sia, e anche più
d’uno, e ognuno è un filo di Ariandersen.
E direi anche che non è un caso che mi sia accaduto
di pensare alle stelle e al caleidoscopio, evocazioni che
forse possono dire qualcosa di significativo rispetto alla
luminosità e al profluvio di immagini. Questo è
sicuramente un nodo, in Pinin Carpi. Tantissime immagini,
in movimento continuo, distribuite a pioggia, senza temere
alcuna possibile dissipazione. E così le sue storie
si configurano come un dono, come un gesto generoso preoccupato
soltanto di non essere inadeguato, di non essere esile, come
il darsi gratuito e incondizionato di chi dona soltanto per
amore. Perché questo, mi sembra, è il nodo decisivo
del lavoro di Carpi, il filo davvero sotteso: il donare –
gesto, questo, che presuppone un destinatario nei confronti
del quale c’è investimento affettivo, c’è
rispetto, c’è desiderio di contribuire a conseguire
la soddisfazione del desiderio.
A me sembra che Carpi possa essere definito un autore politico,
in quanto ha individuato i bambini come propri interlocutori,
soprattutto perché disponibili sempre ad allargare
il terreno del possibile e del desiderabile, perché
esseri mossi dall’incontenibile voglia di sapere e di
fare, di frugare, di continuare a cercare; e però tutto
questo, questa carica forte, in esseri completamente privi
di potere.
Il “partito”
dei bambini
Mi sembra che Carpi abbia scelto senza esitazioni il “partito”
dei bambini, del loro essere senza potere, del loro desiderio
di desiderare, e abbia impostato il proprio lavoro a far sì
che i bambini possano trovarvi ascolto e rispetto e attenzione,
e attenzione ai loro desideri, e ricerca di strumenti volti
a soddisfarli. È anche per questo, direi, che ha scelto
di scrivere usando un linguaggio molto parlato, un linguaggio
non banale e non preclusivo di tempi e di luoghi ma in ogni
caso rassicurante, familiare, vicino, riconoscibile e vivo.
E questo senza esibire nulla, senza volere insegnare alcunché,
senza propinare prediche o precetti – ma, dentro, i
princípi ci sono, e chi vuole vederli può farlo
senza sforzo perché sono semplicemente lì, laicamente,
come il respiro; e dentro c’è anche di che imparare,
e forse si impara persino di più, per il semplice fatto
che ci si diverte.
Sì, senza esibire nulla, ma ben evidenziando percorsi
e sviluppi ed esiti: e ben evidenziando che gli esiti sono
importanti e positivi, ma tanto per il fatto che portano ad
acquisire sicurezza e determinare equilibri quanto per il
fatto che da lì si può ripartire. Perché
è vero che ogni storia finisce, certo, però
è altrettanto vero che
la storia non finisce qui, non solo perché lì
intorno cominciarono a crescere tanti alberi che dopo un po’
il lago si trovò in mezzo a un bellissimo bosco, ma
anche perché le storie, se si vuole, continuano sempre.
Basta pensarci un po’ e ci si accorge che succede proprio
così. Questo è quello che conta di più
(9).
È quello che sente anche Mauro, il protagonista de
Il mago dei labirinti, il quale, dopo aver camminato
camminato per mille e un ovunque e per mille e un altrove
e avere conosciuto dei folletti e degli gnomi, degli dei
e delle silfidi, delle fate e delle streghe, delle sirene
e delle ondine, dei maghi e degli spiritelli e poi dei fruncelli
e degli strarli, dei custolini e dei trumpelli, delle scorosticontine
e delle balzerotte, delle svillere e dei volpitelloni
(10) – oltre, naturalmente,
a mille e un personaggio di varia umananimalità –,
esce dai giardini della notte. E, uscendo da quei giardini
il Mauro non era felice solo perché aveva scoperto
tante cose nuove, ma anche perché sapeva che avrebbe
continuato a esplorare tanti posti mai visti, fra gente mai
conosciuta, e avrebbe svelato tanti altri misteri arcani e
proibiti, nascosti e occulti, enigmatici e clandestini, inaspettati
e incredibili. Si cammina e cammina, e si torna, e si
vuole soltanto ripartire e tornare e ripartire e tornare,
senza fine. Sempre essendo se stessi ma sempre cambiati, come
il sole. Eccoli lì, il Mauro e Ulisse, il bambino
e il leone. Sono usciti dai giardini della notte e entrano
in un giardino dove il sole è appena spuntato. È
lo stesso sole di ieri, però è un sole nuovo,
la sua luce è tutta nuova, mai vista. E è una
luce bellissima.
Stanno arrivando a casa, Mauro e il leone Ulisse, e davanti
a loro c’è un labirinto. Lo supereranno, non
possono esserci dubbi, ma non soltanto perché è
quello che ha immaginato, inventato, disegnato, costruito
lui, il Mauro, e che conduce alla casa più bella di
tutte, la sua casa, quella da cui senza farsi vedere da nessuno
una mattina era partito con il leone per andare in giro per
il mondo. No, non solo per questo, e nemmeno soltanto
perché sappiamo da un libro precedente (11)
che la sua costellazione preferita è la Corona di Arianna.
Lo supereranno soprattutto perché i bambini delle storie
di Pinin Carpi tengono stretto, negli occhi e nelle mani,
il filo di Ariandersen.
 Giuseppe Pontremoli
Giuseppe Pontremoli
Note
- L’ago da rammendo, in Hans
Christian Andersen, Fiabe, tr. di Alda Manghi e
Marcella Rinaldi, Einaudi, Torino 1974, p. 233.
- Pinin Carpi, Nel bosco del mistero, Einaudi,
Torino 1986, p. 13.
- I vestiti nuovi dell’imperatore, in Andersen,
Fiabe, cit., p. 73.
- Ibid., p. 640 n.
- Miguel de Cervantes, Intermezzi, tr. di Vittorio
Bodini, a cura di Oreste Macrì, Einaudi, Torino 1989,
p. 125.
- Osip Mandel’stam, Poesie, a cura di Serena
Vitale, Garzanti, Milano 1972, p. 87.
- Ursula K. Le Guin, Il linguaggio della notte,
cit., p. 27.
- Antoine de Saint-Exupéry, Il piccolo principe,
cit., p. 63.
- Pinin Carpi, La banda del Cane Randagio, Nuove
Edizioni Romane 1989, p. 93.
- Pinin Carpi, Il mago dei labirinti, Giunti
1990, p. 76.
- Pinin Carpi, Mauro e il leone sulla cima del mondo,
Vallardi, Milano 1994, p. 134.
Scheda bibliositografica
Sul bel sito http://www.giuseppepontremoli.it,
curato dall’amico Alberto Melis, è possibile
trovare la bibliografia dei testi di Giuseppe oltre ad alcuni
dei suoi testi in formato digitale.
Roberto
Denti / Perché non essere allegri? |
|
Nel
mese dell’inverno,
quando c’è freddo e gelo
vogliamo intorno al fuoco
far risate e canzoni
parlare con gli amici
e dipingere il cielo
dedicarci all’amore
non avere padroni. (1)
Comincia
un anno nuovo: anche se ci sono cambiamenti nel passaggio
dalle stagioni, gennaio rimane un mese freddo e in molte
zone del nostro Paese la neve imbianca non soltanto le
montagne ma anche le pianure e le case. Con il primo giorno
– che ci distacca dai mesi trascorsi, da un recente
passato con esperienze liete o tristi – si possono
fare i propositi di vita che ci accompagneranno per lunghi
giorni. Il tempo passa in fretta ma sentiamo il bisogno
di condizionarlo, di non essere soggetti passivi rispetto
a ciò che accade intorno a noi.
Perché innanzitutto non essere allegri?
Allora abbiamo bisogno di amici con i quali parlare e
ridere, perché la solitudine può portarci
tristezza senza conforto e nessuno che ci aiuti a superarla.
In compagnia di altre persone è più bello
guardare il cielo e provare a cambiare il colore dell’azzurro
dai toni più tenui a quelli più profondi.
O saper accettare nuvole grigie pesanti di pioggia. Se
non restiamo soli, oltre all’amicizia possiamo trovare
l’amore di chi entra in sintonia con i nostri pensieri
e le nostre emozioni: possiamo affrontare il mondo che
ci circonda e non ci piace e lottare per modificarlo.
Un mondo dove chi detiene il potere si guarda bene dal
capire e soddisfare i nostri bisogni e le nostre esigenze.
Allora, tutti uniti, siamo in grado di opporci “a
chi ci comanda, a chi ci punisce, a chi ci ammaestra,
a chi ci insulta, a chi ci deride, a chi ci lusinga, a
chi ci inganna, a chi ci disprezza” (Marcello Bernardi).
In un mondo nuovo e diverso non è utopia la sicurezza
di essere uomini liberi.
Queste considerazioni sono suggerite dalle otto righe
della poesia di Giuseppe Pontremoli, le cui capacità
di sintesi erano una delle caratteristiche della sua profonda
cultura e della sua meravigliosa fantasia creativa.
 Roberto
Denti
Roberto
Denti
1.
Giuseppe Pontremoli: Ballate per tutto l’anno
e altri canti, Nuove Edizioni Romane, 2004.
|
|
  
|

