|
personaggi
Noi diroccati
di Giuseppe Pontremoli
|
Noi diroccati un po’ ci ninnavamo. Sono ancora senz’altro
in sospeso, i miei conti più veri con la notte e il
sonno. E così ogni volta, in un reiterato sfiancante
e sereno altalenare, oppongo resistenze che si configurano
ben più come un percorrere che come un approdare. C’è
sempre ancora almeno una cosa da fare: preferibile o inderogabile
o utile o necessaria o cupamente ossessiva, si tratti di gioia
o di dolore, è più forte del sonno. È
più forte il frugare, l’impastare; sono più
forti le voci.
E sono voci che, ad ascoltare davvero, raccontano del mondo
e del senso di starci; e dicono, per esempio, che il mondo
è troppo grande, e – in perfetta estenuante alternanza
– che è troppo piccolo, questo stesso mondo.
Che ci vuole troppo coraggio a continuare. Che è troppo
bello per non guardarlo più.
Io consulto l’oracolo e leggo: Ci sono ore in cui,
d’improvviso, il mondo si fa piccolissimo, ma in un
altro d’improvviso torna ad essere, di nuovo, troppo
grande. Si deve aspettare il terzo pensiero (1).
Sì, è vero, bisogna aspettare il terzo pensiero;
e bisogna aspettarlo ben sapendo che – purtroppo e per
fortuna – quando arriva, se arriva, non si dichiara
mai apertamente come tale.
Aspetto il terzo pensiero, e aspettando leggo ancora qualcosa
dell’oracolo, là dove parla di Capo Zequiel:
Il Capo udiva, udiva tutto, condannato. Chi era il nemico?
Chi veniva? La notte passa lontano, e appartiene alla terra,
più di un albero, più di un ventre di serpente.
Ci sono luoghi in cui è più notte che in altri.
[…] Tutti nella casa della fazenda dormono, la gente,
tutti; il nemico non è con loro. Il Capo, no; non si
concede riposo. Se si distrae un momento, sta lì ai
suoi piedi, dentro di lui. Non c’è porta, contro
quello, che si possa chiudere. […] Il Capo, lui ascolta,
rovistando. Una notte dopo l’altra, il mondo ha perso
le sue pareti. Attacca un grillo, piccola sega. Silenzio.
Gli insetti sono milioni. Il bosco, vocetta ammansata, aeiouava.
Dall’altro bosco, e dai buritìs, le risposte.
Più freddo e pieno di calore il Brejão fermenta.
Un pesce guizza in spirale.
Il battere di un remo. Un gemito di rana. Il tùi-tùi
a puntate delle pittime e dei mignattai, tra i giunchi dell’acquitrino.
Non c’è mai silenzio. Le fronde del bosco, un
vento, un grande ramo stridendo. Gli alberi vogliono ripetere
quel che di giorno hanno detto le persone. […] Nel silenzio
non c’è mai silenzio (2).
Anche Achab, anche Fedallah, in Moby Dick, non si abbandonano
al sonno; e quando Stubb avrà l’ardire di proporre
al capitano di fare qualcosa per attutire i colpi del suo
tormentato percorrere la coperta impedendo a tutti di dormire,
si sentirà rispondere con parole piuttosto chiare:
Scendi nella tua tomba notturna dove la gente come te dorme
nel sudario, per abituarsi a quello definitivo. Via, cane,
alla cuccia! (3)
Ma non c’è solo questo, non ci sono soltanto
gli Achab e gli Zequiel. E proprio l’oracolo già
consultato, nel primo dei sette romanzi che compongono Corpo
di ballo, parlando di un bambino, Miguilim, dice:
Non si abbandonava al sonno. Voleva avere il coraggio
di aprire la finestra, contemplare lassù in alto, appeso
con gli occhi, tutte quante, le Sette-Stelle.
Non voleva dormire, mai. […] La notte riceveva più
di sé, formava un’oscurità piena. Allora,
furono lucciole in ogni parte. […] Un’invasione.
Miguilim era incantato (4).
Come si può dormire? Anche qui, tra Zequiel e Miguilim,
bisogna aspettare il terzo pensiero.
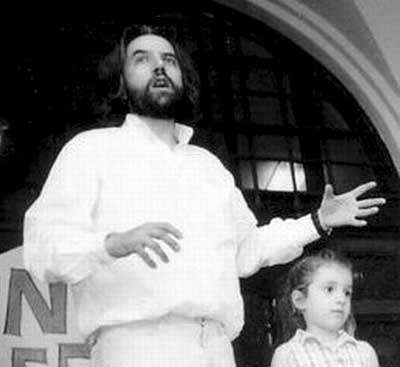
Giuseppe Pontremoli
La notte
porta nutrimento
Aspetto il terzo pensiero, e aspettando leggo qualche poesia
molto amata. Passo da Aleksandr Blok: Come aumenta l’angoscia
sul far della notte / C’è silenzio, c’è
freddo, c’è buio (5)
a Marina Cvetaeva: Per dormire c’è tempo,
c’è tempo, c’è tempo (6)
a Ingeborg Bachmann: Ovunque ci volgiamo nella bufera
di rose, / la notte è illuminata di spine, e il rombo
/ del fogliame, così lieve poc’anzi tra i cespugli,
/ ora ci segue alle calcagna (7).
Ma io non amo soltanto quei poeti che, come quelli citati,
possono consolidare una già ben più che robusta
resistenza all’arrivo del sonno. Amo moltissimo anche,
per esempio, René Char che, in un libro tradotto da
Giorgio Caproni, scrive:
La notte porta nutrimento, il sole affina la parte nutrita.
[…]
Notte plenaria in cui il sogno senza grazia più non
occhieggia,
conservami vivo ciò che amo
e poi:
Notte, mio fogliame e mia zolla (8).
E moltissimo amo Elsa Morante, un altro oracolo che consulto
spesso:
Dormi.
La notte che all’infanzia ci riporta
e come belva difende i suoi diletti
dalle offese del giorno, distende su noi
la sua tenda istoriata (9).
Mi fermo qui, perché in questa poesia c’è
una cosa decisiva: la belva che difende i suoi diletti dall’assedio
di belve. E, fermandomi qui, qui trascrivo una poesia di Fernando
Bandini, troppo bella per non essere riportata integralmente,
intitolata Berceuse:
E fatta la bella cucitura alle palpebre
dormi, bambino, dormi!
Non una goccia di sangue ti è uscita
dai cigli. Stelle enormi
galleggiano nell’aria, la tua manina
pende dal letto. Come rassomigli
al piccolo re dei Cimmerii
che dorme sulle rive del Mar Nero!
E adesso che hai la bella cucitura alle
palpebre
dormi, bambino, in eterei
regni trasvola dove fioco è il pensiero.
Il tuo sonno è un pulcino nel suo guscio.
Io sono un passo e ti fruscio qui accanto,
io sono il ramoscello di calicanthus
nella sua brocca e bramo
la fredda aria d’inverno del tuo letargo.
Gli altri girino al largo
che coverò il tuo sonno nel suo uovo.
Fruste di rovo userò per straziare
il dorso dei cani randagi
che si aggirano intorno al tuo sepolcro (10).
Forse è troppo sottile il confine tra una notte che
ha fine e una notte definitiva, e non mi sembra un caso che
Char, nel libro già citato, abbia scritto una Ninna
nanna per ogni giorno fino all’ultimo: Numerose
volte, molte volte, / l’uomo s’addormenta, il
suo corpo lo sveglia; / poi una volta, soltanto una volta,
/ l’uomo s’addormenta e perde il suo corpo
(11).
È vero, si tratta di una volta a fronte di tantissime,
ma qual è quell’una? Io al mattino voglio svegliarmi
e alzarmi, dico.
Io al mattino voglio svegliarmi e alzarmi, mi ha detto Silvia,
una bambina di sette anni che spiegava di non volere crescere
per il fatto che crescendo si diventa vecchi e si muore e
si va in Paradiso e si sta lì a fare niente: una noia
mortale, io al mattino voglio svegliarmi e alzarmi e fare
delle cose, ha detto. Forse conosceva quel peccatore occhialuto
che in un racconto di Isaac Bashevis Singer dice che i giusti,
in paradiso, muoiono di noia (12);
oppure Huckleberry Finn, che racconta come la signorina Watson,
dopo avergli spiegato che se non si comporta come dice lei
andrà a finire nel posto brutto, prende su e mi conta
tutto per filo e per segno di come è il posto bello.
Mi dice che non c’era più niente da fare lassù,
solo andare in giro tutto il giorno con un’arpa e cantare
per tutti i secoli dei secoli. Così che a me non è
che mi interessa molto (13).
Io la mattina voglio svegliarmi e alzarmi e fare delle cose,
avrà pensato.
Il mattino dopo che si è morti
non ci si può svegliare
la vita è finita
è incominciata la morte
[…]
Io al mattino voglio svegliarmi e alzarmi
non starmene lì sotto terra (14)
scrive Vivian Lamarque nel bellissimo, struggente, doloroso
poemetto Questa quieta polvere.
Questa citazione non rende certo l’idea di cosa sia
davvero il poemetto di Vivian Lamarque, che è da leggere
tutto, con tutte le sue lievi elementari profonde parole;
con tutte le fiabe che cita o che evoca; con tutto il fiabesco,
di atmosfera e di linguaggio, da cui è percorso.
Come sempre, del resto, in tutti i suoi lavori.
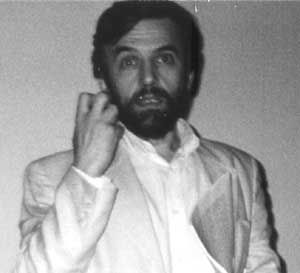
Giuseppe
Pontremoli
Acuminata
grazia
Il fiabesco e l’infanzia sono sicuramente molto dentro
al lavoro di Vivian Lamarque, che nel fiabesco e nell’infanzia
penetra con acuminata grazia, con consapevolezza dolorosa,
con limpidezza e con forza – la limpidezza e la forza
che possono venire, per esempio, dall’essere una
donna forte sì / ma con anche continue tentazioni di
non esserlo e dall’avere qualche pensiero triste / e
due o tre sereni (15).
A me sembra che la presenza più assidua, pervasiva,
del lavoro di Vivian Lamarque sia quella del dolore, e accentuata
proprio dall’apparente lievità del timbro e delle
situazioni. Per esempio, a proposito dell’infanzia,
vorrei ricordare, tra tante altre, una brevissima poesia di
Teresino, Le sue ali infantili, una poesia di grande,
acuta, acuminata profondità: Le sue ali infantili
/ spiccano ogni volta felici il volo / incontro a chi spara
(16).
Quel che pertiene al volo è connotabile come dell’infanzia,
forse perché davvero soltanto in essa il volo è
praticabile; e quel volo è ogni volta felice, proprio
perché volo, libero e gratuito, incurante di tutto;
e felice ogni volta perché assoluto, unico, irripetibile,
necessario e incontenibile come un respiro. E ci sono spari,
spari di ogni tipo, contro i voli, perché il libero,
il gratuito, il felice, l’incontenibile dirsi altro
non è se non intollerabile. E così gli si spara
– ed è uno sparo anche il fatto, inevitabile,
che quel tempo del volo abbia poi fine.
Il linguaggio di Vivian Lamarque è “fiabesco”
e “infantile”, per il suo condensarsi in un “minimo”
che si rivela sempre come un “tanto” se non addirittura
come un tutto: come nelle fiabe, dove non è necessario
che il bosco venga descritto per conoscerlo e riceverne insieme
attrazione affascinata e oscuro terrore, e di una vecchia
di un giovane di un re non ci serve nient’altro che
la più essenziale definizione di entità, le
parole di Vivian Lamarque – spesso superlativi, spesso
diminutivi, spesso ripetizioni, spesso condensazioni di più
parole in una, spesso personificazioni – si danno nella
loro essenziale entità, nella densa intensità
che viene dall’averle scrutate fino in fondo; un po’
come se alle parole, tutte quante, ma soprattutto alle più
elementari, fosse applicato quello che in una sua poesia si
sottolinea della parola mai: sai la parola mai? fino in
fondo? (17) E i superlativi,
i tanti diminutivi, le ripetizioni, sono come necessari, completamente
privi del lezioso e del torbido che connota l’uso che
ne è fatto in troppa parte della cosiddetta letteratura
per l’infanzia e nell’intollerabile bamboleggiare
di troppi adulti. Qui sono solo necessari:
Mentre versava l’acqua pensava
se non ne cadrà nemmeno una goccia
un poco ancora si ricorda di me
e versava con attenzione
versava e non cadeva nemmeno una goccia
nemmeno una finché ne cadde una
piccolissima minuscola (18).
Necessari, e per almeno un paio di ragioni. Una ragione mi
sembra stia nel fatto che il dimensionare in piccolo, oltre
che corrispondere a una scelta di gusto, a una scelta di campo,
risponda anche a una sorta di coazione, e che sconfini anch’essa
in un dolore, che rinvii anche al ridimensionare. E c’è
una bellissima poesia, in Teresino, che si intitola appunto
Ridimensionare:
Quest’operazione
che la costringete sempre a fare
“ridimensionare”
non è come stringere un vestito
non è indolore
si taglia la pelle del cuore (19).
E poi c’è un’altra ragione, speculare,
forse, che trovo in un’altra poesia, di un altro poeta,
il cui nome qui non faccio a caso, Tiziano Rossi: Però
dai pezzettini tantissimi / viene l’intero, / e fiammeggia
anche lui dentro in una / costellazione (20).
E a me sembra che i pezzettini tantissimi di Vivian Lamarque
formino davvero una costellazione, lucciole dentro un nero
– un nero non dissolto e non negato, ma contrastato
sì, e con incantamento.
Sballottati tra
insidie incombenti
Anche Tiziano Rossi scrive con tanto “fiabesco”
e con tanta e acuta attenzione all’infanzia. A questo
proposito voglio ricordare soltanto un esempio, preso da Dallo
sdrucciolare al rialzarsi:
Gli anni quattro di tuo figlio che rovista
in malagevoli domande
(sul come le gòcciole bagnano e sopra la grande
dimensione tranviaria):
dargli una mano perché
lui piano piano ti disfi
e intanto partìcola avanti respiri (21).
C’è dell’altro, ovviamente, ma basterebbe
anche il solo fatto di dare una mano a qualcuno perché
possa respirare e piano piano disfarci; o anche questo niente
riposare sballottati tra insidie incombenti, silenzi senza
silenzio, incantamenti; o anche il sentirsi persone forti,
sì, ma con anche la continua tentazione di non esserlo;
basterebbe anche questo soltanto, per sentirsi spossati, diroccati.
E ci si sente spesso, diroccati. E Rossi, in Quasi costellazione,
dice che
in ultimo, nel nòcciolo più scuro
bisognosi di cura
[…]
noi diroccati un po’ ci ninnavamo (22).
Vivian Lamarque, alla fine del 1989, ha pubblicato Il
libro delle ninne nanne, e nella prefazione ha scritto:
Ho iniziato a scrivere queste ninne nanne nel 1978, in
giorni bui. Nei giorni bui ridiventiamo tutti bambini spaventati
e abbiamo bisogno ancora che qualcuno “ci canti”.
Le ninne nanne cullano i bambini ma anche le mamme (23).
Sono trecentosessantacinque ninne nanne, una per ogni giorno,
raggruppate cronologicamente nella scansione dei mesi. E tengono
anche conto di ricorrenze e di eventi legati alle stagioni,
ma soprattutto sono percorse da agglomerati che si dipanano
a cadenze fisse: tutte le ninne nanne dei giorni 1 iniziano
con ninna nanna il Sonno è...; quelle dei
giorni 5 iniziano con ninna nanna ti racconto una fiaba;
quelle dei giorni 10 sono le puntate della storia di un vecchino
e una vecchina; quelle dei giorni 15 sono ninne nanne di
un bambino che non aveva mai visto...; quelle dei giorni
20 parlano del trascorrere del Tempo; quelle dei giorni 25
sono storie di Re; quelle dei giorni 30 sono la storia dell’Uomo
del Sonno.
Sono piccoli canti d’amore e di dolore, di tenerezza
e dolore, di canto e dolore. Ancora una volta, anche qui,
è il dolore la nota assidua, non esibita ma sottesa.

Tra gioia
e dolore
È facile scivolare dai testi alle biografie; è
facile e ingiusto; ed è facile anche pensare alle dolorose
vicende personali di cui Vivian Lamarque scrive nelle sue
poesie e che ha raccontato esplicitamente altrove (24).
Ma qui, ora, soprattutto mi viene da pensare a coloro che
sono sempre pronti a sdilinquirsi e immaginare roselline e
beote beatitudini a proposito della cosiddetta letteratura
per l’infanzia e i suoi autori. A me sembra di intravedere
invece una impressionante “Galleria del dolore”,
sulla quale si potrebbero innestare non poche riflessioni.
Silvio D’Arzo, figlio di un padre sconosciuto e di una
“cartomante”, morì a trentadue anni.
Stevenson, tisico per tutta la vita, aveva quarantaquattro
anni quando un embolo al cervello lo fermò per sempre
su un’isola dei Mari del Sud.
Un figlio di Kenneth Grahame si suicidò a vent’anni.
Anche il padre di Salgari, oltre a lui stesso, si tolse la
vita; e così pure un figlio di De Amicis.
Kipling da bambino venne picchiato e perseguitato da una “zia”
a cui era stato affidato e una volta che sua madre andò
a trovarlo e gli si avvicinò per abbracciarlo, lui
alzò il braccio per difendersi dal colpo che si aspettava
di ricevere. All’età di sei anni morì
sua figlia Josephine, la prediletta “Effie”; suo
figlio John, diciottenne, morì in guerra.
Il padre di Pinin Carpi fu deportato a Mauthausen e a Gusen;
suo fratello Paolo non tornò mai dal lager di Gross-Rosen.
Andersen aveva undici anni quando suo padre morì; poi,
brutto e diverso, inseguì sempre amori infelici.
La moglie di Ted Hughes si suicidò.
Una figlia di Dahl morì a sette anni, un figlio ebbe
un incidente e rimase menomato; sua moglie restò paralizzata,
e la storia di Roald bambino è proprio come quelle
raccontate da Dickens.
Mark Twain fu preceduto nella morte da due figlie e fu la
sua stessa superficiale negligenza a provocare la malattia
che portò alla morte, a ventidue mesi, il suo primogenito.
Janusz Korczak venne ucciso insieme ai duecento bambini della
Casa degli Orfani di Varsavia da lui diretta, nel corso della
deportazione verso il campo di sterminio di Treblinka.
Uri Orlev passò due anni nel ghetto di Varsavia; quando
esso venne distrutto, la madre fu uccisa dai nazisti e Uri
e il fratello vennero deportati a Bergen Belsen; e oggi Orlev
ci racconta di un bambino e del suo bisogno di una bestia
d’ombra amica, che lo soccorra perché la madre
non può fare nulla contro l’arabo che lo insegue
nei sogni (25).
Salman Rushdie è condannato a morte dagli ayatollah
– dall’antro buio della sua condizione, non potendo
raccontare alcunché al proprio figlio, ha scritto per
lui, e per tutti noi, l’incantevole Harun e il Mar
delle Storie.
In una poesia di Attila Jòzsef si parla di un bambino
che, prima di addormentarsi, chiede alla madre di raccontare
e non sa bene che cosa più desidera, / la fiaba
o la presenza della madre (26).
Mi sembra che Vivian Lamarque abbia un po’ lo stesso
atteggiamento: canta, e non sa bene che cosa più desidera,
quelle parole oppure il fatto stesso di dirle. E comunque
dice, le dice, canta, e sente la necessità della parola
perché il bimbo continui a pendere dalle sue labbra,
e, mentre il sonno arriva, non si compiace di esprimere soltanto
cose gradevoli, anzi, le piace introdurlo appieno nella cruda
realtà e trasfondere in lui la drammaticità
del mondo (27).
Le dice, quelle parole, canta, come in una sospensione, tra
gioia e dolore, tra incantamento e paura, tra difesa e offesa,
tra cane e lupo.
Anche le belle illustrazioni di Aura Cesari che percorrono
Il libro delle ninne nanne si collocano qui e, in
questo senso, mi sembrano un po’ meno “notturne”
di quanto vengano definite nella prefazione; per l’aria
complessiva, per le tinte, per i grandi un po’ sperduti
tanti occhi di uccelli, sono forse invece un po’ più
sulla soglia.
Ho il sospetto che qui si sia affacciato, ogni tanto, qualche
terzo pensiero. Affacciato soltanto, beninteso; ma se è
vero che se ne ha bisogno, è altrettanto vero che è
vitalmente essenziale anche solo il cercarlo, l’aspettare.
Cosa c’era cosa c’era sulla neve della
stradina?
C’era l’ombra della luna.
Cosa faceva lì?
Lì aspettava.
Chi aspettava?
Aspettava l’attesa di un signore.
Aspettava l’attesa?
Sì, prima devono compiersi le attese dei signori,
in seguito sulle stradine arriveranno i signori in persona.
 Giuseppe Pontremoli
Giuseppe Pontremoli
Note
- João Guimarães Rosa, Le sponde dell’allegria,
tr. di Giulia Lanciani, SEI, Torino 1988, p. 73.
- João Guimarães Rosa, Buritì,
tr. di Edoardo Bizzarri, Feltrinelli, Milano 1985, pp. 43-44
e 65; in Corpo di ballo, Feltrinelli, Milano 1964,
pp. 588-589 e 610.
- Herman Melville, Moby Dick, tr. Italiana a cura
di Cesare Pavese, Einaudi Torino, p. 186.
- João Guimarães Rosa, Miguilim, tr.
di Edoardo Bizzarri, Feltrinelli, Milano 1984, pp. 59 e 74;
in Corpo di ballo, cit., pp. 54 e 68.
- Aleksandr Blok, Poesie, tr. di Angelo Maria Ripellino,
SE, Milano 1987, p. 168.
- Marina Cvetaeva, Insonnia, a cura di Giovanna Ansaldo,
Marcos y Marcos, Milano 1985, p. 31.
- Ingeborg Bachmann, Poesie, Guanda, Milano 1978,
P. 57.
- René Char, Poesia e prosa, tr. di Giorgio
Caproni, Feltrinelli, Milano 1962, pp. 563-565.
- Alibi, in Elsa Morante, Opere, a cura
di Carlo Cecchi e Cesare Garboli, Mondadori, Milano 1988,
vol. I, p. 1395.
- Fernando Bandini, Santi di Dicembre, Garzanti,
Milano 1994, p. 28.
- Char, Poesia e prosa, cit., p. 395.
- Shabbath nella Geenna, in Isaac Bashevis Singer,
La morte di Matusalemme, Longanesi, Milano 1989,
p. 187.
- Mark Twain, Le avventure di Huckleberry Finn, tr.
di Enzo Giachino, Einaudi, p. 7.
- Vivian Lamarque, Una quieta polvere, Mondadori,
Milano 1996, p. 70.
- Vivian Lamarque, Teresino, Società di poesia-Guanda,
Milano 1981, p. 52.
- Ibid., p. 55.
- Ibid., p. 25.
- Ibid., p. 39.
- Ibid., p. 63.
- Tiziano Rossi, Quasi costellazione, Società
di poesia, Milano 1982, p. 65.
- Tiziano Rossi, Dallo sdrucciolare al rialzarsi,
Guanda, Milano 1976, p. 99.
- Quasi costellazione, cit., p. 35.
- Vivian Lamarque, Il libro delle ninne nanne, Edizioni
Paoline, Cinisello Balsamo, 1989, p. 5.
- Leggere gli anni verdi. Racconti di letture sull’infanzia
e l’adolescenza, a cura di Cesare Pianciola e Giuseppe
Pontremoli, e/o, Roma 1992, pp. 93-97.
- Uri Orlev, La bestia d’ombra, tr. di Alessandro
Guetta, Salani, Milano 1995.
- Saluto a Thomas Mann, in Attila Jòzsef,
Gridiamo a Dio, a cura di Sandro Badiali e Gilberto
Finzi, Guanda, Parma 1963, p. 127.
- Vivian Lamarque, Il signore d’oro, Crocetti,
Milano 1986, p. 58.
Fausta
Bizzozzero / Costruire uomini liberi |
Giuseppe.
Se chiudo gli occhi rivedo il suo viso intenso e intelligente,
i suoi capelli lunghi e sciolti sulle spalle, i suoi occhi
vivacissimi e curiosi. E risento la sua voce meravigliosa,
calda, di timbro basso, avvolgente, leggere una storia
e trasportarmi là, in un altro mondo. Nei primi
mesi del 2003 la Libreria Utopia, con l’aiuto prezioso
di Filippo Trasatti, aveva organizzato un ciclo di conferenze
sulla scuola, sul ruolo degli insegnanti, sulla lettura.
Giuseppe, ovviamente, era relatore in una di queste conferenze,
ma l’ho visto seduto sui gradini della sala conferenze
e l’ho sentito intervenire con passione e intelligenza
a tutte, nessuna esclusa.
Così l’ho conosciuto e così mi ha
toccato il cuore: perché era un insegnante meraviglioso
capace di trasmettere gioia ed entusiasmo (come avrei
voluto essere anch’io se i casi della vita non mi
avessero “costretto” ad altri studi e altri
percorsi), perché come me amava la lettura in modo
totale e incondizionato, perché leggeva ad alta
voce in modo meraviglioso trasformando la parola in vita,
perché era di una curiosità inesauribile,
perché aveva saputo conservare – forse proprio
grazie alla lettura e alla passione per le storie –
quello sguardo sul mondo fatto di candore e meraviglia
che solo i bambini hanno. Purtroppo dopo l’estate
di quell’anno è cominciata la sua terribile
malattia ed io l’ho rivisto solo quando abbiamo
organizzato la presentazione del suo bellissimo libro
Elogio delle azioni spregevoli pubblicato da
L’Ancora del Mediterraneo.
Stava già molto male e quel giorno aveva avuto
una febbre altissima, ma per nulla al mondo avrebbe rinunciato
ad esserci e, ancora una volta, a regalarci la magia della
sua voce che ci leggeva dei brani. Nella storia trentennale
della libreria nessuna conferenza è stata più
partecipata, più emotivamente condivisa, più
calda d’affetto e di stima da parte di tutti i presenti:
insegnanti, genitori, bambini/alunni e bambini ormai cresciuti
che ancora rimpiangevano il loro maestro che in quest’epoca
di nazi-consumismo e di predominio del dio denaro, aveva
insegnato loro a percorrere le mille strade delle mille
storie dei mille mondi della lettura.
“Maestro di libertà” è il titolo
della serata che abbiamo voluto dedicargli insieme alla
Libreria dei ragazzi e mai titolo fu più giusto
perché questo è il compito che ha cercato
di svolgere Giuseppe in tutta la sua vita, instancabilmente,
con l’insegnamento, con le sue letture ad alta voce,
con i suoi libri: costruire uomini liberi.
 Fausta Bizzozzero
Fausta Bizzozzero
|
|
  
|

